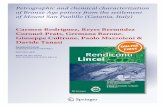Donato Del Piano e l’organo dei benedettini di Catania, ed. by Luciano Buono e Giovanni Paolo Di...
-
Upload
rijksmuseum -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Donato Del Piano e l’organo dei benedettini di Catania, ed. by Luciano Buono e Giovanni Paolo Di...
Donato Del Piano e l’organo dei benedettini di Catania / a cura di Luciano Buono e Giovanni Paolo Di Stefano –Guastalla : Associazione “Giuseppe Serassi” , 2012.ISBN 9788890727221
Collana d’arte organaria – XII, 2012Direzione scientifica a cura di Giosuè Berbennie Federico Lorenzani
Associazione culturale “Giuseppe Serassi”Piazza Mazzini, 7 – 42016 Guastalla (RE)[email protected] – www.serassi.it
Copyright © 2012 by Associazione “Giuseppe Serassi” – Guastalla (RE)I diritti di traduzione, di riproduzione e diadattamento, totale o parziale, con qualsiasimezzo (compresi i microfilms e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.
progetto graficoGuido Mapelli
In copertina: l’organo della chiesa di San Nicolò l’Arena di CataniaIn quarta di copertina: particolare della facciatadell’organo della chiesa di San Nicolò l’Arena.
Si ringraziano, per aver concesso la riproduzionedelle immagini, gli Archivi di Stato di Catania e di Palermo, il Comune di Catania e le CurieVescovili di Caltagirone, Cefalù, Nicosia, Noto,Palermo, Patti, Piazza Armerina, Ragusa e Siracusa.
L’editore, esperite le pratiche per acquisire i diritti relativi al corredo iconografico, rimanecomunque a disposizione di quanti avessero a vantare ragioni in proposito.
Questo volume è stato realizzato in collabora-zione con il Dipartimento Fieri-Aglaiadell’Università di Palermo.
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 2
Donato Del Piano e l’organo dei benedettini di Cataniaa cura diLuciano Buono e Giovanni Paolo Di Stefano
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 3
6 Presentazione Federico Lorenzani
7 PrefazioneAmalia Collisani
9 IntroduzioneLuciano Buono, Giovanni Paolo Di Stefano
13 Donato Del Piano e il suo tempo
15 Di Catania nel Settecento e di un organaro di talento Maria Grillo
37 L’“organum maximum” di Donato Del Piano. Modello insigne tra gli strumenti straordinari del suo tempo Luigi Ferdinando Tagliavini
49 I clavicembali singolari di Donato Del Piano. Fonti documentarie e contesto storico Giovanni Paolo Di Stefano
87 L’arte organaria di Donato Del Piano
89 L’attività organaria di Donato Del Piano in Sicilia (1725-1785) Luciano Buono
103 Caratteristiche costruttive degli organi di Donato Del Piano Francesco Oliveri
115 La decorazione artistica nei prospetti d’organo di Donato Del Piano Giusy Larinà
125 Il restauro dell’organo dei benedettini di Catania
127 Cronistoria del restauro Gianluca Libertucci
135 Il restauro dell’organo di San Nicolò l’Arena Enrico Mascioni, Maurizio Isabella
161 Note sul temperamento dell’organo di San Nicolò l’Arena e degli organi siciliani settecenteschi Diego Cannizzaro
167 Il restauro della cassa lignea dell’organo di Donato Del PianoPiera Vigo
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 4
171 Storia, documenti, testimonianze
173 Gli organi di Donato Del Piano attraverso le fonti archivistiche Luciano Buono, Giovanni Paolo Di Stefano
199 Documenti sull’organo di San Nicolò l’Arena di Catania Luciano Buono
227 L’organo dei benedettini di Catania nei racconti di viaggiatori e di letterati del passato Giovanni Paolo Di Stefano
247 Musica e musicisti in San Nicolò l’Arena (1770-1830). Appunti per una storia della cultura musicale a Catania in età borbonica Dario Miozzi
273 Catalogo degli organi di Donato Del PianoLuciano Buono, Giusy Larinà
299 Bibliografia
311 Indice dei nomi
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 5
6
Presentazione
In questo anno 2013, sono ormai due i lustri che ci separano dall’inizio dei progetticulturali dell’Associazione “Giuseppe Serassi”. Nel corso degli anni è nata la Rivista di Arte Organaria Italiana che ha ospitato
articoli dei maggiori studiosi italiani riguardanti il patrimonio organario di tutta lapenisola. La rivista, con uscita annuale, trova infatti la propria diffusione in tutt’Italia,ricevendo più che lusinghieri consensi dagli appassionati e soprattutto dagli addettidel settore. Nel contempo è nata la Collana di Arte Organaria, con dodici volumi giàpubblicati.Dopo l’uscita dell’imponente lavoro in quattro tomi sulla bottega organaria dei
Serassi, ad opera dal noto studioso bergamasco Giosuè Berbenni, edito dalla nostraAssociazione, ci troviamo ora a presentare questo altrettanto importante testo sull’or-ganaro siciliano Donato Del Piano a cura di due noti studiosi siciliani. Con altri lavo-ri “in cantiere”, non avremmo mai pensato di poter collaborare anche a questoimportantissimo progetto. Questa collaborazione ci riempie di orgoglio e di sinceraadesione, soprattutto per essere stati scelti come punto di riferimento nella diffusio-ne degli studi di settore. Dar voce a questo studio così articolato e metodico, puntua-le e scientifico, ci rende consapevoli e ci onora nel ruolo che abbiamo nell’ambitodella custodia della cultura organaria. Questa nuova pubblicazione ci dà ancora piùforza per continuare in questo ambizioso progetto di conoscenza e salvaguardia dellanostra Arte Organaria che, ora più che mai, possiamo definire italiana. Infatti, daibergamaschi Serassi agli isolani Del Piano abbiamo, almeno idealmente, abbracciatotutta la nostra penisola. E ciò non è poco, anche perché la cultura non conosce limi-ti e vincoli di latitudine, si esprime secondo un respiro così ampio che supera i loca-lismi per riverberarsi lungo le strade dell’assoluto, l’assoluto della conoscenza.
Federico LorenzaniPresidente Associazione culturale “Giuseppe Serassi”
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 6
Prefazione
A partire dagli anni 20 del Settecento fino al penultimo decennio di quel secoloDonato Del Piano, giunto da un antico centro non distante da Napoli, si mosse inSicilia di chiesa in chiesa, da sud-est a nord-ovest, da Siracusa a Palermo, arricchen-dola dei suoi manufatti, prodotti di una tecnica raffinata, di un orecchio ingegnoso,di una mente geniale.Negli anni 40 fissò in Catania la sua dimora, ma la sua propensione per gli affari
immobiliari e per le attività imprenditoriali, oltre a quelle sue principali di costrutto-re di strumenti musicali, lo sospingevano in varie città della Sicilia. A Catania comun-que tra il 1755 e il 1767 costruì il suo opus maximum, cui questo volume è dedicato,l’organo nella chiesa di San Nicolò l’Arena del monastero dei padri benedettini, subi-to considerato straordinario per dimensioni, struttura, qualità, bellezza, e ripetuta-mente descritto come tale da viaggiatori, letterati, studiosi, musicisti. Contendeva inSicilia il primato di grandezza e complessità all’organo di un altro monastero di padribenedettini, quello di San Martino presso Palermo, opera tardo-cinquecentesca diRaffaele La Valle; contendeva il primato in Europa all’organo costruito poco meno ditrent’anni prima a Haarlem da Christian Müller e Hendrik de Werff nella Sint-Bavokerk. Non solo l’organo catanese di Del Piano fu considerato «meraviglioso»;anche il suo autore viene raffigurato come persona fuori dal comune per competen-za tecnica, per inventiva, per generosità, per amabilità da coloro che lo conobbero elo avvicinarono, e che sentirono descritte da lui stesso le ingegnosità meccaniche deisuoi strumenti, e lo udirono suonarli. Cosicché questo volume, costruito dall’acribia filologica di molti studiosi, basato
interamente su documenti e materiali, si illumina del fascino che lo strumento e il suocostruttore esercitarono, e che di pagina in pagina si rinnovano.Gli strumenti sono la componente dell’esperienza musicale più concreta e più sta-
bile. Essi contrastano già con la loro presenza fisica, persino se mal ridotti e quasimuti, l’idea astratta della musica affidata al numero dai pitagorici, quella metafisicaelaborata dai romantici, quella di caducità e contiguità con la morte che suggerì aLeonardo il compassionevole attributo di «sventurata». L’organo è “strumento” pereccellenza già per la sua etimologia onnicomprensiva, e strutturalmente per la com-presenza delle sue molte voci, assunto anche per queste sue qualità al ruolo principenella liturgia cristiana. Un organo mirabile e favoloso come questo di Donato DelPiano che ha potuto riacquistare la sua voce grazie a un sapiente e accorto restauro,tanto da potersi dire che «la sua struttura […] rivela essersi conservata intatta sino ainostri giorni»,1 riesce persino a temperare le ragioni epistemologiche che criticano lapossibilità di accedere e conoscere i modi musicali del passato. Di fronte a esso, piùche leggendo testi di teoria e di storia, più che guardando raffigurazioni pittoriche edisegni tecnici, e persino più che messi a confronto con le pagine di musica scritta lecui note – lo sappiamo – sono ellittiche e allusive, possiamo immaginare che vengarealizzato, anche se parzialmente e imperfettamente, il desiderio di musicisti e musi-
7
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 7
cologi, di dilettanti e amanti della musica: rivisitare il passato musicale nella sua con-cretezza. E di più, possiamo esser certi che il suono che dal settembre 2005 è torna-to a riempire la chiesa di San Nicolò l’Arena si ponga in continuità con la pratica diascolto di diverse generazioni. La complessità delle sollecitazioni mosse da uno strumento straordinario richiede
l’apporto di studiosi di diverse competenze. Storici, organologi, restauratori, esecuto-ri, ciascuno nel proprio ambito, ha rivisitato, ritrovato, interpretato archivi, documen-ti, testi, descrizioni che allargano via via l’orizzonte e contemporaneamente acquista-no profondità e spessore nelle numerose possibilità e variabili che si aprono. DaCatania alla Sicilia all’Europa; dagli organi ai “clavicembali singolari”; dalla meccani-ca alla decorazione; dal manufatto al temperamento; dalla ricevute di pagamento aicontratti, ai testamenti, ai diari, ai romanzi. L’articolazione dei testi qui presentatirende la varietà dei contributi e la loro coerenza. La documentazione allegata da cia-scuno, diversa per genere, collocazione, oggetto, segnala e ricollega i diversi percorsi.E anche quella iconografica, pur interna e pertinente a ogni testo, ci rappresenta nelmodo più immediato la storia di Donato Del Piano e del suo organo nel suo svilup-po e nella sua continuità.
Amalia CollisaniUniversità di Palermo
1. LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI, L’“organum maximum” di Donato Del Piano, in questo volume, p. 43.
8
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 8
Introduzione
Questo volume è il risultato di un lungo lavoro di ricerca avviato intorno al 2000 nel-l’ambito dell’intervento di restauro del monumentale organo realizzato tra il 1755 e il1767 da Donato Del Piano (1704-1785) per la chiesa del monastero benedettino di SanNicolò l’Arena di Catania. Il presente progetto editoriale è infatti il frutto delle ricer-che condotte dai componenti della commissione scientifica che fu nominata allo scopodi seguire le complesse operazioni di restauro e del contributo di studiosi che furonoparallelamente incaricati di approfondire la storia dell’organaro e del suo strumento.Il libro si inserisce nell’ambito degli studi sull’organaria siciliana avviati, di fatto, a par-tire dagli anni 80 del secolo scorso: dopo il pioneristico e un po’ approssimativo contri-buto di Damiano Di Pasquale del 19291 e le brevi notizie pubblicate nel 1962 da LuigiFerdinando Tagliavini e Oscar Mischiati,2 trascorse infatti circa un ventennio prima chefossero intraprese ricerche più approfondite sull’argomento. Nel 1981 fu dunque rea-lizzato un volume dedicato proprio all’organo dei benedettini di Catania, da cui prese-ro le mosse i primi tentativi di recupero del prezioso strumento.3 Qualche anno piùtardi, grazie alla promulgazione della legge n. 44 del 10 dicembre 1985 della RegioneSiciliana, finalizzata alla promozione di Interventi per lo sviluppo delle attività musicali,fu prevista per la prima volta l’erogazione di regolari finanziamenti per il restauro deglistrumenti musicali in Sicilia, in particolare degli organi da chiesa. Proprio a seguito ditali disposizioni, nel 1987 fu dunque avviata la catalogazione degli organi antichi delladiocesi di Caltagirone poi completata, nel 1990, da uno studio sulla decorazione artisti-ca degli stessi organi.4 L’anno seguente, nel 1988, Giuseppe Dispensa Zaccaria diede allestampe la prima importante raccolta di documenti sull’organaria in Sicilia dal XIV alXX secolo5 seguita, nel 1991, da una pubblicazione di Vincenzo Regina sull’organarianella provincia di Trapani.6 A partire proprio dai primi anni 90, furono portate avantinuove campagne di catalogazione del patrimonio organario siciliano i cui risultati con-fluirono in pubblicazioni sugli antichi organi della città di Palermo7 e delle diocesi diMonreale,8 Acireale,9 Piazza Armerina,10 Noto,11 Ragusa12 e Cefalù.13
Sempre con il contributo della Regione Siciliana, tra il 17 e il 24 novembre 1996,fu organizzata in vari centri della Sicilia la rassegna concertistica Antichi organi e nuovimusici in Sicilia, che fu suggellata dalla pubblicazione di un volume con compact discallegato.14 Più o meno in quello stesso periodo, nel 1998, furono pubblicati altri duecontributi sull’organaria siciliana: il catalogo della mostra Per attratto e mastria.Organari siciliani fra XVI e XIX secolo, tenutasi a San Martino delle Scale (Palermo),15
e uno studio monografico dedicato agli antichi organi di Noto (Siracusa).16
Nel corso dell’ultimo decennio, alle pubblicazioni fin qui citate si sono aggiuntepiccole monografie sulla storia dell’organaria a Ciminna (Palermo),17 sulla famiglia diorganari palermitani Andronico18 e sullo Studio complementare per la scuola dell’orga-no di Alfio Laudani,
19contributi sulle biografie dei principali organari attivi in Sicilia
nei secoli XVI-XIX,20 in particolare su Raffaele e Antonino La Valle,21 sull’organaroAntonino Ragonese,22 sul restauro e la conservazione degli organi storici in Sicilia23 esugli organi siciliani a più consolle.24
9
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 9
Il presente volume rappresenta la prima monografia organica sull’attività e sullaproduzione strumentale di Donato Del Piano, il più famoso organaro del Settecentosiciliano la cui opera influenzò in maniera decisiva tutta l’organaria regionale coeva edella prima metà del XIX secolo. I saggi che lo compongono indagano aspetti ineditidella biografia e dell’attività professionale di questo artefice (ricostruita, con approfon-dimenti inerenti anche la sua attività extra-organaria, nell’articolo di Maria Grillo), esa-minano gli aspetti tecnico-costruttivi dei suoi strumenti in rapporto alla produzionestrumentale europea, italiana (nei testi di Luigi Ferdinando Tagliavini e di GiovanniPaolo Di Stefano) e siciliana (nei contributi di Luciano Buono, di Francesco Oliveri edi Giusy Larinà). Particolare attenzione è stata rivolta all’opus magnum di Del Piano,l’organo dei benedettini di Catania, e agli interventi di restauro che ne hanno recente-mente consentito il ripristino funzionale (argomenti affrontati nei saggi di GianlucaLibertucci, di Enrico Mascioni e Maurizio Isabella, di Piera Vigo). La ricerca documentaria ha così permesso di delineare la complessa biografia di
Del Piano sin dai primi anni d’attività in Sicilia, condotta fino al 1733 insieme al fra-tello Giuseppe e successivamente continuata da solo dopo il definitivo trasferimentoa Catania e l’ordinazione sacerdotale. Proprio alle fonti documentarie, che hanno per-messo la contestualizzazione dell’attività di Del Piano e della storia dell’organo deibenedettini di Catania, è dunque dedicata l’ultima sezione del libro (con le ricerchedi Luciano Buono, di Giovanni Paolo Di Stefano, di Dario Miozzi e di PietroValguarnera). Chiude il testo, quasi ad appendice, il catalogo sintetico di tutti gli organi di Del
Piano finora noti in Sicilia e a Malta che è stato curato da Luciano Buono e GiusyLarinà.
Il libro ha beneficiato dell’aiuto di molte persone che ne hanno a vario titolo con-sentito la realizzazione. Tra questi desideriamo in particolare esprimere la nostra gra-titudine ad Antonio Bovelacci, Roberto Carnevale, Ugo Casiglia, Sergio Cilea, AngeloGallotta, Antonino e Marina Leonardi, Luigi Lombardo, Renato Meucci, FrancescoNocerino, Francesco Oliveri, Roberto Pagano, Roberto Santonocito, LilianaScribano, Orazio Trovato. Un ringraziamento speciale va inoltre al direttore AldoSparti e a tutto il personale dell’Archivio di Stato di Catania per l’assistenza prestata-ci nel corso del lungo periodo di ricerca, ai sacerdoti e ai responsabili delle chiese checonservano gli strumenti di Del Piano per averne consentito e agevolato lo studio.Dedichiamo questa pubblicazione alla memoria di Oscar Mischiati, insigne stu-
dioso che tanto si prodigò per promuovere il restauro del monumentale organo diSan Nicolò l’Arena e che incoraggiò con entusiasmo le campagne di studio sull’anti-ca organaria siciliana.
Luciano BuonoGiovanni Paolo Di Stefano
10
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 10
11
1. Cfr. DAMIANO DI PASQUALE, L’organoin Sicilia dal sec. XIII al sec. XX. Suntostorico sulla musica e gli organi e la susse-guente riforma, Palermo, TipografiaTrinacria, 1929.
2. Cfr. OSCAR MISCHIATI - LUIGIFERDINANDO TAGLIAVINI, La situazionedegli antichi organi in Italia. Problemi dicensimento e di tutela, «L’Organo», VII,1969, pp. 53-54.
3. Cfr. GIUSEPPE GIARRIZZO - VITOLIBRANDO - FLAVIO DASSENNO, L’organodel Monastero dei P.P. Benedettini diCatania, Catania, Le Due Colonne, 1981.
4. Cfr. LUCIANO BUONO - GIANFRANCONICOLETTI (a cura di), Arte organaria inSicilia. Censimento degli antichi organinella diocesi di Caltagirone, Caltagirone,Centro di Studi Musicali per ilMeridione, 1987; GIUSY LARINÀ,Contributo per una tipologia dei prospettidecorativi degli organi settecenteschi inSicilia, in Il canto dell’aquila, a cura di L.Buono, Caltagirone, Centro di StudiMusicali per il Meridione, 1990.
5. GIUSEPPE DISPENSA ZACCARIA, Organie organari in Sicilia dal ’400 al’900,Palermo, Accademia Nazionale diScienze, Lettere e Arti, 1988.
6. Cfr. VINCENZO REGINA, Brevi note sugliorgani antichi e storici della provincia diTrapani, Trapani, Cartograf, 1991.
7. Cfr. VITO GAIEZZA, Organi storici diPalermo, in Guida musicale della Sicilia.1989- 1991, Palermo, Centro di IniziativeMusicali Siciliane, 1995, pp. 297-341.
8. Cfr. GIOVANNI BATTISTA VAGLICA, Gliorgani antichi nel territorio monrealese,Palermo, Edizioni Augustinus, 1991.
9. Cfr. Per una catalogazione di antichiorgani siciliani, a cura di G. Cassata conschede di L. Buono, G. Larinà e G.Nicoletti, Palermo, Centro Regionale perl’Inventario, la Catalogazione e laDocumentazione del beni culturali eambientali, 1991.
10. Cfr. LUCIANO BUONO - GIANFRANCONICOLETTI - GIUSY LARINÀ, Organi storicidella diocesi di Piazza Armerina, in Guidamusicale della Sicilia. 1992- 1994,Palermo, Centro di Iniziative MusicaliSiciliane, 1996, pp. 303-347.
11. Cfr. LUCIANO BUONO (a cura di),L’organaria nella Diocesi di Noto.Catalogazione degli organi costruiti tra ilXVIII e il XX secolo, Catania, SocietàMeridionale per gli Studi Musicali, 1998.
12. Cfr. SALVATORE APPIANO, Gli organidella Diocesi di Ragusa, Ragusa, CI. DI.BI. Insieme, 1993.
13. Cfr. DIEGO CANNIZZARO, Cinquecentoanni di arte organaria italiana. Gli organidella Diocesi di Cefalù, Bagheria, Aiello eProvenzano, 2005.
14. Cfr. Antichi organi e nuovi musici, acura del Centro per le Iniziative Musicaliin Sicilia, Palermo, Regione Siciliana,1998.
15. Cfr. FRANCESCO PARADISO - PLACIDOSALVATORE BEVINETTO (a cura di),«Per Attratto e Mastria». OrganariSiciliani fra XVI e XIX secolo, SanMartino delle Scale, AssociazioneCulturale e di Volontariato dei PadriBenedettini, 1998.
16. Cfr. FRANCESCO MAIORE, Gli organiantichi di Noto. Storia e liturgia tra i secoliXV e XX, Noto, Associazione TuristicaPro Noto, 1998.
17. Cfr. GIUSEPPE CUSMANO, Gli organidelle chiese di Ciminna. Storia, arte, mae-stranze e tecnica dal XVI al XIX secolo,Palermo, 2002.
18. Cfr. GIOVANNI BATTISTA VAGLICA,Alcune testimonianze documentarie sul-l’organaria siciliana tra il 1600 e il 1800,San Martino delle Scale, Abadir, 2004.
19. Cfr. GIOVANNI BATTISTA VAGLICA, Un“lavoretto” per il re degli strumenti. Lo“Studio complementare per la scuola del-l’organo” di Alfio Laudani, San Martinodelle Scale, Abadir, 2004.
20. Cfr. LUCIANO BUONO, vociAndronico, Del Piano Donato, La GrassaFrancesco, La Manna, La Valle, Romano,Grimaldi Carlo, Blundo, Platania(Patanè), Pergola Pasquale, Giunta, LoBianco Annibale, in Enciclopedia dellaSicilia, Parma, Ricci, 2006.
21. Cfr. LUCIANO BUONO, Documenti sul-l’organaria rinascimentale in Sicilia: la bot-tega dei La Valle, «Arte OrganariaItaliana», I, 2009, pp. 93-118.
22. Cfr. ROSA DI LIBERTO - MAURIZIOROTOLO (a cura di), Laudate eum in chor-dis et organo. Il restauro dell’organo dellachiesa di San Giovanni Battista inBisacquino, Palermo, ProvinciaRegionale, 2008.
23. Cfr. MAURO SEBASTIANELLI - ADRIANAALESCIO, Gli organi storici in Sicilia.Storia, Tecnica, Conservazione, Firenze,Edifir, 2010.
24. Cfr. DIEGO CANNIZZARO, Gli organimulticonsolles siciliani, «Arte OrganariaItaliana», II, 2010, pp. 291-327.
NOTE
organi impaginato:Layout 1 08/03/13 14:00 Pagina 11












![BIAGINI C., CAPONE P., DONATO V., FACCHINI N. (2015). IT Procedures for simulation of Historical Building Restoration Site [ENG]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633524556c27eedec6061176/biagini-c-capone-p-donato-v-facchini-n-2015-it-procedures-for-simulation.jpg)
![Notizie degli scavi e delle ricerche archeologiche nel Modenese (2012), Modena 2014 [a cura di Donato Labate]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319da6dbc8291e22e0f4d0d/notizie-degli-scavi-e-delle-ricerche-archeologiche-nel-modenese-2012-modena-2014.jpg)

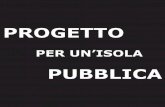
![I nostri rifiuti dalla preistoria all’età moderna, San Martino in Rio 2004, pp. 28-43 [Donato Labate].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f1ff73b43b66d3c0f9f37/i-nostri-rifiuti-dalla-preistoria-alleta-moderna-san-martino-in-rio-2004-pp.jpg)