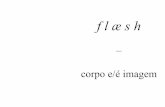Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli in "Il corpo e l'esperienza religiosa" -...
Transcript of Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli in "Il corpo e l'esperienza religiosa" -...
QUADERNI DEL CeSIFeR 7
CENTRO DI STUDI INTERDISCIPLINARI DEL FENOMENO RELIGIOSO
QUADERNI DI SYNAXIS 30
SYNAXIS XXXI/1 – 2013
IL CORPOE L’ESPERIENZA RELIGIOSA
a cura diGiuseppe Ruggieri
STUDIO TEOLOGICO S. PAOLO – CATANIA
EDIZIONI GRAFISER – TROINA2013
Il corpo e l’esperienza religiosa / a cura di Giuseppe Ruggieri. - Catania : Studio teologico S. Paolo ; Troina : Grafiser, 2014.(Quaderni di Synaxis ; 30)(Quaderni del CeSIFeR ; 7)ISBN 978-88-99070-00-71. Corpo umano – Concezione cristiana. I. Ruggieri, Giuseppe.233.5 CDD-22 SBN Pal0271819
CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”
SOMMARIO
A GUISA D’INTRODUZIONE: L’UTILITÀ DI QUESTO LIBRO
(Giuseppe Ruggieri) . . . . . . . . 13
IL CORPO DI GESÙ NEL VANGELO DI MARCO
(Giuseppe Ruggieri) . . . . . . . . 15Analisi del linguaggio sul corpo di Gesù usato dal più antico dei vangeli sinottici.Emergono: lo sguardo, il toccare, l’essere sdraiati a mensa con altri e la manifestazionedel proprio sdegno con voce alterata, l’urlo della morte, la commozione viscerale e ilcorpo come corpo donato
Seven are the aspects of the corporeity of Jesus that the Gospel according to Markpoints out: the looking, the touching, the dining, the getting indignant, the visceralemotion, the cry before the dead and the meaning of the body as a “given body”.
IL CORPO COME CONFINE: RITI DI INCLUSIONE E DI ESCLUSIONE
(CONCILI DI ANCYRA E NEOCESAREA, 314-319)
(Teresa Sardella) . . . . . . . . 27Riti e liturgia testimoniano che corpo e anima sono un nesso inscindibile e di questonesso il corpo è protagonista. Il saggio analizza battesimo e ordinazione, scomunica,penitenza e riammissione nei primi due concili di età postocostantiniana: Ancyra eNeocesarea. Se ne ricava che il corpo è utilizzato come strumento anche per capire edentrare nella coscienza. Particolarmente interessanti sono le procedure richieste perla penitenza. Una lettura interdisciplinare e il ricorso alla moderna semeiotica dellinguaggio non verbale consentono significative conclusioni sui diversi modi in cui ilcorpo può essere usato — da parte di qualunque potere — per piegare un individuo.
Rites and liturgies confirm that the body and the soul are undeniably bound togetherand that the body dominates. This essay analyses baptism and ordination, excommu-nication, penitence and readmission in the first two councils of the post-Constantineera; Ancyra (Ankara) and Neocesarea (Neocaesarea). It finds that the body is usedas an instrument also to understand and penetrate the conscience. The procedures laiddown as regards penitence are particularly interesting. An interdisciplinary readingand attention to the modern semiotics of non verbal language enable significantconclusions to be drawn on the various ways in which the body can be used- by anypower whatsoever- to bend and manipulate the individual person.
IL CORPO NELL’ULTIMO AGOSTINO: IL DE NUPTIIS ET CONCUPI-SCENTIA. IN DIALOGO CON PETER BROWN(Francesco Aleo) . . . . . . . . 57L’esperienza della relazione del sé con il proprio corpo è quella relazione che si ritienepossa offrire un particolare angolo visuale, per considerare il problema del corpo edella corporeità, nella tarda antichità e nel cristianesimo antico. Non dando per scon-tato il retaggio platonico e neoplatonico di Agostino d’Ippona nell’affrontare il corpo,il Peccato Originale e la condizione dell’uomo dopo la Caduta, specie nell’ultimoAgostino, in particolare nel De nuptiis et concupiscentia, si rintracciano nei testimonidel cristianesimo antico, quelle relazioni sociali fondamentali, nelle quali il corpo e lacorporeità sono calati e vissuti: la relazione padrone-schiavo e quella uomo-donna.Due studi fondamentali di Peter Brown, Agostino d’Ippona ed Il corpo e la società,recentemente riediti, ci aiutano a tentare d’instaurare un dialogo storico fra la conce-zione moderna del corpo e della corporeità e quella dell’ultimo Agostino chespalanca le porte del Medio Evo.
Myself’s and body’s consciousness is a relation and observation angle to contemplatethe body’s and corporeity’s problem, during late antiquity and ancient Christianity.The platonic and neoplatonic heritage in Augustine of Hippo is not expected, aboutbody’s problem, original sin and human condition, especially in the late Augustine andin De nuptiis et concupiscentia. In the witnesses of the ancient Christianity there aresocial relations with agreement of body and corporeity: relation between master andslave, man and woman. Two Peter Brown’s masterpieces, Augustine of Hippo and TheBody and Society, recently reprinted, can inaugurate an historical dialogue betweena modern body’s and corporeity’s idea and that late Augustine’s idea, opening theMiddle Ages.
CORPO E GESTO NELLA PARAFRASI DI NONNO DI PANOPOLI
(Arianna Rotondo) . . . . . . . . 93Il corpo di Gesù nella Parafrasi di Nonno è soggetto e contenuto stesso della suapredicazione: genera la sequela dei discepoli e curiosità degli increduli; si muove
consapevole verso la croce, attraverso i momenti cruciali dell’arresto e della passionedi cui è assoluto protagonista. I suoi gesti, che spesso avvengono nel silenzio o lo invo-cano come spazio d’ascolto, accompagnano la sua autorivelazione e sono piùeloquenti delle parole umane, suscitate da un animo volubile e incredulo. Dopo ilcorpo/cadavere trafitto ad una croce appare il Cristo risorto, che come pensiero chevola attraversa le porte chiuse della casa in cui i discepoli sono riuniti, nell’epifaniadella sua prima apparizione.
The body of Jesus in the Paraphrase is the subject and content of his preaching: gene-rates the following of disciples and the curiosity of the unbelievers. Jesus consciousgoes towards the cross, through the crucial moments of the arrest and the passion ofwhich his body is the absolute protagonist. His gestures, which often occur in silence,or require it as a listening space, accompany his self-revelation and are more eloquentthan human words, generated by a fickle mind. Finally, the body of the Risen Lord,as a thought, flies through the closed doors of the house where the disciples weregathered together, in the epiphany of his first appearance.
IL CORPO DI RADEGONDA TRA EROS E MARTIRIONELLA SCRITTURADI VENANZIO FORTUNATO(Rossana Barcellona) . . . . . . . 109Agli antichi scrittori cristiani si deve il primo sviluppo e l’ampia diffusione delle rifles-sioni sulla morale sessuale, con la definizione di precisi modelli di comportamentoaffidati principalmente alle scritture agiografiche di ispirazione monastica. In tali testiil corpo è soprattutto luogo del peccato, ma anche mezzo di redenzione. A questaletteratura appartiene la Vita di Radegonda, di Venanzio Fortunato (fine VI sec.),dove al sapiente uso delle tecniche retoriche si mescola un'intensità espressiva almenoin parte ascrivibile alla diretta memoria storica dell'autore, legato alla protagonista dauna lunga e intensa amicizia. Le terribili pratiche ascetiche cui la regina/monaca sisottopone non si risolvono — come avviene altrove — in una estatica beatitudine: leparole di Venanzio raccontano un corpo che cerca e rappresenta la voluttà delmartirio, mantenendo tutta la sua fisicità.
The initial development and diffusion of reflections on sexual morality can be attri-buted to ancient Christian writers; in fact, the definition of precise models of beha-viour are to be found mainly in hagiographic writings of monastic inspiration. In thesetexts the body is seen above all as the place of sin, but also as the mean to redemption.The “Life of Radegund” by Venantius Fortunatus (end of VI century) belongs to thisgenre of writing. Here the clever use of rhetorical devices together with an expressiveintensity can at least be partly attributed to the direct historical memory of the authorwho had a long and deep friendship with Radegund. The atrocious aesthetic practicesthe queen/nun subjects herself to do not result in estatic beatitude as found in other
works: Venantius, rather, gives an account of a body which searches for and representsthe intense sensual pleasure of martyrdom, while maintaining its physical nature.
CORPI E ANIME NELLE PREDICHE DEL VESCOVO ISIDORO CLARIO(1495-1555)(Roberto Osculati) . . . . . . . . 127Negli anni 1565-1567 Benedetto Guidi, monaco dell’abbazia di San Giorgio Maggiorea Venezia, pubblicò tre grandi raccolte di prediche di Isidoro Clario (1495-1555).Originario del bresciano, monaco anch’egli cassinese dell’abbazia di San GiovanniEvangelista di Parma, traduttore di tutta la Bibbia dall’ebraico e dal greco, abate aPontida e Cesena, egli aveva partecipato al primo periodo del Concilio di Trento.Vescovo di Foligno dal 1547, vi svolse un’intensa attività di istruzione, di riforme eccle-siastiche, di soccorso dei poveri. Le prediche, presentate in lingua latina, sono moltospesso una appassionata denuncia nei confronti di un cristianesimo di pura facciata,completamente privo di sostanza morale. Soprattutto l’indifferenza nei confronti diuna diffusa miseria è indice di una cristianità lontana dal dettato evangelico. BasilioMagno e Giovanni Crisostomo in particolare sembrano essere gli esempi di un mini-stero rinnovato dalle sue fondamenta oltre ogni disputa concettuale e giuridica.
Between the years 1565 to 1567, Benedict Guidi, a monk of the Abbey of St. Georgethe Greater in Venice, published three large collections of the sermons of IsidoroClario (1495-1555). Originally from Brescia, Isidoro was a monk from the abbey ofSt. John the Evangelist of Parma and, like Guidi, was also a Benedictine. He was atranslator of the entire Bible from Hebrew to Greek, abbot at Pontida and Cesena,and was a participant in the first period of the Council of Trent. He was bishop ofFoligno from 1547, and was deeply involved in religious teaching, church reform andrelief for the poor. His sermons, published in Latin, are often an impassioned denun-ciation of superficial Christianity devoid of any real moral substance, indifferent towidespread suffering, and far from the basic dictates of the Gospel. His work is remi-niscent of Basil the Great and John Chrysostom whose work reflected a fundamentalrenewal of ministry free from any intellectual or juridical haggling.
DISEGNI DELL’ANIMA E LINGUAGGIO DEL CORPO NELL’APOSTO-LATO GEORGIANO DI FRA’ CRISTOFORO CASTELLI (1632-1655)(Marilena Modica) . . . . . . . . 149Tema lungamente frequentato da storici e storici dell’arte, il rapporto fra immagini epredicazione assume particolare rilievo nel passaggio dalla rottura dell’universalismocristiano, ad opera della Riforma protestante, alla “normalizzazione“ tridentina.Questo luogo simbolico tanto persistente diviene il tema privilegiato dei “disegnidivoti” di fra’ Cristoforo Castelli, il quale ricerca una forma di comunicazione religiosala più efficace possibile, nella sua opera missionaria che si tradusse in una operativitàdell’immagine devota tanto più radicale in quanto investita da quella spiritualità
emotiva esplosa nel primo Seicento, nella quale si concentrava la dimensione visio-naria del corpo come luogo del suo annullamento nel divino: corpo parlato e inciso,rivelatore della passione di Cristo cui l’anima veniva asservita.
The relationship between images and preaching was a theme, object of historical andartistical studies, for a long time. It’s very important into crossing from breaking ofChristian universalism, made by Reformation, to the Tridentine normalization.Become too the frà Cristofo Castelli’s theme in his “disegni divoti”, for a religiouscommunication effective and missionary, typical of the sensitive spirituality of theXVII century. During this age the body is annihilated in the divine: the body spokenand cut revelate the Christ’s Passion.
IL CORPO SCONFINATO DI ANNA KATHARINA EMMERICK (TRA) -SCRITTO DA CLEMENS BRENTANO(Vincenza Scuderi) . . . . . . . . 191Il 24 ottobre 1818 Clemens Maria Brentano (1778-1842) si reca per la prima volta atrovare la stigmatizzata Anna Katharina Emmerick (1774-1824), mistica visionaria diumili origini che visse nel cattolico Münsterland. Nascerà così uno dei più singolariincontri della storia della letteratura, che si concluderà solo con la morte di lei.Brentano rimane affascinato dalle narrazioni di Emmerick, e dal suo essere “esposta”nel suo letto d’inferma, vero e proprio ostensorio di un corpo trasformatosi nel corpodi Cristo. È così che lo scrittore si dichiara “scrivano” della stigmatizzata, ne descrivelo stato e afferma di trascriverne le visioni, in un processo di scrittura che unisce lapersonale poetica del corpo di Brentano con la fisicità del corpo ferito di Emmerick,reso sconfinato dalle sue visioni, che consistono in gran parte nella testimonianzadiretta della vita di Cristo e di sua madre Maria. Quelle di Brentano non sono peròreali trascrizioni, in quanto lo scrittore da un lato elabora le visioni secondo proprischemi, dall’altro le suscita, sottoponendo Emmerick all’ascolto di vite di mistici estimolandone la capacità di riconoscimento delle reliquie (ierognosi).
On the 24th Oktober 1818 Clemens Maria Brentano (1778-1842) visited the stigma-tized Anna Katharina Emmerick (1774-1824) for the first time. She was a mystic, visio-nary and ecstatic ecstatic Roman Catholic Augustinian Canoness living in the regionof Münster. This became one of the most interesting meetings in the history ofGerman literature. Brentano was flabbergasted by the narration of her visions and bythe exposure of her wounded body, so similar to that of Christ. This is why the authorbecame her “scribe”. He wrote about her illness and her visions, so that his texts repre-sent a metaphoric bridge between the poetic of Brentano’s own body and that of thestigmatized woman. In her visions her body seems to become boundless. Brentano’snotes of their conversations filled many notebooks. Most of them are about the lifeof the Virgin Mary and of Christ. The interesting point is that these notes are not puretranscriptions but an authorial elaboration of her visions, often stimulated by his
telling her about the lives of other saints and by testing her ability in recognising somereligious relics.
DEL SENTIRE. IL CORPO IN DOSTOEVSKIJ E IN PIRANDELLO TRAPOETICA E RISCRITTURA(Antonio Sichera) . . . . . . . . 201La questione del corpo ha un rilievo speciale nell'opera di Dostoevskij e di Pirandello.E in entrambi la cifra ermeneutica del corpo è di tipo cristologico. Nel secondo capi-tolo di Delitto e castigo, all'icona del Christus amans, rappresentata da Sonja, siaffianca quella del padre, vero Ecce Homo del romanzo, che fa del ‘sentire’ corporeoil suo cuore pulsante, alla maniera di un Christus sentiens. Impressionato fortementedalla scena dostoevskijana, Pirandello la riprende più volte nei suoi scritti. Fra gli altri,in due luoghi decisivi: nell’Umorismo del 1920, a supporto del famoso esempio della‘vecchia signora’, e nella novella Sopra e sotto, puntuale riscrittura del modello russo.In entrambi i casi il corpo senziente, in senso cristologico, è al centro della poetica edella visione pirandelliana dell'uomo.
The matter of body has a special importance in Dostoevsky's and Pirandello’s work.And in both the hermeneutics of the body is christological. In the second chapter ofCrime and Punishment, the icon of Christus amans, represented by Sonja, comes alon-gside that of his father — ‘Ecce Homo’ of the novel — which makes the ‘body feeling’its heart, in the guise of a Christus sentiens. Strongly impressed by this scene,Pirandello takes it several times in his writings. Among others, two crucial points: OnHumor (1920), in support of the famous example of the ‘old lady’; the short storyAbove and Below, punctual rewrite of the Russian model. In both cases, the bodyfeeling, in a christological sense, is at the core of Pirandello's poetics and concept.
ALLEGORIE DELLA CONDIZIONE UMANA IN TESTORI. TESTEFRACASSATE, TESTE MOZZE, CRANI E “CRAPE”(Rosa Maria Monastra) . . . . . . . 219Nella produzione di Testori il ricorrente tratteggio di teste mozze, teste fracassate,teschi, costituisce un leitmotiv di grande interesse. Si tratta di un tema che ha una sualunga storia nelle arti figurative e di cui Testori si avvale per esprimere la propriaangoscia di fronte alla vita e alla morte. Se in un primo tempo egli ne ricava allegorievuote, disperate, in un secondo momento invece assistiamo a una transvalutazione cheha il suo fondamento nella caritas paolina.
In the Testori’s production the recurring hatch of severed heads, smashed heads, skulls,is a very important leitmotif. It’s a theme with a long history in the visual arts, andTestori uses it to express his anguish in the face of life and death. If in a first time from
here he draws many empty, hopeless allegories, later instead we find a transvaluationthat is based upon the caritas of St. Paul.
LA SIMBOLIZZAZIONE DEL CORPO NELLA TEOLOGIA SACRAMEN-TARIA DI L.-M. CHAUVET(Maurizio Aliotta) . . . . . . . . 253Nella sua teologia Chauvet sottolinea l’importanza del corpo e dell’ordine simbolico.Da una prospettiva fenomenologica, egli considera la natura dell’esperienza umana.Ora, vi sono due condizioni di possibilità per l’esperienza umana: il corpo fisico e l’or-dine simbolico. Sebbene Chauvet parli a lungo di corpo simbolico, come corpo ditradizione e di cultura che media l’esperienza umana, i corpi sono necessariamenteiscritti in una consapevolezza individuale del corpo. Con le parole di Chauvet, “l’Io èquello che è soltanto perché tessuto, abitato, parlato da questo triplice corpo dicultura, tradizione e natura. È quanto indica il concetto di corporalità: corpo proprio,certamente, ma in quanto luogo in cui si articola simbolicamente, in maniera originaleper ciascuno secondo vicende del suo desiderio, il triplice corpo — sociale, ancestralee cosmico — che lo costituisce come soggetto”. Lo stesso pensiero è espresso con ilconcetto di corpo come arci-simbolo. Qui il corpo è descritto come il luogo ove si arti-colano“il dentro e il fuori. l’io e l’altro, la natura e la cultura, il bisogno e la domanda,il desiderio e la parola” Questo significa che parlando del soggetto umano nella suainterezza, è necessario riconoscere che il soggetto è contemporaneamente biologicoe simbolico. Questo è il motivo per cui Chauvet parla di soggetto umano come “corpodi significato” o “corpo parlante”.
In his theology Chauvet puts a great deal of emphasis on the importance of body.From a phenomenological perspective Chauvet considers the nature of human expe-rience. There are two basic conditions of possibility for human experience: the physicalbody and the symbolic order. Although Chauvet speaks at length of symbolic bodies,such as the bodies of tradition and culture that mediate human experience, the bodiesare necessarily inscribed on an individual body-consciousness. In Chauvet’s words, theindividual body is the place in which “there is a symbolic articulation that is as uniquefor each individual as is the story of his or her desires, an ancestral body of tradition,a social body of culture and a cosmic body of nature”. The same points makes theconcept of body as “Arch-symbol”. Here the living body is described as the placewherein “the within and without, myself and others, nature and culture, need andrequest, desire and word are joined together”. This means that in order to speak ofhuman subject in its wholeness, it is necessary to recognize that the subject is at oncebiological and symbolic. This is why Chauvet speaks of the human subject as a “signi-fying body” or “speaking body”.
INDICE . . . . . . . . . 267
CORPO E GESTO NELLA PARAFRASIDI NONNO DI PANOPOLI
ARIANNA ROTONDO*
1. NONNO E LA SUA OPERA
La Parafrasi del vangelo di San Giovanni rappresenta un’operaoriginale e complessa, ancora in fase di studio e valutazione, nel pano-rama della poesia tardoantica d’argomento cristiano. Scritta intornoalla metà del V secolo dal poeta egiziano Nonno di Panopoli, si può aragione valutare come un’interpretazione del Quarto Vangelo realiz-zata applicando in modo originale la tecnica parafrastica ai singoliversetti. Per la veste formale della sua opera il poeta sceglie l’anticometro dell’epos, riformandolo e creando un modello normativocapace di renderlo riconoscibile e adatto a comunicare i contenutidella nuova fede: dotato di una notevole “percepibilità metrico-ritmica” tale metro doveva apparire funzionale alla destinazionedell’opera nonniana, probabilmente letta e recitata.
Barocca nelle scelte lessicali e dalla forte connotazione mimica, laParafrasi è soprattutto una raffinata opera esegetica. Il modus operandidi Nonno, sia come artigiano del verso sia come attento lettore delNuovo Testamento, rappresenta, infatti, un caso straordinario nellaproduzione poetica cristiana tardoantica di lingua greca, sebbene nonmanchino coeve sperimentazioni del genere parafrastico aventi come
* Ricercatore in Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso il Dipartimento diScienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania.
Vorlage un testo biblico. Il poeta egiziano dà un impulso straordinarioalla fortuna di questo genere, grazie ad un talento esegetico sostenutoda un’invidiabile competenza teologica. Nonostante questo la fortunadi quest’opera ha vissuto lunghi momenti di oblio e d’immeritata deni-grazione per la sua concettosa pomposità, avvertita come irriverente einadeguata. Rappresenta un'eccezione Cornelio a Lapide (1534-1583),barocco ed erudito commentatore di Giovanni, che sceglie Nonnocome uno dei suoi modelli esegetici, ponendolo nella rosa dei cinquecommentatori di lingua greca cui fa riferimento.
La scelta del genere, le soluzioni formali e metriche da una parte,la metodologia esegetica e l’originale interpretazione dei temigiovannei dall’altra, sono le questioni fondamentali che lo studiosodeve porsi, senza trascurarne alcuna, per potersi addentrare nelcomplesso mondo poetico della Parafrasi. In essa il rapporto tra formae contenuto è stretto, anzi dialettico, dal momento che la strumenta-zione retorica e la metrica sono sempre poste a servizio di un’erme-neutica efficace. Dallo studio delle fonti e dei modelli emerge unquadro complesso e assai articolato, in cui da una parte si registra l’in-fluenza della tradizione letteraria greca, classica ed ellenistica, da cuiil poeta attinge immagini, soluzioni formali e lessicali, dall’altra leletture patristiche che supportano la sua esegesi.
La Parafrasi restituisce una lettura del Quarto Vangelo molto accu-rata, quale risultato finale di una diuturna frequentazione delleScritture, il frutto maturo di una competenza ‘tecnica’ accompagnatada una spiritualità esigente e profonda. Nonno si presenta dunque nonsolo come un poeta tardoantico che, con le Dionisiache, ha lasciato l’ul-timo tentativo di un epos degno del confronto omerico, in margine aduna produzione letteraria ormai indirizzata verso altri generi, ma anchecome un esegeta molto accorto e raffinato, meritevole di uno spazio trai grandi commentatori giovannei della sua epoca. La sua costruzioneteologica tende a restituire l’impianto concettuale del modello, chiaritonei suoi passaggi più complessi ricorrendo anche all’immenso patri-monio sapienziale trasmesso dalle tradizioni filosofico-religioseantiche. L’immaginario neoplatonico e quello ermetico, ad esempio,sono chiamati in causa dal poeta per spiegare ad un pubblico verosi-milmente misto, pagano e cristiano, certamente colto e dunque in grado
Arianna Rotondo94
di riconoscerne gli echi, i contenuti dell’ortodossia cristiana, di quellapòstiv o\rqhé cui si fa cenno nella parafrasi del Prologo (A,19)1.
Anche il dionisismo, per il suo impianto soteriologico, è funzionalea quest’enciclopedico progetto ermeneutico e all’efficacia della suafruizione, come attestano i profondi legami fra le due opere nonniane.Così nei versi di Nonno la figura di Dioniso può presentare tratticristiani e viceversa la figura di Cristo accenti bacchici. Anche la mille-naria sapienza egiziana svolge un ruolo importante, rappresentandouna sorta di filtro simbolico attraverso cui sono fatte passare alcuneimmagini evangeliche; per cui tradizioni locali e immaginario cristianosembrano dialogare perfettamente, in una visione del mondo e dellarealtà che predilige la varietà e la contraddizione.
Nel progetto poetico di cui la Parafrasi è espressione convergonoi tratti peculiari dei luoghi di formazione intellettuale e spirituale diNonno: il milieu alessandrino, palestra dell’esercizio poetico e delconfronto religioso; il milieu panopolitano, il nomos di provenienza delnostro, unico dato sicuro della sua biografia, in cui l’eclettica speri-mentazione religiosa aveva offerto una declinazione davvero unica delrapporto fra paganesimo e cristianesimo. Nonno sembra riflettere nelcaleidoscopio delle sue opere l’inquietudine di una società in rapportodialettico con le sue stesse contraddizioni, trascinata da un inarresta-bile e faticoso cambiamento, in cui il cristianesimo doveva esercitareun potere molto forte, pur dovendo continuamente confrontarsi conla persistenza di antiche tradizioni, soprattutto negli ambienti intel-
Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli 95
1 Nonno evoca, parafrasando Gv 1,7 a proposito della testimonianza resa dalBattista alla Luce, quella «retta fede» su cui fonda il suo impianto teologico. Nel lungoinno al Logos il poeta si serve di espressioni tratte dal simbolo niceno-costantinopo-litano, mostrando la sua filiazione teologica nei confronti di Cirillo e i suoi rapporticon l’ambiente alessandrino. Spigolature lessicali, in particolare sulla semanticadell’imitazione, e un sondaggio dei tentativi da parte del poeta di evitare possibili“fraintendimenti ariani”, fanno del Giovanni di Nonno l’ortodosso vangelo/poemadella Pistis. Ho presentato le mie riflessioni sulla teologia nonniana in una comuni-cazione dal titolo: «La vera fede, eterna madre del cosmo»: ortodossia e influenze ciril-liane nella Parafrasi di Nonno di Panopoli, tenuta nell’ambito del XLI Incontro distudiosi dell’antichità cristiana su La teologia dal V all’VIII secolo fra sviluppo e crisi(Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 9-11 maggio 2013). Si attende lastampa degli atti.
lettuali alto egiziani, impegnati a puntellare o a tutelare una propriaidentità stabile e definita. Con la sua rilettura dell’evangelo giovanneoNonno ha inteso di certo affascinare il suo lettore/uditore, interessan-dolo così ai nuovi contenuti della fede cristiana. Mosso dal tentativodi guadagnare un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo sulpiano intellettuale e spirituale, pur affermando l’impotenza dei mezziumani di fronte all’ineffabile mistero divino, il poeta ha celebrato difatto l’infinito potenziale espressivo della parola, interpretandolacome ‘mito’, come arto dell’intelletto, essenziale per fare esperienzadel sacro e per testimoniarla.
2. CORPO E GESTO DI GESÙ
Il Logos si è fatto carne: proprio questa dimensione umana, troppoumana, emerge prepotente nei fatti dell’arresto e del processo. Il poeta“drammatizza” le azioni di Gesù in queste fasi cruciali della suapassione terrena, conferendo centralità al ruolo del suo corpo, cattu-rato, legato, fustigato e appeso ad una croce. Proverò a tirare il filorosso della “storia del corpo divino” secondo Nonno, un corpo carat-terizzato da un’a\paéqeia fisica e morale, più volte ribadita nel corsodella Parafrasi: i suoi occhi e le sue gote non conoscono lacrima, i suoipaéqh sono sempre controllati e voluti dalla sua natura divina. ComeDioniso nel poema maggiore, anche il Cristo nonniano conosce lacommozione solo in eccezionali situazioni di profondo coinvolgi-mento sul piano affettivo, come nel caso della morte di un amico caro,anche se lo stesso di lì a poco risorgerà per opera sua. Come Dionisoper Ampelo, così Cristo per Lazzaro vive il suo unico e controversoabbandono alle lacrime: «E pianse anche Gesù versando lacrimeinconsuete dagli occhi che non conoscevano il pianto» (L,123-124); difronte alla resurrezione dell’amico lo smarrimento di Gesù è attribuitoallo pneu%ma del Padre (L,121: pneuémati patr§é§ dedonhmeénov)2. Il Cristo
Arianna Rotondo96
2 Così anche a X,44, con significativa aggiunta rispetto al vangelo è rilevato dalparafraste che le opere del Figlio sono atti del Padre: suémfutoév ei\mi tokh%ov e\gwè laleéwn,o\ deè r|eézwn: sono connaturato a mio Padre, io parlando, lui agendo. Si ricordi l’imba-razzo di Cirillo che nel commentare Gv 11,35 giustifica Gesù che cede al pianto, debo-
della Parafrasi è pertanto a"tromov, imperturbato, a\diédaktov, ovverodotato di una scienza innata, di una profonda conoscenza dell’animoumano e delle azioni consequenziali alla volubilità dello stesso. Uncaso emblematico riguarda la cattura nel Getsemani, il luogo in cui eglisi dirige «con passo consapevole», dimostrando di non subire la mortema di sceglierla. Sta solo infatti, privandosi della compagnia dei suoidiscepoli, il re «disarmato e con morbide vesti» (a|brociétwn a\siéderov)3,quando il manipolo degli armati dai doppi mandanti (i farisei e iromani), guidati da Giuda, lo raggiungono nel Getsemani, luogoisolato che era solito frequentare. Vale la pena ricordare che il paral-lelo dionisiaco nel poema maggiore, in cui Nonno ambienta la catturadel dio pagano per ordine di Penteo, avviene anch’esso in un luogo soli-tario: gli armati si lanciano per immobilizzarlo, ma Dioniso scomparequasi volatilizzandosi e lasciando le guardie «soggiogate da una costri-zione divina» (Dionisiache 45,228-239), in silenzio4.
Il corpo di Gesù per Nonno diventa soggetto e contenuto stessodella sua predicazione, mentre il corpo di coloro che lo circondano lacartina di tornasole della loro adesione, dell’autenticità della lorosequela. Il corpo del Cristo nonniano manifesta la sua sovranità e la suasovrumanità rimanendo statico e fermo nella maggior parte dei casi, in
Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli 97
lezza della carne, manifestata di fronte ad un uomo fatto a sua immagine che eramorto, solo per frenare le lacrime dell’umanità.
3 Per una approfondita trattazione sull’uso di questa formula nelle Dionisiache esulle sue implicazioni cristiane vedi D. GIGLI PICCARDI, Dioniso e Gesù Cristo inNonno Dionys. 45,228-239, in Sileno 10 (1984) 249-256.
4 Secondo Gigli Piccardi il racconto nonniano della cattura di Dioniso, che accettavolontariamente di essere raggiunto, dipende per buona parte dalle Baccanti diEuripide (vv. 434 ss.). La resa del poeta egiziano tuttavia presenta spunti originali, dalpunto di vista narrativo e descrittivo, probabilmente attinti dal racconto giovanneodell’arresto di Gesù nel Getsemani: il luogo deserto in cui il dio è raggiunto e la reazionedei soldati. D’altra parte nell’esegesi parafrastica l’episodio evangelico risulta pervasoda un’atmosfera dionisiaca, sottolineata dalla metafora cosmica suggerita al poeta dallelanterne notturne dei soldati al seguito di Giuda: è tutto il cosmo, nell’immagine dellavolta stellata, che rende omaggio al suo creatore. Vi si è ravvisato un richiamo allelampadoforie diffuse nei riti egiziani connessi al culto di Iside e caratteristiche anche delculto dionisiaco (E. LIVREA, Nonno di Panopoli. Parafrasi del vangelo di S. Giovanni,Canto XVIII, Napoli 1989, 50-51; per le implicazioni veterostamentarie dell’immaginedelle lanterne si veda il commento di Livrea al v. 36 dello stesso canto).
un atteggiamento di distanza quasi ieratica dalle scomposte reazionidegli esseri umani. Indugio brevemente su qualche esempio, che mi pareopportuno, relativo alla rappresentazione del corpo umano messo aconfronto con quello di Cristo: Nonno ce lo presenta con due possibilie contrapposte reazioni, o rimane immobile o è in rapido movimento.L’immobilità è espressione dello stato di colpa o di malattia, il movi-mento invece coincide con una liberazione avvenuta come esito di unatto di conoscenza e di fede5: il figlio del funzionario regio, ad esempio,salvato a distanza dalla parola di Cristo, «cammina con il vento neipiedi» (D,235: podhénemov). Il corpo di Cristo ha nel movimento la cifrastessa della sua divinità: le mani e i piedi si prestano a sintetizzare l’at-tività e la forza creatrice di questo divino d’azione e in azione6.Chiunque stabilisce un contatto con lui ne è contagiato e il primo segnodi ciò è la rapidità, l’urgenza, la fretta di un agire entusiasta e portatoredi efficace testimonianza. L’autenticità della sequela è segnalata dalmovimento: Filippo, dopo aver ascoltato la testimonianza del Battista,si risolve a seguire Gesù con grande entusiasmo: «accolse il consiglio eprevenne le parole con i suoi passi» (A,174: ou"asi mu%qon e"dekto kaì
Arianna Rotondo98
5 Per Nonno si è parlato, a ragione, di un’epica della gestualità, dal momento chel’attenzione al movimento è un suo tratto distintivo (cfr. G.F. GIANOTTI, Forme diconsumo teatrale: mimo e spettacoli affini in O. PECERE –A. STRAMAGLIA (curr.), Laletteratura di consumo nel mondo greco-latino. Atti del convegno internazionale(Cassino, 14-17 settembre 1994), Cassino 1996, 265-92. Per l’idea di un «gestural style»nonniano si veda R. F. NEWBOLD, Nonverbal Expressiveness in Late Greek Epic:Quintus of Smyrna and Nonnus in F. POYATOS (cur.), Advances in NonverbalCommunication, Amsterdam-Philadelphia 1992, 271-283). Avvezzo alla retorica delparadosso, propria del linguaggio cristiano per la sua necessità di definire l’indefini-bile, egli sfrutta, oltre che come cifra stilistica, anche per l’andamento narrativo unastruttura binaria e ossimorica, che proprio nel binomio immobilità/movimentoconnesso a morte/salvezza trova una delle sue esemplificazioni più efficaci. Isegni/miracoli sono il terreno più fertile per l’esercizio di questo ingrediente fonda-mentale della poetica nonniana. Su tali questioni ritengo magistrali le pagine di Agostidedicate ad alcune strutture stilistiche della Parafrasi nella corposa introduzione allasua edizione del canto V: cfr. G. AGOSTI, Nonno di Panopoli. Parafrasi del Vangelo diSan Giovanni. Canto V, Firenze 2003, 121-125.
6 Sul movimento e l’azione continua del Cristo nonniano si vedano le riflessioni egli esempi in R. FRANCHI, Nonno di Panopoli. Parafrasi del Vangelo di San Giovanni.Canto VI, Brescia 2013, 186 ss.
i"cnesin e"fqase fwnhén). Si veda anche il suggestivo movimento cheanima la ‘bacchica’ scena delle nozze di Cana dopo il segno compiutoda Gesù: le coppe si susseguono da una mano all’altra, l’andirivieni deicoppieri unici testimoni del miracolo, le danze e il rianimarsi delbanchetto per il ritorno copioso del vino. Una grande teatralità è confe-rita ai movimenti, specialmente a quelli femminili, di reazione all’in-contro con Gesù: Maria a Betania ne è un esempio eloquente. Nonnoamplifica la sua rapidità gestuale nei confronti di Gesù7: la vediamoaddirittura slanciarsi «col suo rapido piede in preda al dolore e allagioia» (L,95-96). Quasi degna di una menade danzante, mi si concedal’ardito accostamento, è ancora la sua proscinesi: il maestro rimaneimmobile (L,107: a\tiénaktov) di fronte a lei, che «non appena lo vide,frustata nel cuore da un pungolo, cadde prona a terra, girando su sestessa, e si prostrò dinanzi ai suoi piedi immortali» (L,111).
Nell’esempio offerto dalla gestualità di Maria a Betania il poeta“racconta” il corpo di Cristo innanzitutto attraverso i suoi piedi: pou%v-i"cnov, piede/passo, è un binomio che Nonno usa per rappresentare ilvolere che orienta le scelte di tutti i personaggi del racconto evangelico,ma soprattutto di Gesù, impegnato a compiere la volontà del Padre.Allora il «rapido piede» di Cristo sfugge agli inseguitori (K,140)quando ancora non è giunta l’ora della sua cattura; egli affretta «ilpasso meridiano del suo piede immortale (D,13: podoèv a\mbrosiéoio)», perrivolgere la sua parola salvatrice ai samaritani, agli esclusi; di fronte allasofferenza delle amiche sorelle egli «teneva salda la pianta del piede»(L,108-110), immobile di fronte alla morte, in attesa di essere condottoal sepolcro di Lazzaro. L’orma del piede del Cristo nonniano «correavanti», (N,149) — dice Nonno — troppo avanti, per un ardimentosoquanto incoerente Pietro, che si dice disposto a seguirlo ovunque. Conpasso «consapevole» (e"mfroni tars§%) il maestro si dirige volontaria-mente nel giardino dell’arresto (S,1)8, consapevole nella sua prescienza
Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli 99
7 Sulla gestualità di Maria a Betania si veda D. ACCORINTI, Strutture narrative eretoriche nella Parafrasi di Nonno in La narrativa cristiana antica, codici narrativi,strutture formali e schemi retorici (XXIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana,Roma 5-7 maggio 1994), Roma 1995, 425.
8A proposito dell’attenzione riservata ai piedi dal poeta e sulla venerazione popo-
dell’imminente cattura. I piedi di Gesù sono nell’immaginario delpoeta il luogo dell’adorazione, l’icona attraverso cui il poeta lo presentanell’esposizione alla folla, introducendo così l’Ecce homo giovanneo:«con i piedi purissimi (a\craéntoiv poédessi) <Gesù> camminava fuori delpalazzo9, portava la corona intrecciata di spine aguzze, e la veste diporpora, intrisa del sangue della conchiglia» (T,21-23).
3. IL CORPO IN PREGHIERA
Nella Parafrasi un gesto di Cristo è da considerarsi la sua voce,veicolo della divina Parola, una sorta di arto al pari di qualsiasi altro.La voce è espressione del suo sentire, della direzione del suo pensieroe del suo volere: qualificata con un’aggettivazione spesso improbabilee ardita, valga per tutti la voce «suscitatrice di vino» nelle nozze diCana, oppure quella che «salva dal male», «perentoria», «portatrice ditestimonianza»10, essa è uno strumento esegetico, usato largamente dalpoeta soprattutto come introduzione alle battute dirette dei dialoghiintrattenuti da Gesù, per spiegare i discorsi più oscuri, per introdurrei personaggi più ambigui. È il caso della samaritana, il cui ritrattopsicologico è scandito proprio dalla qualità della sua fwnhé. Allasemplice domanda della donna sul luogo giusto in cui adorare, Nonnoparafrasa l’altrettanto lapidaria risposta di Gesù, introducendo il temadel corpo in preghiera: l’oscuro maestro spiega l’ad-orare rappresen-tando la gestualità rituale dell’orante ideale, immortalato nella suaproscinesi: «ma viene l’ora del sacrificio con riti intellettuali, anzi è
Arianna Rotondo100
lare delle orme lasciate dal piede di Cristo si veda E. LIVREA, Nonno di Panopoli,Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII, Napoli 1989, 107-108.
9 Si tratta del palazzo di Pilato, che lo aveva appena esposto alla folla inferocita;quella dimora pagana verso cui si dirigono dopo il giudizio nel sinedrio i sacerdoti eil loro seguito, intenzionati a mandare a morte Gesù: Nonno, con sarcasmo, neinchioda la fede ipocrita nel loro atteggiamento di ritrosia verso la dimora pagana;temevano di contaminarsi in vista della Pasqua, proprio loro che inferociti in unprogetto omicida si preoccupavano di rispettare «la santità della dimora delle Leggiprotettrici» (N,139).
10 Per una trattazione specifica sull’uso di fwnhé nella Parafrasi di Nonno mipermetto di rimandare al mio: La voce (fwnhé) divina nella Parafrasi di Nonno inAdamantius 14 (2008) 287-310.
proprio questa, quando i veri iniziati (muéstai)11 piegano insieme il collosupplice a terra, il collo piegato mentre il capo si china, tutti in veritàe spirito: perché Iddio altissimo vuole tali fedeli, i quali per luipieghino le ginocchia a terra, tenendole saldamente appaiate, con vocetestimone di verità e con spirito divino, mentre il volto in avantiaderisce al suolo» (D,110-118). Nonno si allontana dalla Vorlage inse-rendo, in luogo della generica menzione giovannea del culto, partico-lari legati ad una gestualità dell’orante: il collo curvato, il piegarsi inavanti, il ginocchio puntato sulla pietra. L’inginocchiarsi, da conside-rarsi in questo caso specifico come un esempio di nohthè gonuklisiéa12,ovvero una genuflessione contemplativa secondo la classificazioneorigeniana operata sulla scorta dell’esegesi paolina, è contemplato inaltri luoghi della Parafrasi in cui il poeta si rende indipendente dalmodello evangelico, rivelando il potere suggestivo esercitato nel suoimmaginario poetico dalla liturgia, costante supporto dell’esegesi13.Una sottile polemica antigiudaica percorre questi versi cruciali, in cuial sacrificio cruento (è il punto di vista della samaritana), inutileofferta degna di una «cuore barcollante» (kradòhv sfalerh%v) comequello dei Giudei, è opposta una più partecipata preghiera (è il puntodi vista di Gesù). Adorare alla maniera dei Giudei è consequenziale aduna mancata conoscenza del divino: si adora una copia falsa passataper vera (D,105-106: geraiérete mou%non a\kou+% mimhlhèn teleéontev a\lhqeéovei\koéna muéqou, «adorate soltanto per sentito dire colui che nell’animanon conoscete, realizzando un’immagine imitativa della verità»).Adorare in spirito e verità è il traguardo che l’autentico fedele deveraggiungere: egli sarà gradito a Dio se inginocchiandosi avrà lo
Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli 101
11 Gli iniziati sono i veri cristiani pervasi dallo spirito; questo termine, risemantiz-zato in senso cristiano, ricorre qui per la prima e ultima volta nella Parafrasi.
12 Sulla gonukliésia in questo passo si vedano le considerazioni di M. CAPRARA,Nonno di Panopoli. Parafrasi del Vangelo di San Giovanni. Canto IV, Pisa 2005, 23-28.
13 Le riflessioni più interessanti sull’importanza del piano esegetico-liturgico nellaParafrasi, a mio parere, si leggono in G. AGOSTI, Nonno di Panopoli. Parafrasi delVangelo di San Giovanni. Canto V, 54-70, che ricostruisce l’interpretazione liturgica inchiave battesimale del segno del paralitico nella piscina probatica, trovandoneriscontri sia nelle rappresentazioni artistiche (quelle ad esempio del battistero di DuraEuropos e dell’arcosolio della catacomba di S. Ermete a Roma del IV secolo) sia nellaletteratura patristica.
«spirito pieno del divino» (D,117: pneuémati qespesié§), «la voce testi-mone di verità» (D,117: kaì a\lhqeéi maérturi fwn+%), e il viso rivolto alsuolo (D,118: kaiè dapeéd§ prhnhdoèn e\reidomeénoio proswépou).
Il capo di Cristo è piegato nei terribili momenti della flagellazione:«intrecciati alcuni arbusti spinosi, taglienti, gli cinsero il capo conquella spuria corona regale e lo vestirono mettendogli addosso unmantello stillante del savio bagliore del mare Sidonio, simbolo di rega-lità pure nei patimenti; poi piegando le ginocchia unite e con il caporivolto a terra [lo salutavano “Re” con questo falso appellativo] nunziodi suppliche, e andavano uno dopo l’altro con mani alterne a colpirglile guance» (T,8-15). Lo sguardo è a terra, in un silenzio irritante eassordante come un urlo, durante l’interrogatorio di Pilato; l’immaginerimandata dai versi di Nonno è potente: «abbassato lo sguardo ilSignore tenne gli occhi fissi a terra e aprendo la bocca non emisealcuna voce in risposta a quanto aveva udito» (T,42-44). La boccaaperta che non emana suono è immagine di grande potenza espressivaal pari delle mani di Cristo, protagoniste di gesti parlanti. Mi appareevocativa, a fronte di questo silenzio eloquente al cospetto di Pilato,la descrizione contenuta nelle Dionisiache (5,104-107) della danza diPolinnia durante le nozze di Cadmo e Armonia: le sue dita sono“icona” di una «voce priva di suono», esprimono forme sapienti in unsilenzio denso di significati14. Dalla bocca del Cristo nonnianopromana un silenzio eloquente, il silenzio di quella Verità il cui signi-ficato allo stesso procuratore romano rimarrà sconosciuto.
4. UN CORPO/CADAVERE «TRAFITTO» AD UNA CROCE
«[…] Con un unico chiodo che simultaneamente trafigge» Gesù ècome saldato alla croce. Con dovizia di particolari Nonno descrive lacrocifissione, in una vera e propria “simbolica” del chiodo (tre chiodicontro i quattro tradizionali per una crocifissione) da leggersi, secondoun’interpretazione probabilmente alessandrina e d’ascendenzaneoplatonica, come «un simbolo dell’unione ipostatica delle due
Arianna Rotondo102
14 M. CAPRARA, Parafrasi del Vangelo di San Giovanni. Canto VI, 30
nature di Cristo, secondo il magistero cirilliano»15: «colà i carnefici lodistesero sul legno dalle quattro estremità sollevandolo da terra inalto, ben dritto, serrandogli a forza di qua e di là con ferreo vincolo lemani aperte, Lui però trafitto da un unico chiodo dal duplice animoinsieme conficcandosi, Lui d’un solo slancio trapassato, i piedi intrec-ciati insieme, nella ferrea morsa del supplizio» (T,91-97).
Il corpo di Cristo è cadavere, rigido di morte, come i ginocchi diLazzaro che ancora avvolto nelle fasce ritorna dall’Ade alla luce, fuoridal sepolcro, nel racconto minuzioso dell’amplificatio nonniana allaresurrezione di Betania. È come scollato dalla croce nella drammaticasequenza della deposizione che ha come protagonista Giuseppe diArimatea, il cui gesto d’amore ha nel suo stesso corpo a sostegno delcadavere di Gesù la più commovente espressione: «quell’uomo, disera, trasse giù il cadavere, rigido (foérton), e sollevato di peso lodepose sulla spalla che accoglie Dio (qeodeégmoni... w"m§)» (19,203). Ilcorpo di Cristo morto (qanoéntov... sw%ma) beneficia anche delle cure diNicodemo, accorso per ungerlo con mirra e aloe; e Nonno ne descriveil rito funebre dettagliatamente: «con teli di lino cinsero il corpo delmorto con un involucro profumato di volute molto intrecciate, comeusano fare gli ebrei che osservano i riti funebri» (T,210-212).
5. IL CORPO DEL RISORTO: DA «CADAVERE SEMPRE VIVO» A«PENSIERO CHE VOLA»
Nonno definisce il corpo di Cristo, deposto nel sepolcro, un nekroéna\eizwéonta, «un cadavere sempre vivo», destinato a non rimanere in unatomba di pietra; ma non è proprio questa la convinzione dellaMaddalena, col suo inconsolabile pianto. Quand’ella, l’«amica dellelacrime» e «notturna viaggiatrice» si rende conto di avere di fronte asé Cristo risorto, manifesta l’istinto di toccarne il corpo, ma è subitotrattenuta: «e mentre si accingeva ad accostare la mano all’immortalemanto (e\v a"mbroton ei/ma) Dio la trattenne» (U,72-73). Nonno parafrasail Noli me tangere giovanneo conferendo centralità al gesto della
Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli 103
15 cfr. E. LIVREA, Nonno di Panopoli. Parafrasi del Vangelo di San Giovanni. CantoII, Bologna 2000, 69 nota 58.
donna, proprio perché bloccato da Cristo, che in questo modo rivela lasua natura e fornisce alla Maddalena il giusto contenuto di un’auten-tica testimonianza animata dall’urgenza: «E Maria corse veloce a testi-moniare con la sua voce a tutti gli undici discepoli, riuniti dentro casa,che il Cristo aveva veduto, spoglie le membra della veste terrena,risplendere in un mantello divino, e tutto questo le aveva detto, irra-diando innanzi una luce folgorante» (U,79-83). Se la mano dellaMaddalena non riesce a toccare il corpo di Dio, il suo piede neannuncia l’eterna vittoria sulla morte. Nonno usa ancora l’immaginedella veste, l’involucro che indica dapprima il corpo umano soggetto adistruzione (metacqoniéou...citw%nov) e poi la nuova immagine di Cristo,splendente e trasfigurato nella sua epifania divina (qeokmhét§ tinièpeépl§). La Maddalena quasi «vola» (pepoéthto) per proclamare quantoha visto e udito ai discepoli riuniti in casa. La promessa della resurre-zione si è compiuta, come sembra provare la luce folgorante (a\ntwépionai"glhn) irradiata dal risorto, segno della sua trasfigurazione divina. Inquesto modo, secondo Accorinti, Nonno rievoca l’a"nodov yuch%v diprocliana memoria (Procl. Theol. 209) e la dottrina del veicolo (o"chma)che durante la risalita in compagnia dell’anima, abbandona le tuniche(citw%nev) che aveva assunto in precedenza nel corso della sua discesa16.
Ancora una volta il corpo del Risorto rivela la sua natura divina inun passaggio molto controverso, al momento della sua prima appari-zione ai discepoli riuniti: «E quando l’oscurità intinse di nero cupotutta l’ombrosa terra e fissi i catenacci chiudevano le porte delladimora dove rintanati stavano i discepoli, ecco come ala o pensiero (w|vpteroén h\eé noéhma) fu in mezzo a loro, sospeso in aria (metaérsiov) e coro-nato dai compagni disse: “la pace sia con voi”» (U,84-88). Cristo arrivadall’alto, in aria, come nelle tradizionali epifanie divine di epicamemoria; il passaggio attraverso le porte chiuse, enfatizzato daGiovanni, sembra attenuato dal poeta che lo rappresenta come ala opensiero. Ancora l’immagine del dio che interviene superando l’osta-colo delle porte chiuse riporta all’Hermes alato dell’Inno omerico(IV,145-7), che compare passando attraverso il chiavistello (diaè
Arianna Rotondo104
16 D. ACCORINTI, Nonno di Panopoli. Parafrasi del Vangelo di San Giovanni. CantoXX, Pisa 1996, 191.
klhéi=qron). Tutto avviene, sia per Cristo sia per Hermes, all’insegnadell’incorporeità: nella similitudine omerica Hermes è ei"dwlon, l’im-magine di un sogno che varca il chiavistello, ma anche nel testononniano Cristo risorto si presenta nell’esordio parafrastico dellaterza apparizione come ei&dov a"mbroton, ovvero dall’aspetto, dallaforma immortale. Anche Origene si era posto il problema dellanatura del corpo del risorto in questo delicato passaggio giovanneo:egli sembra credere che la continuità del corpo di Gesù prima o dopola resurrezione venga garantita non dalla sua materialità ma da unasorta di «forma somatica» (ei&dov swmatikoén) in grado di opporre resi-stenza al tocco di Tommaso, ma anche di passare attraverso le portechiuse17. Nel parafrasare la scena in cui il Cristo mostra ai discepoliriuniti il suo corpo («quando agli occhi di tutti, traversando l’aria,Gesù apparve, sovrano sospinto dal vento, viatore senza traccia»), alcontrario dell’evangelista, Nonno ne menziona prima i piedi e poi lemani18 col segno dei chiodi e infine il fianco trafitto. Nella secondaapparizione a vantaggio dell’incredulo Tommaso, misteriosamenteassente nella scena precedente, narrata in Gv 20,26 si presenta ancorail topos delle porte chiuse superate dal divino, che Nonno ancora unavolta trascura: «senza che lo vedessero, Cristo balzato dentro la casacon piede di vento (a\nemwédei= tars§%) senza ali (a"pterov) si mostrò inmezzo ai compagni simili a Dio» (U, 118- 120). Si noti che a"pterov èepiteto di Hermes, che vediamo entrare in Dionisiache 3,409 ss. nelpalazzo di Cadmo, superando ogni ostacolo. Basta questo ad ipotizzareuna synkrisis fra il messaggero alato e Cristo annunciatore dell’evan-gelo? Di certo la vicinanza tra Cristo ed Hermes sembra potersicogliere in maniera tangibile attraverso gli epiteti comuni ad entrambi,tratti dalle Dionisiache per Hermes e dalla Parafrasi per Cristo.Accorinti ne stila un breve elenco a carattere esemplificativo, in cui sipossono apprezzare termini del tipo di biossoéov, qeéskelov, o\mfhéeiv,poikiloémuqov, tacuégounov, a\lexòkakov19.
Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli 105
17 G. MOST, Il dito nella piaga. Le storie di Tommaso l’Incredulo, Torino 2009, 124.18 Per il Tommaso nonniano le mani trafitte sono la prova più autentica dell’iden-
tità di Cristo: per il poeta sono evidentemente il segno tangibile dell’epifania divina.19 D. ACCORINTI, Hermes e Cristo in Nonno in Prometheus 21 (1995) 24-32.
6. I GESTI
Non sfuggano a conclusione di questa disamina, e non certo perchémarginali, tre gesti che vedono come protagoniste le mani di Gesù, incui esegesi, liturgia e iconografia appaiono come maglie strette di unostesso tessuto. Nonno introduce l’autorivelazione di Cristo di frontealla samaritana con quest’immagine: «E Cristo rispose con voce testi-moniante accostando alla muta narice (a\naudeéi r|iniè) il dito loquace(daéktulon au\toboéhton): “Cristo sono io che ti parlo, vicino con gli occhimi vedi, con le orecchie sempre mi senti: io sono Cristo non ne vieneun secondo”» (D,129-130). Al gesto dell’imposizione del silenzio oltread un forte realismo espressivo si può riconoscere, a mio parere, unvalore esegetico. Tradizionalmente riconosciuto come signum harpo-craticum è gesto ben noto alla cultura greco-romana, al quale dà un’ef-ficace interpretazione Plutarco, nel De Iside et Osiride: Harpocrate,l’Horus infante egiziano, è il dio del silenzio iniziatico, colui che mettein guardia gli uomini contro il pericolo di rivelare ai più la vera naturadegli dei. Egli tiene un dito sulla bocca come simbolo di discrezione esilenzio20. Dal punto di vista dell’iniziato il gesto del dio è un monitoa non rivelare ciò che si è visto e si è vissuto durante il rito. Il Cristononniano compie questo gesto per accompagnare la sua autorivela-zione nei confronti della samaritana: il silenzio è lo spazio necessarioa ricevere tale rivelazione, il luogo naturale dell’epifania divina; ildivino stesso lo crea, lo determina. Tuttavia la donna non è chiamataalla discrezione, al segreto, ma alla testimonianza, che nella parafrasinonniana è sempre accompagnata da un movimento, in questo casodalla rapidità della corsa.
Ancora Gesù presso il pozzo di Sicar, una volta raggiunto dai suoi,rifiuta il cibo offertogli con un gesto della mano: «mossa la mano mutain un silenzio consapevole e testimone Lui rifiutò quell’effimero cibodicendo queste parole» (D,149-151). La mano ancora una volta è
Arianna Rotondo106
20 Per un approfondimento sul signum harpocraticum e più in generale sull’ico-nografia del signum silentii nell’arte cristiana fino alle interpretazioni moderne sivedano A. CHASTEL, Il gesto nell’arte, Roma-Bari 2002, 69-95; P. MATTHEY, «Chut!» Lesigne d’Harpocrate et l’invitation au silence in Dans le laboratoire de l’historien des reli-gions. Mélanges offerts à Philippe Borgeaud, Genève 2011, 541-572.
espressione di un gesto allocutorio, che ha a che fare col tema dellamissionarietà: le suggestioni iconografiche sono infinite, dalla liturgicapostura della mano sollevata per la benedictio, al gesto della manodestra sollevata e aperta del Cristo pantocratore, punto d’arrivo di untema iconografico di derivazione orientale, caro alla ritrattistica impe-riale con riferimento al culto del Sol invictus21.
E ancora a voler ricordare la predilezione nonniana per le mani diCristo, il gesto della moltiplicazione dei pani, presentato in chiaveeucaristica: «E Cristo, dopo aver preso i cinque pani d’orzo e resograzie al Padre sempre vivente, li spezzò (e"klase) con un movimentodella dita ricurve della mano (sumplekeéov palaémhv gamywénuci palm§%)»(Z,36-40). Appare subito evidente l’attenzione descrittiva al movi-mento delle mani, che quasi si uniscono nel prendere il pane con l’in-tento di dare un valore sacramentale allo spezzarlo, anticipando inquesto segno mirabolante della moltiplicazione dei pani e dei pesci ilgesto eucaristico che l’evangelista non contempla nel suo raccontodell’Ultima cena, costituito dalla sola lavanda dei piedi22. La descri-zione delle «dita ricurve»23, artefici della fractio, conferisce una conno-tazione pantomimica a questo momento, in cui s’istituisce una ritualitàfondamentale. Attraverso la scelta lessicale Nonno costruisce in versiun’icona della mano parlante di Cristo, mostrandosi tributario dellatradizione letteraria, liturgica24 e iconografica sulla mano divina,«segno visibile di quella duénamiv a\oératov che rende possibile ciò cheagli uomini è precluso»25.
Corpo e gesto nella Parafrasi di Nonno di Panopoli 107
21 M. CAPRARA, Parafrasi del Vangelo di San Giovanni, Canto VI, 33.22 C. GRECO, Nonno di Panopoli. Parafrasi del Vangelo di San Giovanni, Canto
XIII, Alessandria 2004, 97-98: anche nella diakonìa spiegata attraverso la lavanda deipiedi la gestualità delle mani è messa al centro della scena.
23 Per la suggestiva scelta di gamyw%nux (letteralmente «dai lunghi o ricurvi artigli»)per rappresentare le dita ricurve di Cristo si veda il commento di Franchi: «le mani diCristo, nel piegarsi per spezzare il pane, evocano al poeta la posizione degli artiglidegli uccelli quando si curvano per afferrare la preda» (Parafrasi del Vangelo di SanGiovanni, Canto VI, Bologna 2013, 332).
24 R. FRANCHI, Parafrasi del Vangelo di San Giovanni, Canto VI, 183 fa riferimentoalla liturgia antica egiziana, in particolare all’Anafora del Santo Evangelista Matteo.
25 R. FRANCHI, Parafrasi del Vangelo di San Giovanni, Canto VI, 183.
E sull’onda degli eloquenti gesti simbolici del Cristo nonniano mipiace concludere con i versi finali di un epigramma dell’AnthologiaPalatina: de pantomimo, il 111, che mi sembra offrire la sintesi piùgiusta ed efficace al percorso fin qui tracciato:
«tot linguae quot membra viro. Mirabilis ars est quae facit articulos ore silente loqui».
Arianna Rotondo108
INDICE
SOMMARIO . . . . . . .
A GUISA D’INTRODUZIONE: L’UTILITÀ DI QUESTO LIBRO(Giuseppe Ruggieri) . . . . . . . .
IL CORPO DI GESÙ NEL VANGELO DI MARCO(Giuseppe Ruggieri) . . . . . . . .
1. Lo sguardo di Gesù . . . . . . .2. Il toccare . . . . . . . .3. La compagnia e lo sdegno . . . . . .4. La commozione delle viscere . . . . . .5. L’urlo della morte . . . . . . .6. Il corpo donato . . . . . . .Conclusione . . . . . . . .
IL CORPO COME CONFINE: RITI DI INCLUSIONE E DI ESCLU-SIONE (CONCILI DI ANCYRA E NEOCESAREA, 314-319)(Teresa Sardella) . . . . . . . .
1. Corpo e rito . . . . . . . .2. Riti di inclusione: a) battesimo; b) ordinazione . . .3. Colpa, esclusione, penitenza, riammissione . . . .
IL CORPO NELL’ULTIMO AGOSTINO: IL DE NUPTIIS ET CONCU-PISCENTIA. IN DIALOGO CON PETER BROWN(Francesco Aleo) . . . . . . . .
5
13
1517192223252526
27273240
57
Premessa . . . . . . . . .Introduzione . . . . . . . . .
1. Il De nuptiis et concupiscentia . . . . .2. In dialogo con Peter Brown . . . . . .3. Corpi di uomini, di donne e di schiavi . . . .4. Il Corpus paolinum . . . . . . .5. Testimonianze del Cristianesimo pre-niceno . . . .6. Agostino d’Ippona: coniugium e concubinatus . . .7. L’ultimo Agostino di Peter Brown . . . . .Conclusioni . . . . . . . .
CORPO E GESTO NELLA PARAFRASI DI NONNO DI PANOPOLI(Arianna Rotondo) . . . . . . . .
1. Nonno e la sua opera . . . . . . .2. Corpo e gesto di Gesù . . . . . . .3. Il corpo in preghiera . . . . . . .4. Un corpo/cadavere «trafitto» ad una croce . . . .5. Il corpo del risorto: da «cadavere sempre vivo» a «pensiero che vola»6. I gesti . . . . . . . . .
IL CORPO DI RADEGONDA TRA EROS E MARTIRIO NELLASCRITTURA DI VENANZIO FORTUNATO(Rossana Barcellona) . . . . . . .
1. Il corpo nel cristianesimo . . . . . .2. Il corpo di Radegonda . . . . . . .
CORPI E ANIME NELLE PREDICHE DEL VESCOVO ISIDOROCLARIO (1495-1555)(Roberto Osculati) . . . . . . . .
1.O praesepe adorandum et admirandum . . . .2.Circumcidendum est praeputium cordis . . . .3.Perinde pallescere . . . . . . .4.Tanta et tam absurda inaequalitas . . . . .5.Natura, lex, evangelium. . . . . .6.Magnus Basilius . . . . . . .
Indice268
57596167697274858790
939396100102103106
109110112
127130135138139143145
DISEGNI DELL’ANIMA E LINGUAGGIO DEL CORPO NELL’A-POSTOLATO GEORGIANO DI FRA’ CRISTOFORO CASTELLI(1632-1655)(Marilena Modica) . . . . . . . .
IL CORPO SCONFINATO DI ANNA KATHARINA EMMERICK(TRA)SCRITTO DA CLEMENS BRENTANO(Vincenza Scuderi) . . . . . . . .
DEL SENTIRE. IL CORPO IN DOSTOEVSKIJ E IN PIRANDELLOTRA POETICA E RISCRITTURA(Antonio Sichera) . . . . . . . .
1. Marmelàdov e il linguaggio del sentimento . . . .2. Attraverso Dostoevskij: corpo e sentimento in Sopra e sotto.3. Marmelàdov ‘umorista’ . . . . . .
ALLEGORIE DELLA CONDIZIONE UMANA IN TESTORI. TESTEFRACASSATE, TESTE MOZZE, CRANI E “CRAPE”(Rosa Maria Monastra) . . . . . . .
1. Testori, homo religiosus . . . . . .2. Visioni capitali . . . . . . .3. Il capro espiatorio . . . . . . .4. Decollazioni . . . . . . . .5. Il cranio, la croce e la gloria . . . . . .6. L’«ossea bellezza» degli angeli sterminatori . . . .7. Allegorie, emblemi . . . . . . .
LA SIMBOLIZZAZIONE DEL CORPO NELLA TEOLOGIASACRAMENTARIA DI L.-M. CHAUVET(Maurizio Aliotta) . . . . . . . .
1. Nota biografica e premesse culturali . . . . .2. L’onda lunga della corporeità riscoperta . . . .3. La mediazione necessaria . . . . . .4. Simbolo e sacramenti . . . . . . .5. Il simbolo e il corpo . . . . . . .6. A mo’ di conclusione: la simbolizzazione del corpo . . .
Indice 269
149
191
201201208212
219219221223226239244246
253253256257262264266