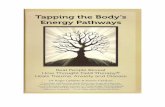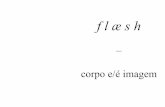"La concezione del corpo in Francesco d'Assisi" ; 2014
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of "La concezione del corpo in Francesco d'Assisi" ; 2014
1
La concezione del corpo in Francesco d’Assisi
Premessa
In questo breve scritto analizzeremo la concezione del corpo in Francesco d’Assisi
(1181-1226) e gli sviluppi del suo pensiero a riguardo, nelle prime biografie
dell’assisiate.
La nostra indagine prenderà in esame esclusivamente gli scritti considerati
autentici di F. e le biografie del santo più vicine nel tempo e più importanti nel
senso della loro diffusione, ovvero la Vita prima Sancti Francisci (1Cel); la Vita
Secunda Sancti Francisci (2Cel); la Legenda major (LegM) e la Legenda minor
(Legm) di Bonaventura da Bagnoregio1.
Utilizzeremo l’edizione del Leonardi per la traduzione italiana e per il commento
delle opere di F., prendendo in esame all’interno di un corpus di una trentina di
testi in latino, uno dei tre testi in volgare, ovvero Il cantico di Frate Sole2.
A livello bibliografico terremo presente il lavoro di quanti si sono concentrati
specificatamente sulla concezione del corpo in Francesco pur consapevoli del
fatto che, nella sconfinata produzione intorno al pensiero dell’assisiate, le
riflessioni sulla corporeità sono numerose3.
Tale analisi, così condotta, individuerà la presenza di due tendenze divergenti ma
complementari tra loro: da un lato una concezione originale che considerando il
corpo umano all’interno della creazione ne esalta la bellezza come dono di Dio; da
un altro lato, il tema del contemptus mundi et corporis che ritroviamo negli scritti
di Francesco.
1 Fontes Franciscani, Introduzioni critiche, a cura di BRUFANI (S.), MENESTO’ (E.), CREMASCOLI (G.), PAOLI (E.),
PELLEGRINI (L)., Stanislao da Campagnola, ed. Poziuncola, Santa Maria degli Angeli, Assisi, 1997; Fonti Francescane,
nuova edizione, a cura di CAROLI (E.), Padova, Edizioni francescane, 2009.
2 LEONARDI (C.), La letteratura francescana, 2 voll., Milano, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, 2005. Fuori dalla
presente disamina la Lauda davanti al Crocefisso e la Lauda Audite, poverelle.
3 Tra gli autori che si sono occupati specificatamente di questo tema: Dajczman, Gniecki, Iammarrone e Zavalloni. Un
interessante tesi di dottorato di Zambon. Per i riferimenti vedi la Bibliografia.
2
In entrambi i casi F. eredita e rielabora, in un pensiero comunque origianle, due
differenti retaggi culturali che hanno attraversato nei secoli la riflessione filosofica
e quella teologica.
Il corpo creato
Il lemma corpo/corporeità è declinato in modi differenti nel pensiero di Francesco.
Prima di analizzarli è necessario tenere a mente però il fatto che i due termini
latini corrispondenti, corpus (corpo) e caro (carne), sono pressoché sinonimi.
Inoltre è utile considerare che questi stessi termini possono indicare, in senso lato,
il comportamento umano contrario all’insegnamento divino.
Dunque per esaminare la concezione della corporeità nel pensiero di F.,
cominceremo dalle opere latine per poi passare ad analizzare una delle sue opere
volgari, il Cantico di Frate Sole. Prima di giungere a delle riflessioni di carattere
generale analizzeremo brevemente l’opera dei suoi primi biografi ricercando in
essa tracce del pensiero intorno alla corporeità.
Per F. il corpo umano è innanzitutto un corpo creato, come il mondo, ex nihilo, da
Dio. Nelle sue opere latine Egli loda sempre gioiosamente, con trasporto
fideistico, il Creatore del mondo e dell’uomo invitando quest’ultimo a dimostrare
la propria gratitudine lodando Dio e la sua opera. Rivolgendosi a Dio, F. dice che
l’onnipotente, con la sua santa volontà - per porre l'accento sulla gratuità di
quest’atto generativo - ha creato omnia spirituali et corporalia e ci ha collocati, a
sua immagine e somiglianza, nel Paradiso.
Ora è importante soffermarsi sul brano in questione, il testo della Regula non
Bullata:
“ Omnipotens, santissime, altissime et summe Deus, Pater sancte et iuste, Domine rex
caeli et terrae, propter temetipsum gratias agimus tibi, quod per sanctam voluntatem tuam
et per unicum Filium tuum cum Spritu sancto creasti omnia spirituali et corporalia, et nos
ad imaginem et similitudinem factos in paradiso posuisti” 4.
4 LEONARDI (C.) (a cura di), La Letteratura Francescana, Volume I : Francesco e Chiara d’Assisi, Milano, Fondazione
Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2004; Regola non Bullata 23, 1-3, pp. 50-51: D’ora in poi abbreviato in Rnb.
3
In questo passo quella francescana si delinea come una antropologia gioiosa che
trova slancio nel reiterato ringraziamento rivolto a Dio, colui il quale ci ha creati,
anima e corpo, in un atto assolutamente unilaterale e gratuito di amore. Non è
possibile non sottolineare che siamo all’interno di una concezione dell’uomo in
cui il male radicale della natura umana è del tutto escluso, e che siamo al centro di
un discorso intorno all’umanità che esclude il male ontologico.
Dio ha creato dunque sia il corpo sia lo spirito, e ha volontariamente inviato suo
Figlio in terra per rinnovare il suo atto creatore. La venuta in terra del Cristo
rappresenta poi il perdono dei peccati degli uomini e la messa che celebra
l’Eucaristia rinnova questo perdono, continuativamente. Posto dunque che
l’uomo, e le creature tutte, siano figli di Dio, s’instaura necessariamente tra esse
un legame sostanziale che tornerà prepotentemente nel Cantico di Frate Sole dove
è la natura, il creato tutto, a coinvolgere, senza trascendere nel panteismo, l’uomo
nella lode rivolta a Dio.
Le parole utilizzate dall’assisiate nel lodare il Creatore sono certamente quelle del
simbolo niceno-costantinopolitano ma acquistano nuovo vigore nella sottesa
polemica che a queste soggiace, nei confronti della concezione dualistica dei
Catari5. Il simbolo niceno-costantinopolitano in F. acquista un nuovo slancio
fideistico. Riflettendo sulla creazione, l’assisiate prende le mosse dal commento
della Genesi ma la sua novità sta nell’aver collegato l’uomo e il Cristo con i due
termini di imago e similitudo. Vediamo meglio in che senso Egli si discosta dalla
tradizione precedente.
La teologia cattolica riferisce la creazione di Dio solo alla parte spirituale
dell’uomo e non alla sua corporeità. Per la tradizione teologica, l’anima e il corpo
sono dunque elementi di natura dissimile, sostanzialmente differenti, solo
giustapposti nell’essere umano. Francesco invece segue un percorso di riflessione
originale e anticipa la concezione tomistica dell’anima6.
Egli compie un passaggio speculativo importante, affermando che la creazione di
Dio è avvenuta attraverso il Figlio:
5 DUVERNOY (J.), La religione dei catari. Fede. Dottrine. Riti, Ed. Mediterranee, Padova, 2000.
6 Per i rapporti tra anima e corpo nella cultura medievale, vedi Atti del V Convegno della Società Italiana per lo Studio del
pensiero Medievale, Venezia 25-28 settembre 1995, a cura di Casagrande (C.) e Vecchio (S.), Sismel Edizioni del
Galluzzo, Firenze, 1999.
4
“… e ti ringraziamo perché tu ci hai creati per mezzo del tuo Figlio (…) hai fatto nascere
lui, vero Dio e vero uomo…”7.
Proprio il Figlio, in effetti, funge da modello per la creazione dell’uomo e questo è
un elemento fondamentale. Francesco dice rivolgendosi idealmente all’uomo:
“ ...creando e formando il tuo corpo a immagine del suo amato Figlio, e il tuo spirito a sua
somiglianza”8.
Qui l’imago concerne il corpo dell’uomo e la similitudo riguarda il suo spirito.
Siamo agli antipodi rispetto alla concezione di Lotario di Segni, papa Innocenzo
III, il quale nel De miseria humanae conditionis, nell’ottica del tema del
contemptus mundi et corporis il corpo umano è creato dal fango in una condizione
di completa indignitas9.
Nell’Epistola ad fideles, Francesco, compie una passaggio teoretico lungimirante,
coerente con la sua antropologia, associando la fragilità del Cristo – uomo, alla
fragilità della natura umana. Qui parla della venuta del Figlio di Dio ed
esplicitamente della sua natura umana, di Maria, sua madre, con termini
palesemente riferibili alla sua corporeità di donna:
“L’altissimo Padre, per mezzo del suo santo angelo Gabriele, ha annunciato al cielo
questo Verbo del Padre, così degno, così santo, così glorioso, presente nell’utero della
santa e gloriosa vergine Maria, e nel suo utero egli ricevette la vera carne della nostra
fragile umanità”10
.
Il lessico che si rifà al corpo utilizzando vera caro, uterus, humanitas, fragilitas, è
uno degli elementi che contribuiscono a creare questo felice stupore per la
maternità illibata di Maria che è parte della rivalutazione che della corporeità che
effettua F. nonostante il riapparire, episodico, della tesi del contemptus mundi et
corporis che citeremo in seguito.
7 LEONARDI (C.) (a cura di), La Letteratura Francescana, Volume I : Francesco e Chiara d’Assisi, Milano, Fondazione
Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2004, p.51.
8 Ibidem, Admonitiones, 5, pp. 86-87. D’ora in poi abbrevieremo in Adm.
9 D'ANTIGA (R.), a cura di, Lotario di Segni. Il disprezzo del mondo, Carocci, 1994.
10
LEONARDI (C.) (a cura di), La Letteratura Francescana, Volume I : Francesco e Chiara d’Assisi, Milano, Fondazione
Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2004; Epistola ad fideles, 2, pp. 168-69. D’ora in poi abbreviato in Epfid.
5
Il corpo bisognoso
Una concezione positiva della corporeità emerge anche dalle prescrizioni di F. nei
confronti del trattamento del corpo e delle sue concrete necessità.
Tutte le sue disposizioni sono ispirate a un misurato realismo, elemento
assolutamente originale che rende la sua proposta etica distante dagli eccessi degli
anacoreti e dalle privazioni di cui i Catari facevano mostra. Le norme che F.
raccomanda ai suoi seguaci sono praticabili da tutti, Egli non impone privazioni
inumane ma dei principi etici ispirati a una certa morigeratezza e a un sano
equilibrio. A proposito le sue parole sono semplici e chiare:
“Noi dobbiamo anche digiunare e astenerci dai vizi e dai peccati, dall’eccesso del
mangiare e bere ed essere ortodossi…”11
.
Nulla di più delle prescrizioni ecclesiastiche condivise dai suoi contemporanei.
Nella Rb (3-6), F. afferma che i frati devono digiunare secondo il calendario
cristiano e il venerdì, e afferma che è lecito mangiare ogni cibo che sia loro
servito, conformemente al Vangelo (Rnb 3,11-13, pp. 12-13). Perciò ’Assisiate
non considera immondi i prodotti di origine animale come i Catari. Nel Cantico
di Frate Sole (riferendosi a Genesi 1, 29-30) fa cenno a un’alimentazione che
escluda la sofferenza sottintendendo che l’entrata nel peccato ha reso gli animali e
l’uomo carnivori ma non si tratta di nulla di più di un riferimento.
Nella Regula Bullata e nella Regula non Bullata, F. arriva a dire, esplicitamente,
che i frati che non vogliano digiunare, oltre le date indicate e il venerdì, non
dovranno esservi costretti12
e ribadisce che in caso di necessità tutti i frati
potranno mangiare tutto ciò che sia loro offerto come Davide che mangiò del cibo
riservato ai soli sacerdoti (Rnb 9, 13).
Per quel che concerne l’abbigliamento e i beni posseduti, F. dice ai suoi frati di
non accettare beni pecuniari, né direttamente né tramite altri, ma prescrive che in
caso di necessità essi accettino cose offerte, come del resto fanno tutti i poveri
(Rnb 2, 5; Rnb, 2, 6-7, pp. 8-9).
11
Ibidem, Epfid 2, 32. 12
Ibidem, Rb, 3-6. D’ora in poi abbreviato in Rb.
6
Quanto al corpo in uno stato di malattia F. è molto chiaro in merito, perche
consente le cure necessarie alla guarigione. Egli arriva a dire che i frati possono
chiedere soldi in elemosina se si tratta di curare degli ammalati, in speciale modo,
i lebbrosi (Rnb 8, 7-10; Rnb 8, 7-10, pp. 20-21).
Se a essere malato è un frate gli altri possono provvedere alla sua guarigione
accudendolo, se si aggrava, possono chiamare un medico di fiducia (Rnb, 10, 1-2).
F. però non consente alcun accanimento terapeutico. Le sue parole a riguardo
sono altrettanto chiare e dirette:
“E se qualcuno si turberà o si adirerà contro Dio o contro gli altri frati, o se chiederà
forse, con insistenza le medicine, troppo preso dal desiderio di liberare dalla malattia una
carne che presto dovrà morire, una carne che è nemica dell’anima, tutto questo gli viene
dal Maligno, egli agisce come un uomo carnale e non pare appartenere ai nostri frati,
perché ama il corpo più dell’anima”13
.
Qui si percepiscono toni adirati nei confronti del corpo, definito una carne che
presto dovrà morire. Eppure simili toni servono solo ad ammonire gli uomini
esortandoli a non amare più il corpo dell’anima, perché la carne è nemica
dell’anima.
Questa tendenza alla svalutazione della corporeità appare per la prima volta nella
nostra analisi e vedremo, da qui in poi, come essa riemergerà talvolta. Comincia,
dunque a essere chiaro che da un lato è possibile rintracciare una valutazione
positiva della corporeità, per quel che concerne la creazione e i bisogni fisici.
Questa tendenza sarà maggioritaria. Dall’altro lato, come nell’ultimo estratto
citato, individuiamo un’eredità culturale che considera l’unico mezzo per
avvicinarsi a Dio il disprezzo del mondo e del corpo umano.
I toni del discorso dell’assisiate tornano a essere pacati allorquando sottolinea che
non solo il corpo va nutrito, vestito e curato in caso di malattia ma che anche
l’atteggiamento con cui presentiamo agli altri uomini il nostro corpo è importante.
Proprio per questo motivo anche la gestualità del corpo, la sua attitudine
involontaria, sono oggetto d’indicazioni da parte di F. Egli dice:
13 Ibidem, Rnb, 10, 1-4, pp. 24-27.
7
“E si guardino bene dal mostrarsi all’esterno tristi e ipocritamente scuri in volto, ma si
mostrino felici nel Signore e allegri e gentili quanto conviene”14
.
Quindi F. prescrive un nuovo modo di essere uomini e donne, non solo
spiritualmente ma anche fisicamente, nel loro essere al mondo e per il mondo.
Rivalutando di conseguenza anche la presenza del corpo.
I francescani, così come F. stesso li aveva pensati, sono uomini e donne attenti ai
bisogni del loro corpo, che accettano il dolore e comunicano gioia, lasciando
trasparire ciò che la loro anima è, ovvero un’anima sempre rivolta a Dio.
Il corpo peccatore e la morte corporale
Se in F. il corpo non ha in sé nulla di ontologicamente negativo, come abbiamo
visto nella sua riflessione sulla creazione e sui bisogni del corpo, affamato o
ammalato che sia, è innegabile che il peccato originale sia all’origine della caduta
del genere umano.
Rispetto al momento della Creazione e della permanenza in Paradiso, una caduta
c’è indubbiamente stata, ed essa è avvenuta proprio attraverso il corpo. Per questo
esso, seppure da un lato è considerato creazione amorosa di Dio, e in quanto tale è
celebrato nella sua perfezione, può essere anche considerato come veicolo della
pratica del peccato. Riconosciamo ancora un’ambivalente concezione del corpo.
Ci sono passaggi concettuali in cui F. considera la carne, e dunque per estensione
il corpo, la fonte unica del male (Adm 10, 1-3 pp. 90-91). Ci sono luoghi in cui
l’assisiate incita a odiare il corpo con i suoi vizi e i suoi peccati (Rnb 22, 5, pp.
42-43) oppure frasi dove la carne e il mondo, proprio come il Diavolo, sono
considerati i nemici dell’uomo (2 Epfid 68, pp. 190-191). In queste riflessioni F. si
allinea alla speculazione filosofia e teologica che l’ha preceduto.
La sua originalità è da ricercare altrove.
14
Ibidem, Rnb, 7, 16, pp. 18-19. Vedi DE BROUWER, L’iconographie franciscaine des origines, 1226-1282, Paris,
Desclée, 1997 e FRUGONI ( C.), Francesco e l’invenzione delle stimmate, Una storia per parole e immagini fino a
Bonaventura e Giotto, Torino, Einaudi, 1993.
8
Parlando del peccato originale, commentando i passi della Genesi, le sue
osservazioni sono davvero appassionanti. Se prima si riferisce in modo generico
alla culpa del genere umano (Adm, 2), in seguito analizza in maniera puntale dove
essa risieda e sviluppa un punto di vista originale sulla questione.
F. parla del peccato originale, la colpa dell’uomo, come un peccato di
disubbidienza. Il peccato originale è un peccato di sfrontatezza nei confronti del
comando divino che ammoniva a non mangiare il frutto dell’albero della
conoscenza del bene. Perché questo punto di vista è interessante?
Innanzitutto perché Egli deresponsabilizza l’uomo dicendo che è il diavolo a
indurre nel peccato d’orgoglio e poi parla di un “albero della conoscenza del bene
e del male” e di un frutto che solo dopo diviene la “mela della scienza del male”.
Ecco il passo in questione:
“Il Signore disse ad Adamo: Di tutti gli alberi tu puoi mangiare, ma dell’albero della
conoscenza del bene e del male non mangiare: Egli poteva mangiare dei frutti di ogni
albero del paradiso, e non peccò finché non andò contro l’obbedienza. Mangia infatti
dall’albero della conoscenza del bene chi si identifica con la propria volontà e si
inorgoglisce del bene che Dio compie in lui con la parola e l’azione; così, per la
suggestione demoniaca e per la disobbedienza a quel comando, nacque la mela della
scienza del male. E’ dunque necessario che l’uomo ne porti la punizione” 15
.
Allora l’uomo non è per natura tendente alla disubbidienza ma è il Diavolo a
indurlo. Ne consegue l’assenza del male morale e l’inconsistenza ontologica del
male come un destino prestabilito dell’umanità.
Non possiamo non porre l'accento su altri due elementi importanti presenti in
questo passo. In primo luogo, come sopra accennavamo, l’albero di cui parla non
è quello “del bene e del male”, come tutta l’esegesi biblica cita, ma il frutto, che
proviene dall’albero della conoscenza del bene, diventa la mela del male quando
l’uomo se ne appropria andando contro il monito divino. Quindi è la cattiva
volontà a generare le condizioni del peccato, il libero arbitrio esiste.
15
Ibidem, Adm, 2, 1-5, pp. 82-83.
9
In secondo luogo è importante sottolineare l’assenza della figura di Eva, neanche
presente come correa. Felice omissione che è un segnale della totale assenza di
toni misogini nell’opera dell’assisiate16
.
Il testo riportato, dunque, accomunando Adamo e tutti i suoi successori nel
peccato della disubbidienza e dell’orgoglio, comportamenti contrari alla volontà
di Dio, parla di un identificarsi nella propria volontà che allontana l’uomo da Dio
e condanna il genere umano tutto. Tornano qui toni piuttosto cupi.
L’assisiate riflette sul fatto che gli uomini, non paghi di inorgoglirsi e sfidare il
comandamento divino, commettono continuamente deicidio (Adm 5, 2-3)
crocifiggendo il Figlio ogni volta che cedono al vizio. E’ come se peccando,
confermassero l’atto oltraggioso della Crocifissione.
Sebbene questi passi rappresentino uno dei momenti più pessimisti della
produzione dell’assisiate, intravediamo comunque uno spiraglio di speranza.
La salvezza rimane difatti accessibile all’uomo a patto che egli riesca a condurre
una vita priva di vizi, su questa terra. E dato che il proposito di condurre una vita
mondata da ogni peccato, passa attraverso il corpo, in quanto mezzo della sua
continua purificazione nell’ascesi, ne deriva una sua ulteriore rivalutazione.
Ancora una volta il corpo torna al centro del discorso di Francesco: anche se da un
lato esso è veicolo del peccato, al contempo è strumento di salvezza. Pur
maledicendo il corpo peccatore, Egli ripete che il male viene dal cuore, in altre
parole dalla volontà. Questo passo è esplicito e importante, qui Egli dice che:
“Dobbiamo odiare il nostro corpo con i suoi vizi e i suoi peccati, perché il Signore, dice
nel Vangelo: Tutti i mali, i vizi, i peccati, escono dal cuore” 17
.
F. recupera qui la contrapposizione istituita da Paolo di Tarso tra la carne e lo
spirito (Adm 10; RnB 17, 9-16) inteso come un io peccatore in quanto
completamente incentrato su di sé e per questo, dimentico di Dio. Eppure c’è
dell’altro. Infatti, quando F. dice che tutti i peccati vengono dal cuore significa
16
Per riflettere sul peccato di disubbidienza interpretato come peccato sessuale vedi LE GOFF (J.), Il corpo nel medioevo,
Laterza, Bari, 2005.
17 Epfid, 2, 37, pp. 179-181.
10
che essi vengono dall’interiorità umana. Ne consegue che non è il corpo in sé a
essere la fonte del male.
Anche rivolgendosi ai suoi frati, già dimentichi del mondo, F. ricorda loro che
tutti i vizi scaturiscono dal ribaltamento diabolico che si opera quando si vive solo
con il corpo senza lo spirito, li invita quindi semplicemente a non “vivere secondo
la carne” (Rnb, 22, 5-8). Pensiamo che, quando F. invita a odiare il corpo, utilizzi
un’iperbole, perché non incita a detestare il corpo in quanto tale. Questo perché se
il male proviene dal cuore dell’uomo è piuttosto un cambiamento spirituale che si
rende necessario e non solo la pratica ascetica, che comunque resta importante.
Anche qui, in filigrana, possiamo intravedere una concezione che considera un
tutt’uno corpo e anima, sia nel bene - quando l’uomo vive nell’amore di Dio - che
nel male – quando vive agendo secondo una volontà corrotta (Epfid 2, 11-12, pp.
190-91).
Certo non mancano i toni crudi riferendosi al corpo e ai suoi vizi: F. paragona,
infatti, l’uomo peccatore a un verme (Epfid, 2, 45). Eppure quando afferma che il
corpo è un nemico interno dell’uomo, giacché veicolo del peccato (Adm, 10, 1-4,
pp. 90-91), è solo per incitare alla continenza.
Solamente in una riflessione abbiamo reperito un discorso radicale sulle colpe del
corpo, all’interno del quale scompare la concezione di anima e corpo come un
tutt’uno. Ovvero quando F. afferma che l’uomo, per sperare nella propria
salvezza, deve sottomettersi completamente a Dio e a tutte le creature18
.
Altrove F. torna a parlare dell’uomo come peccatore volontario,
deresponsabilizzando il corpo, quando ammonisce i fedeli che non praticano
penitenza (Epfid, 63-66, pp. 188-91).
In conclusione, dopo questa serie di citazioni, è ancora più evidente la presenza di
due tendenze nella riflessione dell’assisiate.
Da un lato l’uomo è decaduto a causa della sua volontà peccaminosa perpetrata
nel vivere secondo la carne. Eppure in questi esempi corpus e caro, corpo e carne,
termini sinonimi, sono accostati spesso al termine cor, cuore. Dunque il corpo non
pecca se non grazie alla volontà dell’anima.
18 LEONARDI (C.) (a cura di), La Letteratura Francescana, Volume I : Francesco e Chiara d’Assisi, Milano, Fondazione
Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2004; Salvir Salutatio virtutum, 13-18, pp. 106-7. D’ora in poi abbrevieremo
in Salvir.
11
Da un altro lato il corpo è di per sé tendente al peccato, e quindi le parole di F.
esprimono nei suoi confronti un evidente disprezzo.
L’uomo creato a immagine e somiglianza del Figlio di Dio ha perso il suo posto
eminente nel creato, costretto a lasciare il Paradiso e a vivere nel mondo perché ha
disubbidito al comando divino, ma resta la possibilità della Salvezza. Vedremo in
seguito in quale maniera F. svilupperà questa concezione.
Prima di procedere è necessario accennare al concetto della caducità umana in F.
I toni del discorso tornano a essere negativi quando descrive la sua concezione
della morte corporale.
Qui F. ci fa capire che l’uomo è composto di due sostanze disomogenee, ma non
sostanzialmente dissimili, che alla morte saranno separate. Sia se l’uomo muore
nel peccato mortale sia se accade il contrario. Efficace un exemplum,
probabilmente mutuato da altri predicatori, in cui parlando di un uomo che non si
pente in punto di morte che la sua anima viene rapita dal suo corpo ad opera del
diavolo “con un’angoscia e una tribolazione così grandi che nessuno può
conoscerla se non la prova “ (2 Epfid, 2, 82, pp. 194-95) riprendendo una
immagine presente in Lotario di Segni19
. Secondo F. quando l’anima dell’uomo
morto senza pentirsi è rapita, il corpo è mangiato dai vermi e solo l’anima partirà
per l’Inferno (2 Epfid, 85, pp. 196-197). Se nessuno può sfuggire alla morte
corporale solo le anime morte nel peccato, subiranno però la cosiddetta morte
secunda, cioè la condanna nel giudizio finale.
Quindi nella analisi che della morte F. ci presenta, anima e corpo sono due
elementi alquanto eterogenei, concezioni in contrasto con le riflessioni precedenti.
Incarnazione ed Eucarestia
Come abbiamo visto, un primo momento di rivalutazione della corporeità nel
pensiero di F. è rappresentato dalla riflessione intorno all’uomo in quanto creato
ad immagine e somiglianza del Figlio. In seguito egli è stato collocato nel
Paradiso sebbene da esso, peccando, sarà allontanato. Infine F. riconosce al corpo
alcune necessità considerandole rispettabili (nutrizione, vestizione, cura in caso di
malattia).
19
D'ANTIGA, (R.), a cura di, Lotario di Segni. Il disprezzo del mondo, Carocci, 1994, cit. pp. 146-147.
12
L’ultimo, ma non meno importante, momento di rivalutazione della corporeità è
quello della riflessione intorno all’Incarnazione. Collegato a esso, il momento
liturgico dell’Eucaristia, come riproposizione nel tempo cristianizzato di
quell’evento unico che è la venuta di Cristo.
L’assisiate parla dell’Incarnazione come secondo atto di totale amore, unilaterale
e disinteressato, di Dio, nei confronti dell’uomo, dopo la Creazione. Egli dice a
proposito:
“ ...così per mezzo del tuo santo amore con il quale ci hai amato, hai fatto nascere lui,
vero Dio e vero uomo, dalla gloriosa sempre vergine santissima Maria”20
.
Se il corpo dell’uomo, infatti, è creato a immagine e somiglianza del corpo di
Cristo, unico Figlio di Dio, anche quando Egli viene sulla terra, assume forma
umana. Come già osservato, in una citazione precedente, si dice che “nel suo utero
(di Maria) egli ricevette la vera carne della nostra fragile umanità” (2 Epfid, 4, pp.
168-9).
Quindi il Figlio di Dio, corpo divino, preesistente nella mente di Dio, dove il
mondo è tutto già in potenza, si è fatto corpo umano, assumendo su di sé la natura
umana e la sua congenita fragilità. Quindi il corpo umano è il mezzo attraverso
cui il Figlio di Dio deve necessariamente manifestarsi nel mondo. Il corpo è
strumento per esperire Dio.
Essenziale quindi riproposizione dell’Incarnazione è l’Eucarestia, che F. chiama
sempre il corpo e il sangue di Cristo. Un passo chiarisce magnificamente la
centralità in quanto rituale e continuo abbassamento del Figlio di Dio in funzione
salvifica del genere umano:
“Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dal suo trono regale venne nell’utero della
Vergine; ogni giorno proprio lui viene da noi e ci appare nella sua umiltà; ogni giorno
scende dal seno del Padre sopra l’altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi Apostoli
si è mostrato in vera carne, così anche ora egli si mostra a noi nel pane consacrato. E
come essi con i loro occhi di carne vedevano soltanto la sua carne, ma credevano
contemplando con gli occhi dello spirito che egli era lo stesso Iddio, così anche noi
20
Rnb, 23, 5, pp. 50-51.
13
vedendo con gli occhi del corpo il pane e il vino, vediamo e finalmente crediamo che il
suo santissimo corpo e il suo santissimo sangue siano vivi e veri!” 21
.
Il corpo è fondamentale nell’Eucaristia, atto che quotidianamente ripropone la
esperienza inedita della presenza del Figlio nella storia. E proprio con i loro corpi
gli apostoli videro e toccarono Cristo, e quindi il corpo fu essenziale per fare
esperienza di Dio, alla presenza del Figlio.
E solo attraverso il totale abbandono delle tendenze egoistiche che ci attraversano
(chenosi) e accettando tutte le sofferenze del corpo passiamo sperare nella
redenzione che noi dobbiamo realizzare nel nostro percorso di vita.
Dunque, ancora una volta, il corpo è veicolo di peccato ma anche viacolo di
salvezza (Rnb 16,10 e 2 Epfid, 40) .
Il cantico di Frate Sole
Senza addentrarci nella cospicua letteratura intorno a questa opera, partiamo dal
presupposto della sua autenticità per analizzare in esso i dati concernenti la
concezione del corpo partendo dal testo stesso:
Altissimu, onnipotente, bon Signore,
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual’è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
21
Adm, 1, 16-21, pp. 82-83.
14
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dài sustentamento.
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ’l sosterrano in pace,
ka da te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no ’l farrà male.
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
La critica si è attardata sul valore da attribuire al “per” - dibattendo sul suo valore
causale, strumentale o agente - in quanto da queste differenti interpretazioni
dipende l’identificazione di colui il quale loda e il grado di partecipazione delle
creature alla lode stessa22
.
22
La fonte biblica di questo testo è il Cantico di Daniele ( Dan. 3. 51-90) dove le creature lodano Dio: ciò pone in secondo
piano l’interpretazione del “per” con significato causale. Anche il raffronto con la testimonianza di Tommaso da Celano
che parla di un Cantico scritto da F. per invitare tutte le creature a lodare Dio contribuisce a pensare che il “per” causale
non sia la interpretazione più corretta (2 Cel, 217, p.504). Anche se il “per” causale spiega meglio gli attributi alle creature
elemento che rende il Cantico di Frate Sole diverso del Cantico di Daniele. Il “per” agente potrebbe farci tendere per
un’interpretazione di un F. che invita le creature a lodare Dio (2Epfid, 61, pp. 188-89) avvalorato dal passo di Celano. Se il
“per” ha valore strumentale, sono le creature strumento stesso della lode che Dio fa alla sua opera creatr ice.
15
Di là dalle differenti interpretazioni quelle che a noi interessa è certamente la
gioiosa celebrazione del creato e dell’uomo inserito in esso, la straordinaria
comunione tra uomini, paesaggi e animali.
Per tramite di questa lode F. assume la sua condizione di creatura tra le creature,
accetta di essere corpo e spirito e il fatto di essere peccatore (II, V, 4 del Cantico).
Ci sono alcune precisazioni da fare sugli uomini di cui parla F. nel Cantico.
In primis solamente l’uomo che perdona in nome di Dio, e che sopporta le
infermità del corpo ottiene il Paradiso, quindi ne consegue che non tutta l’umanità
è salva automaticamente. La morte, chiamata sora e nostra è esorcizzata e apre la
porta alla salvezza o alla dannazione dell’anima, tornando a una concezione
dell’uomo come insieme di anima e corpo coerente con la maggior parte delle
affermazioni di F. (Cfr. Rnb, 21, 8, pp. 42-43). Prevale comunque nel Cantico
l’autentico messaggio cristiano della Genesi, dove il creato e l’uomo sono
concepiti come ontologicamente buoni.
La concezione antropologica di F., sebbene offuscata da alcuni passi che abbiamo
citati, è fondamentalmente positiva perché il percorso dell’uomo è dal Paradiso al
mondo, ma in nuce esiste la possibilità di ritornare al Paradiso, giacché l’umanità
è creata a immagine e somiglianza del Figlio.
L’uomo sebbene porti in sé il marchio del peccato di disobbedienza, vivendo
un’imitatio Christi può accedere alla Redenzione. Questo percorso è quello di un
uomo che è un insieme di anima e corpo e anche se la prima è gerarchicamente
superiore, il secondo, come può essere strumento di peccato sarà, secondo una
volontà buona, viacolo di salvezza.
Tommaso da Celano e Bonaventura da Bagnoregio.
Nel 1228 due anni dopo la morte di F., Gregorio IX e le autorità dell’Ordine
Francescano, ordine istituito da papa Onorio III con la bolla Solet annuere il 29
novembre 1223, incaricarono Tommaso da Celano di scrivere la Vita Prima
Sancti Francisci, terminata nel 1230. Di Tommaso saranno prese in esame la Vita
Prima e la Vita Secunda. In seguito alcune osservazioni avranno per oggetto
16
l’opera di Bonaventura da Bagnoregio, la Legenda Maior e la Legenda Minor
scritte nei primi anni sessanta del XIII secolo23
.
Non è questa la sede per tracciare la storia dei due testi e le ragioni storiche della
preminenza dell’opera di Bonaventura a scapito dell’opera di Tommaso.
Utilizzeremo i due autori per riflettere sulla rielaborazione della concezione della
corporeità nel pensiero dell’assisiate. In questa sede, infatti, ci interessa
rintracciare le tracce della concezione della corporeità nei due autori che per
primi, diversamente, rielaborano il messaggio francescano.
Prima di procedere è necessario premettere che entrambi, Tommaso e
Bonaventura, come F., utilizzano i termini corpus e caro in quanto sinonimi.
Vedremo che sia Celano sia Bonaventura restituiscono un’immagine più ascetica
di F., il secondo biografo poi aggiunge una sfumatura misogina inedita nel ritratto
dell’assisiate. Passiamo all’analisi vera e propria dei testi.
In Tommaso da Celano nella Vita Prima il corpo è strumento del peccato di una
volontà cattiva, egli spiega questo parlando dell’educazione dei figli che trovano
dei modelli negativi nei loro genitori e come loro peccano imitandoli (1Cel, pp.
34-35). Poi riportando le parole di F. dice che lui suggeriva di tenere sotto
controllo il corpo (1Cel., 12, 29 pp. 74-75) e che esso va mortificato in quanto è la
sede della lotta tra l’uomo e il Diavolo. Questo è ben chiaro nel racconto delle
lotte fisiche con il Maligno che lasciano il corpo di F. in uno stato di prostrazione
indicibile (2Cel, LXXXIV, 119, p. 552 ). Tommaso dice parlando dell’assisiate
che Egli:
“ …si confeziona da allora una tunica in forma di croce, per allontanare con essa tutti i
pensieri diabolici; la fa ruvidissima, per crocefiggervi la carne con i vizi e i peccati…” 24
.
Tommaso ci parla di un F. che con i suoi compagni si spinge oltre nelle pratiche
ascetiche di mortificazione della carne: ferendosi con rovi per sanguinare,
immergendosi in bagni gelati per temprare il corpo. Ci racconta che lui stesso era
23 LEONARDI (C.) (a cura di), La Letteratura Francescana, Volume II : Le vite antiche di san Francesco, Milano,
Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2005; LEONARDI (C.) (a cura di), SOLVI (D.) (commento), La
Letteratura Francescana, Volume III : Bonaventura: la perfezione cristiana, Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo
Mondadori Editore, 2012. Utilizzeremo le abbreviazioni 1Cel, 2Cel; Legm, LegM.
24 1 Cel, 9, pp. 64-65.
17
vigile affinché nei suoi compagni non ci fosse alcuna esitazione nelle pratiche del
contemptus corporis (1 Cel, 15, 40-41, pp. 94-95; 1 Cel, 16, 42, pp. 98-99).
Parla della sua privazione volontaria del sonno: dormendo su una tunica e
utilizzando come cuscino un pezzo di legno o una pietra (1 Cel, 19, 52, pp. 112-
3). Tommaso narra di un episodio rappresentativo dell’attitudine dell’assisiate:
avendo mangiato dopo una malattia della carne di pollo chiede ad un frate che lo
leghi e lo porti in giro come un malfattore per emendare il suo peccato e liberarsi
dal senso di colpa (1 Cel 19, 53, pp. 112-113). Celano poi ci dice che F.
disprezzava il suo corpo:
“Era diventato per sé come un vaso infranto, non gravato da timori o preoccupazioni per
il suo corpo, e lo esponeva intrepido a ogni oltraggio perché per amore del corpo non
fosse indotto a qualche desiderio terreno. Da vero spregiatore di sé, con la parola e con
l’esempio dava a tutti il salutare ammonimento a disprezzare sé stessi”25
.
I toni di Tommaso sono più radicali di quelli presenti negli scritti dell’assisiate
stesso. Coerentemente con un ritratto di F. disprezzatore del corpo Egli deve
insistere sulla mortificazione dei sensi. Quali se non per primi la vista e l’udito?
A questo fine Celano narra del passaggio di Ottone II che si reca a Roma per
essere incoronato seguito da un corteo sfarzoso che il santo, chiuso nel suo rifugio
con i suoi compagni ignora completamente per evitare che attraverso “i sensi
esteriori (…) la morte entra nell’anima “ (1 Cel, 16, 43, pp. 98-99).
Anche nella Legenda Maior e nella Legenda Minor, ci sono cenni alla concezione
della corporeità in Francesco d’Assisi. Qui i toni sono ulteriormente radicalizzati.
In Bonaventura ricorre spesso il tema della nudità, sia nell’episodio della
conversione davanti al Vescovo e sia nel momento della morte, in quanto simbolo
del rifiuto del mondo. Ecco un passo rilevante nel momento in cui si reca,
consapevole della morte imminente, a Santa Maria della Porziuncola, qui
Bonaventura dice che:
“…egli non aveva nulla in comune con il mondo, durante quella malattia così grave che
pose fine a tutto il suo penare, si prostrò in fervore di spirito, tutto nudo sulla nuda terra:
25
1Cel, 19, 53, pp. 112-15.
18
così, in quell'ora estrema nella quale il nemico poteva ancora scatenare la sua ira, avrebbe
potuto lottare nudo con lui nudo…”
La nudità del corpo rende F. simile al Cristo, Egli votato all’amore di Madonna
Povertà, decide di rimanere nudo sulla croce proprio come il Figlio di Dio:
“… Volle, di certo, essere conforme in tutto a Cristo crocifisso, che, povero e dolente e
nudo rimase appeso sulla croce. Per questo motivo, all'inizio della sua conversione,
rimase nudo davanti al vescovo; per questo motivo, alla fine della vita, volle uscire nudo
dal mondo e ai frati che gli stavano intorno ingiunse per obbedienza e carità che, dopo
morto, lo lasciassero nudo là sulla terra per il tratto di tempo necessario a percorrere
comodamente un miglio…” 26
.
Nella Legm Bonaventura restituisce un ritratto dell’assisiate intransigente dicendo
che sebbene fosse stato un giovane alquanto scapestrato “non seguì gli istinti
sfrenati della carne” (Legm, 1,1 pp. 965-66). Lo stesso biografo ci racconta che
quando F. si trova a ricevere la richiesta di benedizione di un canonico peccatore
Egli gli impartisce la stessa ricordandogli che il peccato della carne, se reiterato,
merita, in quanto peccato di ingratitudine, la peggiore delle pene. Gedeone,
protagonista dell’episodio, tornerà al peccato della carne e sarà punito infatti con
la morte a seguito del crollo di una casa (LegM, 11, 5 pp. 872-73).
Bonaventura come Tommaso parla nella Legm delle punizioni corporali che F. si
auto infliggeva per preservarne la purezza e la castità e anch’egli cita l’abitudine
di immergersi in acqua gelida durante l’inverno (Legm 3, 2 pp. 980-81).
Bonaventura parla del corpo come un nemico ben conosciuto dal quale dobbiamo
difenderci continuamente. Nella LegM considera l’ozio, il maggiore dei pericoli
che induce a peccare e dice che F. chiamava il suo stesso corpo “frate asino”.
Ecco il passo:
“Quanto all’ozio, sentina di tutti i pensieri malvagi, insegnava che lo si deve fuggire con
somma cura e, mediante il suo esempio, mostrava che la carne ribelle e pigra si doma con
discipline continue e fruttuose fatiche. In questo senso chiamava il suo corpo “frate
26
Legenda maior, XIV 3-6.
19
asino”, indicando che va sottoposto a compiti faticosi, va percosso con frequenti battiture
e sostentato con foraggio di poco prezzo” 27
.
Bonaventura come Tommaso parla delle privazioni di F. citando alcune sue
pratiche: l’abitudine di indossare abiti ruvidi e semplici; il bere a stento dell’acqua
sebbene assetato; la totale interdizione del vino; la pratica di mescolare cenere ai
cibi, per lo più non cotti; il mangiare in quantità sufficienti a sostentarsi senza
morire d’inedia e infine l’abitudine di dormire per terra coprendosi con un vestito
come coperta (Legm, 3,1, pp. 979-80).
Bonaventura racconta che F. incitava i suoi frati a praticare le stesse forme di
mortificazione del corpo (LegM, 3,7) e riprende il tema dei sensi come mezzo
attraverso cui il peccato entra nell’anima, riflessione già incontrata in Celano
(LegM, 5,5, p. 817). Nondimeno il secondo biografo insiste sulla vista come senso
principe del peccato e lo collega al problema della vista del corpo femminile.
Nella LegM ci dice che F. evitava la compagnia delle donne consapevole del loro
potenziale demoniaco:
“Comandava di evitare molto accuratamente la familiarità, i colloqui e la vista delle
donne, perché per molti sono occasioni di rovina. Sono queste le cose - asseriva- che
molte volte spezzano gli spiriti deboli e indeboliscono i forti. Riuscire ad evitare il
contagio delle donne, per uno che si intrattiene con loro, è tanto difficile quanto
camminare nel fuoco e non bruciarsi i piedi, come dice la Scrittura. A meno che si tratti di
un individuo sperimentatissimo. Quanto a lui, aveva distolto gli occhi per non vedere
simili vanità, con tanto impegno che, come disse una volta al suo compagno, non
conosceva di faccia quasi nessuna donna. Riteneva rischioso lasciare che la fantasia
assorba la loro immagine e la loro fisionomia, perche questo può ridestare il focherello
della carne, anche se ormai domata, o macchiare il nitore della pudicizia interiore” 28
.
Dunque la mortificazione del corpo deve essere accompagnata da quella dello
spirito (LegM, 5, 3 p. 815). Un solo episodio narrato da Bonaventura contribuisce
a mitigare il rigido ritratto che Egli restituisce dell’assisiate. L’episodio in
questione narra di un frate provato dai troppi digiuni che non riesce a dormire e F.
lo invita a mangiare del pane, mangiandone per primo in sua presenza per non
27
Ibidem, 5, 6 pp. 817-18. 28
Legenda Maior 5,5, p. 187.
20
provocare il suo imbarazzo. In questo episodio, F. ammonisce i compagni dicendo
che la carità è più importante delle pratiche ascetiche (LegM, 5, 7 p. 818-9).
Quest’ultima vicenda, sebbene Bonaventura disegni in generale un F. più ascetico
di Celano e dello stesso racconto di sé che F. ci ha lasciato, è in linea con
l’equilibrato lascito etico dell’assisiate.
Per concludere questo breve excursus nei testi di Tommaso da Celano e
Bonaventura da Bagnoregio, è importante dire che entrambi usano una metafora
interessante riguardante il corpo. Quest’ultimo è paragonato a una parete che
impedisce di vedere Dio, carnis paries. In questo modo, i due biografi,
radicalizzano la gerarchia che F. riconosceva tra corpo e anima.
Celano ne parla in molti punti. Sia dopo aver raccontato l’episodio della rinuncia
ai beni davanti al vescovo dicendo che F. deponendo ogni umana cura aveva tra sé
e Dio solo il muro della carne (1Cel 6, 15, pp. 54-55); sia quando riguardo alle
infermità di F. dice che abbandonata la comunità umana e ritiratosi in luoghi
remotissimi solo lo schermo della carne lo teneva lontano da Dio (1Cel,6, 103,
pp. 102-4). Altrove Celano dice che F. oramai vicino agli angeli quanto a ricerca
della santità è separato da loro solo dalla parete della carne (2Cel, 61, 94, pp.
529-30); e in un altro luogo, sotto un’evidente influenza paolina (Efesini 2,14)
(Cel 1, 27) dice che:
“ Più di ogni altra cosa desiderava andarsene dal corpo per essere con Cristo “ 29
.
Il corpo come impedimento dell’anima torna in altri passi: quando parla di
un’anima sciolta e liberata dalla carne (1Cel 7, 106, pp. 198-99; 1Cel 8, 110, pp.
206-7; 2Cel, CLXIV, 218 p. 634); quando cita l’antica concezione del corpo come
prigione dell’anima (1Cel I, 88, pag. 168-69) e carcere terreno (2Cel, 1, 4, p. 446).
Infine quando afferma che il peggior nemico dell’uomo è la sua carne che si
arroga anche il godimento dei meriti che spetterebbero all’anima (2Cel, XCVII,
134, p. 564) .
Anche Bonaventura nelle Legendae ricorre all’immagine del corpo come
impedimento per raggiungere Dio, ma dice che in vita attraverso la preghiera, il
Santo riuscì a superare questo impedimento e a fare totale astrazione dal proprio
corpo (LegM, X, I, p. 862). Quindi gli attribuisce anche le parole di San Paolo (2
29
Vita prima, Celano, 27, 71 pp. 140-41.
21
Corinzi, 5) quando dice che la morte gli permette di liberarsi dal corpo: qui si
parla di parete della carne e di un’anima finalmente sciolta dalla carne ( Legm,
VII, 5, pp. 1009-10).
Nella visione del serafino raccontata da Bonaventura, Egli dice che F., rimirando
il serafino, ha superato lo schermo della carne e “stava per essere trasformato
tutto nel ritratto visibile di Cristo crocefisso, non mediante il martirio della carne,
ma mediante l’incendio dello spirito” (LegM, 13, 3, pp. 891-92).
Breve riflessione conclusiva:
Proprio quest’ultima metafora analizzata, riguardante il corpo come schermo che
divide l’uomo da Dio, è il tratto essenziale che marca la distanza tra gli scritti
autentici di F. e la rielaborazione successiva del suo messaggio operata da
Tommaso prima, e da Bonaventura poi.
Non arriveremo a dire che i due biografi abbiano “tradito” il suo punto di vista ma
effettivamente sembra chiaro che i toni sono radicalizzati e che si torna a una
concezione del corpo umano come gabbia dell’anima di chiara ascendenza
platonica.
Questo tema ha avuto grande fortuna nella storia culturale dell’Occidente
cristiano, passando nella riflessione agostiniana che trasmette a tutta la
speculazione posteriore, eccettuati i casi di Tertulliano, Bernardo di Chiaravalle e
poi Tommaso d’Aquino, i quali attenuano, nel loro sistema di pensiero, tale
visione del tutto negativa della corporeità.
Riteniamo che l’originalità dell’assisiate, a proposito del tema della corporeità,
risieda nella sua fedeltà al messaggio evangelico.
Pur rielaborando alcuni temi del contemptus mundi et corporis e nonostante la
convinzione di una gerarchia esistente tra anima e corpo, pur conoscendo gli
inganni del desiderio carnale, Egli non giunge mai a demonizzare il corpo in sé.
Il corpo umano non è mai considerato ipso facto peccatore ma può divenire
strumento del peccato. Egli non vitupera il corpo e di conseguenza l’uomo ma
anzi lucidamente individua nella cattiva volontà o nel Maligno la tentazione
dell’umanità.
22
F. è portavoce di un messaggio equilibrato, e sprona alla virtù dello spirito e del
corpo, esalta la bellezza del creato e delle creature, perché l’umanità è fatta a
immagine e somiglianza del Figlio. Amando il mondo si amano le sue creature, si
prova, di conseguenza, affetto per tutti i propri simili.
Con questa teorizzazione l’assisiate dimostra la lungimiranza culturale e la
modernità che hanno contribuito a farne uno dei personaggi più importanti della
cristianità occidentale.
23
Bibliografia:
Admonitiones
Epistola ad fideles (recensio prior)
Epistola ad fideles (recensio posterior)
Officium Passionis Domini
Regula Bullata
Regula non bullata
Salvir Salutatio virtutum
BERNARDUS CLARAEVALLENSIS ABBAS, Opera Omnia, in PL 182-85.
Fontes Franciscani, Introduzioni critiche: A cura di Brufani (S.), Menesto’(E.), Cremascoli (G.),
Paoli (E.), Pellegrini (L.), STANISLAO DA CAMPAGNOLA, ed. Poziuncola, Santa Maria degli
Angeli, Assisi, 1997. Fonti Francescane, nuova edizione, a cura di E. Caroli, Edizioni francescane,
Padova, 2009.
LEONARDI (C.) (a cura di), La Letteratura Francescana, Volume I : Francesco e Chiara d’Assisi,
Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2004.
LEONARDI (C.) (a cura di), La Letteratura Francescana, Volume II : Le vite antiche di san
Francesco, Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori Editore, 2005.
LEONARDI (C.) (a cura di), SOLVI (D.) (commento), La Letteratura Francescana, Volume III :
Bonaventura: la perfezione cristiana, Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo Mondadori
Editore, 2012
LOTARIO DI SEGNI, Il disprezzo del mondo, a cura di R. D’Antiga, Pratiche Editrice, Parma
1994.
TERTULLIANO, Opere scelte di Q. S. F. Tertulliano, a cura di C. Moreschini, UTET, Torino,
1999.
Opere generali:
Anima e corpo nella cultura medievale, in Atti del V Convegno della Società Italiana per lo
Studio del pensiero Medievale, Venezia 25-28 settembre 1995, a cura di Casagrande (C.) e
Vecchio (S.), Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze, 1999.
DUVERNOY (J.), La religione dei catari. Fede. Dottrine. Riti, Ed. Mediterranee, Padova, 2000.
CARDINI (F.), Il cantico delle creature: una rilettura, in Studi Francescani 79, 1982, pp.
283-88.
DE BROUWER (D.), L’iconographie franciscaine des origines, 1226-1282, Paris, 1997.
FRUGONI (C.), Francesco e l’invenzione delle stimmate, Una storia per parole e immagini fino a
Bonaventura e Giotto, Torino, Einaudi, 1993.
24
IAMMARRONE (G.), Corpo-carne in Dizionario francescano, col. 253-266, Edizioni
Messaggero, Padova, 1995.
IAMMARRONE (G.), L’immagine dell’uomo in San Francesco d’Assisi, in Rivista di
teologia morale, 14, 1982, pp. 9-22.
LE GOFF (J.), S. Francesco d’Assisi, Laterza, Bari, 2000.
LE GOFF (J.), Il corpo nel medioevo, Laterza, Bari, 2005.
Studi specifici:
GNIECKI (C.), Visione dell’uomo negli scritti di Francesco d’Assisi, Edizioni Antonianum,
Roma, 1987.
DAJCZMAN (T.), La corporeità nelle opere agiografiche ufficiale del XIII s. su San Francesco,
Tesi di licenza presentata alla Pontificia Università Teologica San Bonaventura, Roma, a.a. 1999-
2000.
SANSON (M.), Il corpo nell’opera di Francesco d’Assissi e di Iacopone da Todi, Tesi di dottorato
ciclo XXIII, anno 2009-2010, Trento.
ZAVALLONI (R.), La “corporeità” nel pensiero francescano. Da San Francesco a Duns Scoto in
Antonianum 66, 1991, pp. 532-62.