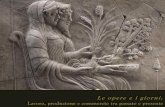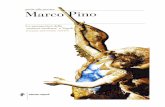Opere di Francesco Redi gentiluomo aretino e accademico ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Opere di Francesco Redi gentiluomo aretino e accademico ...
OPEREDI
FRANCESCO REDIGENTILUOMO ARETINO
ACCADEMICO DELLA CRUSCA,
VOLUME PRIMO.
D*IU SucieU TipograBca uc’ Classici Italiani,contrada di t. Margherita, N.° mg.
anmo 1809.
t
AVVISO
degli editore
Albbiamò dato priticlpiri allf Opere di
Francesco Redi col fahioso suo Ditirambo,per soddisfare cosi alle istanze che fatte
Digitized by Google
TI
ci fiirono Ja moltissimi de nostri Associati.
Diffatti nessun frenerò di 'toscana Poesiavenne più di questo Ditirambo accolto congrandi applausi non solo dagC Italiani , mado tutti gli stranieri ancora. Fu esso pub-hlicato la prima volta in Firenze tanno 1 6tt5 .
in 4*’ e fu dateAutor suo corredato di mol-tissime k\mo\&i\on\, tu lle quali chiaramentesi vede di quanta erudizionefosse egli a do-vizia fornito. Queste Aimolazioni furono poidallo stesse) Autore di molto accresciute
nella tr^rza edizione fatta pure in Firenze
in 4.° nelC anno if>gi. E le ime e le al-
tre furono da noi aggiunte nelf edizion
nostra affmliè in essa nulla più rimanes^
se a desiderarsi. Quanto at testo , ci sia-
mo attenuti specialmente alle due poc an-
zi accennate edizioni , citate amendue da-
gli Accademici della Crusca.
Nel secondo volume noi riprodurremo
tutte le altre poesie di questo nobilissimo
Scrittore, e non dispcriam pure, di potere
aggiungere qualche componimento inedito
e finora sconosciuto. Alla mita dellAuto-re scritta dal celebre Salvino Salvini ab-
biamo a^iunta l'Orazione funebre che in
lode di lui recitò lo stesso Salvini nella
puhblica Accademia di Firenze nelfannoiGgg. Essa lien luogo di quolunque elo-
gio noi avremmo potuto tessere di untanto Autore, che certamente al pari del
Digitìzed by Google
VII
&aUlco fu norl solo colcissimo Scrittore y
ina ancfte uno de' primi Ristoratori della
haona filosofia.
VITADi
FRANCESCO REDIAKF.TIUO
TRA GLI arcadiA • . ;
DETTO ANiaO THADSTIO
'scrittaI
DALL’ ABATE SALVINO SALVINl
FtOFEirttUO
DETTO CRI8ENO ELISSONEO.
I
I
/
T i antica e nobile città di Arezzo fa
sempre mai feconda madre d* uomini in
lettere e in armi chiarissimi , molti dei
quali nella fiorita cittadinanza Fiorentina
Digitized by Google
It
innestandosi , non meno alla prinia , chealla seconda patria fecero onore. Fra que*sti si contano ne’ secoli passali un Lionar-
do Aretino , c un Carlo Marzoppini , am-bedue Poeti laureati, e dottissimi Segretarj
della Repubblica Fiorentina , e i molli
della Casa degli Accolti per dottrina e
pei' dignità famosissimi. Nel segnalato nu-
mero di costoro fu certamente FrancescoRedi insigne letterato de’ nostri tempi ; il
quale nato in Arezzo di nobile famiglia ,
e in ogni tempo illustre per le soleuui
ambascerie , e per le principali magistra-
ture, fu poi allevato e nutrito in Firenzej
agli onori della qual città era il padre
suo stato descritto. Nacque egli adunque ,
come s’ è detto in Arezzo, l’anno 1626. il
fiorno 18. di febbrajo , di Gregorio di
rancesco Redi , e di Cecilia de Ghincialtresi nobil famiglia Aretina in oggi
estinta. Studiò Gramatica e Rettorica in
Firenze nelle scuole de’ Padri della Comjia-
gnia di Gesù , e 1’ altre scienze nell’ Uni-
versità di Pisa ,dove prese la laurea del
Dottorato in Filosofia e Medicina. Si fe’
ben presto conoscere in Firenze , fino da-
gli anni più teneri,
per quel grand’ Uo-
mo, che egli poi riuscì; dandosi non solo
alla cultura delle lettere più amene, delle
lingue volgari, e «Ielle antiche erudite
ma ,quel che era il suo maggiore scopo,
alla intelligenza c pratica della più pro-
ibndit filosofia. Viveva allora il Granduca
Digitized by Google
Ferdinando II. gran Mecenate degl’ingegni
più rari , il quale aftezionalissimo alle
scienze tutte , dava stimolo e comodità ai
Frofessori di quelle, di poter far prova
della loro acutezza, fiarticolarmeute nelle
cose sperimentali , dove veramente il Re-di si rendè immortale
;poiché ebbe occa-
sione di conferire i suoi studj , c coi Bo-
re 1 1 i e con gli Stenoni, e altri dottissimi
uomini , che si trattenevano alla Corte di
Toscana , scuola d’ ogni più rara virtù, e
di esercitar suo valore nella famosa Acca-demia del Cimento , che sotto la protezio-
ne del Principe Leopoldo poi Cardinale
de' Medici , fu aperta. Quindi avendo il
Granduca , ottimo cognilore degl’ iugegui
,
conosciuto quello 'finissimo del Redi, lo
dichiarò suo primo medico; nel quale im-
piego egli servì poi il Regnante Cosimo 111.
e tutta la Casa di Toscana , fino a eh’ ei
tisse, con tanta soddisfazione di tutti queiPrincipi , che gli portarono sempre incre-
dibile affetto; onde non solo ne’ consigli
di sua nohil professione , ma in affari an-
cora, e maneggi di confidenza e di fedel-
tà fu sovente impiegalo. Quindi dalla ma-gnanima Granduchessa Vittoria di felice
ricordanza,
giustissima stimatrice di suavirtù , dopo avere egli da quella ricevute
in vita ad ognora cortesissime diraostrauze
d’affetto, ne fu in morte con nobil la-
scio,
per ultima testimonianza dell’ alto
suo giudicio, onc ralissimameute riconb-
SII
sciato. Nè solo dai nostri, ma dai t*rlnci-i
pi , e personaggi stranieri tenuto era ia
venerazione, lo ho veduto una copia di
lettera appresso 1’ eruditissimo Pierandrea
Forzoni Accolti amico affezionato del Re-di , scritta ad esso Redi l’anno 1678. daCarlo Lodovico Fletter Palatino
,per la
quale ringraziandolo d' un consulto invia-
togli, in occasione di sua malattia
,gli
manda un ricco e nobil regalo, e lo assi-
cura , con espressioni ben distinte , delia
stima, che per lui mantiene. Alla genti-
lezza de* costumi , alla bontà della vita ,
alla professione in somma di Filosofo unìquella della intelligenza delle buone let-
tere ; mettendosi da principio per la mi-
gliore strada , che alla vera cognizione di
quelle ne conduce. Compose in sua gio-
ventù molte Toscane poesie, ed amorose 0
morali per esercizio d’ ingegno , e moltis-
sime osservazioni, distese , un gran fascio
delle quali negli ultimi anni di sua vita
egli consegnò alle fiamme , come mi" af-
ferma il Dottore Stefano Bomicci gentil-
uomo Aretino, domestico famigliare del
Redi , e che molte delle sue cose mano-scritte conserva. Coltivò sera|,'re mai gli
amici virtuosi , mantenendo con loro uncontinuo letterario commercio ; onde benpresto si fe’ conoscere , ed ammirare inItalia, e fuori di essa ancora
,particolar-
mente quando egli diede fiiora i suoi libri
notissimi al mondo, e per l’ameuità della
Digìtized by Google
xmdottrina , e per la pulitezza dello stile ce»
Icbralissimi. Quando egli si trovava disoc-
cupato dalle speculazioni delle naturali
esperienze, da lui più volte, per maggior»
Diente accertarsi della verità, reiterale
,
si metteva a filosofare sulla lingua Tosca-
na , su gli Autori di quella più accredi-
tati, su gli antichi testi a penna, de'qiiali
ne era fornitissimo, per contribuire, giu-
sta sua possa ,al vantaggio e al ripuli-
Diento della lingua , e specialmente alla
grand’ opera del Vocabolario,
del qualefu uno dei Compilatori. Lcggansi le Eti-
mologie della lingua Italiana del famosoletterato Francese Egidio Menagio, il quale
ebbe dal Redi quasi infinite etimologie e
notizie , ed egli bene in molli luoghi di
Suoli’ Opera lo confessa
,protestandosi di
overe alla gentilezza , ed erudizione del
Bedi il migliore di quell’ utilissimo Trat-
tato. Leggansi le Mescolanze del medesimoMenagio , dove sono registrate alcune let-
tere del Redi a lui indirizzate, nelle quali
per tutto risplende unita alla cortesia del-
le maniere la cognizione delle dottrine; e
di queste sue rare doti ne volle ancoralasciare in iscritto testimonianza 1’ incom-parabile abate Regnier nelle Annotazionial suo Anacreonte , lodando il nostro Re-
di , il quale, dice egli , ad una somma
erudizione in ogni genere di litteratura hasaputo accoppiare tanta purità di stile, etanta
, per quel eli io sento ,dolcezza di
i
I
t
Digitized by Google
XITcostumi , cA’ ei lascia in dubbio qual sia
magiare in lui o la profondità della dot-
trina , o la soavità dslt eloquenza, o la
gentilezza del vivere civile. Nutriva egli
sempre un geuio amorevole verso i lette-
rati , benigno ammiratore, censore giudi-
cioso e gentile , lodatore amicbevole,pro-
motore insigne degli altrui studj : ondeuon |)ochi segnalati soggetti da Ini furono,
a’ suoi conforti , e colle sue singolari ma-niere , fatti e formati; ed egli con savio
accorgimento sul bel principio conosciuti,
eli fe’ conoscere al mondo. Uno di ((uesli
( lasciando stare i professori di medicina)f’i il celebre Benedetto' Menz.ini , a cui il
Redi diede animo , anzi le prime mosse
}
)er la nobile carriera , che egli fece, del-
a poesia. Io udii già dire al medesimoFrancesco Redi , che il Menzini
, essendo
ancor giovane gli portava di cpiando in
quando qualche poetica composizione, nel-
la quale, benché non d'intera perfezione,
pur ravvisava il buon genio, e il buonoincomiuciamcnto , ondo facendogli cuore,
ed esortandolo ad esercitarsi colla scorta
de’ migliori autori , crebbe poi iu quel
J
tregio di sublime poeta , che ognun sa,
ila per tornare alle sue sperimentali pro-
ve , e speculazioni naturali e filosoGche ,
egli fu inventore d’uu nuovo c facilissimo
metodo di medicare; nel che quali allievi
e seguaci non fece mai? Basta dire, che
furono suoi diletti discepoli i due celebra-
Digitized by Google
xrtissÌDiì non men filosofi, che letterati, Lo-
renzo Bellini ili felice ricordanza , e Giu-seppe del Papa vivente , ambedue Medicidi queste Altezze, e famosi professori nel-
lo studio Pisano ; i quali ne’ loro scritti
immortali , si dichiarano eternamente al
gran Pedi t<>nuti. Cominciò questo ocula-
tissimo sperimentatore le sue prime osser-
vazioni ,sotto gli auspici di Ferdinando li;
sopra le vipere ; ed avendone raccolto unfinissimo trattato, lo diede alla luce delle
stampe in Firenze l’anno <664. in forma •
di lettera uaiirizzata al conte Lorenzo Ma-galotti , lagnale poi fuor d’Italia tradotta
in latino fu inserita nel primo tomo delle
^ IKiscellanee curiosità naturali; e di nuovoil testo volgare stampato in Firenze
nel i686. Centra quest’opera gli fu scrii- /
to in Francia ; ed egli con ogni maggiormodestia ribattendo tutte le opposizioni
fattegli , ne stampò in Firenze la risposta
pure in forma di lettela ai signori Ales-
!
sandre Moro Inglese , di cui conservava' una bella elegia in sua lode, e Abate!Bourdelot signor di Condè, e di s. Leger.j
E perchè , come egli stesso asserisce in
altra delle sue Opere ,egli ebbe 1
’ onoredi servire in una Corte , alla quale da'
tutte le parli del mondo corrono tutti que’grand’ uomini , che coi loro pellegrinaggi
van cercando, e portando merci di virtu-
de ; seguitò il Redi a dar fuori in diversi
lempi altre bellissime fatiche piijuc di dot-
Digitized by Google
trina e di recondite erudizioni , similmen-te in forma di lettere a diversi amici suoi,
come furono l’ esperienze intorno a diver-
se cose naturali , che ci son portate dal-
. rindie, indirizzate al Padre Atanasio Cbir-
Icber della Compagnia di Gesù , uscite al-
i la luce r anno ibyi. che pure furon tra-
dotte in latino, e stampate in Amsterdamnel 1675. Opera fatta coll’ occasione d’ es-
ser capitati alla Corte di Toscana l’ anno1662. alcuni Padri Francescani dall’ Indie
Orientali, che da que’ paesi recarono mol-te curiosità, e le feccr veder^al Grandu-ca. L’ esperienze intorno all^Henerazionedegl’ insetti a Carlo Dati
,panmente tras-
portate in latino , e impresse in Amstèl^dam, fattane poi la quinta impressione
> Firenze nel i688. Contea a queste stampò
I
alcune opposizioni il Padre Filippo fionan- 1
ni , alle quali in altre sue Opere rispose
il Redi non meno con chiara evidenza
,
che con singoiar gentilezza. Le osservazioni
intorno agli animali viventi , che si tro-
vano negli animali viventi , stampate in
Firenze 1684. con moltissime belle ligure
in rame. E ben si diede a conoscere al
mondo , essere egli il genio della natura ,
discopritorc di verità ,creatore di belle ed
utili dottrine, ed artefice di squisita fa-
condia in tutte queste Opere , scritte dalui nella Toscana favella, le sue delizie e
i suoi amori, con tanta proprietà e purità
di stile che nulla più;
onde perciò sono
Digitized.by Google
XVIIlatte citate nell' ultima edizione del Yoca*boiario della Crusca; della quale Accade-mia egli fu benemerito e affezionatissimo
sempre ,avendovi con sua gloria sosleiime
tutte le cariche fino alla suprema di Ar-ciconsolo. Per questo suo tenero amore al-
la lingua Toscana , meritamente fu anco-ra insignito del titolo di Lettore della me-desima nello studio Fiorentino. Ebbe sem-
ftre in sommo pregio gli autori di nostra
ingua ; onde ritrovandosi tra’ suoi scelti
manoscritti uno antico codice delle vite di
Dante e del Petrarca , scritte da LiouardoAretino , confrontatolo diligentemente eoaaltri testi a penna , lo fe' stampare in Fi-
renze nel 1672. Fu ollremodo vago delle
antiche memorie , e diligentissimo conser-
vatore delle medesime;
per lo che, tra
r altre sue cose , avendo scritta una eru-
dita lettera a Paolo Falconieri, intorno al-
i’ invenzione degli Occhiali da naso , la
diede alle stampe ben due volte in Firen-(
ze , con aggiunta in quest' ultima , e fuquesta lettera tradotta poi in francese daMonsù Spon^ che forma la sedicesima dis-
sertazione delle sue curiose ricerche d’an-
tichità stampate in Lione nel i(j83. Ma
3uanto egli valesse in questo particolare
i antiche , nostre e straniere erudizioni
,
le dottissime annotazioni , che e' fece al
suo celebre Ditirambo, intitolato Bacco in
Toscana, sUimpato due volte in Firenze ,
ed una in Napoli , insieme con tutti gli
J\cdi. Opere, b
T
Digitized by Google
XTIII
altri suoi libri, chiarissimamente il dimd«
Strano. Questo fu l’ ultimo suo ammirabilej)oelico componimento , con artificiosa evaria struttura per lungo tempo , e conamore da lui fabbricato, e delle accenna-
te annotazioni,per le quali altri il cliia-
tnò il Vairone Toscano arricchito. Non si
può mai a bastanza ridire l’ applauso
,
che colle sue dolci Tirtuose maniere s’era
acquistato appresso i nostrali e stranieri ;
basta dire , che in segno di ciò egli rac-
colse un ben grosso volume di poesie to-
scane e latine, fatte in sua lode da diversi
eccellenti soggetti, che si conserva appres-
so il Bali Gregorio Redi suo degno nipo-
te, insieme con altre sue Opere non coin-;
pite; tra le quali sono il Vocabolario Are-
tino , moltissime note a quello della Cru-sca , il Ditirambo principiato dell'Acqua ,
che egli formò, fingendo Arianna amma-lata per lo soverchio vino bevuto ; e me-ditava ancora di dare alla luce le Rime e
le Lettere di F. Guittone d'Arezzo , anti-
chissimo Prosatore e Poeta toscano , delle
quali ne aveva due buoni esemplari. Nonmancarono ancora molli , che aedicaronoal glorioso suo nome le opere loro ;
cometra gli altri furono Pietro Adriano Van-den Brocch Fiammingo Professore d’ Uma-nità nella città di Pisa , il secondo libro
delle Selve Poetiche, le cui Lettere Lati-
ne , sua opera postuma , divisa in tre li-
bri , e già al Redi dall’Autore disegnata •
Digitized by Google
XIXfn a lui dedicata da Loreneu Adriani Luochese scolare del Vanden firoecb ; dodici
delle quali lettere piene d’ alta stima delHedi, sono al medesimo scritte. AlessandroMarchetti celebre Matematico, e Professo*
re altresì nello studio di Pisa , dedicò al
Redi il libro della natura delle Comete.Giuseppe Zambeccari Lettore di Medicinanel sopraddetto studio ,
1’ esperienze intor*
no a direrse viscere tagliate a diversi ani*
mali viventi. Lorenzo Bellini il Trattato
de Urinis et pulsibus , de missione san-
guinis, de fehrìbus , de morbis capitis , et
pectoris. Giuseppe del Papa indirizzogli i
tre suoi libri , dove si discorre della na*tura deir umido e del secco ; del caldo edel freddo; del fuoco e della luce. AntonFilippo Ciucci Aretino il Filo d’Arianna
,
ovvero fedelissima scorta agli csercizj di
Chirurgia. Giovanni Caldesi le Osservazio-
ni Anatomiche intorno alle Tartarughe.
Benedetto Menzini il libro De literatorum
homintim invidia, e il trattato della costru-
zione irregolare della lingua Toscana .
Francesco Cionacci un breve trattato purdella Lingua
; e queste due opere Tosca-ne gli furono indirizzate 1’ anno del suoArciconsolalo. Gio. Cosimo Botiomo
, ePietro Paolo da san Gallo i loro opusculidi naturali osservazioni. Federigo Nomi le
poesie liriche. 11 Padre' Francesco Eschi-nardi Gesuita il Corso Fisico* Matematico,etl una Lettera della meilesima. materi'.r.
Dìgitized by Googl^V
£ Anton Maria SaWini suo grande amicoj Discorsi Accademici. In mezzo a queste
sue glorie , ad onta di sii/u piccola com-
f
dessioue debilitata bene spesso dalle ma-atlie , che lo travagliavano , come fq il
xnatcaduco , da lui pazientemente negli
ultimi anni di sua vita sofferto, mantennesempre indefesso 1’ amore alle Lettere , e
r affezione agli amici, i cui parti d'inge-
gno volentieri tutto di ascoltava ; e sopra
tutto l'assiduo servigio, ebe egli prestava
alla Casa Serenìssima di Toscana , colla
quale portatosi llnalmente a Pisa 1' anno1697. f^u la mattina del di primo del me-se di Marzo dàll’ Incarnazione del Salvato-
re trovato nel proprio letto, esser passato,
a cagione delle suddette sue indisposizio-
ni , da un breve e placido sonno agli e-
temi riposi del cielo , dove il suo buoncostume, e la sua religiosità ci persuado-
no, che egli sia andato sicuramente. Por-
tato il suo cadavere, siccome egli aveva
ordinato, ad Arezzo, ebbe nella chiesa di
san Francesco onorevole sepoltura , dovedalla pietosa riconoscenza del Bali Grego-
rio Redi suo nipote, anch’ egli Accademi-co della Crusca , e Arcade gli è stato e-
retto un nobile c ricco sepolcro di marmi,nel quale sono scolpite solamente queste
parole r FRANCISCO REDI PATRITIOARETINO GREGORIUS FRATRIS FILIUS.
£ ben può servire a tutti i secoli che ver-
rauoo,
per uo lunghissimo e degnissime
Digitizéd by Google
XXIelogio il solo nome di questo erand'uomo.Gli furono fatte colà pubbliche esequiecoir Orazione funebre , composta e recita*
ta dal Canonico Giovan Dario Cipolleschi,
tra gli Arcadi Cloridano Achelojo , chemorì vice-custode della nostra Colonia For-
zata in Arezzo. Lasciò alla sua Casa que-
sto onorato gentiluomo una ricca eredità,
e molti legati pii a favore della sua dilet-
tissima patria; la quale per decreto pub-blico collocò il suo ritratto, come suol fa-
re degli illustri suoi cittadini , nel palagio
pubblico; imitando in ciò il glorioso esem-pio di Cosimo III. che non solo in foglio,
ma in bronzo lui vivente fece imprimerein tre artificiose medaglie con ingegnosi
rovesci , alludenti alle tre facoltà , che in
eccellente grado possedeva di Filosofia",
Medicina e Poesia. Dispiacque oltre ogni
credere la sua morte, non solo a’ suoi piùcari amici , ma ai nostri Principi tutti
,
che molto 1’ amavano. Piansero ancor la
sua perdita le più ce.lebri Accademie d'I-
talia , nelle quali egli era descritto cometra le altre i Gelati di Bologna , che neavevano già stampato un nobilissimo elo-
gio tra le vite di quegli Accademici l’an-
no 1673. La nostra Arcadia, dove si chia-^°*'
mò col nome di Anicio Trauslù) ; e prin-
cipalmente la Crusca^ di Firenze, la qualegrata alla memoria d^un tanto Letterato ,
e gli diè luogo tra le immagini de’ suoi
pia rinomati Accademici , e gli celebrò
pubblica Accademia l’anno 1699. il di i 3 ..
Agosto , con buon numero di poetici com-ponimenti, e colla Orazione funebre fatta
e recitata dal mentovato Anton Maria Sal-
vini ,nella quale mostrollo l’Amico Lette-
rato ;altro non essendo stata la vita sua
,
che un continuo esercizio di letterata ami-
cizia. E veramente, se il principal fonda-
mento della buona amicizia è la virtù ,
quali attrattive non avevano,
per gentil-
mente forzare altrui ad amarlo e riverir-
lo, e tenerlo caro, i suoi incorrotti costu-
mi, ne’ quali spiccava a maraviglia il ga-
lantuomo e 1’ uomo d’onore, le tante vii'-
tù morali , che risplendevano in lui , la
moderazione, la modestia, il genio di gio-
vare a tutti , r avversione a nuocere adalenno , il prevalersi della grazia de’Prin-
cipi più , che a favore de’ suoi , in pròdegli altri ? il ebe fu giustamente notato
dagli Accademici Gelati di Bologna nel-
l’elogio fattogli in vita sua, con dire:
A' suoi serenissimi Padroni non sa maichiedere cosa alcuna per vantarlo di suapersona , a chiedere per altri si mostraprontissimo , e talvolta riesce per cosi dire
importuno. Troppo lungo sarei , se io vo-
lessi numerare tutti coloro, che di lui, edelle Opere sue, fecero nelle loro onorata
menzione. Tra quelli, che 'alla rinfusa misovvengono , sono : Carlo Dati nelle vite
de' Pittori antichi. Donato Rossetti Profes-
sore di Matematica nello studio di Pisa
Digitized by Googl
xxmnella prefazione al trattato della composi*zione de’ vetri. Gemiiiiano Montanari fa-
moso Professore Matematico nello studio
di Bologna , nelle Speculazioni fisiche so*
pra gli effetti de’ vetri, dove in molti luo-
ghi cita molte esperienze fatte dal Redisopra tal materia. Francesco Folli nel suoTrattato fisico. Filippo Baldinucci nei De-cennali delle vite de’ Pittori. Egidio Me-nagio nelle Elegie latine , c in altre sue
Opere. Stefano Lorenzini in molti luoghi
delle Osservazioni intorno alle Torpedini,
dove cita un trattato inedito deH’Anguille
fatto dal Redi. Jacopo Grandi Medico Ve-
neziano nella risposta sopra alcune richie-
ste intorno all’ isole di s Maura e la Pre-
vesa. Ferdinando Leopoldo del Migliore
nella Firenze illu.Urata. Carlo Maria Magginelle rime. Lodovico Antonio Mm|^^||i
nella vita del, detto Magg^Luca xerenzi
ne' soneiii e nelle canzoni. Agostino Col-
tellini nelle sue opere. Ezecchiello Spane-
mio : De praestantia, et usu numisrnatumantiquorum. Gio. Andrea Moniglia nella
spiegazione de’ vocaboli e proverbi della
plebe Fiorentina e del contado , inserita
traile sue opere drammatiche. Giuseppe Ci-
gnozzi nel libro d’Ipocrate dell’ulcere conle note pratiche chirurgiche. Alessandro
Pascoli Perugino Lettore di medicina nel-
l’Università di Roma nel libro delle feb-
bri. Il Vallisnieri ne’ Dialoghi sopra gl’in-
setti. riiccolò Lemery noi suo corso di Chi-
«XlTmica. Giovali Vincenzio Coppi nelle Me-morie isteriche di san Gimignano. II con-
te Vincenzio Piazza nel poema di Bona,
espugnata. Ipolito INeri nelle rime. 11 P. Fi-
lippo Bonanni nel libro intitolato: Ricrea-
zione dell’occhio e della mente. Domenicode Angelis nella Dissertazione della Patria
d’ Ennio poeta. Il P. Carlo Scrnicola Car-
melitano nelle rime. Giusto Fonlanitii in
più luoghi delI’Aminta difeso. Antonio Bu-
lifon nella seconda Raccolta delle sue let-
tere , dove ne scrive una al Redi di rag-
guaglio sperimentale. Alessandro Marchetti
ne’ Saggi de’ suoi sonetti. Anton Francesco
Bertini nella Medicina difesa. Benedetto
Meuzini nelle poesie , c nelle note alla
sua Poetica. Il Senatore Vincenzio da Fi-
licaja in quattro maravigliosi sonetti. Pao-
IwMÌmvcì nelle note al poema di Loren-zo Lippi. Antooio del Casto nel Sp^o so-
}tra r origini della lingna toscana, lì Pa-
dre Tommaso Strozzi INapolitauo della Com-pagnia di Gesù nel poema latino della
Cioccolata. Giovan Mario Crescimbeni in
molti luoghi delle sue Opere , e special-
mente nella Istoria della volgar poesi<< «
dove fa nu breve si, ma sugoso elogio del
Redi , dal quale spezialmente apparisce
quanto grande amore rpiesto famoso lette-
rato portò all’Adunanza degli Arcadi, cui
lino all’ estremo della sua vita mostrò se-
gni di stima ; trovandosi molti componi-menti, e molte lettere di lui nel lor ter-
xxtbatojo. E molli e molti altri autori, clic io
qui tralascio ; oltre all’ onorevole memo-ria ,
che di lui si legge nella Bibliote-
ca Anatomica , e nella Biblioteca Me-dico-pratica. E n verità ciò che si di-
ca di lui, non vi ha sospetto di mentitri-
ce adulazione; orde non saprei meglio lo-
darlo. che colle stesse parole dei due suoi
nominati insigni liscepoli Lorenzo Bellini
e Giuseppe del Papa , coll’ occasione di
dedicargli le opere loro. Son queste, le pa-
role del ])rimo : Tollit quidem omnem dete falsae laudaticnis suspicionem comma-nis iUe consensm omnium gentium
,quo
uhique diceris in omni generb eruditionis ,
in omni splendor* doctrinae , in omni gra-vitate sapientiae
,prudentia , consilio, mo-
rum suavitate , integritate animi, constane
tiaque singidaris , ut nihil snpea , imdeexultat Etruria t»ta
,priscam majestatem
cum simplicitate conjunctam,quam arti
Mediane conciliateiat Hippocrates , et sue-
cedentium temporim conditiones lahefàcta-
verant , et penitus exerterant , tanto cura
plausi* honorum omnium , tanto fremitaimperitorum
, cum tanta hominum utilica-
te , tua opera reititutam. Il secondo, bia-
simando coloro , che lìdandosi dell’ altrui
parere , ,it«i>-si Condano^spUc ragioni >sisull’ cspei ienze ben fatte , dice allo stesso
Pedi ; Non così può già dirsi di V. S. osignor Francesco, la quale non acqueta-tasi punto alla cpinione degli altri , c di
V
XXVIgran lunga separata dalla schiera del vol-
go^ ha saputo colla somna sua intelligen-
za ^ e con accuratissimi esperienze trar
Juori allo splendore della 'verità tante etante belle conclusioni , "//e per t innanzidentro alt oscuro grenho della Naturaerano ascose : onde siicome 'viveranno
eterni i suoi dottissimi llfri , cosi ancoranon morirà mai appreun gT indagatori
del vero la fama e la lede , che ella conessi si è meritata. Vagliami finalmente in
vltimo , in attestalo della virtù del Redi «
la stima , che ne fece d>po sua morte il
Serenissimo Principe Feriinaiido di Tosca-
na; il quale, a spese distia reai munifi-
cenza, ordinò, cne fos^ stampata tina
scelta di 6o. suoi leggiadrissimi sonetti
,
trascelti dai moltissimi , clic vanno attor-
no per le mani degli iiiendcnti. Furonoquesti impicssi in Fircn» in foglio reale
con molti nobilissimi lani nella Stampe-ria del G. Duca Tanno 1702. E poi di
nuovo comparvero alfa |uce in piccolo,
per renderli più comuni,con un sonetto
avanti , fatto sotto al ritmtto del Redi daCarlo Maria Maggi. Sopfa di questi giu-stissimo è l’attestato, che ne fa il dottissi-
mo Lodovico Antonio Miratoci ncL Trat^L^o della perfetta jiocsl; , dovedichiarando 11 liedi uom* di finissimo gu-
sto, ed esaminando aleuti de’ suoi sonetti,
vi riconosce per tutto, cerne egli confessa,
delicatezza e tenerezza naturale , rara soa-
DigitizacLb
xxvnTità , chiarezza continua , finimento singo-iar dello stile , artifizio magnifico , dolcemelodia
,grazia e naturalezza. Il che otti-
mamente s’ accorda col giudizio , che ne•vìen dato nella Prefazione stampata inFi-rraze axanti a’ nominati sonetti, col qualesi può francamente concludere per epilo-go di tutto ciò , che s’ è detto m questabreve Vita di Francesco Redi : essere cosicelebre per tutta V Europa il nome suo ,che è superfluo adornarlo d* encomj
; ^or-chè la sua virtù ^ e la sua universal lette*ratura lo renderanno sempre famoso a'se-coli futuri , come ha avuto vivendo talfor-tuna nel passato.
ZXTX
SlLLl LODI
PI
FRANCESCO REDIACCADEMICO DELLA CRUSCA.
ORAZIONE
D’ ANTON MARIA SALVINI
Detta da esso neU’Accademia pubblica
funerale fatta sopra il medesimo
Tanno 1699. il dì i 3. d’Agosto.
E proprio della forte mnicizia non po-
tere portare in pace il desiderio dell ami-
co,quando è lontano « e consumarsi dt
rivederlo , e sempre nella memoria ripas-
sondo le cose sue^ averlo a quella ognorapresente. Or che sarà
,quando alcuno non
da un particolar paese dilungatoy ma da
questo mondo partito y lascia di se appres-so tistti ottima ricordanzoy e •spezialmentein chi lo conobbe , e famigliarmente il
conversò , desiderio non ordinario ? Certa-mente che quello sarà il contrassegno ve-ridico y e'I paragone sincero duna veracee ben fondata amicizia
,quando col tem-
po la memoria del trapassato amico nons' estingue , nè lui morto muore ; ma vive
sempre, fresca , vigorosa e gagliarda , si
si mantiene. Amai quanto alcun altro ; equesta fu ben avventurosa sorte mia ; a-maiy dicoy il leggiadrissimo Poeta Tosca-no y r insigne Accademico della Crusca y
r oculatissimo sperimentatore , il pruden-tissimo e nobilissimo Fisico
, t erudito , il
dotto y il savio y il cortese, C onorato, il
gentile, e nella patria nostra chiarissimo,per tutte le parti del mondo rinomatofRANCESCO REDI d immortale memoria,e da esso fui sopra ogni possibilità di miabrama riamato, continuamente accarezza-to y onorato , lodato , ed in voce e negliscritti ; talché parca , che me in partico-lare si fosse egli posto innanzi per segno,ove gentilmente saettasse la sua generosacortesia. Cosi in ogni luogo , ad ogni sorta dipersone, si prendeva amichevole compiacen-za difar risonare il mio nome nelle sue lab-
bra,e d empierò di quello P orecchie an-
TLUX'l
cara de' Grandi, per acquistarmi coìr au-
torità sua qualche benigno posto nel lor
giudicio. lo per me in contraccambio gli
rendeva tuttora i miei umili ossequj, ed alui stava in perfetta unione d"amicizia le-
galo ; la quale cosi forti impresse nel miocuor le radici , che nè tempo , nè monepotranno svellere, nè dibarbicare giammai.Tra tutte quante adunque le prerogativa
e le doti , che il nobilissimo e gentilissi-
mo animo suo adornavano a maraviglia ,
ed arricchivano , ben han molta ragione
tutti , che il conobbero , ed io sopra tutti
di celebrare quella , che a me piace ora
dall altre trascegliere , deiramicizia lette-
rata. Eccomi dunque a soddisfare al pie-
toso ufìcio damico , e a consolare in par-
te il desiderio comune nato dalla mancan-za , e dalla perdita di tanto Uomo , confarvene nel miglior mudo , che per me si
potrà il ritratto ;dimostrandovelo CAmico
Letterato.
Quanto cera,quanto santa , e desi-
derabil cosa sia t amicizia, e quanti frutti
e comodi e vantaggi ne arrechi a chi fi-
na e leale ne la possiede,non occorre
che io in molte parole a sporre m' affati-
chi;
poiché torrebbe il sole dal mondo
,
disse colui, chi dal mondo levasse t ami-
cizia Ella le tenebre delle confusioni ede' travagli , che talora ingombrano e pre-
mono r anime nostre,co' dolci ed oppor-
tuni ragionamenti consolativi rischiara. Le
Jtxxii
felicitadi col gaudio, che dal cuore d'uno
amico nell' altro amico si versa, e dijfon-
desi, cresce incomparabilmente e rinnalza
e moltiplica. Il savio , dagli stoici , con
sublime ed invidiosa idea , e non per a-v-
ventura trovabile cosi di facile,Jigurato ,
che sarebbe egli costituito in solitudine
,
se non avesse davanti un lamico per ispet-
tutore e vagheggiatore delle sue doti ?
JJ interna sua felkità ,quantunque com~
pila per ogni parte fosse e perfetta ; tut-
tavia senza gli amici riuscirebbe manca edimperfetta ;
spuria inoltre ed illegittima è
in certo modo quella amicizia ,che dal bi-
sogno e dair itidigenza ne nasce , e a tu-
multo e a varianza soggetta. Ma quella
conciliata dalla similitudine de' costumi,
dal confronto de' genj , e che non sutCin-
teresse, o sul piacere, come quelle de'vol-
gari ;ma sulla bontà sola è forulata ; co-
me quella de letterati,quella ò , e addo-
marìdare si puote bella , buona e leale
amicizia. È una virtù t amicizia ,come
jiristotile vuole, e la cosa stessa il con-
ferma ; ed in essa atti virtuosi e morali
continuamente !t esercitano ,somministran-
do larga materia agli animi generosi e
gentili di spiegare quel bello , che dentro
tengon racclUuso. Gli uficj, i doveri, i con-
venevoli ,non sono cose tutte d' onestà e
di giustiziai Le finezze, le cortesie, le H-
heralitadi , le lealtadi , le gentilezze tutte
han per sorgente la bella amicizia, ììe vii-
Digitized by Google
XXXIII
tà adunque ' è F amicizia,
quegli che èamico si potrà dire ancora virtuoso ; manon dvl genere delle virtù speculative oiF intelletto ;
ma delle pratiche , o morali,
cioè costumato. Or chi potrà meglio esser
tale , del buon Letterato ? le btume Let-
tere , che da noi con titolo al lor pregio
inferiore , belle si chiamano , non essendo
altro in sostanza, che moralità per tutti i
buoni componimenti , cosi degli antichi,
come dé novelli , diffusa. Che se la forza,
e la leggiadria del favellare è uno aggra-
devole e poderoso incanto , che allaccia i
cuori , e tiene gli uomini per gli orecchi
con preziose catene , a guisa delC Ercole
Celtico, legati e stretti, dove si ritrova que-
sta maggiore,
che ne' Letterati ? i quali
ben hanno alle mani di che discorrere,
sopra [opere di Natura, del Cielo , d' Id-dio
, sopra la varietà della fortuna e decasi umani
, che hanno in veduta tutta
T antichità , che per amici si tengono efamiliari i buoni Scrittori, che si dilettano
maravigliosamente nelle loro belle e buo-ne sentenze
,e che la gran Poesia
, comeogni bene armonizzato intelletto dee avercara , così essi hanno in sommo pregio ?
La loro memoria di quante notevoli coseè tesoro, e come fan pendere le genti dal-
la lor bocca i savj e scienziati uomini, li
quali i loro belli e profondi sentimenti, ele loro per lungo studio formate osserva-
zioni , con agevolezza indicibile in pochiRedi. Opere. Voi. l. c
XTXITmomenti apprendono , mentre eglino consoavità mirabile amando di comunicare le
lor cose , senza invidia , o riservo, ne le
compartono. Le toro accoglienze son na-turali e liete , non isforzate e finte , nella
loro fronte aperto si scorge f animo ; everso chiunque egli subodorano
, che dei
medesimi studj si diletti, prontissima corre
là la benevolenza e f affetto , sincera be-
nevolenza , limpido affetto f base e comin-
ciamenta di stabile e di perfetta amicizia.
E come quegli , che sono impastati,per
cosi dire , di vera e generosa gentilezza ,
odiano i vani, gT iruitìU, gli affettati com-plimenti , poiché non son usi a pascersi ,
nè a pascer altri di vanità, l'osto discen-
dono a una Jamigliarità nobile, a una di-
mestichezza gentile, di dignità piena e di
grazia. Ogni lor moto ,ogni gesto , ogni
Tegumento è dal garbo e dalla disinvol-
tura e dalla cortesia accompagnato. Inno-
cente il trattenimento, poiché in quello si
tratta de comuni sutdj , si recitano a vi-
cenda i componimenti , con fare sopra que-
amichevoli critiche riflessioni, così for-
mandosi, e ripulendosi il giudizio. Non
s' intacca , come ne' circoli de' plebei. Tal-
trai fama , non si mormora delle pubbli-
che faccende , nè delle cose si discorre ,
che a noi non appartengono. Le Muse più
gioconde, le Grazie più delicate, le ame-nità più squisite , te finezze (€ ingegno più
rare, le novità letterarie più curiose , le
Digiiized by Google
xxxtdisputazioni pià vaghe formano il passa-tempo, e i ra^onamenti piacevoli insieme
e onesti e fruttuosi. Sbandite adunque so-
no da tali letterate conversazioni le invi-
die , le maldicenze , le smoderate allegrie,
le nauseanti oziosità, i viziosi e gli oziosi
discorsi. Niente di frivolo , di licenzioso,
di stolto;
il tutto pesato , moderato , sa-
vio. Onde uno sempre non pe^iorato
,
non depravato e guasto , ma pià dotto neritorna, e migliore. Ben tutto questo si rav-
visava nella dotta e gentile conversazione
del Redi, il quale parva fatto a posta, emandato dal Cielo espressamente quaggiìt,
per instiIIare soavemente ne cuori di chiun-
que gli s' appressava ,F amore degli studj
e delle Lettere, e per inspirare nello stes-
.so tempo F amore delF amicizia , che perquelle massimamente s' acquista. O geniodel Redi amorevole, benigno , ammiratore,ed amatore de Letterati , e degli studiosi
grandissimo l che nella censura esercitava
la finezza del suo giudieio , nella lode fa-cea spiccare sua gentilezza amichevole ;
gli altrui studj favoriva , sollevava,
pro-
moveva ; onde molti insigni personagginelle Lettere sotto la sua guida , e sotto
i suoi auspici a eccelso posto di gloria
pervennero, col suo finissimo discernimentogli scoperse , e scoperti gF incoraggiò , e
incoraggiali gli formò,gli allevò
,gli mo-
strò al mondo, e la nostra età. ne rendè
pià onorata e pià chiara. Al contrario di
Digitized by Google
XXXTtquei falsi amici e falsi, letterati
(che non.
vi ha cosa si buona tra noi, che' non ma-ligni nella sua corruttela , e che soggetta
non sia a guaslamento, e a falsificazione')
i quali pieni d' orgoglio , di vanirà , dipresunzione , iT invidia , ciechi amatori di
se stessi , disprezzatori rf altri , mal ve.g-
giono chiunque s' apparecchia ad aver po-sto tra i Letterati, amando eglino rtesser
soli gli ammirati e i iodati, onde invidio-
se gore ne nascono, e talora sanguinolenti
contese , con iscialacquamento di tempo,
il quale più utilmente compartire si dove-va , e con accattar brighe e travagli senza
fine , e porre in discredito e in vilipendio
le Lettere , le quali dove aveann a essere
iT amicizia conciliatrici , fanno colle acer-
be liti e nimistà odiosi a un tempo , e
ridicoli comparire nel teatro del mondo i
loro seguaci. Ala lungi , lungi dal bencomposto cuore del Redi un cosi fatto
abuso, e reo maneggio delle Lettere
, chedella pace amiche sono e compagne , e of-
ficiosi e gentili fanno gli uomini, in cui
elle daddovero, e legittimamente s'appren-
dono, e gli oltraggiosi tumulti fuggono, edalle inquiete risse lontane stanno. Esem-pio di letteraria moderazione Jìa sempre il
Redi , rarissimo ed immortale : poiché il
suo dar contro , che non faceva egli se
non di rado , e per grandi cagioni , e co-
stretto,non era un offendere , ma un ob-
hligùre;
il rispondere, alle opposizioni, un
Digilized by Google
XXXTllsemplicemente difendere se stesso senzaoltraggiare altrui ; anzi congiunto semprecolla stima di quello^ a cui egli obbligatodi rispondere si trovava. E per tutto rUu~
|
ceva t amore alla verità,la quale essen- I
dogli sopra tutte le cose rara , non dimi-j
nuiva però punto quella pia affezione^ esolenne carità , che a tutti i letterali por^tava. Tutta la vita sua in somma era uncontinuo esercizio di letterata amicizia. E
|
che altro fu mai quella divozione verso la
Casa regnante di Toscana fedelissimamen-te fino altultimo spirito coruervata^ nella
cui Corte scuola perfettissima tC ogni piùsovrana virtù , allevato , non solo né con-
sigli di sua nobil professione , alla qualeraccomandata era la salvezza di coloro
,
da cui pende quella de' popoli’, ma in affari' ancora ,
e maneggi di confidenza edi fedeltà fu sovente impiegato; per tutto
dando sa^o di sincero e leale amico ,
non già della fortuna , ma delle personemedesime : e ben lo mostrò la savia e pru-
dentissima Granduchessa Vittoria, nel cuialto giud’cio trovò egli ji grazioso posto
,
che essendo da lei con segni di stima edaffetto continuamente riconosciuto
; fu dalei con ultima e vera dimostranza, di no-bil lascito onorato, L' amicizia de' grandinon coltivò egli per farsi abuso di suapotenza , col precipitare questo e quello ,
ma unicamente per beneficare le genti, eavanzarle, A tiiuno dannoso, a tutù uU-
XXXVIUle. Ldifigi da lui la vanità e la burbanza.
E in tanto credito , in tante ricchezze ,
che egli onoratissimamenle acquistò, fu
segnalatamente modesto, e sempre si stette
umile in tanta gloria. Amico egli era ai,
discepoli suoi , a quali il suo sapere, noncon austero sopracciglio , ma per modo di
grave e piacevole conversazione , comuni-cava , andando con essi in volta per la cit-
tà; esercitando sua gentil facoltà a bene-
fizio delPuman genere. E tra questi buonaparte trascegliendo, e le comunità di buonimedici provvedeva , e le cattedre di eccel-
lenti lettori forniva. A' principianti giovani
amico, i quali nelle sue orecchie deposi-
tavano le primizie de' loro studj,e dalle
sue esortazioni prendevan lena, c le mos-se per r onorata loro carriera. I letterati,
e dotti uomini colla sua autorità, che ap-
presso tutti acquistata s' era grandissima ,
con singolare benevolenza abbracciando
,
ben faceva vedere , salda base delTamici-
zia esser le lettere;
poiché non solo i
presenti, ma i lontani ancora di tutte le
regioni , ove pur fosse politezza e civiltà ;
colta infinita dilezion sua, e col letterario
mantenuto commercio , a se univa e com-prendeva. O letteratura adunque nel Redifontana di bontà e d" amicizia ! Traggansiindietro la superbia e T arroganza dallasua umanità e gentilezza disperse e confu-se. Fugga r invidia davanti alla sua cari-
tà, e confessi, che nel vero letterato non
Digitizod by Google
XXXIXHti luogo. ytìTncizia
, pace , concordia, be^nevolenza, ufizj scambievoli, ilarità, schiet-
tezza , cortesia , bontà, generosità
, bene-ficenza ,
queste,queste son le virtuti so-
lenni e legittime, else fanno la corte dellaletteratura. Niuno andava a lui, che con-•solato, e insieme ammaestrato non si par-tisse ,
ammaestrato dalla dottrina , thè egli
dissimulantemente ancora, e per acconciomodo instiilava ; consolato dalla naturaibontà, che tome gioja in lui risplendeva, ein ogni gesto, e in ogni piccolo moto suo,e nel silenzio medesimo a conoscer si dona-va ; bontà di cuore
,fontana viva di nobi-
le e di 'verace cortesia. Giovani voi , chedal dolce desio di gloria spronati, abban-donando generosamente gli spassi, e i di-
lettosi inviti di vostra fresca età non ascol-
tando , aie erto e faticoso poggio della
virtù V incamminate, dite, chi vi fece darei primi passi ,
chi 'vi diè mano , chi -vi
scorse , chi vi confortò nel gran 'viario ,
ehi i vostri sudori con sobrie ed aggiusta-
te lodi inghirlandando asciugò, se non il
Bedit Al Bedi infiniti debbono gli onoraticominciamenti de' loro studj, e i forti pro-
gressi in quelli fatti. Fìsonomo gentile de-gT ingegni-, in questo emulator di Pittago-ra, a prima fronte gli squadrava, gli rav-
visava , ed una •volta conosciuti , non ^lasciava in pigro òzio intristire-, ma qualperito signor di terreni , •volea , che tut-
tora si colti'i'asseso , e con t occhio sue
Digitizad by Google
XLvisitandopU impingitava.’ Gioitami (/fa
dir cosa in me succeduta, perché da que^
sta si conosca la virtù della gentUezuiamichevole di si gran letterato. Produci-
tnce ella fu in me unicamente(rendasi
onore alla verità ) di tutti quei poveri
parti deir ingegno mio , qualunque egli si
sia , aNevati e cresciuti sotto la luminosa
ombra di sua gentil protezione ; che benmnsttava in se stesso trasfuso lo spirito
e V genio nobilissimo di quelt antico suo
cittadino , che alludendo , credo io , adArezzo sua patria , insigne , tra C altre
anticamente per vasellamenti di bella ter-
ra , Augusto Imperadore in una facetalettera al medesimo indirizzata , rapporta-
ta da Seneca , Diaspro per ischerzo ap-
pellò de' Vasari ; di quel letterato Corti-
giano io dico disceso per lunga serie da-
gli antichissimi Signori di Toscana, prin-
cipal lume deltAretina gloria il gran Cil-
nio Mecenate . nome ornai più di virtù ,
che di persona ; favorendo a guisa di
^quello nella Corte di Toscana le lettere ,
• e me in particolare come di quello stu-
dioso e bramoso di quelle,proteggendo ;
e di questo suo generoso favore ne ho sen-
titi , e ne sento pur tuttavia solidissimi
frutti. Città nobilissima di Toscana , edantichissima, che quasi dal santo linguag-
• gin per figura dC eccellenza Arets cioè ter-
ra ti appelli, chiara tTuomini, e in guerra
* • in pai» famosi , clte inventivi hai gFin-
Digiti,: od by Googlc
ffegni ed eloffuenti , come un tuo Guidopadre della moderna Musica i o tramai-tri molti., che per brevità io tralascio., i
Carli Marzoppirù , i Ldanardi Bruni, già
letteratissimi Segretari della Fiorentina
Repubblica-, e i tanti Accolti per lettere,
e pià d' uno anche per sacra porpora in-
signi, tutti- nella nostra fiorita Cittadinan-
za gloriosamente innestali ; nobili e 'ver-
deggianti rampolli tuoi abbondevolmenteil dimostrano
,e fin f istesso Petrarca
gran cittadin nostro, cui nel tuo grembonascente con favorevole aspetto rimiraron
le Muse ;ben può , o città di' Arezzo ,
'gioirti ihcuore , come di antica e buona' madre , nel eedere in questi ultimi tempi
la gloria del tuo nobil figlio , e insieme
nostro cittadino Francesco Redi, fiorire e
distendersi dappertutto ; portendo sopra il
capo tuo corona dC onore luminosa,
pre-
ziosa, immortale. Tanto avea la gloria di
fiti vivente oltre ogni uso umano, e sopra
ogni credere , qual chiara fiamma caligi-
noso fummo sormorUata, e sopraf/atta Fin-
'vidia, che non aspèttasU tu a riporlo tra
t ritratti degt illustri tuoi nobilissimi citta-
dini nel palagio pubblico per segno di
onoranza , come degli altri solevi tu fareappresso morte ; ma vivo ancora , e spi-
rante lo coruacrasti alla gloria-, imitandoin ciò il glorioso esempio del tuo e nostro
sovrano oggi Regnante -, che in bronzo lui
vivente imprimendo in tre artificiose meda-
*LII
fflie con ingegnosi rovesci alludenti alle
tre facoltà^ che in eccellente grado posse-
deva , di Filosofia , Medicina, Poetica ,
fece correre pel mondo nobili , singolari ,
eterni contrassegni della di lui stima verso
, i grandi letterati ; tramandatagli di lungamano , come retaggio , dai suoi gloriosi
maggiori. E ben dovevi tu molto a lui
,
cara patria , sì per» la .iua chiara virtù, ecelebratissima fama, cerne ver Faffettuosadivozione , colla quale te , amantissimamadre sua , riveriva ed oiurruva. Che eglif
che tutto amore era ,e delF amicizia esi-
mio coltivatore , chiaro vedeva, quanto gli
amori nostri trar debbe a se la terra, checi produsse e ci allevò e crebbe, e di beni
e di parentele e (F amicizie ci forni. Sospi-
rava egli nelle tue braccia , come in dol-
ce porto, di finire i brevi e mortali affa-
ticati suoi giorni ;ma quella seconda pa-
tria la bella nostra Fiorenza , che se Fera
come caro figliuolo adottato , e la quale
egli a tutto suo potere onorava e con Co-
pre e coi, detti l^gF ingegni Fiorentini, tra
C altre , sempre al cielo innalzando ) nonlo lasciò mai da se partire, e con ristret-
tissimi vincoli lo ritenne. Cosi era egli per
la sua virtù necessario , utile , e a ariti
giocondo e grazioso. Laonde, o nobil pa-
tria del Redi ,non ti stiegnare , se nelle
sue amabili ed ammirabili doti perduto, e
dallo stupore rapito, rutila io dico de'suoi
onorati maggiori ,che con solermi arnba-
Digitized by Google
XLIII
scene f e colle principali magiscrature si
segnalarono ; nè tengo in conto di lode
r antichità di sua famiglia , e F antico enoifello lustro di quella
,quando
, comedalla luce del sole i minori lumi s abbat-
tono , cosi dalla sua bontà vera, e piU in-
trinseca nobiltà, gli altri quasi esterni or-
namenti, vengono oscurati e coperti. Evoi, uditori gentilissimi, contentatevi, cheproseguendo il filo del mio discorso
, io
descriva alquanto accuratamente le ma-niere, delle quali egli si serviva nelle sue
amicizie , e per quanto amate le lettere
,
vi prego ad essermi cortesi della vostra
attenzione. È cosa innata a quei che stu-
diano , e che compongono , il participare
le cose sue a qualche persona amica edintendente , non solo per comunicare la
gioja, che uno prende di sue fatiche, qualpadre , che ha caro di mostrare i suoi
pargoletti , ma ancora per ammendare i
falli, e perfezionare col giudicioso consi-
glio , e coir amorevole censura delF amicoi suoi parti. Per ritrarre adunque una si
lieta giocondità e utilità insieme conside-
rabile, correva io dal Redi a comunicar
le mie bagattelle ; ed egli mostrando di
fame alcun conto , e per F affetto ancoraforse , e senza forse assai maggiore diquello , che elle per loro si meritassero ,
animo mi faceva e corag^^, e a nuovi enuovi cimenti sempre più rrC invogliava.Contasi degli anticìù una molto buona *
XLIV
bella usanza ,/ic’ giorni cortissimi di Di-
cembre dedicati a Saturno, e perciò Sa-
turnali chiamaà , il regalarsi e carezzarsi
scambievolmente con certe amorevolezze epiccoli regalucci, che essi addimandavanoXeuia , ovvero doni ospitali , c con tfual-
che bel distico , o motto accompagnando-,gli
,crescer>an pregio al regalo. Le anti-
che feste Saturnalizie dir si poteano rin-
novellate al tempo del Redi , anzi fatte
perpetue di tutto V anno. Con amabilepersecuzione regalava egli con doni e vi-
glietti piace voli continuamente gli amici ,
e me fìequentissimamente e particolarissi-
mamente ; nè i regali erano di pompa e
di burbanza , la cui liberalità assomigliar
si puote a diluvio tC acqua, che tosto man-ca
, e dilavando del terreno la scorza, nè
addentro penetrando , in breve ora arido
il lascia ed asciutto. Regali erano per usa-
re la frase d"Omero, e piccoli e cari, e a
guisa di minuta pioggerella e spessa, che
non lo mostrando bagna ; t animo e la
memoria , lasciatemi dir cosi ,inzuppavan
dCamore. Non vi credete però,queste li-
beralitadi del Redi senza alcuno interesse,
che vi era e ben grande ; ma che lungi
dal nojare quegli, dai quali ei T esigeva,
recava loro vantaggio. Interesse era questo
letterario ; e co' regali, cioè coi contrasse-
gni di sua stimabilissima confidenza ed
ajfe'to e zelo dell altrui profitto provoca-
va sonetti, provocava canzoni^ provocava
Djgiliz^ by Google
XLT
ffrofe. Non bisognava venire a Ini conmani, vote dei doni delle Muse, i quili alui
,qual Nume delle lettere , venivano
da tutte le parti in mvravif^iosa copia
presentati divotamente ed offèrti. Oltre atanti in sua lode componimenti, e di stra-
niai letterati, e di nostrali, che un granvolume compongono', quante primizie di’ in-
gegno a lui dedicatei quante Opere uscite
alla luce sotto il suo nome ebbero più si-
cura la fuma, e goderono meglio dell au-
ra del popolar favore', e si poterono pm-mettere dal suo giudicio, e dalt approva-zion sua ben lunga vita. Il più bello , il
più legittimo, il più tranquillo, il più sta-
bile , il più sicuro , il più glorioso impero,
si è quello, che sopra i volontarj si eser-
cita. Or non vi ha cosa al mondo , a cui
r uomo per altro superbo animale e ritro-
so, e del comando mal sofferente, più di
genio si renda e di buon grado , e congajo cuore sottomettasi , che alla virtù ,
al sapere accompagnati dalla cortesia edalla bontà. Queste doti essendo nel Rediin sovrana guisa rnaravigliose, vi stupirete
forse, cortesissimi uditori, e parravvi stra-
tro il mio dire , s' io vi dirò : questo jì
affabile , jt amoroso , si cortese , si rispet-
toso verso di lutti, e si benigno e man-
sueto gentiluomo, essersi da per se stesso,
senza che egli si dispa/a, eretto un trono,
fabbricatosi un regno ; io//ra gente nonvile già e volgare
; ma nobile e scelta e
Digitized by Google
XLTI
d animo signorile,
quale si è la nazioneper tutto il civil mondo sparsa dei cari
alle Muse , degli studiosi , de' letterati. Olettere , o amicizia ! Biasimarono i savjantichi il tenere f amicizia di molti
, cheessi chiamarono con un solo vocabolo Po-liJiUax e ciò perchè essendo i genj e le in-
clinazioni degli uomini tanto strane tra
loro e diverse, e le massime ed i costumi
e le maniere cosi varie e moltiplici ; c ri-
chiederulo la soda e vera amicizia unaunifornìtà e concordia di voleri , malpuote un animo solo alla sua guisa for-mato, reggere a sì gran piena , soddisfare
a tanti , e accomodarsi ad ima si prodi-
giosa diversità di complessioni e dumori-,
non saprebbe andare a versi delCuno, chenon disgustasse V altro ; nè così in tanti e
tanti personaggi trasformarsi , che egli se
non distruggesse , e in varie parti distrat-
to , e per così dire , stracciato , non per-
desse insieme, colla libertà, il riposo e la
pace. Or la forza della letterata amistà è
tale e sì fatta , che ottimamente congiu-
gner si puote, e conservare con molti sen-
za far torto a niuno , senza alienare nin-
no , senza nimicarsi niuno ; ma co t at-
trarre, con ritenere ,
con obbligare tutti
quanti. Perocché quantunque alcune garetra letterato e letterato inter\’ensano : chenon vi ha cosa , come s è det'o
,per in-
nocente che sia, che la sua corruttela nonabbia’, il vero e perfetto letterato tuttavia
Digilized by Googl
XLVII
ia (fueUe si tien lontano , e di meszo ; odove può , e senza turbare la sua tran-
quillità, amore ed amicizia ed unione me-sce ed infonde. E di che tempra mai sonquegli amici, che il leuerato sija\ Amicinon di fortuna , che colla fortuna si mu-tano
;ma amici di virtù , che colla virtù
deir amico , che non abbandona chi (a
possiede, si si conservano e mantengonsi.
Che quando tutti per impossibile al lette-
rato gli amici falliscano, ha pur egli amicicerti e sicuri dove ricorrere , e co' quali
familiarmente può sèmpre, e con sua gran-
de giocondità ed utilità conversare. Questisono i sav/ antichi , che nelle carte la-
sciarono eternati i loro pensieri. Innocen-te e gustosa con versazione, che fa popolonella solitudine , rallegratrice nelle pro-
sperità , nelle afflizioni consolatrice , cheper lutto il letterato accompagna
,per
tutto r attende, ed è tutta a lui. La qualcon versazionc ed amicizia da primi annigustata non intermesse mai ; tra i suoi piùgravi maneggi ancora e occupazioni
,ed
ebbela sempre cara, e coltivolla e accreb-
bela fino alt ultima vecchiezza ; di cui si
può con verità dire, che ella fosse la nu-trice e 7 sostegno. Quella malvagin età ,
che con tacilo ]<ie.de,non aspettata so-
pra^iugnendo colla dolorosa schiera di
tutti , come si dice, i mancamenti sen vie-
ne-, in cui non vi ha cosa la più crudele,
ciré t accorgersi d'essere, come al più de.
XLVIII
uomini idioti avviene , odioso altrui in
quella età', or questa in virtà delle lettere
si fa men grave a se e ad altri j ma chedissi men grave ? leggiera e gioconda, confelicità si trapassa. Che bella cosa i anti-
co uomo la vita sua n prò del pubblicoonoratamente condotta, e in nobili cose
esercitata ,e gli accidenti in quella oc-
corsi, esempio ai futuri , e tante cose ai
suoi tempi succedute con memorabil fa-condia rammemorare', stanno al suo dire
come incantate le persone, ravvisando
nel volto suo una virtù consumata , e il
capitai di virtù in tanti anni ammassato.Che bello spettacolo era al Redi il vedersi
dintorno or questo or quello da lui bene-
ficato e protetto, e con ogni sorta tf ufi-
zio favorito, rendergli spontaneo omaggioe tributo e sacrificio dC ossequio ? I libri
da se composti, de quali, per esser notis-
simi al mondo, e per t amenità della dot-
trina e per la pulitezza dello stile , cele-
bratissimi, e che viveranno sempre nella
memoria de' secoli, io non parlo, per noniscemare colla bassezza del mio ingegno i
loro pregi, e che meriterebbero per loro
stessi un lungo encomio a parte;
questi
libri pure stampati e ristampati,quai di-
letti figliuoli far corona al loro padre ,
dolce rimembranze delle passate fatiche
,
che mirabil vista mai era ella 7 De' quali
quel molti, che Esperienze naturali conten-
gono fatte le prime di esse sotto i grandi
XLIX
uuspicj del Granduca Ferdinando li. e
t altre sotto il presente felicemente Re-
gnante , lo mostrano amatore delta verità,
e per conseguente alla verace amicizia ,
che nelle lettere si ritrova, attentissimo. I
sonetti pieni di sentimenti d'amore nobile
e gentile, che purità tli lingua e unità di
pensiero, doti da lui sommamente in tal
componimento ricercate, a maraviglia pos-
seggono, degnissimi tutti di vedere la pub-
blica luce,per amoroso e gentile spirito
Io dichiarano ,natura attissima alla buo-
na e leale amicizia ; la quale egli pienis-
simamente dimostrò neltultimo suo ammi-rabile poetico componimento , il Ditiram-
bo io dico di cosi varj e bizzarri metri
tessuto , e con bel furore dettato , ame-nissimo e lieto e spiritoso Poema, da dot-
te e squisite e ricche Annotazioni accom-
pagnato, nel qiuile tra tanti ragguardevoli
personaggi e letterati insigni e di Fioren-
za e d^talia e d Europa , non isdegnò
( con tenerezza il rammemoro ) non isde-
gnò queir onorato vecchio di porre il miobasso e ignobil nome , onde in me
,più
che in ogni altro , spiccò la forza delt a-
micizia , che non avendo altro merito che
quello ,che essa aver mi faceva, trattomi
dalle mie tenebre,
mi.fece comparire nel
teatro del mondo luminoso , e adorno , e
se dir mi lice, fondato sull eternità do-
vuta ai suoi scritti, anco immortale, fsugìtefti a penna di toscani antichi autori ,
Redi, Opere, Val. d
I
c he e^li molti possedeva , e rarissimi, e
che tanto gii seri’irono per la grand'Operadel V^ocabnlario , a cui egli non ordina-riamente contribuì , e provvide anche ab-bondantemente in futuro, non F abbando-navano mai, ma respirando egli dalle vi-
site , da' negozi , dagli esercizj , nella do-mestica quiete e solitudine , a se il chia-
mavano, e a gara facevano ,
per rosi di-
re , eC avere da lui un' occhiata, acciocché
dii'loro muti ragionamenti cuaiche gmja e '
gentilezza scegUesse, per adornai ne la sua i
favorita , la sua diletta , ia cara sua to-|
scana fa vella , di cui ei;li,per gli meriti I
verso della medesima , e per le. grandi fa-tiche durate in quella fa inugnito in que-
sto Fiorentino studio del titolo di IjCttore.
II rivolgersi per la memoria quanto oltre
al nostro dolce idioma , la cui cognizionef
colla bella unione delle lingue volgari , edelle antiche erudite ancora mirabilmente
raffinò, e ad alto punto condusse, la na-
turale Scienza ,la Notornia, la Medicina^
da lui si può dire senza invidia e miglio-
rata e rifatta , alle sue diligenze doveva-
no, dir esattezze sue, alle sue attenzioni
e premute, non era questo a lui un riem-
pirsi la mente di cure , e rimisurando col
pensiero le buone e gloriose cose da se
. operate , un ringiovenire ad onta degli
anni, in cuote alta vecchiezza! Per que-
sto , per questo , malgrado dei mali cito
r affù^evat^o , delF età che il premeva » si
tnoneenne egli sempre gajó 6 tranquillo
con vivacità (T occhio « e secondo quella
statone, con bontà ancor di colore. Quin-di la nera morte temendo per ventura
d" assalire a fronte aperta , chi infinite
volte in altri fugata C aveva e sconfitta •
preselo con agnato , e di furto ( in unacittà nobilissima della nostra Toscana
, eper lo suo insigne famosissimo studio ri-
nomatissima , ore uvea egli tante suecreature , colle quali intratteneva virtuosa
e bella amistà ) e il fece passare dal son-
no air eterno riposo,quasi satollo convi-
tato partirsi da questa vita mortale^ comeda breve convito, per portarsi alla nonsazievole mensa celeste , dove il suo buoncostume e la sua pietà, che egli sia sicu^
ramente andato , ci persuadono. E bene aun animo sobrio e gentile un si fatto dol-
ce passaggio disconveniente non fu , nonda mortali agonie , non da angosce , nonda travagli
,non da dolori , non dalla
terribile apprensione di morte accompa-gnato
, ma placido , soave , veloce , sciol-
to : proprio delle belle anime , che standoeUtaccate d corpi per' mera necessità natu*
rate , non per passionato affetto , stan
sempre pronte sulf ale per rivotarne a unpaese più bello « dona ebber ! origine ,
donde discesero. Portato il suo cadaveroda Pisa ad ylrezzo , e per Fiorenza pas-sando
, ricevè da per truto , come era il
dovere, da queste tre città , devote alla
tìt
sua memoria, tributi di dolore ossequioso f
e di pianto. E nel passare che per neces-
sità ebbe a fate dalla casa di mia abita-
zione;qual cuore
,pensate voi, che fossa
il mio , uditori , in dar t ultimo addio aquel corpo
,da quella casa tanto da lui
per sua bontà frequentata ; e nella qualetanto volentieri il carissimo amico si trat^
teneva 7 Abbandono il tutto alla vostra
considerazione, quanto j’ incrudisse allora
la piaga ancor fresca e sanguinante del-
T anima mia,per quella vista , eh' io non
so ,nè voglio descrivervelo.
Or godi adunque , Anima bella, spe-
dita e disciolta dalP impaccio mortale , il
premio delle onorate tue fatiche', e della
vita impiegata tutta , e spesa a prò del
pros'simo , il guiderdone di tue virtù,per
le quali risplendesti , e fosti amico vero ,
quale si è f amico letterato. Virtuosa e
santa cosa è Tamicizia, e celeste e degnadel cielo ;
poiché ella è P epilogo di tutte
le virtù. In essa la prudenza campeggia ,
nel consigliare , nelP ajutare , nel confor-
tare , nel consolare , nelP illuminare, nel-
P indirizzare P amico. Ha luogo dove eser-
citarsi la fortezza nel soffrire per P amicoincomodi, disagi
,pericoli, e nelP eseguire
con prontezza e con efficacia ciò eh'è suobene ; non risguardando ancora di disgu-
starlo a salute , anzi che di lusingarlo apregiudizio. Colle amabili persone impiegaP amicizia la temperanza , e con tutti f-
I
nalmente neìT amicizia spicca a maraviglia
la reina delle virtù la giustizia , di cui è
propria la fedeltà , la ragione , il dovere,
E avendo io mostrato qui in fine Camici-
zia epilogo delle virtù , voglio che questo
senza altra arte o manifattura oratoria ,
basti dC epilogo , e di riconto alC Orazionmia medesima ; nella quale secondo la miadebolezza, CAmico Letterato mi sono in-
gegnato nella persona del nostro Accade-mico FRANCESCO REDI, di dimostrarvi.
*
\,
Digitized by Google
X
BACCOIN TOSCANA
DITIRAMBODI
FRANCESCO REDIAccademico della Ciwca.
Deir Indico Oriente
Domator glorioso il Dio del vin»
Fermato area 1’ allegro suo soggioru*
A i colli Etruschi intorno;
£ colà dove imperiai palagio
L’ augusta fronte inver le nubi innalza
Sul verdeggiante pratto
Con la vaga Arianna un dì sedea,
E bevendo, e cantando
Al bell’idolo suo così dicea.
Redi. Opere, Voi, /. i
Se deir iiTe il sangue amabileNon rinfranca ognor le vene,
Questa vita è troppo labile ,
Troppo breve , e sempre in pene.
Si bel sangue è un raggio acceso
Di quel Sol , che in elei vedete ;
E rimase avvinto e preso
Di più grappoli alla rete.
Su su dunque in questo sangueRlnnoviam l’ arterie e i musculi;
E per chi s' invecchia , e langue
Prepariam vetri majusculi:
Ed ili festa baldanzosa
Tra gli scherzi , e tra le risa
Lasciam pur, lasciam passare
Lui , che in numeri e in misureSi ravvolge, e si consuma ,
E quaggiù Tempo si chiama ;
E bevendo , e ribevendoI ]ìensier mandiamo in bando.
Benedetto
Quel Claretto,
Clic si sprilla in Avignone ,
Questo vasto Bellicone
Io ne verso entro ’l mio petto;
Ma di quel , che sì puretto
Si vendemmia in Artimino,Yo’ trincarne più d’ un tino ;
Ed in si dolce e nobile lavacro.
Mentre il polmone mio tutto s'abbevera,
Arianna , mio Nume , a te consacro
II tino, il fiasco, il Ixitticin, la pevera.
Digilized b iioCKjle
ÀecQsat*,
Tormentato
,
CondannatoSia colui
, che in pian di LecorePrim’osò piantar le viti:
Infiniti
Capri e pecoreSi divorino quei tralci
,
£ gli stralci
Piogaia rea di ghiaccio asprissimo;Ma lodato
,
Celebrato
,
CoronatoSia r eròe , che nelle vigneDi Petraja e di CastelloPiantò prima il Moscadello.
Or che stiamo in festa, e in giolito
Bei di questo bel Crisolito.Ch’ è figliuolo
D’ un magliuolo
,
Che fa viver più del solito;Se di questo tu berai
,
Arianna mia bellissima,Crescerà si tua vaghezza,Che nel fior di giovinezzaParrai Venere stessissima.
Del legpiadretto
,
Del SI divinoMoscadel letto
Di MontalcinoTalor per scherzoNe chieggio un nappo.Ma non meappo
^
"Bigifeed by Google
A
A berne il terrò:
Egli è un vin ,eh’ è tutto grana
Ma però troppo mi saria.
Un tal vino
Lo destino
Per stravizzo , e per piacere
Delle vergini severe.
Che racchiuse in sacro loco
Han di Vesta in cura il foco;
Un tal vino
Lo destino
Per le dame di Parigi
,
E per quelle
,
Che si belle
Rallegrar fanno il Tamigi :
11 Pisclancio del Coione
,
Onde ricco è lo Scarlutu ,
Vo’, che il bevan le persone ,
Che non san fare i lor fatti. —
Quel cotanto sdolcinato, r*^
Si smaccato ,
Scolorito ,snervatello
Pisciarello di Bracciano
Won è sano
,
E il mio detto vo’ che approvi
Ne’ suoi dotti scarubelli
L’ erudito Pifmatelli ;
E se in Roma al volgo piace
Glie lo lascio in sanU pace :
E se ben Ciccio dAndreaCon amabile fierezza
,
Con terribile dolcezza
Tra gran tuoni d’ eloquenza
5Nella propria mia presenzainnalzare un di volea
Quel d’Aversa acido Asprino,Che non so s’ agresto, o vino.Egli a Napoli sei beaDel superbo Fasano in compagnia
,
Che con lingua profana osò di dire,Che del buon vino al pardi me s'intende;Ed empio ormai bestemmiator pretendeDelle Tigri Nisee sul carro auratoGire in trionfo al bel Sebeto intorno;Ed a quei lauri, ond’ave il crine adorno.Anco intralciar la pampinosa vigna ,
'
Che lieta alliba in Posilippo e in Ischia;E piu avanti s innoltra, e in fin s’arrischiaBrandire il Tirso, e minacciarmi altero:Ma con esso azzuffarmi ora non chero;Perocché lui dal mio furor preservaFebo e Minerva.
Forse avverrà, che sul Sebeto io vogliaAlzar un giorno di delizie un trono:Allor vedrollo umiliato, e in donoOfferirmi devoto
Di Posilippo e d’ischia il nobil Greco;E forse allor rappattumarmi secoNon fia ch’io sdegni, e beveremo in trescaAll’usanza Tedesca;E tra r anfore vaste, e l’ inguistare >
Sarà di nostre gareGiudice illustre
, e speltator ben lieto
Il Marchese gentil deir Oliveta,Ma frattanto qui'sull’Arnolo di Pescia, di Boriano,
Il Trebbiano ,il Colombano
Mi tracanno a piena mano ;
Egli è il Tcro oro potabile
,
Che mandar suole in esilio
Ogni male inrimediabile;
Egli è d’ Elena il Repente ,
Che fa stare il mondo allegro
Da i pensieri
Foschi e neri
Sempre sciolto, e sempre esente.
Quindi avvien, che sempre mai
Tra la sua Blosoiìa
Lo teneva in compagnia
Il buon vecchio Ruceìlai ;
Ed al chiaro di lui ben comprendea
Gli atomi tutti quanti, e ogni corpusculo,
E molto ben distinguere sapea
Dal mattutino il vesj>ertin crepusculo.
Ed additava donde avesse origine
La pigrizia degli astri , e la vertigine.
Quanto errando, oh quanto va
Nel cercar la veriti
Chi dal vin lungi si sta !
lo stovvi appresso , ed or godendo ac-
corgoini ,
Che in bel color di fragola matura
La Barbarossa allettami
,
E cotanto dilettami,
Che temprare amerei T interna arsura.
Se il Greco Ipocrate
,
Se il vecchio AndromacoNon mel vietassero.
Nè mi sgridassero.
by Google
Che suol talora infievolir lo stomacoLo sconcerti quanto sa ;
Voglio berne almen due ciotole.
Perchè so mentre eh’ io votole
Alla fin quel che ne va.
Con un sorso
Di buon Corso,
O di pretto antico Ispano
K quel mal porgo un soccorse,
Che non è da Cerretano :
Non fia già, che il cioccolatte
V’ adoprassi , ovvero il tè ,
Medicine così fatte
Non saran giammai per me :
Beverei prima il veleno ,
Che un bicchier ,che fosse piene
Dell* amaro e reo caffè :
Colà tra gli Arabi
,
E ti-a i Giannizzeri
Liquor sì ostico
,
Sì nero e torbido
Gli schiavi ingollino.
Giù nel Tartaro
,
Giù nell’ ÈreboL’ empie Belidi 1’ inventarono
,
E Tesifone , e 1’ altre Furie
A Proserpina il ministrarono;
E se in Asia il MusulmannoSe lo cionca a precipizio.
Mostra aver poco giudizio.
Han giudizio , e non son gonzi
Quei Toscani be zi tori
,
Che tracannano gli umori
8Della vaga e della Bionda, '
Clic di gioja i cuori innonda.Malvagia di Montegonzi ;
Allor che per le fauci, e per 1* esofagoElla gorgoglia e mormora
,
Mi fa nascer nel petto
Un indistinto incognito diletto ,
Che si può ben sentire
,
Ma non si può ridire.
lo noi nego, e preziosa
OdorosaL’Ambra liquida Cretense; •
Ma tropp’ alta ed orgogliosa
La mia sete mai non spense ;
Ed è vinta in leggiadria
Dall’ Etrusca Malvagia :
Ala se fia mai , che da Cidonic scoglio
Tolti i superbi e nobili rampolli
Bingentiliscan su i Toscani colli
,
Depor vedransi il naturale orgoglio
,
E qui dove il ber s’ apprezzaPregio avran di gentilezza.
Chi la squallida CervogiaAlle labbra sue congiugnePresto muore
,o rado giugne
All’età vecchia e barbogia:
Beva il Sidro d’IughilteiTa
Chi vuol gir presto sotterra ;
Chi vuol gir presto alla morteLe bevande usi del Norte :
Fanno i pazzi beveroni
Quei Norvegi , e quai Lapponi ;
Quei Lapponi son pur tangheri
,
/ Digilized by Google
9Son pur sozzi nel loro bere;
Solamente nel vedere
Mi fariano uscir de’ gangheri :
Ma si restio col mal die
Sì profane dicerie,
E il mio labbro profanato
Si purifichi, s’immerga ,
Si sommergaDentro un peccherò indorato
Colmo in giro di quel vino
Del vitigno
Sì benigno.
Che fiammeggia in Sansavino;
O di quel clic vermigliuzzo
,
Brillantuzzo
Fa superbo l’Aretino ,
Che lo alleva in Tregozzano,
E tra’ sassi di Giggiano.
Sarà forse più frizzante ,
Più razzente e più piccante
,
0 coppier ,se tu richiedi
Quell’Albano
,
Quel Vajano,Che biondeggia.
Che rosseggia
Là negli orti del mio Redi.
Manna dal ciel sulle tue trecce piova
,
Yigna gentil, che questa ambrosia infondi;
Ogni tua vite in ogni tempo muovaNuovi fior, nuovi frutti e nuove frondi;
Un rio di latte in dolce foggia , e nuova
1 sassi tuoi placidamente innondi :
Nè pigro giel , uè tempestosa piova
Digilized by Google
toTi perturbi giammai, nè mai ti sfrondi:
E ’l tuo Signor nell’età sua più vecchiaPossa del vino tuo ber colla secchia.
Se la druda di Titone
Al canuto suo marito
Coi) un vasto ciotolone
Di tal vin facesse invito.
Quel buon vecchio colassù
Tornerebbe in gioventìi.
Torniam noi Irattanlo a bere:
Ma con qual nuovo ristoro
Coronar potrò ’l bicchiere
Per un brìndisi canoro ?
Col Topazio pigiato in Lamporecchio,Ch’è famoso Castel per quel Masetto,
A inghirlandar le tazze or m'apparecchio, \x .
Purcliè gelato sia , e sia puretlo
^
Gelato,quale alla stagion del gielo
Il più freddo Aquilon fischia pel cielo.
Cautlnette e Cantinpl(>re
Stieno in pronto a tutte 1’ ore
Con forbite bombolette
Chiuse e strette tra le brine
Delle nevi cristalline.
Son le nevi il (|uinio elemento,
Che compongono il vero bevete:
Ben è filile chi sjiera ricevere
Senza nevi nel bere un contento:
Venga pur da VallombrosaNeve a josa :
Venga pur da ogni biccocca
Neve in chiocca ;
V £ voi Satiri lasciate
Digilized by Google
11
Tante frottole e tanti riboboli
,
£ del ghiaccio mi portate
Dalla grotta del Monte di Boboli.
Con alti picchi
De' mazzapicchi
Dirompetelo ,
Sgretolatelo,
Infragnetelo ,
Stritolatelo,
Fioche tutto si possa risolvere
In minuta freddissima |K>lvere
,
Che mi renda il ber più fresco
Per rinfresco del palato.
Or eh’ io son mortoassetato.
Del vin caldo s’ io n’ insacco ,
Dite pur eh’ io non son Bacco.
Se giammai n’ assaggio un gotto
Dite pure, c vel pendono.
Ch’io mi sono un vero Arlotto:
E quei, che in prima in leggiadretti versi
Ebbe le grazie lusinghiere al fianco
,
E poi pel suo gran cuore ardito e franco
Vibrò suoi detti in fulmine conversi
,
Il grande Anacreontico ammirabileMenzin, che splende per Febea ghirlanda,
Di satirico fiele atra bevandaMi porga ostica, acerba e inevitabile;
Ma se vivo costantissimo
Nel volerlo arcifreddissimo
,
Quei , che in Pindo è sovrano , e in
Pindo godepriorìe immortali
, « al par di Febo haì vanti , w'i
\
Digitizad by Google
12Quel gentil Filicaja inni di lode
Su la Cetera sua sempre mi canti ;
E altri Cigni ebri festosi
,
Che di laui-o s’ incoronino
Nc’ lor cauli armoniosi ,
Il mio nome oguor risuouino,
E rintuouino
"Viva Bacco il nostro Re;;
EvoèEvoè :
Evoè replichi a gara
Quella turba si preclara
,
Anzi quel Regio Senato,
Che decide in trono assiso
Ogni saggio e dotto piato
Là ’ve l’Etrusche voci e cribra e affina
La gran Maestra, e del parlar Regina;
Eli il Segni Segretario
Scriva gli atti al Calendario
,
E spediscane Courier
A Monsieur F -lbbé Regnier.
Che vino è quel colà
,
Ch’ ha quel color dorè ?
La Malvagia sarà
,
Ch’ al Trebbio onor già diè :
Ell’è da vero, eli’ è;Accostala un po’ in qua ,
E colmane per meQuella gran Coppa là:
E buona per mia fc,
E molto a grè mi va ;
lo bevo in sanità
Toscano Re di te.
i
Digitized by Google
i3
Pria eh’ io parli di te, Re saggio e forte.
Lavo la bocca mia con quest’ umore
,
Umor, che dato al secol nostro in sorte
Spira gentil soavità d’odore
Gran Cosmo ascolta. A tue virtudi il
Cielo
Quaggiù ]iromette eternila di gloria.
E gli Oracoli miei, scuz’ alcun velo
Scritti già son nella immortale istoria.
Sazio poi J’anni, e di grandi'opre onusto,
Volgendo il tergo a qnesla bassa mole
Per tornar colassù ,donde scendesti
,
Splenderai luminoso intorno a Giove
Traile Medicee stelle Astro novello,
E Giove 'stesso del tuo lume adorno
Girerà più lucente all’etra intorno.
Al svion del cembalo ,
Al suon del crotalo
Cinte di Nebridi
Snelle Bassaridi
Su su mescetemi
Di quella porpora ,
Che in Mouterappoli
Da’ neri grappoli
Si bella s|>remesi ;
E’ mentre annaffione
L’ aride viscere
Ch’ognor m’avvampano,Gli esperti. Fauni
Al crin m’ intreccino
Serti di pampano;Indi allo strepito
Di flauti e nacchere ^
14Treseanclo intooniné
Sirambuui e frottole
D’ alto misterio ;
E 1’ erbe Menadi
,
E i lieti Egipani
A quel mistico lor ro«o sermoni»
Tengan bordone.
Turba villana intanto
Apj>lauda al nostro canto,
E dal poggio vicino accordi e suoni
Talabalaccai'v tamburacci e corni; ^
E cornamuse’ e pifferi e sveglioni ; 'y
£ tra -cento colascioni
Cento rozze forosette
,
Strimpellando il dabbuddà.
Cantino e ballino il bombababà ;
E se cantandolo
,
Arciballandolo
Avvien che stanchinsi
,
E per grandavida
Sete trafelinsi
,
Tornando a bevere
Sul prato asseggansi.
Canterellandovi
Con rime sdrucciole
Mottetti e cobbole.
Sonetti e cantici ;
Poscia dicendosi
Fiori scambievoli
Sempremai tornino
Di nuovo a bevere
L* altera porpora , v .
Che in Menterappoli
rsT
i5
Da’ neri grappolj
Sì bella spremesi
}
£ la maritino
Col dolce Mammolo ,
Che colà imbottasi ,
Dove salvatico
Il Magalotti in mezzo al Solleone
Trova 1’ autunno a quella stessa fonte
,
Anzi a quel sasso, onde 1' aulico Kìoiie
Diè nome e fama al solitario monte.
Questo nappo, che sembra una pozzan:?, itera.
Colmo è d’uu vin sì forte e sì possente.
Che per iscberzo baldanzosamente
Sbarbica i denti, e le mascelle sganghera:
Quasi ben gonfio e rapido torrente
Ul ta il palato , e il gorgozzule inonda ,
£ nrecipita in giù tanto fremente
,
Cb appena il cape l’una e l’altra sponda:Madre gli fu quella scoscesa balza
,
Dove l’annoso Fiesolano Atlante
Nel più fitto meriggio e più brillante
Verso rocchio del Sole il fianco innalza:
Fiesole viva , e seco viva il nomeDel buon òalviati, ed il suo bel Majano;£gli sovente con devota manoOTfre diademi alle mie sacre chiome ,
£d io Lui sano preservo
Da ogni mal crudo e protervo:
£d intanto
Per mia gioja tengo accantoQuel grande nnor di sua reai CantinaVin di Val di Marina :
Ma del via di Val di Botta
Voglio berne giorno e notte ,
Perchè so che in pregio l’ hannoAnco i Maestri di color che sanno :
Ei da un colmo bicchiere e traboccanteIn sì dolce contegno il cuor mi tocca
,
Che |)er ridirlo non saria bastante
Il mio SaUin, ch’ha tante lingue in bocca:Se per sorte avverrà, che un di lo assaggiDentro a’ Lombardi suoi grassi cenacoli.
Colla ciotola in man farà miracoliLo splendor di Milano il savio Mag^
:
Il savio Mag^i d’Ippocrene al fonte
Meniognero liquore unqua non bebbe ,
Nè sul Parnaso lusinghiero egli ebbeSerti profani all’ onorata fronte :
Altre strade egli corse; e un bel sentiero
Rado, o non mai battuto aprì ver l’etra ;
Solo a i numi , e agli eroi nell’aurea cetra
Offrir gli piacque il suo gran canto altero:
E saria veramente un Capitano,
Se tralasciando del suo Lesmo il vino,
A trincar si mettesse il vin Toscano ;
Che tratto a forza dal |>ossente odore ,
Post’ in non cale i Lodigiani armenti
,
Seco n’ andrebbe in compagnia d’onoreCon le gote di mosto, e tinte e piene
Il Postar de Lemene\Io dico Lui , che giovanetto scrisse
Nella scorza de’ faggi e degli allori
Del Paladino Macaron le risse ,
E di Narciso i forsennati amori :
E le cose del Ciel più sante e belle
Ora scrive a caratteri di stelle :
f '
d by Goo^lc
«7
Ma qiiando assidcsi
Sotto una rovere ,
Al suoa del zufolo
Cantando spippola
Egloghe, e celebra
11 purpureo liquor del suo bel colle.
Cui bacia il Lambro il piede ,
Ed a cui Colombano il nome diede
,
Ove le viti in lascivelti intrichi
Sposate sono in vece d’ olmi a’ Cebi.
Se vi è alcuno , a cui non piaccia
La Vernaccia
Vendemmiata in Pietrabtta,
Interdetto
Maladetto
Fugga via dal mio cospetto
,
E per pena sempre ingozzi
Via di Brozzi ,
Di Quaracchi e di Peretola,
E per onta e per ischerno
In eterno
Coronato sia di bietola ;
E sul destrier del veccbierel Sileno,
Cavalcando a ritroso ed a bisdosso.
Da un insolente Satiretto osceno
Con infame ilagel venga percosso,. v
E poscia avvinto in vergognoso loco ^
Ai fanciulli plebei serva per gioco
E lo giunga di vendemmiaQuesta orribile bestemmi^.
Là d’Antinoro in su quei colli alteri ,
Cb’ bau dalle rose il nome
,
Redi. Opere, P''ol. I. 2
Oh come lieto, oh comeDagli acini più neri
D'un Canajiiol maturoSpremo un mosto si puro
,
Che ne’ etri zampilla.
Salta, spumeggia e brilla!
E quando in bel paraggio' '
D’ ogni altro vin io assaggio ,
Sveglia nel petto mioUn certo non so che.
Che non so dir s’ egli è
O gioja , o pur desio :
Egli è un desio novello,
?ìovel desio di bere ,
Che tanto più s’ accresce
Quanto più vin si mesce :
Mescete, o miei compagni,E nella grande inondazion vinosaSi tufi! , e ci accompagniTutt’ allegra e festosa
Questa, che Pan somiglia
Capribarbicornipede famiglia,
Mescete , su mescete :
Tutti affoghiam la sete
In qualche vin polj)Uto,
Quale è quel , eh a diluvj oggi è vendutoDal Cavaìirr elail’y^mOrn
,
Per ricomptarne poco muschio cd ambra.Fi s’ è fitto in umoreDi trovar un odore.Si delicato e fino.
Clic sia più grato dell’ odor del vino ;
Mille inventa odori eletti ,
• )
Digitized by Google
*9Fa ventagli e guancialetti
,
Fa soavi jirofumiere,
E ricchissime cunziere,
Fa nolvigli
,
Fa norsigii.
Che per certo son perfetti;
Ma non trova il poverino
OJor, che agguagli il grande odor del vino.
Fin da’ gioghi del Perù,
E da’ boschi del TolùFa venire ,
Sto per dire ,
Mille droghe , e forse più ,
Ma non trova il poverino
Odor, che agguagli il grande odor del vino.
Fiuta, Arianna, questo è il vin deH’Atnbra !
Oh che robusto , oh che vitale odore !
Sol da queslo nel core
Si rifanno gli spiriti , e nel celabro ,
?’'
Ma quel che è più ,ne gode ancora il labro.
Quel gran vino
Di PuminoSente un po’ dell’Affricogno
,
Tuttavia di mezzo AgostoIo ne voglio sempre accosto ;
E di ciò non mi vergogno
,
Perchè a berne sul poponeFarmi proprio sua stagione :
Ma non lice ad ogni vinoDi PuminoStar a tavola ritonda ;
Solo ammetto alla mia mensaQuello
, che il nobil Albiai dispensa ,
E die fallo J’ uve scelte
Fa le menti chiare e svelte:
Fa le menti chiare c svelte
Anco quello,
(ih' ora assaggio, e ne favello
Fer sentenzii senza appello:
Ma heii piia di favellarne
"V o’ gustarne un’altra volta.
Tu,Sileno , intanto ascolta,
t^lii ’l crederla giammai? Nel bel giardino
Ne’ bassi di Gnalfonda inabissalo,
nove tiene il liiccanh alto domino ,
In gran palagio, e di giand’ oro ornalo.
Ride un Vermiglio, che può stare a fronte
Al Piropo gentil di Mezzomontc;
Di Mezzomonte , ove talora io soglio
Render contenti i miei disiri a pieno,
A Por che assiso in verdeggiante soglio
Di ([nel molle Piropo empiomi il seno.
Di (juel molle Piropo almo e giocondo,
G'inma ben degna de' Corsini eroi,
(ieiii'na deH’Arno, ed allegria del mondo.La rugiada di Rubino ,
Cile in Valdaiuo 1 colli onora.Tanto odora ,
Che per lei suo pregio perde]^a brìi netta
Mainmolelta *
Qu indo spunta dal suo verde :
.S’ io ne bevo,
iVli sollevo
Sovra i gioghi di Perincsso ,
E nel cauto si m’ accendo
,
Digitized by Google
21
Che pretendo , e mi do vanto
Gareggiar con Febo istesso ;
Dammi dunque dal boccal d’oro
Quel Rubino, eh’è
’l mio tesoro;
Tutto |iicn d’ allo furore
Cantero versi d’amore,
Che sarau via più soavi,,
lì più grati di quel che è C
11 buon vin di Gersolè :
Quindi al suon d’ una ghironda ,
O d’ un’ aurea cennamella
,
Arianna idolo mio
,
Loderò tua chioma bionda
,
Loderò tua bocca bella
,
Già s’ avanza in me 1’ ardore ,
Già mi bolle dentro ’l seno
Un veleno
Ch’ è velen d’ almo liquore :
Già Gradivo egidarmato
Col fanciullo faretrato
Inferrifoca il mio core:
Già nel bagno d’ un bicchiere
,
Arianna idolo amato ,
Mi vo’ far tuo cavaliere ,
Cavalier sempre bagnato :
Per cagion di si bell’ ordine
Senza scandalo ,o disordine
Su nel cielo iu gloria immensaPotrò seder col mio gran padre a mensa;
E tu gentil consorte
Fatta racco iinmnrtal verrai là dove
I numi eccelsi fan corona a Giove.
r-
22Altri bera il Falerno, altri la Tolfa ,
Altri il sangue, che lacrima il VcsutÌo;
Un gentil bevitor mal non s’ ingolfa
In quel fumoso e fervido diluvio:
Oggi vogl’io, che regni entro a i miei vetri
La Vei-dea soavissima d’Arcetri :
Ma se chieggio
Di Lappeggio
La bevanda porporina
,
Si dia fondo alla cantina.
Su trinchiam di si buon paese
Mez/ograppolo , e alla Franzese ;
Su trinchiam rincappellato
Con granella c soleggiato;
Tracanniamo a guerra rotta
Viri Rullato, e alla sciotta;
E tra noi gozzovigliando
,
Gavazzando ,
Gareggiamo a ohi più imbotta.
Imbottiam senza paura.
Senza regola , o misura :
Quando il vino è gentilissimo,
Digeriscesi prestissimo,
E per Ini mai non molesta
La sprangbetta nella testa ;
E far fede ne potria
L’anatomico BrìUnì
,
Se dell’ uve , e se de’ vini
Far volesse notomia ;
Egli almeno, o lingua mia,T’ insegnò con sua bell’ arte
In qual parte
Di te stessa , e in qual vigore
23Puoi gustarne ogni sapore ;
Lingua mia già l'atta scaltra
Gusla un po’,gusta quest’ altro
"Vili robusto , che si vanta
D’ esser nato in mezzo al Chianti
,
£ tra’ sassi
Lo produsse
Per le genti più bevoneVite bassa , e non broncone:Bramerei veder trafitto
Da una serpe in mezzo al petto
Quell’avaro villanzone ,
Che per render la sua vite
Di più grappoli feconda,Là ne’ monti del buon Chianti
,
Veramente villanzone ,
Marilolla ad un broncone.
Del buon Chianti il vin decrepito
MaestosoImperioso
Mi passeggia dentro il core ,
E ne scaccia senza strepito
Ogni affanno, e ogni dolore;
Ma se Giara io prendo in manoDi brillante Carmignano
,
Cosi grato in sen mi piove
,
Ch’ambrosia e nettar non invidio a Giove.
Or questo, che stillò dall’ uve bruneDi vigne sassosissime ToscaneBevi, Arianna, e lien da lui lontane
Le chiomazzurre Najadi importune ;
Che saria
Gran follia
E brullissimo peccalo
Bcvere il CarmigQHU,ijuando« innacquato.
Chi r acqua beve
Mai non riceve
Grazie da me :
Sia pur l’acqua o bianca , o fresca , O nc’
O ne’ loiifani sia bruna:
IVcl suo amor me non Invesca
Questa sciocca ed importuna ,
Questa sciocca ,che sovente
Falla altiera e capricciosa ,
^ Riottosa ed insolente
Con furor perfido e ladro
Terra e del mette a soqquadro:
Ella rompe i ponti e gli argini
,
E con sue nembose aspergini
Su i fioriti c verdi margini
Porte oltraggio ai fior più vergini;
E r ondose scaturigini
Alle moli stabilissime
,
Che sariaii perpetuissime ,
Di rovina sono origini.
Lodi pur Tacque del MioIl Soldati de’ Mammalucchi,Nè T ls|’ano mai si stucclii
D’ innalzar quelle del Tago ;
eh’ lo per me non ne son vago .*
E se a sorle alcun de’ miei
Fosse mal cotanto ardito.
Che Ix'vessene un sol dito,
Di mia man lo strozzerei ;
Yadan pur, vadano a svellere
La cicoria e raperouzoll
Digitized by Google
aSCerti magri mediconcoli ,
Che coir acqua ogui mal pensan di c»>
pellere :
Io di lor non mi fido
,
!Nè con essi mi aflanno ,
Anzi di lor mi rido ,
Che con tanta lor acqua io so eh’ egli hannoUn cervel cosi duro e cosi tondo ,
Che quadrar noi potrla nè meno in pratica
Del f^iviani il gran saper profondoCon tutta quanta la sua Matematica.Da mia masnadaLungi sen vadaOgni bigoncia
Che d’acqua acconciaColma si sta :
L’ acqua cedrata
,
Di limoncello
Sia sbandeggiata .'
Dal nostro ostello :
De’ gelsominiNon faccio bevande
,
Ma tesso ghirlandeSu questi miei crini :
Dell’aloscia c del candieroNon ne bramo , e non ne chero :
I sorbetti ancorché ambrati,
E mille altre acque odoroseSon bevande da svogliati
,
E da femmine leziose;
\ ino vino a ciascun bever bisogna,
Se fuggir vuole ogni danno
,
E non par mica vergogna
I Digitized by Google
i6Tra i bicchier impazzir sei Tolte T10 per me son nel caso
,
E sol per gentilezza
Avallo questo, e poi quest’ altro vaso,É SI facendo del nevoso cielo
PJon temo il giclo,
Nè mai nel più gran ghiado m’imbacuccoNel zamberlucco.Come ognor vi s’ imbacuccaDalla linda sua parruccaPer infìno a tutti i piedi
11 segaligno c freddoloso Redi,
Quali strani capogiri
D’ improvviso mi fan guerra ?
Farmi proprio, che la terra
Sotto i piè mi si raggiri;
Ma se la terra comincia a tremare,E traballando minaccia disastri
Lascio la terra , mi salvo nel mare.Vara vara quella gondolaPiù capace , e ben fornita ,
Gli’ è la nostra favorita.
Su questa nave ,
Che tempre ha di cristallo
,
E pur non pavéDel mar cruccioso il ballo ,
Io gir men voglio
Per mio gentil diporto,
Conforme io soglio.
Di Brindisi nel porto
,
Purché sia cacca
Di brindisevol merceQuesta mia barca.
Digitized by Google
Su voghiamo ,
INavighiamo
,
Piavighiamo infino a Brindisi :
Arianna, Briudis , Brindisi.
Oh bell’ andare
Per barca in mareVerso la sera
Di PrimaveràlVenticelli e fresche aurette
Dispiegando ali d’ argento
Sull’ aiEuiTO pavimentoTesson danze amorosette ,
E al mormorio de’ tremuli cristalli
Sfidano ognora i naviganti ai balli.
Su voghiamo.Navighiamo
,
Navighiamo infino a Brindisi :
Arianna, Briudis, Brindisi.
Passavoga , arranca , arranca ,
Che la ciurma non si stanca ,
Anzi lieta si rinfranca
Quando arranca inverso Brindisi :
Arianna , Brìndis , Brindisi.
E se a te Brindisi io fo.
Perchè a me faccia il buon prò
,
Ariannuccia , vaguccia , belloccia,
C intami un poco, e ricantami tu
Sulla Mandola la cuccurucùLa cuccurucùLa cuccurucùSulla Mandola la cuccurucù.Passa vo
28Passavoga , arranca , arranca
;
CLe la ciurma non si stanca;
Anzi lieta si rinfranca
,
Quando arranca
Quando arranca inverso Brindisi :
Arianna, Briudis, Brindisi.
E se a te ,
E se a te Brindisi io fo,
Percliè a mePerchè a mePerchè a me faccia il buon prò11 buon pr«
,
Ariaunuccla leggiadribcll uccia ,
Cantami un po’
Cantami un po’
Cantami un poco, e ricantami tu
Sulla ViòSulla Viola la cuccurucùLa cuccurucùSulla Viola la cuccurucù!
Or cjual nera con fremili orribili
Scatenossi tempesta lierissima
,
Che de’ tuoni fra gli oiiidi sibili
Sbuffa nembi di grandine asprissima?
Su noccliiero ardito e fiiTO,
Su nocchiero adopra ogn’arte
Per fuggire il reo periglio;
Ma già vinto ogni consiglio
Veggio rolli e remi e sarte,
E s’ infuriai! tnllavia
Venti e mare in traversia.
Gilta spere ornai per pi'ppa,
E riutoppa, o marangone
,
agL'arcìpoggia e l’ artimone.Che la nave se ne vaColà dove è il fìnimonJo,E forse anco un po’ più in là.
lo non so quel cn’ io mi dica
,
E neir acque io non son pratico;
Farmi ben , che il ciel predicaUn evento più rematico:Sccndon Sioni dall’aerea chiostr.a
Per rinforzar coll’ onde un nuovo assalto,
E per la lizza del ceruleo smalto1 cavalli del mare urtansi iu giostra:
Ecco, oimè, ch’io mi mareggio,
E m’ ayvegglo,
^
Che noi siam tutti perduti : v » \
Ecco,oimè , eh’ io faccio getto
Con grandissimo rammaricoDelle merci preziose
,
Delle merci mie vinose;
Ma mi sento un po’ più scarico: ,-
Allegrezza allegrezza : io già rimiro
,
Per apportar salute al legno infermo.Sull' autenua da prua muoversi in giroL’ oricrinite stelle di Santermo:Ah ! no, no; non sono stelle:
Son due belle
Fiasche gravide di buon vini :
I buon villi son <{uegli, che acquetano
Le procelle si fosche e rubelle,
Che nel lago del cor l’ anime inquietano.Satirelli
Ricciutelli ,
Satirelli, or chi di voi
SoPorgerà più pronto a noi
Qualche nuovo smisurato
Sterminato calicioue
Sarà sempre il mio mignone,
riè m’ importa se un lai calice
Sia d' avorio , o sia di salice ,
O sia d’oro arairicchissinio
,
Purché sia molto grandissimo.
Chi s’arrisica di bere
Ad un piccolo bicchiere
Fa la zu])pa nel paniere :
Questa altiera,questa mia
Dionea bottiglieria
rion raccetta , non alloggia
Ilicchicretti fatti a foggia :
Quei bicchieri arrovesciati
,
E quei gozzi strangolati
Sono arnesi da ammalati :
Quelle tazze spase e piane
Sou da genti poco sane :
Caraflini ,
Buffoncini
,
Zainpilletti e borbottini
Sou trastulli da bambini :
Son minuzie, che raccaltole
Per fregiarne in gran dovizia
Le moderne scarabaltole
Delle donne Fiorentine ;
Voglio dir non delle Dame,Ma bensì delle ])cdinc.
In quel vetro, che chiamasi il tonfanoScherzai! le Grazie , e vi trionfano ;
Ognun colmilo, ognun volilo
,
1
Digilized by Google
3iMa di che si colmerà?
Bella Arianna con bianca manoVersa la manna di Montapulciano ;
Colmane il tonfano, e porgilo a me.
Questo liquore, che sdrucciola al core
O come l'ugola c baciami, e mordemi !
O come in lacrime gli occhi disciogliemi!
Me ne strasecolo , me ne strabilio
,
E fatto estatico vo in visibilio.
Onde ognun , che di LieoRiverente il nome adora
,
Ascolti questo altissimo decreto ,
Che Bassareo pronunzia , e gli dia fe.
Montepulciano d’ ogni vino è il re.
A cosi lieti accenti
D' edere e di corimbi il crine adorneAlternavano i canti
Le festose Baccanti ;
Ma i Satiri, che avean bevuto a isonne.
Si sdrajaron sull’ erbetta
Tutti cotti come monne.
ANNOTAZIONIDI
FRANCESCO REDIA t B T 1 N O
ACCADEMICO DELLA CRUSCA
jit
DITIRAMBOcon aggiunta.
Redi. Opere. Voi. I. 3
Digitized by Google
35
JN NOTAZIONI,
Pag. r. yers. i.
Deir Indico Oriente ^ f*0
Domator glorioso il Dio del vino.
Molti Poeti Latini e Greci hanno da<
to a Bacco il titolo di domator dell’ la^
dia , e con questo lo circoscrive il Ron-sardo nell’inno delle lodi della Francia: ^
f
Plus quen nul lieu dame Ceres la blonde^
Et le donteur des Indes i abonde.
Antologia lih. i in un Epigram-.
ma d' incerto Autore sopra Bacco , con-
cd by fìoogle
36lenente, oltre #1 primo verso, tanti ver-
si,
(|iiante sono le lettere del Greco Al-
fa'nelo, ognuno de’ (piali versi lia paro-
le, die com iieiaiio dalla stessa lettera;
e ogiii parola è un titolo, e un atlri-
hiito di Bieco; al verso della lettera I,
die è tessuto di tutte jiarole, die prin-
cipiano per 1 , è chiamalo tra gli nhriI ''.'i di Iriiggitore degl’Iiuli, cioè h^o-XéTì2(, 11 verso Intero si è:
l’ .l^ufpTÒ» .IotXóxov . tlpapiÓTHiV.
in cui osservo li licenza del Poeta, chenon gli sovveiieii.io parola jier liiiire il
verso , la quale cominciasse da [ola , si
servi d’ una , die cominciasse da tt dii-'
toiigo. Se si sapesse TAiitore di ipieslo
Epigramma, o più Insto Inno sopra Baoco , e ’l tempo iii cui visse ; e si ritro-
vasse essere de’tempi buoni, o vicino a(quelli
,potrebbe non poco avvalorare
1 opinione d’ un moderno, il cjuale si
sforza di provare la moderna pronunziade’ Greci , seguitata in gran parte da-
gl’ Italiani, e rifiutata dagli ollraluonta-
ti, esser biioua c legittima ; e trall’ al-
tre esser buono il pronunziare il ditton-
go ss , come se fosse una sola lettera ,
«d un semplice iota. Ma temo forte,
anzi lo credo fermamente, che quest’in-
no sia cosi stato capricciosamente com-posto da alcuno de’ secoli bassi
,quan-
I )itized by Google
tìo già s’era alterata la scliietta « natu-
rale ^^ronunzia de’ Greci, e format.isciie
quella ,cbe oggi è comune tra loro.
Certo die di tal sorta di fauci ullesclie
comj'osizioiii con (juesia osservanza di
lettere, e di versi non se ne leggono,
per quanto a me pare, trall’ antiche.
Pag, T. V. 5. Imperiai pala "io.
Intende della villa iinpei iale fuor del-
le mura di Firenze fahbticata dalla Se-
renissima Ai cidnehessa Maria Maddale-na d’Austria Granduchessa di Toscana,
e lasciala da essa per retaggio delle fu-
ture Granduchesse , come sì legge ia
una cartella posta sopra la porla del
Salazzo di essa villa
,posseduta oggi
alla Serenissima Granduchessa Vittoria
della Rovere moglie già del GranducaFerdinando 11. c madre del Serenìssimo
Cosimo III. Granduca di Toscana Re*gnante.
f^illa imperiaìis ab Austriacis
AtTfrustir'’iomen consecuta
Futurae magnae Dares Etruriaa
l'estro odo deiiciisrjug
Aeternum inserviat.
»
Pag. I. V. 8. Arianna.Molli degli scrittori Toscani antichi
'volgarizzando il nome latino Atiadnascrissero in nostra lingua Adriana. L’an-
/
38tico volgarirrator Fiorentino dell’Episto*
le A'Ovidio nel prologo dell’epistola di
Fedra a Ippolito: E poiché Teseo fugiunto, jldrìana innamorò di lui. E ap-
presso ; Ma Teseo non fu percontento
di menarne Adriana, ma egli ne menòancora Fedra. E ivi medesimo: Abharv-
donò Adriana a dormire piena di vino,
e di sonno. T?el principio della lettera
d’Arianna a Teseo; Alcuna delle ferebestie non è tanto crudele , quanto tu
Teseo fosti in verso di me Adriana.
Bernardo Gianibullari nel 2. lìb. del
Ciriff. Calvaneo.
Come fe d'Adriana poveretta.
Luigi Pulci Morg. i6. 87.
Tu non aresti Adriana lasciata
Suir isoletta in tanta passione.
Il Petrarca nel Trionf. d’Am. cap. i.
Ì
ella ne moria , vendetta forse
polito , di Teseo e d'Adrianna.
ero ancora Andriana. Nel sopracci-
prologo Lo Be Minos , il quale
ignare di Creti ebbe di Pasiffe sua
moglie, tre fgliunli\ fra quali' fu An-
dwgeo, Andriana e Fedra. E nel pro-
- lego della pistola di Arianna a Teseo:
t^uestà è quella. y4ntlriana , chó Teseoabbandonò in sulla diserta isola. Volen-
tieri i nostri Scrittori antichi aggiupiie-
vanb la lederà n. alla prima sìllaba di
cosi falli nomi, come si piiò vedere nel
Novelliere antico nov. 8o, dove si legge
F.nsiona invece d’ Estone, In RicordanoMalespini cap* S. Anseraco , Ansiona «
Giànsone,per Assaraco «
Estone , Gia-
sone. In Gio. Villani Hb. i cap. la.
Ansaraco , Anson , Ansiona , e cap. i a.
Anceste,
per Assaraco , Esone, Esio-
he, Aceste. Nel prologo della pistola di
Medea: Dappoiché Giànsone JigUuolo di
Ensone ebbe conquistato lo ricco 'vello
deir oro, ec. In due antichissimi manu-scrilti della pistola di san Girolamo aEnstochio , volgarizzata da fra Domeni-co Cavalca Pisano dell’ ordine de’ Pre-
dicatori , si legge sempre costantemente
Èanbillonia e linbidiné in cambio di
Babilonia e libìdine. E in un antichis-
simo manuscritto intitolato Fioretti di
san Francesco: Santo Francesco, ec. adi-
venne una volta oltre a mare con do-dici suo' compari Santissimi per andarisene diritto al Saldano di Banbillonia.
Paj 2. V. I. ^e deir uve il sangue ama-bile.
Nel cantico di Moisè, Denter. 3a. 14; '
Sanp^uinem uvae biberet meracissimum:Nell’ Ecclesiast. 5o 16. Porrexit mattani
suam in lihation* ,et libavit de san-
guine uvae. Nel i de Maeab. 6 34. Eie-
phantis ostenderunt sanguinem uvae, et
mori. Giuffredi di Tolosa Poeta Proyen-
zale :
Vveillh el sang del racin
,
Lai cor platz en ioi en rire.
Soggiugnerei , che Plinio lib. 14 eap. 5riferisce , che Androcide disse ad Ales-
sandro Magno: Vinum poUUurus , Bex,memento te bihere sanguinem icrrae ;
ma temo, che i critici non mi sgridino
•ol Dalecampio
,
il quale volle , che si
leggesse sanguinem tauri, e non sangui-
nem terrae. Achille Tazio lib. 2 fa, che
Bacco banchettato da nn pastore Tiri»
gli dia da bere del vino ; e che il pa-
store, dopo averlo assaggiato, interroghi
Bacco : Ove hai tu ritrovato sangue si
dolce! « Bacco gli ris]'onda : Questo èsangue digrappoliTovro ètrìf alga ^orpvov.
Ma il Chiabrera genlilissimameute nelle [
ballatene :
'
y Tosto che per le vene erra ondeggiandoI \ Delle bell uve il sanale,
« . \
Romolo Bertini nelle poesie maau-•ci'itte :
Ma se non va delle belT uve il sangue
^ DigitizecUifci'iUOgl
4 *
Per le mie vene a riscaldarmi il petto ,
E morto nel mio canto op^ni diletto
^
Ogni piacere intiepidisce e langue.
^ Francesco Maria Gnalterotti nel Di-
tirambo intitolato la morte d'Orft* :
Statinvemar possa in cucina
Chi non amaChi non brama i
Questo sangue di cantina.
In Toscana sogliamo dire per proverbio:
Il buon vino fa buon sangue ; e per
parlar con Galei.o aifiarof ètri
Yevftirixóf.
Pag. 2. v. 5. Sì bel sangue è un raggio ac-
ceso
Di quel Sol, che in del vedete.
Il divino poeta Dante nel PUrg. 25.
Guarda il color del Sol, che si fa dnoGiunto alt umor, che dalla vit^ cola.
Un non molto dissimll pensiero pare ,
che avesse Empedocle
,
il quale opinò ,
che le piante fossero figliuola della ter-
ra , ed i loro frutti' nascessero di fuoeo
e d’ acqua ; come si può leggere ncl-
TAutore , chi chi sia , della Storia Fi-
losofica attribuita a Galeno verso il li-
I
i
42ne. Ateneo ìib. 1
1
cita F.iiripide, che dìcC}
che uno de’ca valli del Sole nominato l’Ac-ceso, è quello, che fa maturar 1’ uve ,
e che da lui il vino sia chiamato aiiòrj/,
cioè ardente ,o nero. Da Sabino poeta
nell’Antologia lih. G. vien chiamato il
vino ^avo(; , colla qual parola si signi-
fica ralh-gria, c il lume, o splendore,che parte rìsce allegria.
, ^,
,
• . . . àv^trt 9'aifì
,
nàj»; aye^tiv. Ni(Upai, xi9axa.
favo^.
E Snida alla lettera f. yavóov. XtÌM/t-i
xpitifiivoc. E immediatamente soggiugne
yayof ó oivoc, e per esemplo cita que-sto medesimo verso di Sabino jrav àys*
, ec. Al qual esempio di Sabino
,
Se ne può aggiugnere un alti*o d’ Eurì^
pide nel Ciclope, da cni per avventuraSabino lo prese : ove Ulisse dice al Ci-clopo
,per mettergli volontà di bere;
Guarda , che divina bevanda producedalle viti la Grecia ,
allegrezza di Bac-co, e splendore. Lo stesso Euripide nel-
le Baccanti ;f
,
O'itórraat Pótpvo( i^^riTdvo( h Salti ^eSf‘ ii •
k ...,1'
Un altro esemplo ne somministra Ala-ctobio Saturn. lib. 5< cap. zi. preso dal-
Jvkìuu-gltf
431* Andromeda , ovvero Anilivimaca del
taedesimo Euripide. /
Pag. a. V. 7. E rimase avvinto e preso
Come la luce del Sole rimanga hn-
prigìonata ne’granelli dell’uva è da fa*
vellarne in luogo molto più opportuno»
che non sono queste baje.
Lasciai cosi nobil pensiero al mio
grande amico il sig. Dottore Giuseppe
del Papa, uno de'più pregiati e de’ più
celebri Filosofi e Medici del nostro se-
colo, come fanno ampia teslimonianva
le sue dottissime Opere con tanta gen-
tilezza scritte e stampate, e particolar-
mente quelle intorno alla natura del
caldo e del freddo ;quelle intorno alla
luce : quelle della natìira delC umido e
del secco : le quali tutte a questo pro-
posito sono da vedersi attentamente con
molto diletto , e giovamento de’ leggitori.
Pag. 2. V. II. E per chi s' invecchia, e lan*
gue, ec.
In Firenze è trito proverbio: Il vinU
è la poppa de’ vecchi ;che potrebbe il-
lustrarsi con quel verso di Macedonio »
che si legge tra gli epigrammi Greci.
OvSlixo( èst ^pvov iav^òv yaintti
dove il grappolo è detto la poppa, da cui
li mngne il vino, \jjilamanni Colt. 1.
44, ^ _
C1Ì è sì chiaro a ciascun, che'l mondocanta ,
CìC alla dehil 'vecchiezza il 'vin man-tie le
Solo il caldo e T umor, le forze »r alma.
Pag. 2 . V. 12 . fletti mnjitsculi.
A Ciro per vago da bere usata antica-mente da Franco Saccheui citato dalVocabolario alla voce Cioncare : Si co-mincia ad attaccare al 'vetro
; bei è ri-
bei ; cionca e ricionca. Bernardo Giam-builari Cirìff. Calv.
A Cirìffo gli piace, e il vetro succiaSenza lasciar nel fondo il centellino.
Romolo Bertini Poes. manuscr.
Versate pur 'versate
Anfore preziose in, questi 'vetri
Manna di Chianti , e nettare étAreetri.
La Vetriuola in lingua furbesca si-
gnifica il biccliirre. Bastiano de' Rossigià Sfgret. AcM'Accadernia della Cruscachiamato l’Inferigno in una sua Cica-
lala fatta la sera dello Stravizzo dciran-no i5y3. Per la qual cosa andatomenea casa con una graziosissima sete , vi
so dir io , che la 'vetriuola andò attor-
•Ì.3V
Digitized by Google
no , e che non risecco, ma molle me ne _andai a letto,
Pag. 2 . V. I». Preparlarn vetri majutculi.
Majusculo, e majiiscolo propi iameiite
si dice di lettera , clic gli antichi chia-
mavano grossa , a differenza della ini-
miscola e piccola. Gli antichissimi ado-
f
ieravano per tutto nelle scritture la bel-
a lettera majnscola , e qnesto era il
proprio carattei'e Romano , come t> osr
serva nel Virgilio mannscrilto della Li-
breria di s. Lorenzo: poi ne’ tempi j>tu
bassi usarono simihucnte la majnscola ,
ma un poco più piccola e tralignante
in minuscola , e come noi diremmo ca-
rattere formatcllo , come si vede nel-
r ( Irosi» della medesima Libreria di
s. Lorenzo, e nelle famosissime Pandet-
te, che nella reai guardaroba del Sere-
nissimo Granduca mio Signore come uatesoro si conservano ;
finché a^ipoco ap-
poco tralignando, per cosi dire, la let-
tera dall’ antica , e soda architettura
nella stravagante e barbara , fece quetanti cambiamenti , i <|uali tempo per
tempo dagli eruditi s’ osservano. Si trae
questa voce ail altri , e diversi signifi-
cati, come per esemj'io si suol dire unerror majuscolo, un crror grosso, e».
Pag. 2. V. ig. E bevendo, e ribevend»
1 pensier mandiamo in bando.
Bacco è detto . da’ Latini Liher , da’Greci Avaìoc^raa da Anacreonte Avai-\(ppov , perchè libera dalle cure nojose.
hìel 2. lib. dell’Antolog.*
(Xffoutv àtSpo/póvop (ppoftLòck rmJs (pià-
^ai(
Scacciamo co’ bicchier cure omicide.
11 Chiabrera gentilmente :
Bei'iatno, e diansi al 'vento' \ 1 torbidi pensieri.
Vedi Tilml. lib. 3. Elee, ult., ed OrazioOd. 7. lib. I. Od. II. lib. 2. Vedi altresì
‘
Stasino ,o chi si sia il Poeta scrittore
delle cose di Cipro, citato da Ateneonel principio del libro secondo :
Il vino, o Menelao, fecer gt IddeiOttimo a dissipar P umane cure.
»
Pag. 2. T. 24. Questo vasto Bellicone
Bellicone è voce nuova in Toscana
,
ed è venuta di Germania , dove chia-
masi wilkomb , o wilkumb quel bicchie-
re, nel quale si beve all’ arrivo degli
amici, e significa lo stesso che benve-
nuto. Gli Spaguuoli , che ancor essi pi-
gliarono questa voce da’ Tedeschi , la
dissero in loro lingua V^eiicomen. Don
Digitized by Google
Francesco de Quevedo nella Fantasia
intitolata Fortuna con seso: A.xparecieron
alli Iris con nectar, y Gantmedes conun Velicomen de ambrosia.
Pag. 2. . 27. Si vendemmia in Artimino.
Villa del Serenissimo Granduca di
Toscana fabbricata già dal GranducaFerdinando 1 . delÌEÌosissima non sola>
mente per le cacce de’ Daini, e d’altri
salvaggiumi , ma ancora per i vini pre>
ziosissimi che produce, i quali a giudi>
zio degl’ intendenti sono i migliori della
Toscana, Anticamente vi era un casteb
lo assai forte, di cui più volte fa inen>
zione Gio. Villani. Oggi il castello è
distrutto, ed il posto, dove prima era
situato, chiamasi Animino vecchio.
Pag. 2. V. 28. Ve» trincarne più d^un tino.
Nel Ciclope d’ Euripide domandandoesso Ciclopo a Sileno, se il desinare eraall’ordine, e se i vasi per bere il latte
eran pieni. Sileno gli risponde, che, se
volesse, ne potrebbe trincare un intero
doglio.,
ET. ^ xal ’jfó.Xantot tln stpax^pet xXéo ;
SIA. òffr'iMxislf vi óAoy **^ov.
Pag. 2. v. 3o. Mentre il polmone mio tutto
s' abbevera.
KA(1 imìMzione à'Aleso poeta Greca,
[
che disse réyye xvtvttovaf alvo, annuffia i
i polmoni •'.oL vino, PlaUme
,
forse poco'
,pratico nella uotomia , insegnò nel Ti-meo che i polmoni sono il ricettacolo
delle bevande. Proto^ene grainatic» ap-’
presso di Ateneo volle, che Omero fos-
se il primo, il quale avesse una cosifatta opinione. L’ ebbero parimente tragli antichi Greci molti nomini per altr»
dottissimi, e particolarmente Eupoli^
Przttn^oru,
Eratostene, Euripide
, Eu-stazio appiresso di Macrobio , PUistioneEocrense Medico, e Diosippo i l’Autoredel libro intitolalo xepì xapiitK , attri-
buito falsamente ad Ipocrale, fu un po-
\j co più ritenuto, e forse ancora un poco
/ ])iù veridico, e credette, che la m.aggior
]>arte di quello , che gli animali bevo-< no, cali nello stomaco, ed una piccolaI particella ne vada a’ polmoni; e lo volle
1persuadere con una certa sua esperien-
iza di dar ber* ad un porco ben asseta-
to qualche beveraggio tinto di colore
,
! c*l tagliar poi subito 1’ aspera arteria :
e si troverà, dice egli, la canna de’pol-
' moni tinta evidentemente del colore di
quel beveraggio. Se questa esperienza
sia vera, o no, non è da favellarne qui.
Da ipieirAiitore imparò forse MaestroDomenico di Maestro Bandino cTArez-zo
,quando nel Trattatello manuscritto
de Pidnionibus ebbe a scrivere : Durn
Digitized by Google
animàlia bihunt , olùjua potus pomosimul cum aere in puhnonus delui ftur
per lacera arCerialts cannae. Fra Jaco-pone da Todi, che fiori ne' letn|>i [uùro7.zi deMa fanciullezza della poeiiia To-scana , in una sua Satira , die traile
stampate è la decimasesta :
Bevo e'rifondo il mio polmone. KVedi Aecllio lib. 17. cap. 11. MacrohioSaturnaT. lib. 7. cap. i 5. Marsilio Cagna/-Co Var. Osserv. lib. i. cap. 22.
• Pag. 2. T. 3i. Arianna, mio Nume , a te
consacro II tino ec.
In un Epigramma di Eratóstene nellib. 6. àeWAntologia , Senofonte consa-cra un doglio voto a Bacco, pregandoload accettarlo volentieri
;poiché non ha
altro da offerirgli.
. Olvorcbxac; Stevofòv xivsov xi^op àv^txolìixjfo.
Aé^pv<ro d’evpevéo(. yàp ovdsv• Syei.
Debbo questo luogo alla cortesia del-r eruditissimo sig. Antonmaria Salvini,che nella seguente maniera lo portaeir idioma latino:
\ -
Redi. Opere, Voi, I. 4
5oQuod vacuum JCenophon tibi vas dicat,
accipe , Bacche ;
Namque aliati,quod dei , non habeù
ille tibi.
?
Pag. 3. V. 93. Pevera.
La Pevera è un iu$trumcuto per lo
più di legno , che serve in vece d’ itn-
hiilo, quando co’ barili si versa il vinonella botte. Impiria la dicono i Vcne-xiani ab implendo, come vuole OttavioFerrari nelle Oi-igini della Lingua Ita-
liana. Pevera non è voce nuova in To-scana. La trovo in autori antichi , e par-
ticolarmente in un antichissimo Libromanuscritio di Mascalcia. E se non haialtro strumento
,prendi una Pevera da
imbottare colla canna torta. Cosa difle-
rentissima dalla Pevera appresso gli an-
tichi si è il P&’ero, che, come afferma
il Vocabolario delta Crusca , è un in-
tingolo fatto di varj ingredienti* con pe-
verada ; e la Peverada si è quell'acqua,
nella quale è cotta la carne ; e tal vo-
ce ebbe origine da Pepe
,
che dagli an-
tichi era chiamato Pevere; ed allora
quando quest' arumato era in maggiorcredito e prczxo ,
lo solevano comune-mente metter in tutte le minestre ; maoggi tal condimento è rimaso al volgo.
» w ^Pag. 3. V. 4- pian iU Lccore.
Lecore , villata posta nel più bassoj
Digitized by Coogle
5tpiano in vicinanza di Firenze. Onde vi-
no, di Leeone passa iu proverbio pervi- '
no debolissimo , e di ninna stima ; e'
snol esser proverbiato col dirsi , che fa
sulla groppa de’ ranocchi , e che di po-
co è migliore dell’ acqua. Traile leggi
antiche della città d’Arezzo ve ne era
una, la quale permettendo il piantar le \
vigne nelle colline abili a far buon vi-
no, lo proibiva severamente nelle pia- /
nure> basse destinate alla semenza de*
grani. »‘
!'
Pag. 3. V. 5. Prim osò piantar le viti.
Costume è de’ Poeti prendersela co*
primi che ritrovarono quella tal cosa ,
che essi pongonsi a biasimare , o chestimano esser nocevole , o disutile al
mondo. Tibull. lib. i.
Jam tua qui Venerem docuisU vendereprimus ,
Quisquis es, infelix urgeat ossa lapis.
Vedi altrove nel medesimo libro , enel 3.
Vedi Oraz. lib. i. od. 3.
’ f*
,
Capri e pecoreSi divorino quei tralci. .
Virg. Georg. 2 . trattando del danno
,
che riceve la vite dal morso di questi
animali:
,' VA'* A
J'
Frtgora ,nec tantum cana concreta
jtmina,,w,
^
Aut gravis incumhens scopnlis arenti-
hus aestas ,
Quantum Uli nocucre greges , duriquevcncniun
Dentis, et admorso signata in stirpe ci-
catrix.
Lib. Cur. Malat. maouscrilto. Come il
dente della capra è velenoso alla vite
,
cosi lo dente delP uomo adirato è vele-
noso aie uomo.
Pag. 3. V. r5. Di Petraja e di Castello.
La Pctraja e CasteIJo sono due ville
della Casa Serenissima di Toscana , fa-
mose per i preziosi vini che producono;alla bontà oc' quali aggiugue pregio la
nobile diversità de’ vitigni fatti venire
dalla Spagna , dalle Canarie, dalla Fran-cia , e dall’ isole jùù celebri deirArcl-
;' p
Pag. 3. vJf6. Piantò prima il moscadcllo.
In una traduzione Franzese di Palla-
dio falla da Gio. Darces stampala in
Parigi l’anno i554 nel Febbrajo, al lit,
g, ove l’Anlore Aìcc svnt Apianae prae-
cipuae
,
il Traduttore rende cosi; nousavons aussi les vigues Apianes, ou Mu~scadettes fort excelìenles. E al marginesi legge stampata questa postilla : Les
Digiiized by Google
53'itignes Muscaelettes ont pris le nom (TA-pianes , des mousches a miei, que nousappellons opes. Agf^iungi Plinio lib. 14.
cap. 2. Apianis nvis apes dedere cagno-
nten,praecipue earum avidac. Papia
citato dal Ferrari alla Toce Moscato
,
Moscatello , uvae Apianae dnlce vinurn
faciunt,
quas nisi cito legas , a vespis
et apihus injeslantur ,unde et dicuntur.
Di tale infestamento io ne feci menzio-ne nelle mie Esperienze intorno alla
generazione degt insetti a car. 41 della
((uinta edizione Fiorentina del Matinidel 1688. Non ò però che le vespe nonvivano ancora di fiori, e di frutti e fre-
schi e secchi; ma f uva, ed in partico-
lare la Moscadella , troppo ingordamen-
te la divorano ;come ne fan testimo-
nianza Cointo Smirneo, e Nicandro ne-
gli Alesìfarmaci , e si vede tutto giornoper esperienza. Vedi Egidio MenagioAccademico della Crusca nelle Originidella Lingua Italiana alla voce Mosca-della, dove approva il Vocabolario del-
la Crusca y che dice Moscadello. Nomeif uva detta cosi dal suo sapore, chetiene di Moscado onde Moscadello il
suo vino. a,
Pag. 3. V. 17. In giolito.
Stare in giolito vale lo stesso che sta-
re in riposo , ed è termine marinaresco,e per lo più dicesi delle galere
,quan-
54do si trattengono nella Darsena , o nel
/Porto; e de’ vascelli d’altobordo, qnan-do in alto mare sono in calma. Gli Spa-
\ gnuoli &crivTOO iolito.
Pag. 3. V. 1 8. Bei di questo hel Grisolito.
Cosi più sotto Topazio pigiato in
Lamporecchio-. Ambra liquida Cretense.
Rugiada di Rubino, e simili.
Questi traslati sono proprj nostri To-scani , nè vi si ardirono
,per quanto io
mi ricordi , nè i Greci , nè i Latini :
solamente quando io leggo in Virgilio,
Eneide lib. 7.
. . et in lento luctantur marmoretonsae ,
mi si rappresenta un traslato simile
,
chiamando egli il mare in quel verso
un marmo viscido , e cedente. £ certa-
mente siccome molt’ altre maniere, cosi
dovette prendere questa da Catullo,
il
3uale ne’ versi Galliambici sopra Ati ,
isse verso la fine di essi versi Mormo-ra Pelogi per 1 ’ acqua, del mare.
V
Pag.3. V. iQ. figliuolo fCunmaf^liuolo^
Anacreonte
,
o chi sia l’autore della
Canzone tuówffov , attribuita ad Ana-creonte : ,
Vévov àpxé^ov fóv otvov.
• \
Digiti?:-;! by Google
55 »
E Pinàaro con più robustezza nella no*na delle jNemee :
Apfvpiam dè vo(id-
vo (piàÀaKTi ^laTÙy^ . /. . i t
.
ApijieXov 'xa.ìS'. o*
!
Madre del vino fu chiamala la Tite daCinea Ambasciadore del Re Pirro aTlo-
mani , il quale vedendo nella Riccia le
viti, come per aria, sopra olmi terribi-
li, che andavano fino alle stelle, scher-
zò sul sapore del vino bruschetto , anzi
che no , con dire , che giustamente
ne portava le pene la madre sua fatta
un penzolo sopra forch^ cosi rilevate.
Miratumque altitudinem earum Ariciae
ferunt L^gaLum Regis Pyrrhi Cyneamfacete lusisse in austeriorem gustum vi-
ni ; merito matrem ejus pendere in tamaita cruce. Plin. lib. r4- cap. i. Achiìle
Tazio similmente chiama la vite tov
pi^ipa. Ed in S. Matteo cap. ayquel yèwqpa si è lo stesso
,
che yó»o<; àpxéXov.
Pag. 3. V. z5. Giovinezza. 'i
Alcuni Gramatici hanno volu^ dire,
che la voce giovinezza sia solamentedelle Scritture moderne , e giovanezzadelle antiche. S’ingannarono. Dante stam-
pato in Firenze Accademia della
Crusca, Purg. 20 .
«6Per condurre ad onor la giovinezza.
Lapo Gianni manu scritto :
Pur giovinezza sembri uno bambino :
Fr. Giord. manuscrilto : Fiero , e per
rohust-a giovinezza baldanzoso. Potrei
adtlurre molti e molti esempli degli an-
tichi testi a penna.
X l-Pag. 3. V. 26 . Parrai Venere stessissima.
stofane nel Fiuto att. i. se. 2. per
ischerzo , come vuole Snida , e alla co-
mica ,disse ai'rÓTtt,ro(. Lo stesso dice
r.ioti co Scoliaste dtAristofane ^ cui per
avventura in questo luogo copiò Snida,
come è sua usanza il copiar gli Autori
senza citargli; ed ag^iugiie, che non si
trova ((uesto superlativo avrórarof
,
ne-
gli Scrittori di prosa ;ma bensì un sì-
mile , cioè (tovórarot
,
il che è come se
noi dicessimo solo solissimo, usato pure
più sotto dal Poeta nella stessa (Comme-
dia. Plauto disse ipsissimus che corri-
sponde al Greco avTÓrarot. Nelle anti-
che Prediche di Fra Giordano manu-scritte leggo : Si accorse esser lui Inis-
simo. 4 >''}
S -"4"
Pag. 3 . v.3z. *JVe chieggio un nappo.
1 Fianzesi dicono Henap, e lo prese-
li) da Sassonico Hnaep. \edi il dollissi-
! CCoogIc
5?ino Du-Fresne alla voce Hanapus. TediEgidlcf Menagìo nelle Origini della Lin-
gua llaliana , ed in quelle della Fran-
zese. Aedi altresì Pieti-o Boivlli nel Te-
soro delle Ricerche e Antichità delle
Ganle , ed il Fenario nelle Origini.
Pleir antico lAhro della cura delle Ma-lattie volgarizzato, per quanto posso cou-
ghietliirare , da Sere Zucchero Benci-
venni, trovo Annapo invece di nappo.
Stea per tre ore in una annappo fatto
di legno di edera, e poi si bea. Tra gli
Aretini oggi il nappo è un vaso di le-
gno per uso di bere , e per altri usi
nel tempo della vendemmia , e non so-
lamente dicesi nappo, ma ancora nappanel genere femminile.
Pag. 4. V. 20. Quei cotanto sdolcinato, ec. 1
Pisciarello. /
Tale era forse il vino descritto daBoileau nella terza delle sue Satire fa-de et doucereux
,
e il quale rìavoit rien >
qiìun goust plat. Di questo sapore sdol- '
cinato può essere, che intendesse Plinio
lib. 14 cap. 6, quando, discorrendo de’
gradi della nobiltà de’ vini , e venendoa quegli del terzo merito, dice AlbanaeUrbi eicina praedulcia
, ac rara in au-
stero. Catullo certamente non approva-va i vini cosi dolci :
il
\
Digitized by Coogle
58Minister vetuli piter Falerni
In^er mi calices amariores.
Sebbene lo Scaligero spiega, che per
atnari abbia voluto intendere pretti , esenza alcuno annacc^uamento
; c certo
dal Ilio tutto deir Epigramma si rendemolto ragionevole lo spiegamento dello
Scaligero. Ma noi abbiamo in Toscanaun dettato
Vino amaroTienlo caro.
il che s’ intende del vino non dolce , e
che pende gentilmente nell’ austero. Tut-
tavolta lasciando il parlar da scherzo
,
non fia eh’ io voglia biasimare il Piscia-
rello di Bracciano, che è gentile, e vi-
no da Dame ,ed è lo stesso vino di
quello , che in Firenze si appella Pi-
sciando,
Pag. 4. V. 26. Scartabelli.
Gli antichi dissero Cartabello, e se
ne valsero iu sentimento di libro di
pregio. Fr. Giordano pred. : Fo scri-
ve nel suo Cartabello sopra il Genesi il
Maestro Alessandro. Tratt. Astiu. Tutti
gli antichi savj ne' loro Filosofali Car-
tabelli lo hatino scritto.
Digìtized by Googl
Pag. 4. T. 27. L' erudito Pignatelli.
Intende del sig. Stefano Pignatelli ca-
valier Romano mio riveritissimo amico,e litterato di maniere senlilissime , co-
me ne fanno fede i Libri, cbe ha stam-
pati, e particolarmente il Trattato Pla-
tonico di quanto più alletti la bellezza
delC animo , che la bellezza del corpo ,
dedicato al nome immortai della Mae-stà di Cristina Regina di Svezia.
Pag. 4. V. 3o. Ciccio di’Andrea.Questi si è il sig. Don Francesco
d'Andrea nobilissimo Avvocato Najvoli-
tano , anch* esso mio riveritissimo ami-co, che altamente possiede tutte le -belle
arti, e tutte le belle scienze, che in unanimo nobile possono allignare.
Pag. 4. V. 3ì . Con amabile fierezza^
Con terribile dolcezza.ì
Claudiana nel Panegìrico , eh’ egli fa '
in lode d'Onorio quando per la quarta,
volta prese il Consolato, a ice di lui : (
Quantus in ore pater\ radiat quamjor^,
va vuluptasFrontif , et augusti majestas grata pu^
àoris l t
Quel torva ‘voluptas frontis spiega evi- ì
dentemente quel terribile dolcezza. Arist.|
X
Colib. I. della Rellorica discori'endo della
bellezza, secondo i p;radi dell'età, af-
ferma, che la bellezza del fiorane, per
cosi dire, fatto, ovvero dell’ uomo, ch’è '
nel vigore dell’età, è lo avere il corpo i
abile alle fatiche della guerra, ed il pa-
rere dolce con terribilità riB^vv di etvat <
doxtlv iifxw (po^epóxrrtOQ. < ìratore an- '
cora nel suo dire dee avere un orna-mento maestoso, una soavità soda e au-
stera. Cic. de Orat. lib. 3. Ita sit nobisigitur ornatus , et suavis Orator, nec la-
men potest alitar esse , ut suavitatemhabeat austeram , et solidam , non dul-
cem, aUiue decoctam. Dee aver dunque
una terribile dolcezza.
Pag. 4. ^.33! Tra gran tuoni dteloquenza.
Di Pericle grande Oratore della Gre-cia fu detto da Aristofane negli Acar-nesi att. 2 se. S. '
Yiorpaxx', è^pòvx» ,
^vftxvxa rii* iZ~Àdda,
Tonabat, fuìgurabat,permiscebat Grae-
ciam.
Questo verso senza ninna adulazione I
s’ adatta all’ eloquenza del signor Don >
Francesco dAndrea, '
Digitized by Google
6i
Pag. 5 . V. 3 .Quel d‘Aversa acido Asprino,
Che non so s' è agresto, o vino,
Plinio lib. 14. cap. 6. racconta di Ti-
berio Imperadore , che il vino di Sur-
riento non lo soleva degnare del nomedel vino; ma gli dava titolo d'un aceto
nobile, e «juasi cosi ^er appunto il chia-
mava il Cajo detto Caligula : ’l'iberius
Caesar àicehat coiuensisse medicos , ut
nobilitatem Surrentino darenf, alioquin
esse generosum aceturn : Cajus Caesar ,
qui successit illi , nobilem vappam. Puòessere, che tal vino fosse fatto da quel-
r uve d’ aspro sapoi-e mentovate dallo
stesso Plinio lil). 14 cap. 2. che facevano
sul Vesuvio , e nelle colline medesimedi Surriento. Gemellarum , scrive egli
,
quibus hoc nomea uvae semper geminaededere , asperrimus sapor , sed vires
praeciputte. Ex iis minor Austro laedb,
tur , caeteris ventis alitur , ut in Vesu-vio monte Swrentinisque collibus. Il
• moderno Asprino di l^apoli è lodato,
ed è messo in compagnia della Lagri-
ma, e del Greco da Felippo Sgrutten-
dio nella sua Tiorba a Taccone nella
corda nona della Canzone intitolata : JLeglorie di Carnevale.
Ma su lo avantete
De chella Lagrema^Pe chi, ainunè , sospiro si
62Dm lo Posileco ,
Grieco ed Asprìno^ ec.
E Gian Alessio Abba^utis nell’ Eglogaterza delle Muse Napolitane:
Ca trovo cienlo sorte
De vine da stordire ,
C hanno tutte li nomme appropriateVAsprinio aspro a lo gustoLa Larema , che face lagremare t ec.
Pag. 5. ». 6. Del superbo Posano in com-pagnia. .
11 sig. Gabbriello- Fasano di Napolij
poeti celebre ha tradulto eoa galanteria I
spiritosissima la Gerusalemme Liberaladal Tasso in lingua Napolitaua. Questo I
leggiadro Poeta leggendo un giorno il
Ditirambo , c tingendo d’ essere in col-
lera,
perchè in esso non si lodavano i
vini generosi di Napoli,
rivoltosi con 1
gentilezza ad un Givaliere comune ami- 1
co , ebbe a dire : Voglio fa verà, Baccoj
a Posileco, e le voglio fa 'vede , che I
differenza n c è tra li vini nuostri, e lei
PisciazzeUe de Toscana.^
Pag. 5. V. 8. Che del buon vino al par di
ine s' intende.
Gl* intendenti de’vini, e gli assaggia-
tori son detti con un nuovo e galante
vocabolo oìvó}fT<u da .Fiorentino uno de-
X
Digitized by Google
63gli autori Geoponici al lib, 7. e l’assag-
giare i vini ohoyev(TiIv,e son quest’esse
le sue parole ; oi àè éfiireipoi ohóìrtat
Tov rÓTov trréovroi oivoyevarov-
civ
,
delle quali paiole ce ne dà la Ua-duzione Pier Crescenzio al cap. 36 , del
lib, 4. bienni altri sperti conoscitori dea'ini altAustro gli assaggiano. Ho det-
to , che ce ne dà la traduzione PierCrescenzio
;perchè tutto il lib. 4. del
medesimo è copiato in buonissima parte
quasi a parola per parola dal lib. 7 del-
le Gcoponiche. Vero è che il Crescenzio
non \ide i Greci ;ma bensì una tradu-
zione Latina fatta da un certo Burgun-dio, siccome egli, citandolo in più luo-
ghi del lib. 4. viene a darci notizia , c
ai questa vecchia traduzione Latina , e
insieme del suo prendere da quella.
L’ eruditissimo sig. Antonmaria Salvini
Lettore della Lingua Greca nello Studio
Fiorentino va dottamente congetturando,che quel soprammentovato Burgundiosia quello stesso , che tradusse le cose
Greche delle Leggi Latine compilate daGiustiniano. Que/ Burgundio
,
dice il
sig. Salvini, citato sempre da Pier Cre-
scenzio ne Capitoli , che apparisconotratti dagli Autori Greci Geoponici , io
r ho per quel Burgundio Pisano , chetradusse ciò che <v' era di Greco nelle
Latine compilate da Giustiniano,il quale però il Panzirolo nel Lib. de
64Claris Legum Interpretibus, chiama Ber-
ffuntio, Jura ergo Gr.xce coiiscripla, di-
ce egli, Berguntio Pisanus Lcoai» Juris-
coiisulti Avus Latina fecit , ut Odotre-dus vetustissiiniis Auctor testatur. Que-sto OtIoJ'redo fu discepolo di rizone , efiorì circa il 12S0 , come evidentementemostra il Panzirolo nel suo Elogio lih. 2cap. óS de' Lettori di Legge Illustri. Eraadunque in tpie tempi mollo famoso ,
come intendente di Lingua Greca, que-sto Durgundio , o Berguntio
, e potette
siccome le Leggi Greche , che sono nelDigesto, e le Novelle, così anche avertradotto i Geoponici , o pure fatto unLibro della Vendemmia, nel quale nonV era di suo altro che il nome e la fa-tica del tradurre, di cui si potette be-
nissimo servire Pier Crescenzio, che fiori
al tempo di Carlo IL di ringiò He di
Napoli e di Sicilia.
Pag. 5. v.i3. y rinco intralciar la pampinosavigna.
Qui vigna vale lo stesso che vite
,
nel medesimo modo che appresso i Greci
il àpiceÀec , e appresso 1 Franzesi la
veigne significa e vite e vigna ; ed in
questo significato di vite non ne man-cano esempli appresso i buoni Autori
Toscani. Ne porterò (lui un solo sommi-nistratomi dal Vocabolario alla voce
'Tralcio, ed è di Seneca pistol. ò6. Pren-
Digitized by Google
65
dea il tralcio del ceppo della vippia vec-
chia, e mettealo sotterra. Il Testo La-
lino dice Illud etiam nane vidi vUemex arbusto suo annosam trans/erri.
Pag. 5. V. a8. L' ingiMtare.
La voce Inguistare può esser nata
dalla Provenzale Engrestara. ?lelle Rime
Provenzali, antico manoscritto in carta-
pecora della Libreria di s. Lorenzo sen-
za titoli di Autori si legge:
yénc al temps èCArtus, ni d" ara
Non crei, qe nuls homs uis
• Tan bel colf , cum en las crins
Pris Sordel dtun Engrestara.
Et sei colp non di fo de mori
Sei qel pezenet nac tort
,
Mas el al cor tan umil, e tan frane
Qel trend en patz totz colps, pois no
i e sane.
La Engrestara de’ Provenzali è cosa fa-
cilissima , che prendesse origine dalla
oce Greca Tàaipa, vaso corpacciuto
mentovalo da Àteueo e da altri , dalla
quale senz’alcun dubbio derivò il voca-
bolo Ciciliano Grasta usato dal Boccac-
cio nella Novella della Ciciliaua. G)$i
gli antichi Provenzali dissero Engresta-
. ra
,
quasi Ingrastaria. Quindi il Novel-
liere antico, libro pienissimo di Proven-
zalesimi , usò Inguistara , e noi iiual-
Eedu Opere. Vol, L S
66mente Guastada , di cui hanno Tolnto
scriTcre diverse etimologie il Menagio ^
il Ferrari
,
il Monosini , ed il Canini ,
che tutti sono da vedersi.
Pag. 5. . 33. Io di Pescia il Buriana.
Forse il Burlano è fatto dell’ uve diquella razza , di cui Crescenzio 4. 3. io.
Ed è uri aUra maniera , ciré si chiamaBuranese , che è uva bianca molto dolce.
Pag. 6 . V. 3. ^gli è il vero oro potabile.
Un pensiero non molto differente si
legge in un antico Quadernario d’ unPoeta Turco tra' Libri Orientali manu-scritti del Serenissimo Granduca Cosi-
mo 111. mio Signore.
Ibrik zerden salkia laal mezbbi Rii
revan
Àltum olur isciunij taman kibrit ah-
mar ghendidurRaher zemanunij deft itmea isaki devan
llla sciarab dilkuscia Teriak acbar ghen*
didur.
Dal boccal ét oro , o coppiere, fa cor-
rere il rubino fondato.
Tati oro sarà la tua opera^ perchè que-
sto è il vero zolfo deltAlcharùa :
Per iscacciare il 'veleno del tempo reo,
e iniquo non v' è altra più possen-
te medicina
I
Digitized by Google
®7Del vino , che apre i cuori. Questo è
la Teriaca massima.
Debbo questo luogo al sig. Bartolomfmeo dErbellot gran litterato Fraozese,e yersatissìmo iu tutte le lingue Orien-tali.
Pag. 6. T. 6. Egli è Elena il Nepente.Questa medicina, cbe messa uel vino
faceva rallegrare il cuore, e toglievaogni tristezza data ad Eleua da Polida-mna moglie di 'fune colà nell' Egitto
,
cbe alcuni vogliono, che fosse la Borra-na, e Plinio l'Elenio, vien descritta daOmero nel 4. dell’ Ulissea al verso 220.
Pag. 6. V. 14. Il buon vecchio Rucellai,
Allude a’ Dialoghi Filosofici del sig.
Cavaliere Orazio Rucellai Priore di Fi-
renze : e perchè non sono per ancorastampati , e si conservano manuscrittiappresso il sig. Priore Luigi suo figli-
uolo, mi fo lecito portar qui 1’ argo-
mento di quella degna e nobilissima
Opera.I Dialoghi sotto nome dellImperfetto
Accademico della Crusca pigliano il
motivo dall indirizzare i figliuoli nellavia della virtù ^ tr(ì quali Luigi il mag-giore interviene in detti Dialoghi. Que-sti sono disposti in tre villeggialwe ^
Tusculana , Albana e Tiburtina ì eia-
tr.
scuna delle tjuali è divisa in varie^
di ricreazioni studiose, e queste ne Ùia^
loghi. L' occasione di esse Dillegpature
si assegna al contagio , nel cui tempo
si finge dalCAutore , che molte conver-
sazioni di uomini eruditi ritirati in quel-
le buone arie ,si trovassero insieme
,e
discorressero di varie materie ;fra’ quali
per mantenitor del discorso , s' introdu-
ce Don Raffaello Magiotti, come uomo
versato in alte scienze ; e fuori che TIm-
perfetto e Luigi, i quali intervengono
. col Magiotti in lutti i Dialoghi-, ortu-
na ,or P altra di quelle persone erudite
s'introducono in etri, secondo che la
materia si confà col genio e co talenti
loro. La materia universale sifonda so-
pra le due proposizioni-, hoc unum icio
quod nihil scio, e nosce te ipsum,la
prima di Socrate , e P altra , che dalla
gentilità s'attribuisce ad Apollo scolpita
nel frontespizio del Tempio di Delfo.
La prima , di' è contenuta dalla villeg-
giatura Tusculana ,si vien provando col
dedurre in varj Dialoghi le opinwrd
cotanto diverse degli antichi c più re-
putati Filosofanti , (P intorno a' principi
universali, che variamente e' si sono
immaginati della Filosofia naturale ; e
mostrando , che niuna opinione ne con-
vince con prova manifesta ,si viene a
dimostrare per vera la mentovata pro-
fosiiione di Socrate. Nella villeggiatura
Digitized by Google
Cibària si tratta dèli animà e delle suépotenze ,
siccome degli organi e degt i-
stramenti ,per cui , e dove esse si ma-
neggiano ; che perciò discorrendosi della
otomia , si vengono a distinguere quali
strumenti servano agli appetiti^ e a sene
si : e quali alla mente e alt intelletto
e alla rosone. Per mezzo di tal cogni-
zione si passa alla villeggiatura Tibur-
tino , onde s' indirizzano le dette opera-
zioni al conseguimento della virtù e allo
sfuggimento del vizio ^ con varj Dialo-ghi intorno alle materie morali. Per tal
modo conesso il conoscimento di noimedesimi s' impara a distinguere il Jine^
a cui sieno destinate le parti sensibili,
e a quale le ragionevoli^ e come quelle
abbiano a essere ministre , e suddite di
queste. In somma in tutti i sopraddetti
Dialoghi si favella distesamente .delLst*-
na e -deWohm Filosofa naturale e mo-rale i e dove il luogo sia opportuno, ci
vengono sparse molte di queste opinioni
moderne tanto di’ intorno alle cose fisi-
che, che alla Notamia i traendo m^tiltto
e per tutto la materia filosofica^ dalle
questioni , c dà termini delle scuole ; eridurendoTa , il pià_ che si può
,a dl-
scorsi facili e familiari,
TT Opera corrisponde molto bene , e
con gran nobiltà all’ argomento ; e per>
cbè questo virtuosissimo Cavaliere noa•olaaeuU nelle prose lilosoiicbe , ma
I
J3igitized by Google
7»ancora nella poesia era genlilissimo
, e
{
>ieno d’altissimi pensieri , voglio farmi
ecito di soggiugner qui, come per sag-
gio , uno da’ suoi Sonetti di sentimentoPlatonico.
Sentimenti amorosi secondo il concetto
Platonico che Dio creasse l’ anime
Sarticolari degli nomini degli avanzi
eli’ anima universale del mondo.
Con eterne faville il sommo Sole
Suo divino valor nel mondo accese i
E quelC alta ragion dal Ciel discese ^
Che spirto infuse a cosi vasta mole.
Ma perchè si belP opra adempir vuole ,
/ preziosi avanzi in man riprese',
E vostra abita gentil formarne intese
Con divine virtudi al mondo sole.
E se ben mille e mille altri composeSpiriti accesi da suo ardente zelo
;
Qualche raggio più vivo in voi nascose :
E 'n porgervi Natura il mortai velo
,
, Tanta chiarezza ed armonia vi pose
,
Che ben traspare in lui, che cosa è'
l
cielo.
Digìtiz^i»_L
Pag. 6. V. tg. Ed additava donde avesseorigine
La pigrizia degli astri , e la vertigine,
UAlamanni Colt. lib. 3. dice del vino :
Ma l'ingegno, il discorso, e t alte parti.Che delt animo son, risveglia.
E appre&so:
(Questo ci mostra in del le stelle e i
poli-,
I cerchi e gli animai, che van d'intorno ;
II viaggio del Sole , e le faticheDella Sorella sua ; degli altri i passi j
I dolor di'Orlon ; del Can la rabbia.
Pag. 6. T. 21. Quanto errando, oh quanto vaNel cercar la verità
Chi dal vin lungi si sta !
Presso Ateneo lib. i. vien fatta menzio-ne del proverbio oivot xai àXijSfeià, del
quale si servì Teocrito ,Idill. 35 . che
' cosi comincia :
<
Olvoc, ov (piXt stai Mytxai xai àXaòéa.
Tanto è a dir vino,
che verità. Plin,
lib. 14. 22. ulgoque veritas jam attri-
huta vino est. Noi Toscani abbiamo unproverbio ; La tavola à una mezza eolia.
72Pag. 6. T. 25. Che in bel color di fragola
matura.
Questo forse è quel colore di Tino
,
che PUrì. lib. 14 . cap. g. chiama sangui-
gno : Coìores vini quatuor : albus, ful-
vas ,sanguineus , niger.
Il Chiabrera :
Sulla sponda romita
/ lamgo il bel rio di questa riva erbosa ,
Y O Filli, a bere invita
A Ostro vivo di fragola odorosa.
Pag. 6. V. 36. La Barbarossa allettami.
È un -vino gentile , scarico di colore,
d’un vitigno particolare, per lo più del
contado di Poscia.
I
I
I
I
Pag. 7. V. 3. Voglio berne almen due cio-
tole.
Ateneo nel lib. ir. ove fa una lista
secondo T abbiccì di varie fogge di bio>
cbirri, alla lettera K. pone un tal nomeKotvAi? , che è un biccniere fondo sen-
za manichi , simile ad una conca , ovaso da lavarsi , differente dal calice ,
!
>er non aver manichi, o orecchi , comeIO detto. Più sotto alla voce Kv3t^ cita
un certo Glaucone nelle Glosse , cheafferma, il calice da’Cipriotti esser no-
minato Co^la. Da questa voce usata
anche da’ Latini per una misura di li-
Digitized by Google
^. .
.73qttidì abbiamo sene* alcan dubbio fatta
la nostra Ciotola. Cosi ancora tenne il
sif;. Egidio Menagio nelle Origini della
Lingua Italiana, rij^rtando quivi quan-' to ne avea prima di lui scritto Girola-
mo Aleandri nella risposta all'Occbiale.
Soggi ligne poscia ingannarsi il Monosi-ni, cbe deduce Ciotola dal Greco xéòov.Quindi nelle Giunte non gli sembra an-
co inverisimile il pensiero del PadreBertet Gesuita , che da Scutula detta
per Scutella fa derivar Ciotola.
Pag. 7. T. 9. A quel mal porgo un soc-
corso.
Euripide nelle Baccanti dice, che nonV* è altra medicina de’ mali, e degli af-
fanni , cbe il vino.
ovò' iftìf àÀXo (pàppaxov
XÓPOV.
E P"arone nella Satira , cbe egli intito-
lò : Est modus matulae jttpi x
volle dire , che vino nihil fucundius
qtiidquam cluit. Hoc ad aegritudinemmedendam invenerunt.
Pag. 7. V. II. Non fui gtàj che il Ciocco-
latte.
Il Cioccolatte è una mistura , o con-fezione fatta di varj ingredienti , tra i
' quali tengono il maggior luogo il Cacao
ahbronr.ato , ed il zucchero. Così fatta
confezione messa nell’ acqua bollente
colla giunta di nuovo zucchero sei-ve
di bevanda a’ popoli Americani della
nuova Spagna. E di là traportatone Tu*
so in Europa, è diventato comunissimo,e particolarmente nelle Corti de’Princi-
p5 . e nelle case de’lNobili; credendosi,che possa fortificare lo stomaco , e cheabbia mille altre virtù profittevoli alla
sanità. La Corte di Spagna fu la primain Europa a ricever tal uso. E vera-
mente in Ispagna vi si manipola il Cioc-
colatte di tutta perfezione: ma alla per-
fezione Spagnuola è stato a' nostri tempinella Corte di Toscana aggiunto un nonso che di più squisita gentilezza
,per
la novità degl' ingredienti europei , es-
sendosi trovato il modo d’ introdurvi le
scorze fresche de’ cedrati e de' limoncel-
li , e r odore gentilissimo del gelsomi-
no , che mescolato colla cannella , colle
valniglie, coll’ambra, e col muschio fa
un sentire stupendo a coloro , che del
Cinccolatte si dilettano. Del resto in no-
stra lingua r uso ha introdotte le voci
Cioccolatte , Cioccolate ,Cioccolata e
Cioccolato derivate dal nome Indiano.
Uno de’ primi, che portassero in Euro-pa le notizie del Cioccolatte, fu Fran-cesco dAntonio Carletti Fiorentino
,
che in un suo lungo e maraviglìoso
viaggio, avendo circondato tutto l’Uni-
Digitized by
verso dall’ Indie Occidentali alle Orien-
tali, ritornò quindi in Firenze il di 12
di luglio 1606 ,donde si era partito
l’anno i 5gi a’ 20 del mese di maggio:e lo raccolgo da alcuni ragionamenti dalui fatti alla presenza del Serenissimo
Ferdinando I. Granduca di Toscana , il
manuscritto de’ quali si trova appresso
il sig. Conte Lorenzo Magalotti , ed io
ne ho estratte le seguenti notizie.
Pigliammo prima posto in s. Jonatdiscosto da Limma 1600 miglia posto in
altezza di gradi e mezzo verso il polo
Artico , luogo ove nasce il Cacao frut-
ta tanto celebre^ e di tanta importanza
per quella provincia , che si affermaconsumarsene ogni anno per pià di cin-
quantamila scudi , la qual frutta serve
ancora di moneta per ispcndere , e per
comprare nelle piazze le cose minute ,
dandosene per un giulio il numero di
settanta^ o ottanta, secondo che se neraccoglie più , o meno ;
ma il suo priri-
cipal consumo si fa in una certa be-
vanda, che gt Indiani chiamano Cioc-
colate, la quale si fa mescolando dette
frutte , che sono grosse come ghiande ,
con acqua calda e zucchero ; e primasecche molto bene , e brustolate al fuo-co si dUfanno iopra certe pietre, sicco-
me noi vediamo disfare i colori alli pit-
tori, fregando il pestello, che è ancKes-so di pietra
,per le lungo sopra detta
76pietra piana e liscia ;
e cosi si viene d '
formare in una pasta, che disfatta nel-
r acqua serve di bevanda, che s' usa
comunemente bere per tutti i naturali
del paese \ e gli Spagnuoli , e ogni altra
nazione , che vi vadia , e una volta si
accostumi a essa , diventa cosi viziosa
,
che con difficoltà può poi lasciare di
berne ogni mattina, o vtro il giorno altardi dopo desinare
,quando fa caldo
,
e in particolare quando si naviga ; eperciò si porta accomodata nelle scatole
fattone mescolato con spezierie, o fatta
in panellini, che messi nelt acqua su-
bito si disfanno in certe ciotole, fattedalla natura di frutte grosse , che pro-ducono alberi di quei paesi, come zuc-
chette, ma tonde, e più dure di scorza-,
che secche diventano come legno, nelle
quali bevono detto Cioccolatte , rime-
scolandolo in esse con un legnettn, cheraggirandolo colle palme delle mani se
li fa fare una spuma di color rosso , esubito se le mettono alla bocca , e lo
tracannano in un fato con mirabile gu-sto e satisfazione della natura
, alla
quale dà forza ,nutrimento e vigore in
tal maniera , che quegli , che sono usi-
tati a beveme , non si possono mante-
nere robusti lassandolo , se bene man-giassero cose di maggior sustanza ; epare loro venirsi meno
,quando a quel-
r ora non hanno detta bevanda -, sicco-
,77
me avviene ancora a tutti Olitegli , c/ie
sono avvezzi a pigliare il fumo di ta-
bacco similmente molto stimato, e usato
per vizio da ogni condizione d" uominiin tutte queste Indie per cosa moltonaturale del paese , che lo produce ; il
quale è caldo e umido, e quivi usano
pigliare detto tabacco fattone polvere ,
la tirano su pel naso: e nelluno e nel-
T altro modo vien commendato assai perdiverse sorte d infirmità, e per evitarne
molte ;e in particolare guarisce t acci-
dente del mal dellAsima , ma io , se
bene stetti nel detto paese , beveva del
detto Cioccolate, e mi piaceva e giova-
va', e quasi non mi pareva potere stare
un giorno senza berne, ma non mi pia-
cque già mal pigliare il fumo del ta-
bacco ,del quale per esser foglia tanto
conosciuta non dirò altro ; e solo toc-
nonrio al Cacao ,col quale si fa detto
Cioccolatte, dico, che è una frutta, chenasce nella predetta Terra di S. Jonat,
ma molto più se ne raccoglie nella pro-
vincia di G-uattimala iT un albero pic-
colo , a maraviglia bello, e tanto deli-
cato , che se non si coltiva lavorandoli
la terra , e nettandola da ogni malaerba
,e se non si pianta , e si custodi-
sce appresso in mezzo di due alberi
molu> più grandi', che gli stessi Indianichiamano il padre e la madre del Ca-cao , acciocché venga difeso dal sole e
dal vento ; non produrrebbe il suo frut-to ^ che produce una volta t anno, ser-
rato in Ulta scorza durissima, come unapina-, se bene vi sono compartiti dentro
i frutti in differente ordine, e molto piùgrossi, che non sono i pinocchi con la
loro scorza dura : ma questa frutta ca-vata dalla sua prima scorza
, non haaltro che una sottilissima buccia che la
copre , e tiene unita quella carne, che
si divide come una ghianda in molti
pezzetti cC intorùcciate commettiture in-
sit-rne , e di color lionato scuro , e disapore amariccio , tenendo in se urta
certa untuosità e crassizie , che gli dàuria sostanza e virtù , che chi ne beve
la mattina una di dette ciotole ( cheesse dicono cìiichera ) acconcia comesi é detto , è cosa certa , che per tutto
quel giorno se la può passare senza al-
tro mantenimento , ec.
Fin qui il Carletti
,
nel quale s’ os-
stM'vi, che ne’ suoi tempi si bevea unachicchera di Cìoccolalte tutta iu un fia-
to ; ed oggi si costuma universalmente
Eigliiii'la a piccioli sorsi ; ed è prover-
iule detto degli Spaglinoli en Choco-late no se beve , sino se toma. E unagran Dama soleva dire , che el Choco-
lute se ha de tornar calienle,sentado
,
y murmurando.La maniera di manipolare il Ciocco-
latte in pasta « e di ridurlo poscia in
Digitized by
foggia d’ una bevanda ogni qualvolta
che voglia prendersi, l'u gentilmente de-
scritta con nobiltà e proprietà di versi
latini , come per uno scherzo , dal Pa-dre Tommaso Strozzi Mapolitano granTeologo , e Predicatore insigne della
Compagnia di Gesù. Spero di far cosa
grata a’ Lettori col portare in queste
Annotazioni quella galantissima Poesia
conceduta cortesemente alle oue pre-
ghiere dall’Autor medesimo.
Principio t chalybis rvpelito crsbrius ictu^
E gravidae 'vena silicis mUii seminaJlammae
Elido, imbutus quam sulphure fomesin auram
Excitat , et multo satur excipit un-guine lychnus :
Appositae lychnus triplex substemi-tur umae
Abditus , instabili ne fluctuet ignis
ab aura :
Abditus , incluso 'vires ut colligat
igne.
Quo lateat, subjecta umae stat ahe-nea circum
Turriculae in speciem dimenso carce-
re fomax,Multiplici fomax oculata foramine ,
flammam
Ut modico sentim spiramine nturiat
aer ,
Angustoijue vomat glomeratwn in car-
cere fumum.Ni pateat ,
vivum mox deserat halir
tus ignem.
Ni pateat ^ vigilem fìanus mox obrual
ignem ,
Hinc subito lymphae semissem infun-
dere in urnamSoUicitus propero : semissem pondero
certo
Hesperii statuunt. FerU imam cuspide
ahenumIgnis, et infusae frigus mihi perdo-
mat unda.
Interea facili Cocolatem scindereferro^
Dives ab occiduo mittit quem Mexi-cus orbe ,
Aggredior\ strata surgunt praesegmi-
na charta
In cumulum , cumuloque modum le-
vis uncia ponit.
Q^uin et sacchaream decisa in /rag-
' mina metamComminuOf cumulusque pati mihi portr
dere surgit,
Mixtaque stai fusto simuly uncia et
uncia metro,
Vix opus expedio , mussai simul un-
da ,susurroque
Advocat ipsa suos libamina dulcia in
aestus.
Digitized by Googl
8f
Haud mora , fumiferòs pretiosa obso-
nia jacto
In latices ,digito relegens vestigio ,
si quaUda vaporato servai sibi chartula
fumo.Sunt et qui geminos , dainnato more^
vitellos
Adjiciant ,liquidum ut cogant em-
bamma vitelli.
Hi potius ventri faduni \ bis vectaLibumo ,
Et vel amygdalinae , vel foede sordi-
da quernae
Glandis adulterio^ Cocolatis nomine
^
gleba
Ah precor obveniat ; quando tamcrassa palato
Arrident ,vilemque movent pulmenta
salivam.
Sed jam fervei opus , versandaqueturbino lympha est.
Est mihi roborea decerptus ab arbore
turbo ,
Turbinibus vulgi dispar, nam longius
unHastile assurgit , cui cuspide figitur
imaTordlis , et muhis dissectus dentibus
orbis j
Ille inolarn simulat,palmaque inclus-
sus utraque >
Redi. Opere. ul. I. 6
Trudit odorotum ,miscetque volumi-,
ne ìihum.
Quae mihi ,quae gravidis flavo de
vortice bullis
Spuma tumet\ lepido nubes quam ro-
scida labro
Emicatt et fumo nares pnmtat odoro ! •
Mox ubi multiplici detrita est utra-
que gy ro
Palma,, molae insislens, permistaque
frugibus unda,Excipit incoctum mellita ad pocula
nectar\
Ipse etiam patulo sitiens brevis ur-
ceus ore ,
Urceus illimi vincat qui murrhina
creta ,
j4st mihi non uno temere stani po-
cula jactu ,
Nec simul exhausta cumulantur fun-
ditus urna.
Funditur ad numerum succus , quae
turgida bullas
Pars agii ,inverso perii liaec decer-
pta lahello',
Quae superest ,muhos iterum revo-
catur in orhes\
Utque novo spumae tumet altius ex-
cita flore ,
Ipsa etiam cyathis , suspenso parcius
imbre
,
Additar ;alterno mihi terque ,
qua-
terque rotata
Digitized by Google
83In spumoni liquor omnis ahìt
, fusus-que capacem
Explet , ballato turgescens fornice ,
nirnbuin.
GuUur hiat , nimbuinque inhians al-
lambere labro,
Spumea suspenso delibai pacala suctu.
Qui sapori exsucti quae roris gradaiqui ftos !
Augurar. Edocto non gradar alla pa-lato ,
Non dedignantis stomachi torporibus
Itila
Blandior Ambrosia est. Hispani o di-
cite ; Galli
Credito : non animos quae vellicet al-
la supinos
ForUor , et crebro jubeat sibi plaude-
re saldi.
Ast non fas uno siccare voracius
haustuFocaia ;
fumanti quod ferveat humorab aestui
Nec lubet: admoto combusta^ parcius
igne
Infudisse juvat medicato in nectare
ofellas
Panis , et intinctu mollitas frangeremorsa.
Vina vorent olii, seu quae non sub-
dita praelo ,
Jnjussisque fluens lacrj'mis dedit uvarubend
94Muijxe, Cretaeo seu quae stillata
cerno
Nauta peregrina vexit super aequoracymha.
Haud eqiudem invideo, capitique ,
oculisque nocentemDevoveo ; Hispana laetus promulside
,
Bacchimi.
Hoc hoc uberius te nectare protue ;
buccas
Huc centumgeminas Fama o demer-ge , canoram
Ut gemines animam, centenaque for-tius infles
AEra^ et utroque canas magnum subSoie Columbum.
Hic prior Herculeas Abylam , Calperir
que columnasNec sibi defixas , tati nec censuit
orbi ;
'^Icidemque animo exuperans , ubi
Jiocerat ille,
Extulit ipse gradum , ignotisque au-dacia ventis
Carbasa, et Oceano gemini spém cre>
didit orbis.
Ipse sibi PolluXi sibi Costar et ipse^
suosque
Pro geminis oculos Ursis, prò pjrxide
mentem'fronte gerens alias Terzis ostenderq
4erms,
Digitized by Googk
83Jiitra Astris potait, 'mundùmqùè ad^
fungere mando ;
t^uodque novo paceat rerum natura
cheatro ,
Se major ,magno debet detecta Co-
' lombo.
Huic nova labentis debes opobahamavitae
Gens hominum , nostri quae ìttrùte
cìauderis orbis
Scilicet Americis qua Mexicus expli-
cat oris
Frug^feras late ^ebas , caput exetit
arbos
In speciem tenuis;gratae sed germi-
ne glandis
K^uae truncos Arabum vincaU Ce-
drumque ,Cupressumque i
Et vitae amisso prope Jloreat aemulaLi^o.
Indica vox, Italis ingrata sed auribusi
illam
Exprimit, illecebramque gulae dixere
Cacaum ,
Hisce edam late Faginula provenit
• oris ,
Phaseolum siliqua referens Vaginula,sed quae
Tantum Phaieolo praestet, gratissi-
ma quantumExuperant predo pallentes Cynnama
cannas :
86Delicium Aumraé , lecto tjiutm rare
tenellam• lllecehras inter, redoìentis et ubera
' F/orae
. Educai, et grato donai pinguescere
succo.
DLeeris enatam qua comua dejicit
Iris ,
Gleba ubi Sidereo felicius halat odore :
Tanta illi ex ipso fragrantia corticc
spirai,
Illam languiduli circum Zephyrique ,
jocantesque
Aurillae allambunt, dulcique per oscu-
la furto
Fragrantem rapiunt animam , vectam-
que volucri
Remigio alarum vicina per avia furi-
dunt.
Haec Cocolatis erunt tibi bina eie-
menta parandi.Qui si nosse lubet qua fruge metro-
que paretur
,
Accipe. Delecti partem sepone Cacali
Praecipuum Guaxaca dabit, quo Me-xicus ullum
Fnigij'eris nusquam praestantius edu-
cai arvis.
Pingue legas ,carptumque ex arbore,
namqueExesum macie, vel rmiltìs ante re-
postum
Digitized by Google
htensibus tfxiuctt» sine viribus unguiriè
torpet.
Arserit interea moderato Clibanus
igne,
' Torreat ut lectas afflata deside glan-
des ,
Est sapor , est tosto major mihi cre-
de CacaoGratia ,
nec cyathos dabit exTiaurire
salubres
Ni vehemens succi ingenium prius igne
retandosi,
Tarn fragili tostas simul exue cortice
gìandes
Ne puram infìciónt neglecta putaminet
massam ;
‘ ‘
Neve imo vilis Jundo subsidat a-
murca ,
Dulcia nectareo sorbes cum pocula
nimbo.
Hinc defaecatum partita froge Ca-
caumMarmoreo lapidi
,qitem levior als^eus
aequet ,
insieme ,et duro pressum defringt
cilindro ,
Injice mox labro , atque alias super-
ingnre fruges ,
Pondero quas certo ut statuas , age ,
pende Cacai
Ante alias libram , cui roris congere
hessem
Digitized hy Google
88Saccharei, et junctos cognato foedere
mìsce.
Augeat et tritis fragrans Va^nulafhistis
Vel tema libram silùjua , vel fortequaterna ,
Si mavie nares ut oìendor • halitus
afjflet.
Et contendit iners stomachi depellere
fngus\ :
^am calido target pinguis Vaginulasucco.
Cynnama quin edam mordaci e cor>
tice sectamPardculam pendant, piperi sed parca
calenti ,
Qued praefert spolio rubicundi corti-
cis urens
Immodico fbras Cocolates Indicus
aestu.
Sed potius moschi puìvis , vel messis
odoraePrimus apex , Ambar, modico sed
aromate mixtumAccedat, capiti quaesitum, et nari-
tus Arrwar.
Mox age coUectas itentm supetingere
frugesMarmoreo lapidi , modicos cui sub/ice
prunasUt sensim lentus tibi cuncta coup-
let ignis.
n>gitized by Google
Marmoream posthac iterans age ti*-
me cylindrum ,
B.t eotam lùctante manu ,luctantibus
armisCantere ,
pinse , agita , validoque re-
perdite nìsUf
Donec permistam, et saxo molitore
subactamUnguinis in morem cogas coalesceie
massam.Hanc aut in teretes demum dispesce
cylindros ,
Vel sterne in lateres , latumv* recol-
lige in orbem.
Tum clausa libi conde arca-, nec prò-
fer in usum,
Signifemm 'l'itan donec compleverit^
orbem ,
Ut constipata durescantfrustala mica.
Et calida demum citius solvantar ab
andò.
Fin qui il Padre Tommaso Strozzi :
ed acciocché si conosca chiaramente
,
eh' è stato uno scherzo, se nel Ditiram-»
ho ho biasimato il Cioccolatte;
soggiu-
gnerò alcuni versi latini scrittimi negli
anni passati dalla gentil penna del sig.
Pier Andrea Fononi Accademico della
Crusca , dotto non meno nelle Toscane^
che nelle Latine Lettere.
9°
AB
FRANCISCUM REDt
PÀTRICIUM ARRETINUM.
J^^umantem pateram teneo dum nectare
plenam ,
Quod parit Occiduo terra sub Orbe
jacens,/ f ! |
Libo llbens, Gen^mgu^ voco;\laetus^ I
'que prmino ,>
Atque Ubi "ex animo fata seconda
precor.
O dutcem Ambrosiam\ validam firmare
salutem ,
Digiiized by Googic
Labentem , et vitam quae reparare
vales !
rid Superum mensas genus immortaleDeorum
Crediderim succos appetiisse tuos.
Mexicus Occiduis Cocolutem mittit aboris ,
Qui fama implevit Solis utramqueDomum,
Felix qui prior ignotum tentare pro-
jtindumjdusus , et indomito ponere fraena
mari.
Non quia divitihus ripis argentea cur-
runt
Flumina, queis fulvwn subdit arenavadum ;
Non quia gemmiferis iìlic plaga rupibus
ardet ;
Sed quia 'vitali cespite frondet hu-
mus.O fortunata , et Saturni tempore digna
Arbor,quae tarUas prodiga fundis
opes\
Indidit arcanum tibi Fatum rohur^
ut
omnesFxupetes plantas , cedat et omne
nemus.Sic te felici despectet sydere Coelum ,
Sic fetus teneros nulla procella petat.
Sic le rare levi ciemens enutriat ÀEther\Radicem in nostrum ftge benigna So'
ktm.
9»Sic longaeva Salus depellet pectore soni-^
num :
Si Cocolatis adest i is , sopor '' èxulerit.
Sic luctus , curae >,morhi
, tristisque se-
nectns
Longe aherunt,potus si Cocolatis
adesti
Quare age , cnlte Redi , Cocolatem tol-
lera canta
Incipe ;namque illi ìtaec Gloria sola
deest.
Pag. 7. T. 12. Il TeE una bevanda usitatissima traile per-
sone nobili nella China « nel Giappone^
e quasi in tutte le parti dell’ Indie O-rientali ; e si compone col tenere infusa
. nell'acqua bollente mia certa erba chia-
mata Te, ovvero dà.Chi vuol notizie più particolari di
tal erba, legga il Padre Giovanni Maf-
feo nella Storia dell’ Indie ,il Padre
Matteo Ricci , Giacomo Ronzio ,Oio-
'vanni Linscot, Pietro Jarrie , Luigi
Froes nelle Relazioni del Giappone , il
Libro dell Ambasceria delle Provincie
Unite all Imperador della duna ; il
Fiag^o del Vescovo di Berit alla Coc- ,
cincina. Il Padre Alessandro de Rodes,
il Padre Atanasio Chircher nella China
illustrata , Simone PaulU nel Quadri-
Digiiized by Google
partito Botanico, dell’uso dell’erba 2 e,
. e molti altri autori , che ne hannoscritto.
Pag. 7. V. 17. Caffè.
Beveraggio usato anticamente tra gli
Arabi , ed oggi tra’ Turchi , e tra’ Per-
siani, e quasi in tutto l’Oriente; ed è
un cerio legume abbronzato prima , eposcia polverizzato, e bollito nell’acqua
con un poco di zucchero per temprarner amarezza. Non è gran tempo, che co-
mincia ad esser costumato in Cristiani-
tà , ma vi piglia gran piede; e vi son
persone ,le quali voglion dire , che il
Caffè non sia altro che l’antico Nejien-
te d’ Elena,
giacché ella , come recita
Omero,
ne imparò la composizione in
Egitto,dal qual paese per lo più ci ò
portato il fruito uel Caffè. Tra’ Persiani
da molti anni in qua si è introdotta
una nuova bevanda amarissima chiama-ta Choc-nar , la quale per ancora nonè costumata da’ Turchi : e piglia il no-
me dalle radiche del Melagrano , cheson il principale ingrediente. Per com-porla pestano quelle radiche , e ne ca-
vano il sugo ,il quale mescolato con
altre droghe gagliarde, si mette a bol-
lire io acqua come il Caffè , e si bee asorsi caldissimo in ogni tempo del gior-
po ; ma più particolarmente ne' couviti
tanto tra’ grandi ,che tra’ plebei, e tanto
tra gli uomini , che tra le clonue per
conciliare 1* allegria. Comiuciano bene
i Turchi più civili ad usare una be-
vanda fatta col sugo spremuto dalle
mele cotogne, delle quali è abbondante
il territorio di Costantinopoli, raddolcita
con un poco di 7-uccbero, e la succiano
bollente, e a sorsi, come se fosse Caffè.
Pag. 7. V. 1 9. Giannizzeri,
Vedi il Covarruvias nel Tesoro della
lingua Casligliana alla voce Genizaro
,
vedi il Vossio de vitiis sermonis ; vedi
l’Abate Egidio Menagio nelle Origini
delia Lingua Italiana , e Ottavio Fer-
rari pur nelle Origini della medesima
Lingua Italiana.
Pag. 8. v. 3 . Montegonzi
Villa posta nella Diocesi Aretina ce-
lebre per la bontà de* vini.
<' * *!
w V-‘
' Pag- 8 . V. 7. Un indistinto incognito dilette 1
Dante , Purg. 7.
Ma di som'ità di mille odori
Fi faceva un incognito indistinto.
I
I
Tass. Amint. att. 1.2.
A poco a poco nacque nel mio petto
Non so da qual radice
Coni erba suol che per se stessa germini^
Un incognito affetto.
Digitized bv Goosle
5)5
P« 8. V. 20. Depor cedratisi il naturale or-
goglio
Galeno nel terzo Libro delle cagioni
de’ sintomi ci lasciò scritto,che le viti
trapiantate in paesi differenti producono
altresì il vino differente xd^axep olpat
•itai tò xctp fipiv apjieÀiOV , o( wcoiÀ>~
Àdtrovin 'là j(ppia> ,iidpopof ixpepàvn
TÒf olfor. Dello stesso parere fu Empe-docle appresso raulore della Storia Fi-
losofica attribuita falsamente a Galeno
oavtp exi lòri àpxé^o». ov "jfàpai dia-
(popai Tovxov xoiovn xòv oimv 9iaiiÀ,dT-
rovra , dÀÀà rov rpèportot; èSiupovf. Ej
pregio singolare della Toscana , che i ì
magliuoli delle viti straniere non sola- i
^nte v’ allignino bene, ma che ancoraj
vi producano il vino più grazioso e più
leggiadro.
Vr;
Pag. 8. V. 23. Chi la squallida Cervogia
Alle labbra sue congiugne
Presto muore, ec.
r
Jìon dissimile è il pensiero del Ron-|
sardo in quella Raccolta di versi , che
egli intitola les Meslanges nella Ganzo-|
netta , che comincia Boi Vilain :
I' home sot ,qui la-ve sa pance
D' autre breuvage,que du vin
,
Mourra iT urie inauvaise fin.
Il Maestro Aldobrandino maiuiscrittoPartita 3. cap. 2 . Cervogia è una manie-ra di beverof^io , che Cuomo fa di for-mento e di vena e d orzo. Ma quellaCervogia ,
cfie si fa di formento e divena, vai meglio, perche non enfia cosimalamente , e non ingenera tanta ven-tosità : ma di che ella si sia fatta , odi formento , o d orzo , o di vena , im-pertanto si fa ella mala testa , e si en-
fia la forcella , e si fa malvagia alenadi bocca , e ma' denti , e si riempie digrossi fammi le cervella, e chi con essoil vino la bee , si innebria tostamente.Ma ella ha natura di far bene orinare,
e di fare bella buccia , bianca e morbi-da. Ma la Cervogia
,fatta di segale, è
sopra tutte F altre la migliore. E anti-
chissimo r uso della Cerv^ia. Tuttaviaebbe molta ragione queir^/vco Abritv-
cense
,
che fiori sotto Enrico 111. Red’ Inghilterra , e citato dal dottissimo
Du-Fresne nel Glossario,quando volle
cantare i seguenti, versi in biasimo di
essa Cervogia :
Nescio quid Sty'giae monstrum confor-me paludi,
Cervisiarn plerique vocant : riil spissius
illa
Dum bibitur-, nil clarius, est,dummin-gitur-, unde
Constat,quod multas faeces in ventre
relinqiùt.
Digitized by Google
". I
Contro la Cervogia altresì nel lib. i.
dell’Antologia si può leggere un genti-
lissimo Epigramma di Giuliano Intuirà-
dorè ,che comincia Tif ; jro^sv et( dtó-
yvas , ec. del qual Epigramma iu unadelle sue eruditissime Lezioni fu osser-
vato dal sig. Anton Maria Salvini ^
quanto maggior grazia e vivezza di spi-
rilo abbia la chiusa nel nativo Greco
idioma, che nel Latino, in cui traspor-
tolla Erasmo.
Pag. 8. V. 27. Il Sidro tf Inghilterra.
Il Maestro Aldobrandino Partita 3 .
cap. 2. Il Sidro, che è vino di mele, se
è fatto ,quando le mele sono mature ,
si è caldo e umido temperatamente, maelli non è sano a usare-, perciocché elli
enfia e ingrossa la forcella , e instoppa
tutte le vie del fegato e del polmone :
ma elli ha natura tf ingrassare e di do^
nare assai nodrimento , e vale molto aquelli, che hanno il petto aspro e sec-
co, e che non possono leggiermente ale-
nare. E se tal vino è fatto di mele afre,
si tiene a natura di vinagro , cioè tT a-
ceto, e vale spezialmente a quelli, che
hanno la collera amara alla forcella, e
che a dismisura hanno riscaldato il fe-
gato ; e tutte genti potrebbono di state
tale vino usare. Nel Ditirambo si nomi- Ana spezialmente il Sidro d’ Inghilterra , /
Redi, Opere. Voi. J. 7
• <
by Google
9#
Serchè a’ nostri giorni è in credito più'ogni altro Sidro , ed è stimato il mi-
gliore che si faccia : se ne fa parimente
in alcune parti della Germania; ma in
Francia nella Provincia di Ngpin^jjd^ «
più che in ogni altro paese ; onde Gu-glielmo Britone nel lib. 6. della Filippi-
de parlando del paese d’Auge in Nor-
mandia.
Non tot in autumni rubet Algm tem-
pore pomis ,
Unde liquore solet Siceram sibi Neustria
gratam.
Quegli del paese d’Angiò in loro lingua
lo dicono Sitre. I Parigini ed i Nor-
manni Sidre, come si può vedere nelle
Osservar.ioni della Lingua Franzese com-pilate dal dottissimo sig. Egidio Meno-mo. Dalla voce Normanna è nata l’ Ita-
liana Sidro. La Normanna nacque daSicera degli Ebrei e de’ Latini, cne va-
le ogni bevanda diversa dal vino, abile
ad imbriacare. Isidor. lib. 3o. cap. 3. Si-
cera est omnis potio, quae extra viruim
inebriare polest. Cujus licct nomea He-
braeum sit ,tamen Latinum sonat
,prò
0o quod ex succo frumenti , 'vel pomo-rum conficititr. San Girolamo a Nepo-(iano. Sicera Hebraeo sermone omnispotio nnncupatur, quae inebriare potest,
tive illa quae frumento conficitur, sivc
Digitized by Google
pomorum succo. Zaccaria vescovo di
Crisopuli , che fiori ue’ tempi di PapaPasquale II. ne’ Commentar] sopra i
quattro Evangelj. Siceram vocant Hebraei
omne poculum ,quod inebriare potest ,
sivc de pomis ,sive de frugibus , sive de
qualibet alia materia confecturn. Svida
alla parola Sicera dice , che è una be>
randa fatturata, e che cosi chiamasi per
gli Ebrei ,e che imbriaca : ma non è
già vero ciò, che soggiugue , che la Si-
cera sia un vino concio , e mescolato
con condimenti ; ed è falso parimente,
che tal voce sia originata dalla Grecaovyxexpà^M ; imperocché la voce è ve-
ramente Ebrea, nè accade cercarne l’o-
rigine nella Grecia : le parole di Svida
sono le seguenti : liixtpa. I,xBvacròv sró-.
pa. xai xap é^paioa; ovto Xeyóuevor.
pé^vffpa. otv<K ^iv<njOiaiv èx
Tov ffvyx£xpài3obi. ^latteo estmonaste^
riense, ed altri di quel tempo chiama-
rono il Sidro Mustum Pomatium. In
s. Girolamo ancora si legge Pomatium^e Piratìum. Quest’ ultimo da’ Normannimoderni si chiama Poiree, e non è al-
tro che una bevanda fatta col sugo spre-
, muto dalle pere macinate, il dottissimo
Du-Fresne alla voce Pomata afferma ,
che il Sidro è chiamato da’ GuasconiPomado. Pomata patio ex pomis cotu
fecta Vasconibus Pomada , nostris Ci'
dre.
^ ~:.;itizRd by -_iOOgle
looPag. 8. T. ult. Tangheri.
Villani ,7otichi. Di costumi rozzi. Di
natura ruvida e rozza. Epiteto proprio,
ma per disprezzo de’ contadini più sal-
vatichi. Ottfivin terrari nelle Origini
«Ila voce Tanghero, eh’ egli spiega Rn-stìcus y crede che tal voce derivi dalPersiano, e perciò manda a Angaria,ove spiega la voce Andari per con ieri,
o messi del Re ; d’ onde forse è venutala voce àyytXoi a’ Greci , che lo stesso
signi lica Ma non dice tutto. PerciocchéneW' Etimolof'ico Mastio si leggono duealtri signilicati della voce àyyapoi
,
ches’avvicinano molto alla nostra Tanghe-ri. Primo signilìca Lavoratore^ colla
qual ]>.nrola n^i chiamiamo il contadinoàyyapfvo . rò èpyó.'rat iyeipo. óxò tovàyyapof. ó o'v(iaivti ròv èpydr^v. Poise;;ii«'; àyydpot( Xéyovnv oi fii* rovi
trpéa^Hi. 4 àrpdxTOVi, xai voteti.
Au:.'ari chiamano alcuni i messi, o
gii amhasciadori\ ed altri i dappochi, e
balordi. E questo secondo significato
non è tocco punto dal Ferrari. Svidasimilmente alla voce àyyapog, dopo aver
detta la comune sua significazione di
corriere , di messo ,o ambasciadore ,
soggi ugne ,che si dice angari anco a’
facchini , e in universale a gente stoli-
da ,vile ed ahhiftla riderai rò óropa
xaì stù ròv (poprfjyòv , xai ÒÀO( àvan-
^i^rop , ttaì àvdpaxodeSàv.
Dìqilized by Googlc
Pag. q. V. g. Peccherò.
Vocabolo venuto io Toscana dalla
Germaoia. Vedi il dottissimo Du-Fresnenel Glossario alla voce BicarUtm.
Pag. g. V. IO. Colmo in giro di quel vino.
Omero nell' Ilìade 8. vers. 282. disse
bicchieri coronati di vino:
II(vom( Mpqviipat ixiittipéaf aivoio.
Pag. g. V. II. Del vitigno.
Qualità e sorta di vile, detta, cred’io,
dall’ add iettivo vitigineus usato da Plinio
lib. 4. cap. I. Metaponti Temptum Juno-TÙs vitigineis columnis stetU.
V*Pag. g. V. 12. Si benigno.
Al vino Albano par che dia questo
tìtolo di benigno Marziale nel libro in>
titolato Xenia al Distico io3 . che haper titolo Albanum.
Hoc de Caesareis mitis lùndemia cellis
Misit , Juleo quae sibi monte placet.
Pag. g. V. i 3. Che fiammeggia in Sansavino.
Plinio lib. 14. cap. 6. favellando di
certo Contado nel Regno di Napoli cbia-
maio Ager Faustianus disse. Nec ulli
in vino major authoritas. Solo vinorum
fiamma accenditur.
T02Pag. g. T. 14. Vermigliuzzo.
Diminutivo di vermiglio. Vermigliovale di color rosso acceso , e nacquedal Latino 'vermiculus. Papìa vermicu-him ,
nihrum , sive corcineum ; est enimvermiculus ex silvestribus frondibus
, in
quo lana tingitur, quae vermiciUum ap-
peìlatur. E appresso vermiculum tinctura
a similitudine vermis. Del nascimento di
(piesti vermicciuoli per servizio delle
tinte , vedi jéndrea i.esalpino nel lib. 2.
delle Piante cap. 2. Carlo Clusio nelprimo delle Piante più rare cap. 16.
Pietro Bellnnio lib. i. delle osservazioni
cap. 17. Simon Paulli nel QuadripartitoBotanico, ec. Dalle parti d’America ci
viene una certa altra preziosa mercan-zia di vermicciuoli, la quale si adopraa tignere in cremisi , e si chiama Cuc-cinielia, ed è di diverse maniere, la piuperfetta delle quali dicesi Lanuta percagione dell’ esterno colore , che pendeal canuto.
Dell’origine della voce Vermiglio veg-
gasi il Canini ncH’Ellenismo, ed il dot-
tissimo ed eruditissimo Egidio Menagionelle Origini delia liingua Italiana , epiù di flitsamente in quella della Fran-zese. Gli antichi Provenzali ebbero an-ch’ essi tal voce. Ramhaldo de V^acheras
del lesto a penna della Libreria di
S. Lorenzo :
“ Digillzed by
to3Ane Persevai cani ella corte ctArtus
Tolc las armas al cavalier vermeilh.
Bernardo del Ventadom:
Prat me sembla veri , et vermeill
Issamen com lo temps de MaiSim ten fin amor coinC, e gai
Nef mes fior bianca, e vermeilla.
Beltramo dal Bornio :
Qtie riaia calps recebutz eit ma taria
E faitz vermeilh de mon gonfanottblanc.
Guido d’Uzez manuscritto Strozzi :
IjO vermeilha, e bianca kara
De la mea fina entendensa.
Da’ suddetti versi di Guido dC Uzez per
passaggio si può osservare,quando nel
Poema del Filostratò il Boccaccio cantò:
Di poter riaver qual si vuol pria
La dolce sua , e unica intmridenza.
Che disse intendenza alla Provenzale in
vece dell’Amata;
siccome ancora nella
Fiammetta disse intendimento. Mentreio fra loro alcuna volta il mio intendi-
mento mirava.
*•4Bìaneh/tcet del Testo della Libreria
di 8. Lorenro in siguificato d’amore, edi pensiero amoroso :
Car ay en lei mes mon entendimen.
Ma per tornar alla voce Vermiglio, nonsolamente fu usata dagli antichi Proven-rali, ma altresì da' Guasconi, e da que-gli di Linguadoca. Goudelin nel librointitolato le Ramelet Moundi:
A pourtat dous hroutousD' uno couloureto hermeillo.
E ivi medesimo :
Frese, et biu de sas coulouretos
Coumo Uu rosos hermeilletos.
Ed in somma comunemente da tuttel’ altre nazioni della Francia. MarzialdAuvergne nel libro chiamato les Figi-les de Carle VII. descrivendo un granfunerale :
Puis venoit urte hacqueneeConverte de beau cramossy
, ec.
Et mtis venoit le CancelierHabille de velours vermeil.
?ie suddetti versi di Marzial dAuver-gne dalla Ghinea covertala di cremisi-
Digitized by Google
io5' Bó , e dal Cancelliere vestito di vermi-glio, raccolgo, che tal colore era in usonell’ antiche esequie ; ed il Monaldinella sua Cronica manuscritta parmiche confermi questa asservazione. Mer-coledì, dice egli, addi 28 étAgosto i 38 r
a ora di terza si fé VEsequie , e ripo-
sesi in s. Croce messer Francesco Ri-
nuccini , che mori martedì addi 27 di
Agosto. Ebbe grandissimo onore. Cin-
quanta doppieri, due cavalli a bandie-
re , uno a pennoncello , ed uno col ci-
miere, spada e sproni, ed uno covertodi scarlatto il cavallo e 'I fante , cheaveva il mantello di scarlatto co' vaigrossi per mercatante', tutto il coro de'
frati pure a torcìdetti , e 'ntomo t alta-^
re , la cappella sua della sagrestia, otto
fanti vestiti alla bara, e drappelloni di
drappo d'oro, egli vestito di velluto ver
miglio : onore grandissimo, e pianto daogni gente per lo migliore caxmliere di
ogni bontà. Nella stessa Cronica. Ve-nerdì addi 7 Agosto mori messer Nicco-
lao di Jacopo degli Alberti per lo piùricco uomo di danari ci fisse per av-ventura dugento anni sono
; e addi 8dAgosto alle dodici ore si seppellì in
Santa Croce con grandissimo onore e
di cera e di gente. Ebbe letto di scia-
mitx> rosso ; ed egli anche vestito del
detto sciamito,
e di drappo a oro , e
guaizeroni;otto cavalli, urfo dellarme
dèi popolo,perchè era cavalù re del po-
polo , e. imo della parte Guelfa, perchèera de capitani ;
due. cavalli coverti conle bandiere prandi con T arme degli jdl-
herti , ed un cavallo con un pennoncel-lo ,
ed uno col cimiero, .^pada e sproni
df oro ;il cimiere una donzella con due
ale ;ed un cavallo coverto di scarlatto,
e ’/ fante con un mantello di vajo gros-
so foderato , ed un altro cavallo noncoverto con un fante con un mantellodi pavonazzo foderato di vajo bruno ;
arrecato il corpo dalle logge loro , equivi fu predicato. Ebbe settantaduetorchi , cioè sessanta da se
, e dodicine diè la parte Guelfa : grande arcatutta fornita di torchietti di libbra , etutta la Chiesa intorno , e le cappelle
alte dal mezzo tutto ogni cosa pieno di
torchietti di mezza libbra, e spesso se-
minati di quei di libbra. Tutti i con-sorti e parenti stretti della casa vestiti
a sanguigno. Tutte le donne entrate eduscite di tor casa vestite a sanguigno ,
ec.
IViccola Villani nel quarto degli otto
Canti di quel suo nobilissimo Poemaeroico della Fiorenza difesa
,
i quali
furono fatti stampare in Roma da Ono-
frio Ippoliti suo nipote, e dedica ti al-
rEminentissimo Cardinal francesco Bar-
berino; nel quarto,dico, di quei Canti
descrivendo il funerale d’ Armanai ico
Digl;i2^
107
fratello di Hadagaso Re de’ Goti asse-
diatore di Firenze, vi fa apparire usato
il colore vermiglio. Stanza 6o.
Curate avean étArmanorico intanto
ZjC membra mute ,pallide e defunte ,
E ogni ferrea salma ,e tC ogni am-
mantoSpogliate e terse e profumate ed unte.
Dentro infuso gli avean di Mirra il
pianto ,
E T ambrosio liquor di Jericunte,
E 7 sudor del gran Cedro , e varie
sorti
D' odor possenti ad eternar le morti.
Di sciamito vermiglio , e drappi ad oro
Eo vestir poscia in barbaresca foggiai
Cuopre il letto , ove ei posa , aureo
tesoro
Di nobil coltre , e pur serica e ro^ìa. .
Stanza 63.
D' un rosso crudo è quella tenda im-
mensa.Che chiude intorno il cataletto altero.
Stanza io8.
r
Radagaso alla fin vestito tutto
Di vermiglio color, la pompa serra-,
E col manto seguace, al collo addutto
Con fibbia di rubin , rade la terra.
/io8
Simil costume leggesi per antico in Po»libio, ma io non voglio avanzarmi taii-
t’ oltre : soggiugnerò solamente, che a*
nostri tempi in Francia è in uso talvoN
ta il color sanguigno tra gli abbiglia-
menti di quelle persone che portano
!
} * bruno. Ho saltato di palo in frasca : ne
I! dovrei esser proverbiato. Kon lo farò
I * più.
Pag. q. V. i 5 . Brillantuzzo.
Un gentilissimo e pulitissimo Scrittore
^esalta la moilema lingua Franzese, per-
chè non ammette i diminutivi ^ biasima' l’antica, perchè gli costumava f non lo-
da l’Italiana, perchè ne ha dovizia. Io
per me sarei di contrario avviso, e cre-
derei , che i diminutivi fossero da nove-
j
rarsi tra le ricchezze delle lingue , e
.particolarmente se con ilnezza di giudi*
\zio , e a luogo e tempo sieno posti in
uso. La lingua Italiana si serve non so-
lamente de’ diminutivi ; ma usa altresì
i diminutivi de’ diminutivi , e fino—ift_
terza e quarta generazione.)
Pag. 9. V. 27. Manna dal ciel sulle tue
trecce piova.
Mutato da quel del Petrarca. Fiammadal ciel sulle tue trecce piova. Questa
figura da’ Greci è chiamata itapodia ;
e vi erano Poeti, i quali con poca mu-tazione si servivano de’ versi di qualche
Digitized by Google
l.
*®9I antico e accreditato per fornirne alcuna' nuova e capricciosa materia
, e questi
\erau detti xapodoi : travestivano
,per
I
così dire ,Omero , e con qualche ag-
i giunta del loro traevano il serio d'Ome-\ro a) giocoso. Di questa sorta di poesìa,
e de’ poeti che vi s’ impiegarono , uite- {
neo iin. i 5 verso il line. >. i i
''
Pag. 9. T. 27. Sulle tue trecce. '
Esprime quello che i Latini pur par*
landò delle viti , dissero Capillamenta ,
come si può vedere nell’ epistola 8(j di
Seneca, e nel lib. 4 cap. 11 di Columel-
I
la. Plinio li' . 17 cap. 24 disse crines.
Vemacula putatio dejectis per ramosvitium rrinibus circumvestit arborem. EMarco Varrone volendo > spiegare checosa sia il capriuolo delle viti, e per*
che sia cosi detto : Is est cauliculus vi-
teus intortus ut cincinnus; is enim, vi-
tes ut teneat , serpit ad locwn capiun-
dum, est quo a capiendo capreotus di-
ctus.
Pag. 9. v. 28. frigna gentil, che quest; am-brosia infondi
Archestrato Poeta, il quale, yercioc*
che ne’ suoi versi descrive cose attenenti
a cene e a desinari , è soprannominatoDipnologo
, riferito da Ateneo lib. t ,
esaltando sopra gli altri vini il vino del-
n.
110r isola di Lesbo scrive , che doq s’asso-
mi{jlia a vioo , ma ad ambrosia.
Mfivof ds doKriazk
Ovai òivo mi c ^tif òfioiof Xéfta . àfi^po»ffia dì.
Pag, 9. V. iq. Ogni tua vite in ogni tempomuova
Nuovi fior, nuovi frutti e nuove fronM
. / Omero nel settimo dell’Odissea aven-
\ /do affermato , che gli alberi, le piante 1
'/ d’ ogni ragione sempre fon Borite, e
tutto Tanno fan frutti là negli orti del /
' Re Alcinoo , segne a dire della vigna !
carica d’uve, che alcune di esse si ra-
sciugano, e si stagionano al sole ; altre
son fatte , e si vendemmiano ; altre si
pigiano ; alcune ancora sono agresto,
I
ed hanno buttato il fiore ; e alcune fi-'
nalmente hanno cominciato a pigliar^
colore. Vedi quivi. La nostra uva dij
tre volte non fu incognita a Plinio, il
qual lib. 26. cap. 27. f'Ues quidem , etj
triferae sunt, quas ob id insanas vacanti
Xquoniam in iis alia maturescunt
, alia|
tuigescunt, alia florent. ' t
Pag. g. v. 3 i. [/n rio di latte in dolcefoggià , e nuova , ec.
Eu'ipide nelle Baccanti, contando nel >
V tuo linguaggio poetico le maraviglie dij
Digitized by Gì
Bacco, dopo aTer detto, che le Baccan- '
ti, ferendo le pietre colle loro aste, fa-
cevano scaturire i rugiadosi umori del-
r ac(|ue , e che alcuna di esse ficcando
il suo bastone in terra , Bacco ue faceva
sorgere fontaue di vino ; aggiugue, che
a quante arcano gusto di bevanda bian-
ca e lattata ,bastava , che chiamandosi, .
I
ìrendessero pizzichi di quella terra, per '
a quale passn'vano; e tosto si vedeva-;
no le mani piene di fiali di latte. E I
nella stessa favola una di esse Bac-canti , che rappresenta tutto il coro , f
dice , che per dove passava Bacco , la
campagna correva latte, vino e nettare,
o miele. Cosi la S. Scrittura per dise-
gnare la fecondità della terra promessa,
o per dirla colla frase Ebrea , di pro-
missione, la chiama terram Jluentem la-
cte, et melle-
Pag. IO. V. 3. Possa del vino tuo ber colla
secchia
Ipponatte citato da Ateneo lib. 1 1 nel
catalogo de’ Bicchieri alla voce Tt'ÀÀa ,
che è quel vaso da muguere, die i La-tini dicono mulctrale conta in certi suoi
versi, che forse sono scazzonti; che nonavendo alcuni bevitori calice da bere ,
per avervi dato dentro il servitore , erottolo , si servirono d’ uno di questi
vasi, o sia d’iin bicchiere simile ad essi.
E appresso , lo stesso Ipponatte non so-
tl2lamente fa menEÌone del Taso da mu-gnere , ma anco d’ un vaso , col fjnale
s' attìgneva l'acqua chiamato àpvxaivcb
da àpvtiP
,
che in Latino è haunre, con-
versi tutti due a uso di bere il vino.
. . . èx 9è ‘xà'KXtiz
EariTO* aXZox’, avrò; àÀZor' ipvxctitti
Tlpovttivey,
'\
Pag. IO. V. 4. (Se la druda di Titone" La voce drudo, il cui femminile è
druda, vale lo stesso che amadore , va*go , amante , damo ; nè sempre si pren-
de in significato disonesto , come volle-
ro scrivere quei valentuomini, che com-pilarono il nostro Voraholario della
Crusca della seconda edizione. DantePar. 12. favellando di Callagora patria
di s. Domenico :
Dentro vi nacque T amoroso drudo
Della fede cristiana il Santo atleta
Benigno a suoi , ed a' nemici crudo.
Cristofano T^andini nel Cemento : Den-tro vi nacque Domenico drudo
, cioè
sommo amatore delia fede cristiana. Lostesso Dante nel Conv. chiama drudi
gli amatori della filosofia : O dolcissimi,
o ineffabili sembianti , ruhaton subitanei
della mente utnana , che nelle ilimo-
straiioni negli occhi della filosofìa ap-
Digitized by Google
ii3parve
,quando essa olii suoi drudi ra-
dono. Il bealo Jacopone da Todi anti-
chissimo Poeta ne’ Cantici sacri si vale
della voce druderia in sentimento pio e
devoto , e particolarmente in uno alla
Beatissima Vergine , dove ebbe a dire :
La balla tu rC hai avuta '
Lungo tempo t hai tenuta
Per pietà ; Madre or rrì ajuta
Che 7 ci presti in druderia,
E nello stesso sentimento ei medesimosi vale altresì del verbo indrudire. LucaPulci nel Gir. Calvan. c. 7. in personad’ una onesta vergine :
Ed ogni cosa del suo vago , e drudoVeder potea Aleandrina bella.
Onde non è da ascoltarsi il terribile fa-
mosissimo critico Benedetto Fioretti, il
quale nel quarto volume de’ suoi Pro-
ginnasmi poetici al proginnasina bg vol-
le dire, che contro al decoro poetico
, j
e cristiano è questa metafora di. D.mte j
stravagantissima,chiamando un santo '
nel Parad. tz. drudo della fede. Del;
che Monstg. della Casa nel Galateo me~ i
ritamente ne fece ramare. Se questo Cri-
tico, e con lui Monsignor della Casa,avessero considerato iu qual uso , ae’
Redi. Opere, Vol. I. 8
l tempi di Dante, era la Toce drudo, nongli arrebbon ,data questa cosi j)Oco eru-
dita accusa. K degna a ciuesto proposito
di esser letu una delle Veglie toscane ,
ohe reruditissimo sig. Carlo Dati lasciò
I
compilate ,nella quale gentilmente di-
I fende Dante dall’ accuse di Monsignor
'della Casa. 1 Provenzali parimente si
servirono della voce drudo , e druderia
in buon senso. lu una canzone registra-
ta nella vita di Ganselm FaidUz testo
a peuua della Libreria di s. Lorenzo.
Cant, et depott, dompneis et sollaz
Enseniamen , largetsa et coitesia ;
Honor et pretz ,et Hai drudaria,
Folcbetto da Marsilia :
Cane mais tant nom plac iovem
JV/ pretz, ni cavalaria
iV/ dompneis , ni drudaria,
Rambaldo de Vacheras:
Jjial drutz honrat ,et pretzan
Fer la amansaEn beneuonsaIni el cor port honestat, •
Glossario Provenzale lesto a penna di
Francesco Redi. Dmtz. diUetus , umans
jfidelis. Enrico Spelmunno nel Gloasario,
Digitized by Gopgle
• DrwJes drudi spiega Jtdeles. Ne’ capitoliReiueos. e Rotumag. neU'aanodiS. sinesolatio , et comitatu drudorum
, atquevassorum nuda , et desolata exìbit. Vediquivi alle voci drudes , drenches, dren.-gits, druchte
y druthe. 11 sig. Egidio Me-nagio nelle sue Origini della LinguaFranzese
, osserva , che le parole anti-che drud, e drurie significano in quella
feal, fidel, amy, fidelitè, amour,
onde nel Romanzo di Fiorimondo scrit<to l’anno iiz8.
Li Roy ses chambeìlans appaile
,
Li Roy appella de ses drus,
Et commanda qu'il soit vestus.
£ quivi medesimo :
Li Roy li a sa ftlle monstreeLi autre Cont par lui veve ,
Se dii ja quelle Feste sa drue.
Nel Romanzo di Guido di Toumaut;
Onq ne fout tei criee de puis le RoyJirtus
La regreue chucun son amy, et son drus.
Il Romanzo di Guglielmo aucourh-nez:
S‘avons perdu et je , et voiis assezAmis et dius et parens et ptivez.
i6Sono da vedersi Mons. Bicone nelle
Note sopra le forni, di Marcolfo, il Pa-
dre Sirmondo sopra i capitoli di Carlo
Magno , il Vossio ne’ Libri de’ vizj del-
la tavella , e 1' eruditissimo Du-t'resne
nel Glossario. Egli è ben vero , che il
suddetto sig. Ecidio Menagio afferma
,
obe siccome i più anticlii Poinanci Fran-
zesi si servirono di quella voce in buonsenso, cosi cominciarono poi ad usarla
inumala parte ne’ tempi di san Luigi, e
di Filippo il Bello , 9jq^licauJ^ol^..agli
amori disonesti , come si può leggere
nel Romanzo della Rosa , cominciato daGuglielmo de Lorris, e terminato dal
.Maestro Giovanni de Meung
,
che fu il
Padre , ed il primo inventore dell’ elo-
iquenza Franzese , nel qual Romanzo io
'osservo ;
I
ai (Ili il a voulu retenir
Quelle ne puisse alter ne venir
Soie sa moviller , ou sa drue ,
Tantost en a Tamour perdue.
E nell’ Ovidio manuscritto , che si con-
serva nella Libreria del famoso Mons.Conrart, favellandosi di Agamennone edi Criseide :
jigamennon en fit sa drue,
Idais cher fu ceste amour vendue.
Digitizéd by Gòogle
ii7Ho posto mente, che i Proyenzali altresì
la usarono in significato oscenp. Nella
•vita di Gauselm Faid'uz. K tant Cao-rat, et tant la servii, e il clatnet mer-ci, que elle s’ennamora de lui, et fetzGauselm Faiditz son cuvalier , et sondrutz. C nella stessa vita. L'accollia
cortesamen , et fasiali bel semhlant, et
sollazar<a , et risea ab lui-, don era ere-
sutz,qel coms fbs sos drutz. Et fon dii
a en Gauselm Faiditz,
qel corns aviaagiit de lei tot son plaser, et tota vo-lontat. In somma drudo è voce che po-
trebbe corrispondere a procus de’Latiui,
e si trova indilTerentemente secondo ì’or-
dine de’ tempi in buono ed in cattivo
significato: il perchè con molta ragione
l’Autore del Rimario Provenzale manu-scritto della Libreria di san Lorenzo.
Drutz , idest procus,qui intendit domi-
nabus. Negli esempli suddetti per lo piùdrudo è nome sostantivo; ma io lo tro-
vo ancora in forza d’addiettivo appressogli scrittori Toscani più antichi, ed ap-presso (quelli che fiorirono nel secolo
passato, cavale forte, valoroso, gentile,
di maniera graziosa , destro , ec.
Facio degli Uberti nel Dittamond. 4. 22.
$
Silvestri, montuose
, fredde e nudeIn molte pari vidi le sue rive
,
E in altre assai di belle ville, e drude»
i6ISelle sestine trorate in un antichissime
teslo a |>enna , e stampate nella Rac*colta de’ Poeti antichi in Firenze dai
Giunti i5zy a carte i3i.
Jo ai>ea duro il cor come una pietra
Quando vidi costei druda com' erbaNel tempo dolce , che fiorisce i colli,
Ser Lippo d’Arezzo manuscritto ;
E quando me mìrao si bella e drudaIn del cor me passao così rapente.
Trojano manuscritto canto 3.
Ma quando vide il franco Baron drudo.
Il Berni Ori. i. 2 .
Mosse il destriero ^ e la gran lancia in
manoNel corso T anestò quel baron drudo.
In tal significato del Berrà fu usato da-
gli antichi Franzesi « come si legge nel
Bomanzo di Bertrando de (luesclin
cap. 28 .Quant vous sercz en bataille ,
altez si avant, camme il vous plaira, et as~
semblez aux greigneurs ^ et aux plusdrus. E avverbialmente
(osto ivi mede-
simo : Grant temps doura t assault , etle trait de nos gens, les quelz trayoient
Digitized by Google
si Jru , éfue a pene osoient les Engloìztnettre la teste dehors. In alcune Scrit-ture manuscritte citate da Monsig. t^in-cenzio Borghini intorno agli anni 1214.si legge Dritdo, e Drudolo per nomi pro-prj a uomini nobili.
Pag. IO. V. 7. Di tal vin facesse invito,^E frase usata ancora da’ Latini, Plau- >
to neirAnfitruone att. i.'sc. i. vedendo|
tardare a venire il giorno :
Credo aedepol equidem dormire solem
,
atque appotum probe ! i
Mira sunt, nisi invitavit sese in coena 1
pluscutum,I
Pag. IO. V. 12. Coronar potrò il bicchiere.
Più sotto :
A inghirlandar le tazze or rrC apparec-chio.
Frase SOmero nell’Iliade al g. vers. 176imitata da Virgilio nell’ Eneida lib. tverso la fine.
Pag. IO. V. i 5 . C/l è famoso costei per quelMasetto
n Bemi nell Ori. lib. 3 . canto lettimoifavellando di se stesso ;
r-
Digitized by Google
Costui eh' io dico a Lamporecchio na-
cque ,
Ch' èr famoso costei per quel Masetto.
La novella di Masetto da Lamporecchio
,^'sì può vedere nel Decamerone. Giom. 3.
nov. r. Lamporecchio è villa deliziosa
degli eccellentissimi sigg. Rospigliosi nonmolto lontana da Pistoja.
Pag. IO. v- 17. E sia puretto.^ I nostri contadini chiamano puretto il
vino, che non è innaci|uato: da puretto
nacque la voce Fiorentina pretto , che
ha lo stesso signilìcato secondo l’opinio-
ne di Jacopo Corbinelli nelle Annota-
zioni sopra Dante de 'vulvari eloquen-
tia, la quale opinione fu confermata
dal sig. Carlo Dati nelle Origini della
Lingua Italiana del sig. Egidio Mena-gio.
Pag. IO. V. 20. Cantinplore.
r In Toscana la Cantinplora è un vaso
di vetro, che empiendosi di vino ha nel
mezzo un vano ,nel —quale si mettono
'' pezzi di ghiaccio, o di neve per rinfre-
scarlo , eìl ha un lungo e grosso collo
,
. che sorge da uno de’ banchi a foggia
1 d’ annafli.ntojo. Oggi non è molto in uso;
ed alla Corte si chiamano cantimplore
quei vasi d’argento, o d’altro metallo,
che capaci d’ una , o più bocce di ve-
Digitized by Google
I2I
tro , servono per rinfr^care il vino , e
r acque col gnìaccio. Donde abbia avu-
ta origine tal voce , io per me sarei
della stessa opinione di Don Sebastiano
Covarrnvias
,
il quale nel Tesoro della
Lingua Castigliana scrisse: Cantimploraes una carrafa de cobre con el cucilo
muy larf^ para enfriar en ella el agita^
o el vino medendola , y enterrandola
en la nieve , y meneandola dentro deuno cubo con la dicha nieve, cosa miyconocida
, y usada en Espanna, y en
todas partes. Dixose Cantimplora por-
(jue al dar el agua , o el vino rjue tie~
ne dentro,por razon del aire
, que se
encuentra en el dicho cucilo , suena enmuchas dijèrencias, unas baxas, y otras
altas , unas tristes, y otras alegres, que
pareze cantar, y llorar juntainente. En
Griego se dite , idest rUlens,
et flens a vèrbo xXaio fico , et
rideo. Por està mesma razon llaman los
Franceses Lhanteplure , a cierto arca-
duz, y regadera , con que sacan agua
para regar los jardines.
Pag, IO, V, 22, Bombolette.
Diminutivo di bombola. Bombola è
un vaso di vetro col collo corto per usodi tenervi il vino , o altro liquore. Edè voce a mio credere originata dal Gre-co ^op^vXov. Svida. BouSv^ov. axivo(
(spoyYv^otiSéf, Polluce nel capitolo de*
122nomi (le’birchieri ^ofi(tvXiò( 9è rò (rtfòt
ixvona , xaì fiou^ovv èv xdoct , ó$
Avri^èv*ic iv UpoTptxrixó- Appresso di' Esicrhio la voce significa lo
stesso che Orcìnlinn dell alio. Il soprac-
citato esemplo di PoUuce mi fa sovve-
nire molto a proposito un luogo di Gorlena nella sposizione delle voci antiche
usate da Ipocrate^ il qual luogo ne’Li-*
bri , che furono stampali da' Giunti èmolto scorretto. E di quivi parimentesi può ridurre alla sua vera ed amicalezione ~Rofip,vXiot ( leggi ^op^vXmv )éxrofta ti (Tt» rò (TÓpa, p xopasrapà rò (
leggi Boplietv ) èvo-
(ta<ruivov. In un frammento di Ateneoportato dal Casaubono nelle sue dottis-
sime Animadversioni , si fa menzioned' un vaso da bere di quelli detti dal-
l’Autore Tericlei fallo in Modi , o alla
Rodiana appellato Bop^v^toi ,il quale
dovea essere di bocca stretta , e però vi
si bevea appoco appoco , e non quantouno avrebbe voluto , come quando si
attaccava la bocca alle fiale, e si me-sceva con esse.
Pag. IO. v. 22. Forbite.
Forbito vale nello, pulito. Vedi il
Vocabolario. Trovo questa voce in Pro-
venza. La Contessa de Dia , o de Di-gno :
Digitized by Google
123£/ $eu druti
A'vinem , gai et forbitz.
Nella Gram Provenzale della Libreriadi s. Lorenzo. Forbir
,polire e tergere.
Glossar. Provenz. F. Redi Forbir , ter-
gere, mundum facete.
Pag. IO. . 25. Son le nevi il quinto ele-
mento.
Ai quattro elementi de’ Peripatetici
aggiugne per ischerzo il quinto. Essereil quinto elemento è un modo prozer-
biale Toscano , che vale esser cosa ne-
cessarissima. Bonifazio Vili, nella suaincoronazione, avendo da diversi poten-
tati dell’A.sia e dcH'Europa , dodici am-basciatori Fiorentini
,mo.sso da maravi-
glia, disse in pieno Concistoro: I Fio-
rentini nelle cose umane sono il quinto
elemento. Antonio Pucci, che fiori pocodopo a’ tempi del Petrarca , nel Capi-tolo di Firenze, stampato nella Raccolta
delle Rime antiche fatta dal Corbinclli
nel i585 chiama la città di Firenzequinto elimento:
\
Ben fé' chi la chiamò quinto elimento.
Questo proverbiai modo di dire mi fa
sospettare, se in Giovanni Villani lib. 7cap. i38 nura. 7 quando ei disse la città
di Acri essere un alimento al mondo.
Digitized by
124e quando lib. r i eap. 87 num. 3 le faini>
glie de’ Bardi e de’ Perutri essere quasi
un alimento , mi fa sospettar, dico, chela voce alimento in questi due luoghi
del Villani non si debba intendere nel
significalo di alimento ^ che vale gene-
ralmente ogni cibo di che l’uomo si nu-trisce ; ma si debba intendere per ele-
mento. I motivi del mio sospetto sono
,
che in un Testo del Villani manuscrit-
to della mia Libreria , in vece di ali-
mento in que’due esempli si legge sem-
pre elimento, che significa lo stesso cheelemento , come si può vedere dal so-
praccitato Capitolo ai Antonio Pucci\
e come |X)trei mostrare colla citazione
di molti Autori de’ primi tempi. Inoltre
ì nostri più antichi Scrittori Toscani in
cambio di elemento dissero sovente ali-
mento, cangiando la lettera e della pri-
ma sillaba in a, come è chiaro per gli
infrascritti esempli. Ser Brunello Latini
nel Tesorelto cani. a5 stampato in Romadal conte Federigo Ubaldini:
E tutta terra , e mare
E 'I fuoco sopra F aire
Cit'i son quattro alimenti ,
Che son sostenimenti
Di tutte creature.
11 Maestro Aldobrandino
i
cap. t.
Domeneddio per sua grande possanza
\
Digilized by Google
125tutto V mondo stahiho
; primieramentefece il Cielo
, appresso fece li quattroalimenti , cioè la terra
, f aria e 7 fuo-co , e si li piacque , che tutte V altre
cose dalla Luna in piuso fossero fatteper la virtù di questi quattro alimenti.
E appresso : Perchè questi quattro ali-
menti si rimutano tutto giorno P uno anatura delP altro , e si corrompono
,
conviene , che tutte le cose , che sonfatte di questi quattro alimenti, ec. Eappresso : Dunque poiché P uomo è diquesti quattro alimenti ingenerato
, efatto. Luca PuJci nel i lib. del CirifF.
Calv.
Ower nelP alimento arson del fuoco.
Lo stesso Dante nel 29 del Paradiso si
servi di tal voce nello stesso signiiicato,
quando disse :
I
Non giugneriesi numerando al ventiSi tosto , come degli angeli parteTurbò 7 suggetto Je’ -vostri alimenti.
Che cosi si legge in molli buoni manu-scritti, e cosi parimente nel Testo stam-pato AaXVAccademia della Crusca l’an-no 1595 ancorché tutti gli altri Testistampati abbiano elementi. Egli è benvero, che quei valentuomini
, che com-pilarono le postille marginali al snddeU
I to testo della Crusca spiegarono la roee
I
alimenti in signi licato di nutrimenti
,
ma forse allora non fecero reilessione a
I
quanto gli antichi amavano di mutare' la lett* ra e nella a. Dante da Majanonel primo de’ suoi Sonetti stampati dis-
se Alena invece di Elena:
Alena greca co lo gran plagere.
Ser Brunetto nel Tesoretto cantic. ii.
Aìlifanti e leoni
CammeUt e dragamene.
Nella Tavola Ritonda del testo a pen-na della Libreria di s. Lorenzo : Unacolonna di marmo
,là dove era appic-
cato un corno (T aulifante. Nella stessa
Tavola Ritonda si legge freq ueutemen-te Arcante per Errante. Jo sono uomo
,
che amo molto li cavalieri arranti. Nel-la grande volle di Basìgnano ae duecavalieri arranti morti. La corte dello
Re Artus era tutta piena di Re , di
conti,di baroni e di cavaliei i arranti.
Guillone d’Arezzo nelle lettere manu-scritte usò il verbo alvggere invece di
eleggere. Lettera 3 Jacomo Apoitolo di-
ce, poveri nel mondo alesse Dio. E ajv
pressot Molli uomini sono servi di ?»o.
lontà, bestiale vita aleggendo, seguendo‘ diletlo corporale. Usollo ancora Gio. Vil-
Djgiiized by Google
'Ioni, e tutt’a duci Malespini, ne’ quali
si trova sanatore , sanato, assempro ,
assemplo
,
con altre situili voci. E Ri-
cordano nel cap. 128 volle almeno unasola volla storpiare il nome del Re En-zo figliuolo di Federigo li. chiamandoloAnzo
,
se però non è errore di stampa.Lo stesso Ricordano cap. 5 e 6 e Gio.Villani I 12 scrissero Ansiona invece diEsione. Nel Novell, antico nov. fio e inGio. Villani i. 12 si legge Talamoneper Telamone-, e nell’ Omelia manu-scritta di s. Gio. Grisostomo bastemmia,e non bestemmia. Spo"liato delle suesustanze , o in qualunque altro modoafflitto gitti parole di bastemmia con labocca sua. E appresso : In tutte questecose non solamente niente di bastemmiauscì dalla bocca sua. E ivi medesimo :
Che scusa potranno aver coloro, i qualiper piccole ingiurie
,ec. si conturbano
,
e bastemmiano. La più bassa plebe diFirenze conserva alcune poche reliquiedi tali arcaismi nelle ]>arole abreo, or-rore, datftno, sagrato, ec. Negli antichi
Provenzali si trova spesso tale amisl[ù eparentela tra la lettera a, e la e. Nellavita di Guidousel del testo della Libre-ria di s. Lorenzo si legge Raina perReina. Neza de Gutllem de Monpeslier,cosina germana de la Raina tfArago-na. Giuffredi di Tolosa nella Servente-se , eh’ ei fece per amore d’Alisa dami-
128gella di Valogne, disse molte volte pÌA-
tot invece di pietat.
A Madompna senes pitUat
Nitec , e dia eu clam mercè.
Tralascio infiniti altri esempli e de’ To-scani e de’ Provenzali. Del mutarsi le
lettere 1’ una nell’ altra veggasi Angelo
Canini d’Augbiari neirEllenismo, Claw-
dio Daìtsrjuio uell’ Ortografia,
il cav.
Lionardo Salviati negli Avvertimenti
,
Egidio Menagio nelle Origini della Lin-
gua Italiana , ed in quelle della Fran-zese.
Pag. I o. V. 28. Contento,
Contento nome sustantivo in signifi-
cato di contentamento , contentezza ,
soddisfazione,gusto
,piacere : non so-
lamente è voce dell' uso moderno ado-
perata dagli Scrittori più politi, ma an-
cora trovasi nelle scritture degli antichi,
ancorché di rado. Boccacc. Fiamm. lib. 4.
Le quali cose sono a te assai leggiere ,
e a me grandissimo contento daranno.
Filocop. lib. 5 . Non sarà senza contento
del tuo desio. Dittam. lib. 2 cap. 21.
E questo mio Signore , e mio contenta
(Quattordici fue meco Imperatore.
Digitized by Coogle
E lib. 5 . cap. I.
129
Ed era il Sol poco più giù, che il mentoDel montone , e la luna si vedeaSI viva, che ciò rrì era un gran contento.
Storia Nerbonese manuscritta cap. 5. Il
Nano prttmise a Hanieri di fare il suo
contento.
Quell’ultimo esemplo del Dittamondo
fu osservato dal dottissimo Padre Da-niela Battoli nel libro intitolato iL Tor*
to ,e _il Diritto del_ non si libro
degno d’ esser letto dagli amatori della
toscana favella.
Pag. IO. V. 29. VallombrosaI nostri antichi scriveano per lo più
Valembrosa. Ricordano Malespini
,
o
Ricco di Dono , che si abbia a dire
,
cap. 65 . Andò come romito nell alpe di
Valembrosa, e cap. 169. Nel detto an-
no il popolo di Fiorenza fece pigliare
TAbate di Valembrosa. Nella Storia di
Gio. l^illani lib. 4 cap. 16 e lib. 6 cap. 68.
si legge l'unirOmbrosa. In un mio anti-
chissimo testo a penna si trova semprescritto costantemente yalembrosa. Tal
voce vive ancora tra la plebe Fiorenti-
na , e parimente in qualche Scritture
moderno.
Redi. Opere. Voi. I., g
i3«»
Pag. II. T. 2. E àel ghiaccio mi portate^
Tra’ Greci e tra’ Romani fu costumenolo il bere con la neve e col ghiaccio.
Andò poscia in disuso, e solamente ne’
nostri secoli si è rinnovellato , e forse
con soverchio lusso. Quindi è, che nella
vita manuscritta della beata serva di
Dio Umiltà, che mori nel i33g, e fuBadessa del già monastero di s. Gio.Evangelista presso alle mura di Firenzedell’ ordine di Yalombrosa , al cap. 35si legga il seguente miracoloso avveni-mento. Essendo la santa Badessa , nel
mese d' agosto , aggravata dafebbre con-
tiìuia , avea perduto ogni appetito , chenon potea mangiar cosa alcuna : stan-
dole intorno le suore , la confortavanodolcemente dicendo: o Madonna nostra
lasceretevi cosi morire ^ che non volete
pigliare alcun cibo ? Madonna , che vi-
vanda avreste a gusto ? che la faremovenire. Allora la Badessa santa sollevò
il capo , e disse : figliuole mie, del
• ghiaccio, O Madonna madre nostra, voi
dimandate cosa impossibile a noi , sa-
pete che non è ora il tempo del ghiac-
cio, Alle quali disse : come, fgliuole
mie, siete di poca fede\ Andate al poz-
zo, Come andarono la mattina al poz-zo , trovarono
,cavando la secchia , un
pezzo di ghiaccio •, si maravigliarono', lo
tolsono , e portaronlo alla santa Bades-.
sa, laudando Iddio di tanto miracolo.
i3tNe’ tempi altresì àcW'Ariosto il gbiac*
ciò non era in uso , e si rinfrescava il
ino ne' pozzi ; e perciò favellando egli
di un gran Sovrano ebbe a dire nella
prima delle Satire :
'A chi nel barco , e ’» villa il segue ,
dona ;
A chi lo veste , e spoglia , o pone i
fiaschi
Nel pozzo per la sera infresco a nona.
E molto prima àeWAriosto il Boccaccioracconta nella novella seconda della se-
sta giornata, cbe Cisti Fornajo per grandelizia in una secchia nuova e stagnata
di acqua fresca teneva il piccolo orcio-
letto del suo buon vin bianco. Senecanelle Questioni naturali lib. 4. verso la
fine afferma, cbe oltre la neve andava-
no usando ancora il ghiaccio. Inde est,
inqiuim,quod nec nive contenti sunt
,
sed glaciem, velut certior illi ex solido
rigor sit, exquirunt , ac saepe repetitis
aquis diluunt, etc. 1 Franzesi modernisono stati più tardi degl’ Italiani a rin-
novare l’uso del ghiaccio e della neve;ma oggi lo frequentano , e particolar-
mente tra la nobiltà : onde Boileau nel-
la terza delle sue Satire:
ìdais qui T auroit pensò ? pour cembhde* dissrace .
ì3zPar ìe ehaud, qui faisoit, nous navlons
point de pflace.
Poin de giace , bon Dieu\ ec.
A’ Turchi in Costantinopoli non è poranco arrivata , o ritornala questa deli-
zia ;an/i comunemente oggi amano più
le bevande calde, che le fresche; c molti
a desinare non soglion valersi di altra
bevanda, che del caffè, pigliandolo nel
fine del mangiare. Pietro Beìlonio nel
cap. 22 del lib. 3 delle Osservazioni
scrive , che ne’ suoi lcm|)i bere col
ghiaccio , e con la neve era molto iu
uso tra’ Turchi.
Ho detto di sopra , che per lusso co-
stumasi oggi il bere col ghiaccio e conla neve ; ma questo lusso di freschezza
non è per ancora arrivalo a tanto, che
ne’ conviti si sia introdotto lavarsi le
mani con acqua nevata , come usavaTrimalcione appresso Petronio: Tandemergo discubuimus
,pueris Alexandrmis
aquam in manus nicatam infundentibus
^
o come quel Sabello mentovato da Mar-ziale , che per tutto ’l tempo della cenafaceva a’ convitati teucre i piedi nudisu pavimento di marmo più freddo del-
lo stesso ghiaccio.
Pag. li. V. 3. Dalla grotta del monte diBoholi,
Col nome di Boholi si chiama conau-
i33«cwiente In Firense il giardino del Pa-lazzo del Serenissimo Granduca. In unadelle collinette si mantiene una ghiac-
ciaja per conservar quei vini , che si
tengono la State nella grotta incavata
sotto di essa gbiacciaja. Gio. Villani
lib. g cap. 258 chiamò il sito di questo
giardino la 'villa di Boboli, e lib. io
cap. 58 il di Boboli. IVe’ tempipiu anticlù dicevasi Bup;oli
,
e lo raocolgo dalla Storia di Bicorduno Male-spini, il iquale nel cap. i5g. 'I en^onosu per lo pogf^ di santo Giorgio , do-
'i' è una porta , che riguardava 'versa
ylrcvtri , e dalla detta porta seguendo
su per lo poggio, e poi discendendo per
Bagoli insino alla porta della Piazza,
^’on credo che possa aversi per errore
di stampa ;imj;eroccliè lio veduto la
stessa voce Bagoli nell’ antica Cronica
de Velluti manuscrittu. Anzi nello stesso
Gio. Villani di un antico maniiscrilto
del sig. Anton Maria óalvini si legge
Bogole, e Bogioìi.
Fag. II. V. 14 . Or dì io son mortoassetato.
Mortoasselato è detto nella stessa ma-niera , che innamoratomorto : di qualsi-
voglia, che abbia brama, o voglia gran-
de di che che sia si dice e muore di
sete , di fame , d’ amore. Onde i Latini
l’ amare iu eccesso dissero depetire.
i34Pag. ii.T. i5 . Dèi vin caldo s' io n* in-t
sacco.
Lo stomaco per similitudine fu detto
sacco. Morg. 19 i 3o.
Poi si cacciava qualche penna in boccaPer 'vomitar
, quando egli ha pieno il
sacco.
E 142.
Margutte cK avea ancor ben pieno il
sacco.
Quindi insaccare significa mandar giùnello stomaco. Morg. ig. 187.
E mangia e beve e insacca per duoverri.
Pag. IT. T. 17. Gotto.
Vale lo stesso che bicchiere ; ed èToce pigliata in presto da’ Veneziani
, ederiva non da giutus
,
ma da cyathus\e cosi mostra di credere Ferrari nelleOrigini alla voce Bufjone. Nella descri-
zione della processione e festa di Baccofatta da Tolomeo Filadelfo
, e riferita
da jiteneo lib. 5 . trovansi nominati certi
vasi olvojifiai,
,
che il Dalecampio tra-
duce gutti vinariì. Ma (juesli son vasiper mescere , e non per here , sicchénon sono il medesimo co gotti Venezia-
Digitizad by Google
i 35ìli, l quali sono sorta di bicchieri. Far*
laiio più proprio i Milanesi, che gottodicono al buffone di vetro , come narrail suddetto Ferrari alla t. gotto. Cheveramente in Milano si dica gotto adun piccolo vasetto di vetro in loggia di
huffoncino me lo conferma il sig. Dott.,
Giovannantonio Paganini gio-'
vane , che agli studj della miglior nlo^'
sofia , e della più sana medicina , ne* ì
quali 8* è innoltrato molto avanti, accop-
pia nobilmente quegli delle poetiche
amenità, e delle toscane erudizioni. ,
Pag. II. V. 19. Arlotto.
Arlotto significa uomo vile e sporco,
e che mangia e bee oltre ragione. 11
Giamhullari Ciriff. Calv. lib. 2.
B non vi dico se sapea tT arlotto
,
Morg. cant. 3 . 45.
E cominciò a mangiar con*’ un arlotto,
E cant. 19. i 3 i«
£ sapeva di vin coni un arlotto.
Trovo questa voce negli antichi Proven-
zali. Rimario Provenz. della Libreria di
san Lorenzo. Arlolz, Pauper, Vilis. Un
236poeta Provenzale incerto del testo a pen*na della suddetta Libreria.
Anc persona tant avaraNo crei qe nuls lioms vis
i Cum al veil Arloc meschins
,Naimeric ab trista cara.
Della viltà e bruttezza di questo no-me se ne legge un esemplo nelle Face-zie del Piovano Arlotto del raanusci it-
to della suddetta tante volte mentovataLibreria di san Lorenzo. Mandò per il
Piovano Arlotto per aver cierta infor^
mozione , e parlato alquanto insieme ,
domanda TArciveschovo. Ditemi Piova-no qual fu il 'vostro directo nome alla
fonte, quando ricevesti Pacqua del san-
ato boptesimo ? rispose Arlotto. Assaisi maravipliò PArcivescovo , e disse : se
affirenze fosse una pliahella chon questi
incarichi, che quando uno padre volesse
porre nome a un suo figliuolo ,pagasse
cierta quantità di danari, e chiane 'vo-
lesse uno più bello ,paghasse mag^or
somma-, ciertamente e' non è si poveris-
simo uomo, che non impegniasse il man-tello par potete comperare il più bello,
per porre un degnio nome al figliuolo ;
e vosLto padre,che era uomo da, bene
,
e di grande ingiegnio, ed al quale noncosta'va cosa alchuna, vedete che nomeistrano vi pose -, ciertamente mi pare ,
Ogitized by Googl
elle lui commettessi grande errore. Ri-spose il Piovano yiriotto : Alonsigniore
non 've ne fate mara-vìglUt , mio padre
ne comisse assai de' maggiori , ec.
Questo Piovaao non fu il primo ail
aver colai nome, il quale, forse ne’pri-
mi tempi , non era tanto dispregevole ;
imperocché in una scrittura antichissi-
ma citata da Mous. Vincenzio Borghini
nel Trattato della Chiesa, c de’ Vescovi
Fiorentini si iegge ; che 1 ’ anno 1072. i
nobili uomini Rolando di Federigo , e
Arlotto di Sicltehno rinunziano in ma-no del Vescovo di Firenze quanluiujucragioni avessero nel castello di Cercina.
• E nel 1842 quando i Fissai assedin'^ono
la città di Lucca, venùnta a' Fiorentini
da inesser Mastino della Scala, fu capi-
tano del Popolo, e Comune di Pi^a Ar~lotto da Recanati
,
come ho letto i:i
una antica Cronaca Pisana mannscritta
della mia Libreria a car. 167. L li'a le
Scritture antiche del sig. Cavalier Ron-doni Pisano, fascio 2. niim. i 3 . trovo unContratto del i22Ó. nel quale interviene
Arloclus fdius fìonagruae della Gattaja.
Rogatus D. Joseph notarius DominiOthonis Imperatoris. E.xemplavit Bovn-fede Judiìx. Ne’ libri pubblici del sud-detto Comune di Pisa dall’ anno i2t(7.
sino al 1438. vi è notizia della nobile
famiglia degli Arlotti, i quali abitava-
no u«lie parrocchie di sau Michele di
j38Boi^rt, di 8. Paolo all’ Orto, di s. Pìe»«in vìdtoIì, e faceano per arme due leo»ni rossi in campo bianco divisi da unasbarra rossa. Se soggiugnerò, che IJuigiPulci nel Morganle cant. x5. ij3. poseil nome Arlotto ad un Re di Scria ,
;s’ accorgerà molto bene il Lettore
, che
^
per ischerzo , e per baja mi son messo,a scrivere queste annotazioni#
Prti gli o.ltri un Re di Jdma e gagliar-dia
,
Ch'io dissi appresso, Arlotto^ di Sona.
Nome non men bello di Arlotto è il
di Broda/o , che si trova nell’an-tichissima e nobilissima famiglia de’Sac-chetti ; siccome ancora in essa , ed innella degli Adimari si trova il nomei Tegghiafo.
Pag. li. V. 27. Ostica.
Ostico forse dall’ antica voce Latinahosticus, Varrone de Lingua Latina 1. 4.Ut nostri augures publice dixerunt
,
agrorum sunt genera quinqne, Romanus,Gabinus , Peregrìnus , Hosticus
, Incer-tus. E più sotto: Hosticus dictus ab ho-stibus. Così Ostico quasi nemico , spia-cente. Vedi il Menagio nelle Origini ,che lo fa venir dal Greco. Vedi CarloDati nelle Giunte delle medesime Ori-gini.
Digiti; ed by Google
Pag. 12. f. 9. Evoè.
11 Poliziano nella favola dì Orfeo fa
dire al Coro delle Baccanti :
Ognun segua Bacco te
Bacco Bacco e'voè,
E alla fine dopo più repliche di questo
medesimo intercalare :
Ognun gridi evoèOgnun segua Bacco te
Bacco Bacco e'voè.
Orazio, Ode 19 del lib. 2.
Evoe nienti fmens trepidat metu
,
Pìenogue : Bacchi pectorh ^ turbidum
LaetOfur, eh)oe pasce Liber ,
Pasce gravi metuende lltyrso.
Euripide nelle Baccanti canta, che Bac-
co è quegli , che dà la voce^ al Coro
delle Baccanti intonando egli 1 evoè , a
cui esse rispondono a coro pieno:
O 9 ' $v di :
E Luciano nel Bacco joatra , che quan-
do ques^ Dio fece l’
i
gipresa .delT-In-
^aj il Tegno accordato della battaglia
era Evoè Mai rò pi* (vvòtipa n*nxò ti 9Ì‘ Questo Evoè parrebbe una
sorta di acclamazione, e -che volesse dì*
re bene a lui secondo la scrittura gre-ca; ma dubito, cbe questa nou sia unadi quelle voci barbare, cbe come solen-
ni e legittime e sacre si usavano da’Gentili ne’loro sacrifizj per testimonian-za di Jamblico nel lib. de’ Mister)
, le
quali , dice egli, conforme alla loro su-perstizione, che aveano in se religione,
e che perciò non era lecito il mutarle.Ognun sa , che Bacco non era nato inGrecia , ma che bensì vi trasportò le
mistiche cerimonie. Io credo dunque ,
che questa appellazione di Eroè sia unavoce non altrimenti Greca , ma barba-ra, nella quale in linguaggio mistico esacro viene invocalo Bacco, e forse vie-
ne invocato come Signore, affermandoloLuciano, al quale per esser di Soria si
può dare in questa parte qualche fede.
Dice egli , nel Ragionamento intitolato
/ Bacco,
quando le Baccanti gridano
/ E'voè, che questo Evoe significa
, che1 esse chiamano il loro Signore, xat
I tv oi, tvvro H'tlxàietv, avróv\ TÒt 9tfTÓT*iv. E forse tal nome di Signo-
\ re fu tolto dalla lingua Ebrea, ed è
I una storpiatura fatta da’ Gentili del no-me del vero Iddio. '11 Bociarto
,nella
seconda parte della Geografia sacra lib. i.
cap. i8. trae il significato di E'voè da*Proverbi di Salomone 25. 29. 3o,
/
»
Digitized by Google
*4»
Pag. 12. . 20. E spediscane caurier‘ A monsieur Fabbi Regnier
11 sig. abate Regnier des Marais granLetterato del nostro secolo
, Segretario
della nobilissima Accademia Franzese ,
e Accademico della Crnsca scrive prosee versi Toscani con tanta proprietà, pu-rità e finezza
, che qualsisia più ocula-
tissimo Critico non potrà mai credere ,
che egli non sia nato e nutrito nel cuo-re della Toscana. Con la stessa felicità
scrive ancor nella materna sna linguae nella Spagnuola e nella Latina e nel-
la Greca : e dalla Greca ha traportato
mirabilmente nella Toscana tutte le poe-
sie di senza scostarsi punto dal
Testo. Io ne parlo con certezza di scien-
za, essendomi stata comunicata questa
nobile Operetta dalla cortese modestia
dello sig. Abate per mano del sig. PierAndrea Forzoni Accademico della Cru-sca in cpiel tempo, che egli si trovava
in Parigi.*
Pag. 12. V. 22. C/ie vino è quel colà,
Ck' ha quel color dorè ?
Plinio lib. 14. cap. 19. sul principio:
Colores vini quatuor: albus, J'ulvus, san-
guineus , niger. Fnlviis è il colore del-
r oro. Tibullo eleg. 5 . lib, i. Divitias
aliiis fulvo sibi congerat auro ; e par-
rebbe quindi sì potesse inferire , che il
color dorè, ovvero dorato fosse il fulvus
de’ Latini. Ma questo fatto de’ colori ap-
presso gli Autori è confusissimo. Ovidio
fib. i3. delle Trasformazioni:
Sunt auro similes longis in vitibus uvae^
Sunt et purpureae.
Alam. Colt. lib. 3.
Chi più brama il color , che T ambra ,
o t auro
Rappresenti nel vin fumoso altero.
Pag. 12. V. 25 . C1Ìal Trebbio onor già die.
11 Trebbio è una villa posseduta oggi
da’ Padri della Congregazione di san Fi-
lippo Pieri. Anticamente posseduta dalla
famiglia de’ Medici. ?
Pag. 12. V. 3i. E molto a grò mi va.
Grè, voce venuta di Francia, c usata
dagli antichi Toscani ancora. L’ antica
Provenzale è grat dal Latino gratum.
Dante , Farad. 4. disse contr a grato
,
e Farad. 3. contr a grado. Gio, Villani
lib. 8. Il 5. a grande grado. Emblanchor
cet Poeta Provenzale del testo a penna
di san Lorenzo:
Perdio non dei amor ocaisonar.
Tan eum los oilli el wr ama parvenzot
Digitized by Google
14^
Car li oill son dntgoman del cor t
E ili olii van vezer
Zp cal cor plaz retener
,
E con son ben accordan
,
E ferm tuit Irei d'un semblan
Adoncas pren verni amors nascenzha
Da so qe li oill fan al cor agradar,
Qasthers non poC naisser, ni comen-
zhar.
Mais per lo grat deh treis nais , e co-
menifui.
E appresso:
Per lo grat , e pel comanDel treis ,
e per lor plazer
Nais amor q en bon esper
Vai SOS amics confòrtan.
Siccome dunque i parliclpj Provenzali
amat , desirat
,
e simili il Franzese
spiega per aimè ,destri
,
e simili ; cosi
grat Provenzale è detto in Franzese grè.
Il nostro giuoco della Litma^rè
,
per1 ^ «
iscambiarsi in esso la carta , che non /''
'
piace con quella del compagno ,che è
allatto, è detto da Ella non mi va agrò , e cosi credeva il già sig. Giraldi
Proposto di Empoli. Questo giuoco tra
gli Aretini si chiama Piacitella , cioè
Ti piace ella 1 II che conferma il sud-
eletto signilicato di Lumaggrè.
Digitized by Google
»44Pag. 12 . T. 32. Io bevo in sanità
Toscano Re di te.
T brindisi de’ Latini, dice il Ferrarialla voce Brindisi
(la quale egli con
r autorità dello Sdoppio fa TCnire dalTedesco) era di questa foggia. Bene te^
bene mei ma nr-n cita per conferma delsuo dello ninno Autore. Plauto nel Per-
siano so. I. att. 5. disse: Bene dbi, benemihi , come si vede in questo verso :
Paegnium , tarde ciathos mihi das , ce-
do sane :
Bene mihi , bene vobis , bene amicaemeae.
/
,Pag. i3. V. 4. Spira gentil soavità odore.
Omero nel g. delTUlissea vers. 208.
Quando bevean del dolce vin vermiglio
Pieno un bicchier , con venti parti
tT acqua
[Temprollo \ e un dolce odor spira dal
\ vaso.
Ne’ tempi d’ Omero ,come da’ suddetti
versi osservali ancora da Plinio, si rac-
coglie, innacquavasi dagli uomini sani
il vino molto più di quello che si co-
stumi oggi. £ se Ipocrate nelle febbri
ardenti in alcuni casi dava il vino ,
egli lo mescolava con venticinque parli
i45di acqua Tovre di Stdaiov Sivo* *ea/iaìo*
iKtvTt Kiteonv vdaxo^ , xaì iva òt-
vov SiSov- Tuttavia Esiodo per cemuueusanza consigliava bere il vino iaua-
cqualo con tre sole parli di acqua;
Tre parti d acqua, ed una sia di vino.
£d il suo parere fu seguitato da Giulio
Polluce nel cap. 2. del lib. 6. dell’Oao-
mastico. Vedi quivi. Vedi ancora Plu-tarco nella Quist. 9. Simpos. 3 . ed Ate-neo lib. IO. Contuttociù gli antichi nel-
r innacquare facevan differenza tra vi*
no e vino; ed aveano ancora riguardoall’ età degli uomini , ed alla stagione
dell* anno.
Pag. i3. V. 9. Sazio poi danni, e di gran-di opre onusto
Per tornar colassà donde scendesti '
Orazio lib. i. Od. 2. ad Augusto:
Serus in coelum redeas ,diuque
Lroetus intersis populo Quirini.
Pag. i3. V. i3. Tra le Medicee stelle Astranovello
Gli antidii, e particolarmente i Pla.<
tonici settatori della teologia di Orfeo ,
stimavano 1’ anime più pure degli eroi'
Redi. Opere. VoLI. io
146•
pigliare corpi celesti. E la nuora stella,
o cometa, che fu veduta dopo la mortedi Giulio Cesare , fu creduta 1’ animadi lui divinizzato ; laonde Orazio lib. i.
Ode 12.
.... minat inter omnesJulium Sidus , velai inter ignes
Luna minoret.
E Virgilio , nel primo della Georgica ,
mostra di credere, che egli possa essere
dopo morie una nuova stella , e gli di-
se^a *il luogo tra il segno della Vergi-
ne, e quello dello Scorpione :
Anne novum taràis sidus te mcnsibusaddas ,
Qui locus Erignnen inter, chelasque se^
quentes
Panditur ? cc.
Ed il Tasso nella cantone pel natale
del Principe di Toscana:
Di Giulio ancor la vendicata morte,Clt ebbe alt antico Giulio cgual fortuna.
Sappia,e per duol ne pianga 'e ne so~
spiri.
Sappia , che in del translato or gli èconsorte
D'onore-, c quando Vorizzonte imbruno.Fra r altre stelle lampeggiar rimiri
*47La Giulia luce, e vigilar ne' giri
,
Mentre ad ogni alma al sangue suo ru~
bella
Con orrido splendor, con fiera facciaSangue e morte minaccia.
Teman pur gli empj i rai delT altra
stella;
Che o custodire , o vendicar puoC ella.
Pag. i3. V. i 6 . jft suon del cembalo. Alsuon del crotalo. '
Il Cembalo degli anticbi Greci e Ro-mani era molto differente dal Cembalo,che oggi è in uso. Vedi il Vocabolariodella Crusca. De’ Cembali e de’ Crotali
antichi reggasi il dottissimo ed eruditis-
simo Medico Jacopo Spon nella Disser-
tazione 8. delle sue Ricerche curiose di
antichità, stampale in Lione l’anno i683.
in quarto.
Pag. i3. V. 23. Da' neri grappoli
Palladio nel mese di Ottobre tìt. 14.
riferisce l’opinione de’ Greci, che il vi-
no gagliardo e polputo stimano farsi
dall’ uve nere. Uvis nigrit fieri forte ,
rubeis suave , albis véro plerunujue me-diocre. Fiorentino ne’ Gróponici lib.' 5.
dice, che l’nva néra per lo più fa' il
rio buono in gran oopia , e cne basta.
E Diafane nel lib. 6 . afferma , che l’u-
ve nere avranno più possente il vino.
J48Anacreonte chiama il grappolo
xòv ittXavoj^póxa, ^àrpvf. -» 1'
nero
'*V\
Pag. i3. V. uh. NacchereNacchera io lingua Toscana ha di-
versi siguilicati. In primo luogo vale lo
stesso che ÌMadreperla. 1 Francesi la dis-
sero Nacre , e gli Spagnuoli Nacar. 11
Covarruvias nel tesoro della lingua Gi-stìgliaiia. Nacar \ la concita •,
dentro dela qual se criaii las pcrlas , o margari-
•tas: yo no alcanzo su etimologia', deve
ser nombre parùcular de aquellas par-tes
, y mares donde se crian ; salvo si
,,.en razon de que se labra el nacar enescamas para guarnecer escritorio , yotras cosas
, es forzoso hotadarlo por la
parte, que se tiene de clavar , y assi
! se pudo dezir del verbo hebreo Nacharperforare. ISacebera signifìca ancora quel-
la sorta di conchiglie marine , che daPlinio furono chiamate pemae , e dal
Mattinolo , e dall’ Aldovrando furono
dette pinnae
,
le quali producono unacerta lana , o seta chiamata volgarmen-
te da’ Medici pelo di nacchera ; ed è
. credula buona per coloro ,che patisco-
no di sordità. Si dice eziandio Nacchere
nel plurale a uno strumento fanciulle-
sco da suopo , fabbricalo di legni , o
. d’ossi, o di gusci di noce, o di nicchi,
che posto fra le dila della mano sinistra
ai batte con la destra , e prese per av»
Digitized byGi-O' le
i49
ventura il nome Nacchere,
per essa e
ne’ primi tempi fabbricato eli soli gusci
- di Nacchere ,o di altra razza di con*
chiglie. Le Nacchere sono altresi due
«Uumenti di rame in foggia di due
grandi pentole vestite di ciiojo , e per
di sopra nel largo della bocca coperte
con pelle da tamburo ,e si suonano
con due bacchette ,battendo con esse
vicendcvolmeistc a tempo or sopra 1 u»
no , or sopra 1’ altro di questi strumeu-
ll ,detti poi TabalU, e presentemente
Timballi, i quali anticamente erano per
lo più in uso tra’ Saracini , siccome lo
sono ancor oggi , e da essi in loro lin-
gua si chiamano Nachar ,ovvero Nac-
hur, Giovanni signore di Joinville , che
fiori ne’ tempi di s. Luigi H-e di Fran-
ci.a nella vita di esso santo ,scrivendo
dell’ esercito de’ Saracini intorno a Da-
miata : Le tumidte qu ilz menoienC ave-
qnes leurs cors et naccaires • eetoit una
espouvantahle chose a ovir ,et muult
estranfie aux Franzois E appresso ;
Quant les chevaliers de la. Hiitih qua
eurent occis leur Soldan, les Admiraiilx
firent sonner leurs trompettes , et na-
cquaires.
Bern. Ori. lib. i. cani. 4>
Passi un romor di trombe e di^Carr^urL
Di nacchere e di comi alla moresca
I
| 0 ()
' L’uso di questo strumento passò poscia' tra’Crisliani , e si legge in Gto. Villani
lib; IO. cap. 59. l’anno 1327. che nel-
l’ assalto di Pistoja Con gran vigore e
grida e spa<^’ento di trombe e di naephe*• re entrarono nella Terra,, e lib. n.cap. 37. quando 1
’ anno i 335 . i Peru-gini e loro collegati tolsero agli Aretini
la città di Castello per istrattagemma.
Fecero cista con gran tumulto digridOf
e di suono di trombe e di nacchered' assalire altra porta. E lo stesso Vil~
lani nel lib. ri. cap. 92. facendo men-zione delle spese , che nel i 338 . faceva
il Comune di Firenze , dice : 1 tiomba^
jdori e banditori dèi Comune, che sono
t i banditori sei, e trombadori e naoche-
ì vino e sveglia ,cennamella e trombetta
IO. tutti con trombe e trombette di ai'^
gento, per loro salato Tanno lir. 1000.
Il sig. Egidio Menalo nelle etimologie
delia lingua Italiana fa venir INacchera
dal Greco àvixapa
,
significa una spe-
zie di tamburo, come si può vedere ap-
' presso Codino nel Trattato degli ufici
della Corte di Costantinopoli, llsig, y^/z-
ton Maria Salvini non crede, che ven-
ga dal Greco; anzi va opinando, che i
Greci la prendessero dalle lingue Orien-
tali, e per avventura da’ Saracini e da*
Turchi, del che ne può far fede, comeegli dice la sillaba A preposta a vàxa-pm
,
che coirisponde ad uno degli arti-
Digitizod by Google
i5i* coli de^U Arabi. Similmenle anche i
.. Franzesi dissero non solamente ruiquai-
res
,
e nacaires
,
ma ancora coll’articolo
arabesco anacairesj come afferma d’averosservato nelle sue Annotazioni al sig.
di*Joinville il Du^Fresne nel Glossario.
1 Veneziani dicono gnaccare. Tra gli
Aretini. Non essere una gnacchera \a-
le lo stesso, che non ‘essere una cosa di
poco momento.
Pag. 14. V. r. Trescando intuonino
Glossario Provenzale Lat. manuscritlodella Libreria di san Lorenzo Trescar,
choream intricatam ducere. Vedi la ori-
gine di questa voce nel Menagio alla
voce Tresca. >
Pag. 14. V. 2. Strambotti
Il Vocabolario. Poesie, che si canta-
no dagli innamorati, e sono per lo piùin ottava rima. Un gran letterato mo-derno scrive tal voce essere un dimi-
nutivo di strambo
,
che vale torto,
ri-
torto, lo crederei , che strambotto aves-
se avuto origine da motto , che da’ no-stri antichi si prendeva in signiiìcato di
componimento poetico, e tanto' più Io
crederei, quanto che in .ilcuni luoghi
d’ Italia dalla plebe appellasi volgar-
mente strammotto , come si può vederenel frontispizio del Tirocinio delle cose
volgari di Diomede Guidalotto Bolo-
rSi
gnese stampato in Bologna i 5o4. in 4.*
appresso Caligula di Bazzaleri. E nel
frontispir.io parimente àtM'Opera nuovadi messer Bernardo Accolti chiamatorUnico Aretino stampata in Veneiia
nel i 5 iq. in ottavo appresso Ni(%olò
Zopino. vedi in queste Annotazioni Mot^tetto. E se si ha curiosità di leggere
esempli degli Strambotti del secolo pas-
sato , si troveranno ne’ due meniovati
autori ; e tra quelli dello Accolti, veue sono molti acutissimi
, e sull’ andarede’ buoni epigrammi de’ Greci e de’ La-tini. Oggi così fatta soi-ta di composizione
è andata quasi totalmente in disuso.
Tra’ Provenzali non ne trovo esemplo.
Pag. 14. v.a. Frottole (F alto mistero
Qual sorta di composizione poetica
sia la Frottola si può leggere nel Vo-cabolario , e nel 6. lib. delle Lettere del
•' Bembo nella lettera all’Arcivescovo Tro-
Jìmo , dove il Bembo osserva , che il
Petrarca ad una sua Frottola da esso
Bembo trovata in un codice antico diè
nome di Frotta. E veramente da’ più
antichi Poeti cosi fatte poesie erano
chiamate frotte, e non frottole. Per mo-
strar quali fossero quelle de’ primi , e
più rozzi tempi, ne porterò qui appres-
so una , lasciandola nella stessa forma ,
nella quale sta scritta nel mio antico
testo a penna.
Digit'-
~
Cìoogic
ot nEssm
BANIEEI DE’SAMARETANI
j mcssEK
POLO DI CASTELLO POETA.
Comen samaria nato far di fe : ferme
lo nome saura quello cagio.
Cosi come ver voi son dricto in Jè :
messere Polo però del senno cagio.
Sono vi mando c anvero Dio fé : e hi
rincontra lui vantene cagio.
Ludite volte mante ^ ad anime cornante i
probate son parole’, dicio he fo pa^
Tale.
Le frotte, o frottole sogliono per lo pii
parlare oscuro, e con misterio, comesi
può osservare nella sopraddetta , ed in
quelle del Petrarca ’, e 'perciò simili
poesie di senso arcano e misterioso poi-
soQ piacere a Bacco , come a quegli
,
i54che portò i mister)
nella Grecia.
e le cose mistiche
Pag. 14. V. 5 . jE i lieti Egipani.
II passo , ed il saltare degli Egipani
era imitato dagli antichi coH’andar^suitrampoli. Pesto Gramatico alla lettera G.Grallatores appeìlabantur pantomimi ,
qui ut in saltatione imitarentur AEgipa^
nas ,adjectis perticis furculas habenti-
bus ^ atque in his superstantes ad sùni~
litudinem crurum ejià generis,gradie-
hantur utique^ propter dijficultatem con-
sistendi.
Pag. 14. T. 7. Tengan bordone.
Dante, Purg. 28.
A/a con piena letizia P ore prime
Cantando risedean intra le foglie
,
' ette tenevan bordone alle sue rime.
Pag. 14. Y. IO. E dal po^io vicino accOr<r
di, e suoni
Talabalacchi , ec.
Questo baccano di contadini è descrit»
ito mirabilmente dal Poliziano nel Ru-
stico con que’ versi ,ove gli descrivg^
con tutta la famiglia passar le ^unghc
veglie del verno bevendo , saltando , so-
nando , cantando , e in varj modi im-
pazzando :
,x
, 7
rijilizod by Googic
i55
Mntuaque inter se ludunt ; tum tibia
folle
Lascivum sonat inflato ; tian carminacantant ,
Carmina certatim cantante tum tenta
recusso
Tympana suppìodunt bacalo , et cavacymbala pidsant ,
Et laeti saltant , et timdunt aeribus
aera ,
• Et grave conspirat coma tuba flexiìis
anco ,
Conclamantque altum unanimes , tol-
luntfjue cachinnos.
Pag. 14. V. II. Talabalaccfti
Strumento di sonare in guerra usato
da' Mori.
Bern. Ori. 3. 8 .
S" udì 'I rumor nel campo de' PaganiTalabalacchi e timpani sonando.
Pag. 14. V. II. Tamburaccio11 Tamburaccio è un grande strumen-
to da suono alla Moresca simile di figu-
ra ad uno de’ due timballi della caval-
lerìa Alemanna,fatto di rame copeiio
di pelle di tamburo , e si suona conbattervi sopra un pezzo di canapo inca-
,tramato. Teria lo dicono i Mori in loro
i lingua: Griff. Calv. lib. 2 .
i 5GTante tromhette ,
sve^Jié e cennamelle,
E lamburacci e naccheroni e comu
E lib. 3.
E certi, tamburacci e naccheroni.
Pag. 14. V. jz. Svegìioni
Svegliane. Accrescimento di sveglia.
La sveglia era uno strumento da sonare
usato da’ nostri antichi. Morg. 16. 25 .
Trombe, trombette, nacchere e hassoni.
Cembali , staffe ,cennamelle in tresca ,
Comi, tambur , cornamuse , sveglioni
,
E molti altri strumenti alla Moresca.
Pag. 14. V. 12. Colascione
Strumento musicale a due corde ac>
cordate in diapente. Il Ferrari alla vocecola, par che voglia, c\\e colascione
,
o,
come esso dice, colazone, sia detto dai
Coli Napolitani, che lo sogliono sonare.
Ma a Napoli non colazone, o colaicio~
ne, ma calascione lo chiamano. Giulio
Cortese nel viaggio di Parnaso canto 2.
in fìne :
E pe fare conzierto assale pià tannoSonaje lo calascione compà Junno.
Felippo Sgruttendio de Scafato nella
Digitizod by C
i57Tiorba a Taccone cemincia il suo libro
cosi :
Sto galasciorw, che me metto 'nzino ^
E sto taccone , che mi piglio 'mmano,
£ alla corda quinta della Tiorba :
Piglio lo calascione pe cantare.
Gian Alessio AhhattuUs nell’egloga no-
na delle Muse I^apolitanc si lamenta,
che al colascione sieno state aggiunte
modernamente più corde di quelle, che'
gli furono assegnate dal primo inventore:
Che malannaggia tante 'nmentiune.
Si benedetta tarma a li Spartane
,
Ca mpsero na celala
,
Perchè se ne era ag^onta ri autra_
corda ,
Ca mo f'uene farria lo permericolo
Lo primo, c ha guastato ,
Lo calascione re de li stromiente
Co tante corde e tante ,
Cli ha perduto lo nomme , e se po dire
Quanto mutato, ohimè, da citello cK era.
^on sarebbe gran cosa , che colascione
fosse originato da chelys
,
e non da’co/*
Plapolitaui. La più bassa plebe lo chia-
ma in Firenze ganascione.
j58Pag. t 4< . i5. Dabbuddà
11 Vocabolario. Strumento simile alBuonaccordo ; ma senza tasti , oggi an-
che chiamato Ogniaccordo , e si suonacon due bacchette , che si battono in
su le corde. Vaat. di Rinald. Una da-migella della Regina sonava il dabbud-dà con due bacchette d' avolio. Simile
-voce a la Napolitana zucchezzà detta aun altro strumento, che suonano le ma-schere per carnovale. Felippo Sgruttendio
da Scafato nella Tiorba a Taccone, cor-
da nona :
Lasso stare li piacire.
Che' pigliare me fai tu ,
E de mascare vestire
Co sonà lo zuchezù.
Gian Alessio Abbattutis nell’egloga so-
,praccitata disse zugo zugo , e nominòmolti altri strumenti fanciulleschi:
Valea chiù lo conzierto
De lo tiempo passato.
Lo pettano e la carta
,
D ossa 'nmiezzo a le deta ,
,Lo crocròf che parlava
Lo bello zuco zuco ,
La cocchiara sbattuta
Co lo taglierò, e co lo pignatiello.
Lo vottafuoco, co lo fiscariello
Che te ne ive 'nsiecolo.
Dìgitized by Google
i5gPag. 14. T. \6.iCantinq e ìndUno il bom-
bahabàIl bombababà ò! uoa canzone solita
in Firenze cantarsi dalla turba de’bevi*
lori plebei , e comincia :
Con questo calicione
Si corca la balestra , , ^Chi ha 'I bicchiere in manoAl suo compagno il presta
,
E mentre eh' ei herà
Noi diremo bombahabà.
Pag. 14. 26. Mottetto
Voce oggi restata a’ Musici, che, co*
me afiferma il nostro Vocabolario , conessa appellano una breve composizione
in musica di parole spirituali latine.
Anticamente signilicava una composi-
zione toscana per lo più di pochi versi
in rima contenente alcun concetto , co-
me si può vedere ne’ mottetti di messer
Francesco da Barberino, de’ quali altri
sono di due soli versi , altri di tre , o' di quattro , o di cinque al più , eccet-
tuatone il cinquantesimo, che può dirsi
canzone di sette strofe. Messer Lapo ,
che da altri fu detto messer Lupo di
Farinata degli Liberti , chiama per os-
' servazione del conte Federigo Ubaldini,
mottetto (|tiella ballata di Gelido Caval-
canti, che comincia:
i6oIn un boicJiett» vidi pastortUa ,
la quale è di molte stanze, dicendogli
in risposta :
Però rassetta se va' tuo mottetto,» • • l
Mottetto parimente si chiama una can-zone del Re Enzo , che comincia ne*
miei manuscritii ;
’jimor fa come'l fino uccellatore y
Cli olii auselli sguardare
Si mostra pià ingegnUri tTinvescare. ,
E similmente un* altra di messer Sim*buono Giudice , che cmnincia:
Spesso di &oja nasce, e iacomenzaCiò che aMuce dolore
Al core umano , e parli gio’ sentire
E frutto nasce di dolce semenza,' Che dà amaro savore, ec.
Del resto mottetto è diminutivo di mot-to. E motto ne’ primi rozzi tempi signi-
ficava ogni sorta di composizione poeti-
ca , e le sue parole ancora semplice-
mente. Onde nelle cento Vovelle anti-
che : I cavalieri e i donzelli , eli eranogiulivi e^gai , si fiu'.evano 'fi belle can-zoni , et suono e ’l motto, ndl’ antico
Tratt. Gov. Fam, Se nella brigata si cari-
Digìiized by Google
i6i
tino suoni e motti. Ed è voce lasciata ìa
Toscana da’ Rimatori Provenzali. Ponsde Capdoill :
E'I mòt K eu cant si no es gai e poli.
Nella vita di Ganselm Faidit, cioè di
Anseimo Federigo del testo a pennadella Libreria di s. Lorenzo :
Fetz moli bos sos e nos motz.
Salvarico di Malleone Inglese Poeta Pro-
venzale , che è quello stesso mentovatoda Guglielmo Britone nel Poema della
Filippide con nome di Savaricus Mal-leo, e da Matteo Parisio
,
e da MatteoVestmonasteriense Savaricus de MalloLeoni ; e da Ricordo Savaricus de Ma~lo Leone :
Doussament fait motz , et sos
Ab amor que tria vencut.
Qui mi sia permesso di replicare , chedelle canzoni t fare il suono e il motto^
fare buoni suoni e buoni motti, e faredolcemente motti e suoni , parmi chevaglia quello
, che noi diremmo com-porre insieme e la musica e le parole.
Gli antichi Poeti Lirici de’ Greci nonsolamente eran detti Àvpneoi dal cantare
Redi. Opere, Vol. 1. il
le loro ode, ovvero canzoni sulla Lira;
ma ancora si nominavano fie^neói ; per-
chè essi stessi si componevano 1* aria, e
il suono dello da’ Greci E simile
i Poeti Provenzali doveano comporsi1’ arie ,
sulle quali cantavano le ioi- ri-
me , come si legge nelle loro vite, e nefa fede chiaramente Arnaldo Daniello,che una sua canzone manuscritta della
Libreria di san Lorenzo termina così
dicendo :
Ma cantori prec qe non vus sia en nois,
Qar si volez grazir lo son, el mozJHauc prez AmauC , cui qe plaz o qe
tire. ^
Lo stesso Arnaldo in un’ altra Can-tone :
Ges per maltrag quem sojri
De ben amar non destali.
Si tot me son en desert
Per lei Jaz lo son el rima.
Quel che presso de’ Provenzali si dicemotto e suono ,
rima e suono , il Boc-caccio nella Novella settima della Gior-nata decima venne a dire parole e suty^
no. Le quali parole Minuccio presta-mente intonò a un suono soave e pie-toso , siccome la materia di quelle ri-
eluedeva , cioè mise in musica, spiega
Digìtìzed by Google
i63qui ottimameate il Vocabolario. E piùsotto lo stesso Boccaccio. Monsignore
,
rispose Minuccio , e non sono ancoratre giorni ,
che le parole si fecero , e Vsuono. Il termine a intonare usato dalBoccaccio ^er mettere in musica mi fa
sovvenire d un verso , che si legge nel
Poema intitolato Os Lusiades scritto in
lingua Portoghese da Lssigi Camocs, ovelodando un tal canto dalle parole e dal-
la musica , dice:
Soave a letra , angelica a toada.
£ veramente il mettere in musica ariet-
te, o canzoni non è altro , che un in-
tonarle , cioè dare loro il tuono nella
5rima stanza , o cobola
;poiché la me-
esima maniera di canto chiamata da'
Latini modus
^
e da’ Latini de’ secoli più.
bassi con voce greca Lropus, veniva tan-
te volte a replicarsi,quante si replica-
vano le stanze in essa canzone. LaondeStefano Paschiere in una delle sue let-
tere al Ronsardo intorno all’ origine , e
all’ antichità della Poesia Franzese affer-
ma aver viste più canzoni del conte Ti-
baldo di Sciampagna fatte tutte sopra
la Reina Bianca madre di san Luigi
,
delle quali ciascuna prima stanza era
segnata con le note delia musica usata
in que’ tempi. Je cous rcprescnte, dico
egli , ces vers ( intende de’ versi del
xC4conte Tibaldo) hchillez a la vietile fran-
colse , mais en ceste naifuetè ie mas-seure , fjtìy troverez pìusicurs traits
,
doni nous pourrions auiourdhuy /aire
nostre profjìt, et qui est une chose,queie vous veucc icy dire par excellence ,
c'est qne sur chasque premier couhletyest la musique ancienne. Io mi trovo
un antichissimo libro manuscritto di
Laudi , U maggior parte delle quali
nelle prime stanze è segnata con quelle
note di musica , con le quali antica-
mente s’intonavano le laudi in Firenze.
Per intonazione,
yier cosi dire, delle
parole, innanzi al Boccaccio avea usa-
ta Dante la voce suono. Purg. cant. t.
Seguitando 'I mio canto con quel suono^Di cui le Piche misere sentirò
,
Lo colpo tal, che disperar perdono.
£ di qui intendo qnel che si dice in unantico Libro conservato nell’ Archivio
principale di Toloja; de' sette Manteni~tori della gioja efyimore ; ove si tratta
de’ ludi poetici, e de* premje delle leg-
gi di Amore , siccome furono instituite
Tanno 1324. scritto nel linguaggio di
Linguadocca da Guglielmo Monilier Can-celliere di essi Ludi , e menzionato daPietro tahro Agonistic. lib. i. cap, 2 r.
]ib. 2. cap. 14. lib. 3 . cap. 20. c 28. In es-
so Libro aduuque viene definito , che
i63dictat am bon compas , am boti
mans ,am bel ornai de parauìas
, et
am sentensa cominal, que ne porta fritg,
cantque haja bel so, es yssorba vila, ocome poma defors bela
, e dedins poy~rida. Quelle parole cantque haja bel so
vorranno inferire , bencliè abbia bella
musica, ancorebè la musica sia buona,e buona la maniera del canto , non se
ne dee tener conto, se non è buona la
sentenza , e se non ha in se la bontà
de’pensieri, che è quella che principal-
mente si considera da’ savj. Nel Liside
di Platone avendo saputo Socrate, che
un certo per nome Ippotale componevasopra TJside amico suo versi e canzoni;
e che di più le andava cantando anchea chi non l’ avesse volute ascolure , e
nee;andolo Ippotale con dire , che era
un matto chi queste cose di lui a So-
crate raccontava ; Socrate per impe-gnarlo gli dice, che non chiede d’udire
i versi; che nè anche ha curiosità della
musica ; ma che solamente gli basta
d’intendere il pensiero; per poter quindiessere informato del motlo, che esso tie-
ne coll’amico suo, trai èyò ehcov , SovTi róv pérpav 9éofia,i àxov-
aai, oììdt fièXoc si fi rrs^oiijxai; sl<; roy
vtavlexov,àXXà ri^c IfiavoioiS , iva sl95
riva rpóito* •jrpotrpipq itpòt rà xaidixd.
Questo testo è poco dopo il principio ,
« l’ho posto qui volentieri, perchè nel-
i66la traduzione del Ficino non pare cosi
vivamente, nè così pienamente fatto ve-
dere quel 9iavoia(
,
il pensiero, o
come i Latini direbbono sententiam, e
il libro Tolosano citato qui sopra sen-
tensa.
Pag. 14. V. 26. CohboleCobbola , cobola e gobola son voci an<
tiche , e vagliono componimento lirico ,
ed ebbero origine dal Provenzale coblof
che in quella lingua avea lo stesso si-
gnificato. ^ella vita di Lanjhanco Cica"
la Genovese , che scrisse in Provenzale,
manoscritto della Libreria di san Lo*renzo ,
amparet chanson et vers et ser-
ventes et coblas et tenzons. ?iella vita
di Guidusel della stessa Libreria: Perrepenre Gvidusel fet a qesta cobla , et
mandetli. Jlella vita di INuc de Sam Si-
re : FI coms de Rodes , el vesconz deTorena sii leverent mout a ioglaria conlas tenzons, et con las coblas qe feiren
collui. Il Re Riccardo, manuscritto Redi:
Coblas a teira /aire adreitamenPor vos oillz enten dompna gentilz.
Federigo Uhaldini nella Prefazione a*
Documenti di Amore del Barberino:Non pure 1 versi , ma quello che piùimporta
, le gobole istesse eccedono lanorma prescritta, trovandosene alcune
d by Google
maggiori d»lt altre , non essendoci però
multiplicate le rime . Chiama messer
Francesco con vocabolo Provenzale co-
bole (quelle certe piccole quantità di
versi tra se rimati, di cui essendo rima»’
sti solamente tra gli Spagnuoli i vestigj,
oggi andrebbono sotto nome di stanze*
Don Sebastiano de Covarruvias nel Te-
soro della Lingua Castigliana : Copia ,
cierto verso Castellano ,qite llamamos
Redondillas,
quasi copula,porque va
copulando , y juntando unos pies con
otros para rnedida, y unos consonantet
con otms para las cadencias. Tambien
se usaron coplas de arte mayor , en
culo lugar succedio el verso Italiano ,
de que estan eompuestos los sonetos, ylas canciones. Ebbe ragione 1’ Ubaldini
a scrivere , che le coìrle anderebbono
talvolta sotto nome di stanze,perchè le
sUmpite de’ Provenzali erano per lo più
scompartite in tante stanze, o strofe co*
me son le nostre canzoni. Vita di Ham-baldo di Placherà : Si com el dis en unacobla de la stampida ,
qe vos ausirst,
Fuggibot :
En chantan de una stampida
Coblas de bellas faissos.
1 Franzesi con nome diminutivo chìa»
mano le stanze couplets quasi coboìette-.
Certe stanze fatte alla maniera Casti*
iB8gliana da Boscano
,
esso le intitola e»-
p/as,perciocché vanno a coppia a cop-
pia,
c sempre queste stanze vengonoad essere di numero pari.
Pag. 14. V. 27. Sonetti
Il Vocaboìarìo della Crusca ottima-
mente: Spezie di poesia lirica in rimacomunemente di quattordici versi di un-
dici sillabe. Mi sento inclinato a crede-
re, 'che tal foggia di sonetti fosse total-
mente invenzione de’ nostri più antichi‘ Poeti Italiani trovandone io esempli dei
così fatti nel Maestro Pietro delle Vi-
j^ne chiamato dal 'Villani, il buon Det-
tatore , iti Guittone di Arezzo Frate
Gaudente ,in Geronimo Perramagnino
Pisano , in Pucciandone Martello daPisa , in Meo Abbracciavacca da Pi~stoja
,che nell’ Indice di Mons. Leon
Allacci è scritto con nome di BraccioVacca ,
in Maestro Bandino eTArezzo ,
nel Giudice Ubertino , che tutti fioriro-
no nel tempo di Fra Guittone, in mes-
ser Lapo Salterello , in Mino del Pa-vesajo étArezzo, in Guido Guinizzelli ,
nel Notar Giacomo da Lentino , inmesser Gonnella degt Interminelli daLiicca, in Grazialo da Firenze, in Gio-vanni Marotolo , in messer GioxannidArezzo , in Masarelto da Todi
, inmesser Francesco Barberino , che na-cque nel 1264. ed in altri di quel se-
Digitizod by Google
colo : ma ne’ primi , e ne’ più antichi
Poeti , o trovatori Provenzali non netrovo esemplo veruno. Non mi è però
ignoto, che il vocabolo sonetto si legge
frequentemente nelle com])osizioni poe>
tiche di essi trovatori Provenzali, i quali
ne’ tempi che fiorirono , misero in cosi
gran lustro e pregio la loro lingua, cheella era intesa , e adoperata quasi datutti coloro che professavano con le let-
tere gentilezza di cavalleria , e di corte
non solamente ne’ paesi della Francia ,
ma altresì nella Germania, nell’ Inghil-
terra e nell’ Italia. E veramente neH'lla-
lia vi furono molti Italiani , che poesie
Provenzali composero, tra’ quali furono
Sordello Mantovano^ Bartolomeo Gior-
gi Veneziano , Alberto di Sisterone àe\-
l’antichissima e nobilissima Casa de’Mar-
chesi IVIalespinì ,Pietro dalla Rovere
Piemontese , Rugetto da Lucca , Lucadi Grimaldo , Bonifazio Calvi , e Lan^franco Cicala tutti da Genova, e da Ge-nova parimente quel Folchelto , che
Folchetto di Marsilia fece appellarvi
,
onde di lui il Petrarca:
Folchetto , eh' a Marsilia il nome ha• datoEd a Genova tolto ; ed alt estremoCangiò per miglior patria abito e stato.
Molti ancora Italiani scrivendo in fin-
»Togua Toscana mescolarono ad arte nelle
loro poesie molte toc! , frasi e modi di
dire Provenzali , e tra questi Italiani si
possono francamente numerare MaestroPiero delle Viarie , Guitton Arezzo ,
messer Francesco da Barberino^ Puccian^done da Pisa, Arrigo Baldonasco, Zuc-chero Bencivenni volgarizzatore del Mae-stro Aldobrandino , e di Rasis , Buona-giunta Urbiciani da Lucca, messer One-sto Bolognese, Guido Guinizzelli , Gui-do Cavalcanti , ser Lippo iTArezzo ,
Dante da Majano. Dante Alighieri, edil Petrarca medesimo , ed altri moltopiù antichi del Petrarca
,
i nomi de*
quali si trovano in molti testi a pennadella mia Libreria , senza quegli altri
che furono stampati da’Giunti in Firen-
ze nel iSay. in ottavo, e quegli altri
purè , che ultimamente uscirono in lu-
ce , per opera di Mons. Leone Allacci
Bibliotecario della Vaticana, in Napoli
in ottavo. In somma , com’ io diceva ,
mi sento inclinato a credere, che il so-
netto di quattonlici versi di undici sil-
labe sia stata invenzione degl’ Italiani
,
ancorché il vocaliolo Sonetto si trovi fre-
quentemente ne’ Provenzali. Imperocché
i Provenzali appellavano sonetti altre
composizioni rimate , e distese In molti
più versi di quattordici, c aventi diver-
sa quantità di sillabe; onde Giuffri
di Tolosa appella sonetto una certa 11-
Digitized by Coogle
I?!
lastrocca di Tersi , che arrÌTano al nu-
mero di trentasei, indirizzata per rispo-
sta ad un simil sonetto della Contessa
di Digno ,o come altri dicono di Dia^
pur aneli’ ella Poetessa Provenzale :
Ben aja vostro sonet
Qe ar eu autre farai.
Mais no aus si perfet
Dir si cori le darai,
E de luenck en cantan
Qer mostrar el meu afan :
Dompna eu piane, e sospir, ec.
Elias Carel citato dal conte Federigo
Ubaldini chiama sonetto una sua lunga
canzone , che comincia :
Pues col la fueilla del garrier
Farai mi gai sonet.
Arnaldo Daniello , di cui inesser Fran-
cesco Petrarca :
Fra tutti il primo Arnaldo Daniello,
Gran Maestro di amor, chi alla sua terra
Ancor fa onor col dir pulito e bello
nominò pur anch’egli una sua canzone
sonetto
En este sonet condes e Ieri
Fai moz ca puie d* oli
«7 *
In qiiesli cliie Tersi si può osservar perpassa{>gio
, che Arnaldo volendo esalta-
re la diligenza del lungo studio, cheponeva nelle sue ]ioesie, dice, che puz-
zan d'olio;siccome appunto d'un anti-
co Oratore della Grecia fu detto , che
le sue Orazioni sentivano di lucerna.
Periol. d’Alvernia:
Un. sonet vau pensanPer solatz , e per rire.
Bernardo del Ventadorn , o del Venta-dom nel fine d' una sua gobola :
Sonet and a MadompnaQe es de luenck, e clam mercé;
e Giraldo di Borneil Limosini chiamatoil maestro de’ Trovatori :
Un sonet fatz malvatz , e bo.
I nostri Poeti antichi Toscani si valsero
ancora di t|uella voce in quel significa-
to ; onde sere Zucchero Bencivenni Fio-
rentino, che fiori nel i3ie.
A voi , donna , che gente
Sor le tutte altre siete
,
Manda *neo cor fervente
Esto sonetto'^ eh' ora voi leggete
Secondo meo parvente
Digitized by Google
lyS
Senza verun paraggio
In voi s' alluma di beltà lo raggio :
Mante fiate il dico
In vostro belt onore, ec.
Fra Guittone nella Lettera, che nel mioantichissimo Codice è la cinquantesima,
mandando a Pucciandune da Pisa unacerta sua poesia di molti versi , che qui-
vi è scritta ,l’appella sonetto. Dante
stesso osservato dal Bembo nel secondoLibro delle prose
,dopo avere scritta
quella breve canzone, che comincia :
Oh voi , che per la via etAmor pas-sate,
Attendete , e guardate
volendola dichiarare nella Vita nuova ,
soggiugne: Questo sonetto ha due partii
ancorché poi , come dice esso Bembo ,
più volte in quella stessa opera della
Vita nuova , ed altrove , nominasse so-
netti quegli, che ora veramente si chia-
mano. Ne’ miei antichi testi a penna sonappellate con nome di sonetti rinterzati
non solamente la mentovata canzone di
Dante, ma ancora quelle altre due del
medesimo stampate ; una delle quali co-
mincia :
vr
Morte villana di pietà nemicaDi dolor madre antica
•I
/
Qualunque volte , lasio , mi rimembraChe non debbo'giammaiVeder la donna., ondio vo si dolente,
E di più ua’ altra pur di Dante, la
quale non è stampata, ed è la seguente:
Quando il coruiglio degli augei si tenne.
Di nicistà convenne
,
Che ciascun comparisse a tal novella
,
E la cornaccìùa maliziosa e fella
Pensò mutar gonnella
,
E da molti altri augei accattò penne.Ed adornossi, e nel consiglio venne :
Ma poco si sostenne.
Perché pareva sovra gli altri bella,
yilcun domandò V altro : chi è quella ?
Sicché finalment' ella
Fu conosciuta. Or odi che n avvenne.
Che tutti gli altri augei le Jur dintorno.
Sicché sanza soggiorno
La pelar si , eh' ella rimase ignuda,
E t un dicea , or -vedi bella druda;
Dicea r al^ ella muda;
E cosi la lascù^ iìy erarale scorno.
Similemente aeUviai'tùtto giorno
D' uomo , chessi fa adorno
Di fama , o di virtù, ch'altrui dis^
chiuda ,
Che spesse volte sudaDeiraltruicaldo tal, chepoi agghiacciaiDunque beato chi per se procaccia.
Ne* medesimi testi a penna si possono
vedere altri simili sonetti rinterrati di
Nocca di Cenni, di Frediano da Pisa,
di Niccolò Soldanieri
,
e di Francesco
di messer Simone Peruzzi da Firenze,
a’ quali si aggiunga , che Galeotto daPisa ne’ medesimi testi dà nome di -
netto ad una sua lunga ballatella :
S'J-
Un sonetto eo vollio fare
Per laudare
Està mea donrta gratiosa
,
Che amorosaBella gio' mi fa provare, ec.
1 Poeti antichi non solamente -aveano i
sonetti rinterzati
,
ma ne costumavano
altresì certi altri ,che appellavano so-
neUi donni, e potrei portarne qui molti
e molti di Fra Guittone d'Arezzo, di
Geronimo Terrarnagnino da Pisa
,
di
Pannuccio dal Bagno Pisano, e di al-
tri Autori senza nome : e perchè questi
sonetti doppj erano di diverse foggie ,
ne scriverò qui uno per sorta , comeper appunto stanno ne’ miei testi a pen-
na , e con la stessa ortografia ; e da que-
sti si potrà considerare la rozzezza dei
Poeti di quel primo secolo.
iy6
SONETTO DOPPIODI FRA GUITTONE.
O benigna^ o dolce, o preziosa,
O del tute' amorosaMadre del mio Siffiore, e Donna mia,
, O refagio a chi chiama, o sperar osaIJ alma mia bisognosa :
Se tu mia miglior Madre alla in obbriat
Chi , se noti tu,, misericordiosa
,
Chi saggia , o poderosa ,
O degna 'n farmi amore e cortesia
,
Merce dunque-, nonpiù mercè sia ascosa^
!^e appaia in parva cosa :
Che grave in aboiidanza è carestia.
Ne sanaria la mià gran piaga feraMedicina leggiera :
Ma si tutta si fera , e brutta pare,Sdegneraila sanare ?
Chi gran mastro, che non gran piagachera ?
Se non misera fosse ove mostrare ;
Se porca, ne laudare
La pietà tua tanta , e si vera;
Convien dunque misera
,
Madonna , a te , miserando, orrore.
DigiiizTti tay érreogle
7TT
SONETTO DOPPIO
DI rANNUCCIO da;, BAGNO.
Lasso di far più verso V >
Soni poi veggio ogn om mancoD' amor far tutto del diritto inverso
, ^Che qual denom più franco ^Di lealtate
,perso
Tosto fa se veder^ se po, del bianco^ BChe donna , ne converso yNon sol compia, stanco % fDi ciò pensare elfare onde ben perso
ifSicché vertù non branco ,
‘
Pò dire ; anzi P ahberso : ^ ^Leal om sì P a preso per lo fianco ^
Jslealtate , inganno
,
c’ ognor monta, QE lo mondo governa
Sicch' a quella lanterna tvVol gir ogn omo, e in ciòfar si ponta C
Tanto , c oobriaS anno la superna\\
Membranza , dove P onta,
£ ’/ bel eP ogn' om si conta , ^E di ciascuno an merto in sempiterna.
Redi. Opere, ì^ol.I. tz
»7«
SOWtTtO DOPPIO
»’ INCEkTO.
Pér lunga dimoranza ,
Co fatt' an gran tormento
O" cangiata natura ;
Co piangendo allegranza\
E ridendo noi tento
Onni gioì mè rancura ,
jy aver ben o petanza ,
E del mal mi contento
Farmi il di nocte scura ^
Degli amici ò doctanza.
Coi nitnici ò abbento.
Per lo caldo freddura-.
Di quel c’ altri è siguro son temente \
Per gran dogUenza canto ,
Im solaccio rrC attrista ,
Credo aver ben per male.
Ciò c' ò ditto rtì aven certanamente
^
Ma anc ò senno tanto ,
Che , segando mia vista
Mal si -volla semi ale.
Digitizesl-by C^JOglc
Vi ha un’altra maniera di sonetti dop-
pj , che son fatti come quel primo di
Fra Guittone, se non che hanno di piùil ritoroello di cinque altri versi ; ondeson sonetti di ventisette versi. Gli anti-
chi poeti Franzesi, e lo riferisce Monsitde Nublè appresso Egidio Menagio nel-
le Osservazioni sopra le Poesie di Fran-cesco Malerba , usarono la stessa vocedi sonetto nello stesso sentimento di poe-
sia avente più di quattordici versi; tra
i quali Tibaldo conte di Sciampagna inuna canzone da lui fatta per la ReginaBianca di Castiglia madre del Re Luigiil Santo:
Autre chose ne ni a Amour meri
De tant que fay està èn sa baillie.
Mais bien m'a Diex par sa pitie gari^
Quand eschappè je suis sans perdre vie
One de mes yeux si belle heure ne vi.
Sen oz ye faire encor maint geni parti.
Et maint sonet, et mainte recordie.
E Guglielmo de Lorris , che mori l’ an-no 1 260. nel suo romanzo della Rosa :
Lais d'amours, et sorteti courtois.
Pel contrario i migliori Scrittori dellaFrancia affermano, che prima del regnodel Re Francesco I. non furono mai ve*
diiti sonetti di quattordici Tersi in ìin«
gua Franzese.
Nello stesso tempo , e non prima co-
minciarono simili sonetti in Spagna, ed
il pi imo che ne facesse fu GiovanniBoscano da Rarzellona, e con lui Gar-
tilasso de la di Toledo, che fio-
rirono ne’tempi uelTlmperator Carlo V.
e Botcano vi fu indotto dalle esortazio-
ni del celebre Bernardo Nuvoffiero, co-
me esso Boscano afferma nella Prefa-
zione diretta alla Duchessa di Sommanel principio del secondo libro delle sue
poesie stampate in Barzellona l’ anno1642. I Tedeschi per avventura nonprima del corrente secolo praticarono
3uesta appresso di loro nuova manierai ]ìOesia , e vi sono stati applauditi
Martino Opizio Siicsita, Andrea Grijio^
ed il F/emminffio. Tra’ Fiamminghi il
primo sonettatore forse fu il celebre Da~niel Einsio padre del dottissimo iVrco/no
Einsio,
Donde poi sia originata la voce so-
netto, vane sono sUte le opinioni degli
Scrittori. Il sempre con lode mentovatoEgidio VIenagio nelle Origini della lin-
gua Franzese tenne, che il nome di so-
netto abbia l’ etimologia dal suono, cherendono le doppie rime de’due quader-nari ; e sono (|nest’ esse le sue ))arole :
sonet du son ,que font let doublts n-
m^s dtp deux premiers rpiadiains. Temo
Digitized by Google
t8t
fbrte ,ctie questo gran ìettefàto , e mio
gentilissimo amico, non cogliesse allora
tael vero segno ; e tanto più , elle egli
stesso nelle Origini della lingua Italiana
fu di un altro pat ere , e si conformò
«ol sentimento di Lodotico Dolce nel
lib. 4. delle sue Osservazioni, e con Fe*
derigo Ubaldini. La verità è , che gli
Accademici della Crusca nel Vocabola-
rio della Seconda edizione alla voce suo»
no vollero, che sonetto sia derivato dasuono inteso nel significato del quarto
asterisco della stessa voce, dove si spie-
ga suono intendersi per le parole , o
canzoni, che si cantano in sul suono;
e ,dopo essersene portati esempli del
Boccaccia nelle Novelle, e dell Autore
della Tavola Ritonda , si soggiugne :
Dalla qual voce suono creder si può
che venga sonetto per esser breve com-posizione. Agli esempli del Vocabolario
si può aggingnere Fra Giordano da Ri-
valto, che in una delle sue prediche ci
lasciò scritto; Avea composto un suono
scandaloso,
e pieno di profanità e di
lascivia. Il Vocabolario vien fiancheg-
giato dal suddetto Federigo Ubaldini
nella Tavola delle voci , che si trovano
ne’ Documenti d’Amore di messer Fran-
cesco Barberino. Come abbiamo , dice
riJhaldini , da motto mottetto , così so-
netto è diminutivo di suono,pigiando
suono per una sorta di cantare : onde il
Boecaceio chiama tuono quella carne-ne , che fece Mica da Siena al Re Pie-
tro d'jdrragona per la Lisa, che è di
ben tre stanze, ciascheduna di dieci versi
senza il principio, E Franco Sacchettidisse :
Che si cantasse , o suoni, o madrigali.
E nel Laberinto Vistesso Boccaccio c. 'jm.
canzoni, suoni e mattinate, o simili piùche altra volentieri ascoltava. Cosi dun-que da suono è sonetto, e da mottomottetto. Fin qui l' Ubaldini: ma vagliail vero panni , che egli prendesse unosbaglio, quando disse, che il Boccaccionella Novella settima della decima Gior-
nata chiamò suono ciucila canzone di
AJico da Siena. Poiché non ho saputo
rinvenire , che la chiami con altro no-
me , che di canzonetta e di canzone.
Minuccio partitosi ritrovò un Mico daSiena assai buon dicitore in rima a queitempi , e con preghi lo strinse a far la
canzonetta che segue. £ appresso: E conlei sola parlando ogni cosa stata rac-
contò , e poi la canzone cantò con la
tua vivuola. E quando Minuccio dice al
Re: E non sono ancora tre giorni, chele parole si fecero e 7 suono
;per le
Savoie significa la canzone composta da[ico, e per 1* suono la musica, e l’aria
accomodatavi sopra da lui medesimo, il
. tDigitized by Google
tSS;
Sual« finÌMÌm» cantatore • tonalore era.
qui il Boccaccio imitò i Provenzali
,
cbe aneor essi talvolta si valevano della
voce suono in significato dell' aria del
canto. Giraldo di Borncllo in una delle
sue Serventesi , che comincia : HonmzOS hom per despendre^ in fine di essa
Tolgcodosi a lei dice:
Servente^ , tal sap ton son^
Qui no enten ta raion.
E Raimondo Giordano Visconte di San>
tantolino , cbe da Alessandro Tassoninelle Note al Petrarca fu chiamato Re-mondo lorda y e fiori ne’ tempi di Rai-
mondo Berlingbieri conte di Provenzay
e di Folcachieri , in alcune Ottave alla
maniera Provenzale , cbe cominciano :
yas vos suppèei donna primeramenty par
cbe dica insonare i motti per quel che
disse il Boccaccio intonare le parole y
ovvero mettere in musica un componi-mento y se non vuol dir piuttosto ean*
tarlo e sonarlo :
Ar conosc ben, feu fai grand ardimm,Quant ia l entfuier damary ni mot l en
so.
Tnttavia dei>bo giustamente affermare|
. cbe la voce suono fu usata ancora da*
Provenzali in siguificato di quc* campo*
1
ì64nimenti che si cantano in sul anono
,
. come si può Tcdere nelle •vite de’ loro
Poeti , e nelle loro opere. "Vita di Ric-cardo Berbesin: Mas ben cantava, e di-
. sia Sons ,et trokava avinemen motz et
Sons. Pietro Bremoute :
Cant, es raison, bos sos, et lausengiers.
Il soprammentoTato Visconte di Sant'An-tolino :
Serventes, motz et sons
En la onor dirai de luy.
Vedi sopra a Mottetto. — E tanto basti
intorno all’ origine della voce sonetto.
Dirò solamente , che negli antichi testi
a penna in tre modi si trovano scritti i
sonetti. Nel primo modo si trovano scritti
seguitamente, come se fossero prosa, sen-
sa far nessun capoverso; e distingueva-
no un verso dall’ altro col farvi duepunti di mezzo. Nel secondo modo era
scritto il primo quadernario dipersè an-
dante tutto insieme , come se fosse pro-
sa; e dipersè parimente il secondo qua-deimario , che faceva capoverso , c cosi
ancora tutt’ addue le terzine ciascuna
dipersè. Nel terzo modo eia scritto il
primo ed il secondo verso del sonetto
nella prima riga tutt’ andante ,il 3. ed
il 4 . verso nella seconda riga, e così a
Digitized by Googli'
i85coppia a coppia tulli quegli altri versi.
• Chi avesse curiosità <li sapere la manie*' ra, e la diligenza dello scrivere i versi' de* Greci negli antichi testi a penna leg-
ga Efeslione ff amatìco nel suo Enchiri-
àio al cap. vtpì (ri^y, xó?>v, xóiifiarof,
xa'i ffvi;T*niaro(
,
dove aflerma , che nel
secondo e nel terzo Libro delle canzonidi Saffo, la maniera della scrittura era
tale, che si vedeano versi della stessa
misura a due a due uno dopo 1’ altro
,
ed ogni coppia dipersè distinta dalla se-
guente. Veggasi quivi.
Osserva il Bembo nelle Prose, che gli
antichi fecero tal volta sonetti di duesole rime. Talvolta in emenda di ciò
non contenti delle solite, e usate nel li-
ne de’ versi,quelle medesime rime an-
cora tramisero nel mezzo di tutti i ver-
si. De’ cosi fatti in un mio manuscritto
ve ne sono molti di Guitton dArezzo ,
e di ser Pace Notajo
,
e alcuni pochi
di messer Jacopo Mostacci da Pisa, di
Galletto da Pisa, di messer Lapo Sal-
terello, di messer Giovanni dArezzo,di Dello da Signa , di Ugo da Massadi Siena , di Amorozzo da Firenze, e
di alcuni altri, che non contenti di unasola rima nel mezzo, ve ne misero lino
in due, ed anco lino in tre, alla foggia
quasi di quei sonetti Leporeambi , cheagli anni passati furon fatti stampare in
Koma da Lodovico Leporeo. Egli è bea
i86Tero , che alcune fiate non in tutti i
mezzi versi trametteano le rime; ma so*
lamenle in quelli delle terzine , comene può esser esemplo un souelto di FraGuiUone , che comincia :
*
O Regina del cielo , o giglio aulente ,
Madre e figliuola del figUuol deDeo^Abbie pietate del tormento meo
,
Mira in la zambra dC osto cor dolente^
Verone pura, che fosti possente
Speziar la fronte al fiero verme e reo\
De soccorrimi tu , ec.
Ed alcune volte tramettevano solamentele rime ne’ versi delle quartine del so-
netto , senza trametterle in quegli de*
terzetti. Per un esemplo di quegli chehanno le rime tramesse in tutti i versi
potrà servire il seguente sonetto di Puc-
dandone Martello da Pisa copiato per
appunto nella stessa forma, nella qualesta scritto in un mio antichissimo teste
a penna in cartapecora:
Similemente . gente . criatura .
La portatura . pura . ed avenente .
Paite piagente . mente.per natura .
Sichen altura . cura . vola gente •
Callor parvente , nenie . altra figura .
Non a fattura . dura . certamente .
Pero neente . sente . di ventura .
Chissua pintura . scura . no presente.
Digitized by Google
Tanto dohìata , data . vè beliessa .
E addomessa . messa . con plagensa.
Cagna chei pensa . senso . peimirata.
Peto amata . fata . vonnaltessa .
Che la fermessa . desso . conoscensa.
In sua sentensa . hensa . onorata .
Si osservi , che questo sonetto di Puc-ciandone è scritto secondo la pronunzia,
o dialetto Pisano; e si può da esso rac-
cogliere , che siccome ne' nostri tempiquelle voci , che hanno la z , son pro-
nunziate da’ Pisani come se avessero la
8, e quelle, che hanno la s son pronun-ziate come se avessero la z , cosi ezian-
dio anticamente i medesimi Pisani avea-
no la stessa pronunzia , o dialetto mo-derno. Ad un’ altra cosa è da porsi
mente intorno a’ sonetti; che i Poeti an-
tichi non facevano sempre i sonetti d^
quattordici versi ;ma talvolta ne face-i
vano qualcheduno di sedici, ponendovidue versi rimati , come nel line delle
ottave, dopo i quattordici,per appunto
come si è quel soprammentovato sonetto
di messer Francesco Barberino ed altri,
che si leggono ne' miei manuscritti , e
particolarmente uno di Dante, che co-
mincia :
Jacopo, io fai nelle nevicai' alpi
Con tjuei gentili, donde nata è quella,
dì amor nella memoria ti suggella :
i88E perchè tu parlando anzi lei pdlpi
;
Non credi tu, pereh' io aspre vie scolpii
Ch'io mi ricordi di tua vita fella! ec.
Ed altri di Passera della Gherminella ^
e di Guido Orlandi , di Fazio degli
liberti, di Maestro Antonio da Ferra~
ra , di Franco Sacchetti
,
ili Gano di
messer Lapo da Colle , di rnesser Dol-ciberie
,
di Ciscranna Piccolomini daSiena, di Niccolò Soldaweri
,
di Mae-stro Migliore da Firenze
,
di Pippo di
Franco Sacchetti, òìAdriano de' Fossi y
di messer Antonio da Siena , di Brac-
cio Bracci d'Arezzo, che fiori iie’teinpi
del Petrarca, di Marchionne di Matteo
Arrighi, di messer Guido della Bocca ,
di messer Arrigo di Castruccio
,
di An-
drea di messer Biado de Bardi
,
e di
I
quel Sandro_di Pippozzo df landra cit-
tadùw fiorentino , il quale nel 1299.
! nHIultiina sua rimbarbogita vecchiaja
1 compose un Trattato del governo della
\\/amiglia, del qual Trattato io feci men«i zione nella Lettera intorno allinventore
i degli occhiali che si portano al naso }
[e di molti e molti altri, clie si leggono
nel Libro de’ Poeti antichi raccolti da
Monsig. Allacci, e vissero nel tempo
del Petrarca, e dopo ancora la di lui
morte. Il Petrarca stesso fece alcuni di
questi sonetti di sedici versi , ed in tmmio testo antico se ne vede uno
, che
Digitìzed by Gopgl
i8^e^1 i mandù in risposta a Maestro- Antò-mo da Ferrara, c comincia:
Perchè non chagi nelle schure chaveDove t animo tuo par che vaglile
Piacemi di prestarti alchune stille
Di mio secretto fonte piu suave.
Crede Federigo Ubaldlni, che, dal nonesser bene ancora in fjue’ tempi prefissa
la regola del sonetto, i Poeti mettesserotalvolta a capriccio nel fine que' dueersi rimati ; e saviamente so^giugne
,
•che tali sonetti di sedici versi fossero
piuttosto sonetti familiari, c da scherzo,
che da senno, e gravi : e va opinando,che da essi abbian forse avnt’ origine i
sonetti con la coda, de’ quali si crede,che non ne facesse mai alcuno il Pe-trarca, perchè, come soleva dire il Com-mendatore Annibai Caro , dovean gire
alla presenza di Madonna Laura, che
era una damigella molto savia e mode-sta. Non voglio tuttavia tralasciar di di-
re , che quel sonetto stampato del Pe-trarca , che comincia :
Benedetto sia ’/ giorno e ’/ mese er anno
In un testo a penna del sig. Conte Lo-renzo Magalotti copiato intorno al 1481.si trova scritto colla coda seguente :
igoE non fona , nè arte
Farà, ch'io non sia suo buon servidojVf
E sempre mai terrò lei per signore.
Ma dubito, che tal coda non vi $ia sta-
ta appiccata dal copiatore, il quale peravTcntura fu Filippo Scarlatti Poeta,che liorì in que’ tempi. E tanto più nedubito , anzi lo credo
,quanto che in
tutti i manuscritti della Libreria di sanLorenzo , e della famosa Libreria delSenator Carlo Strozzi quel sonetto si
trova sempre scritto semplicemente sen-
za la giunta di quella coda ; siccomesemplicemente si trova scritto in alcunialtri testi a penna della mia Libreria.
Fece bensì il Petrarca de’ sonetti di di-
ciassette versi tutti di undici sillabe, unode’ quali si legge nel suo originale stam-
pato dAÌV L/baldini in Roma 1 anno 1642.
in foglio appresso i Grignani. Tali so-
netti di diciassette versi gli antichi gli
appellavano sonetti col ritornello , e netrovo molti ne’ miei testi a penna , eparticolarmente di Pannuccio dal Ba-gno , di Gerì Giannini Pisano , di Na-taccio Anquino Pisano^ di Passera del-
la Gherminella , e di messer Giovanni^Arezzo., senza quegli altri Poeti più
moderni stampali a&\VAllacci, e sono di
Borscia da Perugia , di Cucco di Fal-freduzio , di ser Filippo degli Albizzi ,
di Giglio Lelli, c del Burchiello', e non
Digìtized by Google
'9 '
solamente trOTO di cpiesti sonetti col ri-
tornello ^ma ne’ miei mannscrìtti ue tro*
-vo ancora di quegli col ritornello dop-
pio ,cioè sonetti di venlt versi , e tutti
di undici sillabe.
Veramente ebbe ragione VUbaldini acredere ,
che ne’ primi tempi non fosse
prefissa la vera quantità de’ versi del
sonetto ;imperocché tra’ manuscritti io
ne considero anco di quegli , che sono
quindici versi in Niccolò Soldanieri, in
Francesco di messer Simone Peruzzif
ed in un Autore incerto , che compose
otto sonetti sopra le immagini di otto
uomini illustri dipinti nella sala del ReRuberto di Napoli. 11 mentovato Nicco-
lò Soldanieri fece altresì de’ sonetti di
diciotto versi, come ancora Dino di Tu-
ra Bastafo j e molto prima ,di costoro
Bacciarone di messer Saccone da Pisa^
Giovanni Marotolo ,messer Benuccio ,
e Bindo Bonichi da Siena manuscritti;
e tra gli stampati daH’Allacci ser Filip-
po degli Albizzi , tra’ quali stampati
Cucco di Valfreduzio ne lasciò compo-sto uno di diciannove versi pur tutti di
undici sillabe. Pel contrario ne’ manu-icritti si vedono sonetti di soli tredici
versi, e de’ simili io ne ho esempli di
Forese Donati , che fiori ne’ tempi di
Dante ; di messer Giovanni da Prato,
di messer Alberto degli Albizzi , e di
Andrea Carelli da Prato, lo Fra Gaie-
192tane tì sono sonetti, che inrece dì ayerquattro versi per quadernario
, ne han-no cinque, rimanendo le terzine al so-lilo con tre versi per ciascuna.
Quanto a’ sonetti colla coda , cioèquelli che sono di diciassette versi , il
quindicesimo de’ quali ha sette sillabe ,
e gli altri tutti ne hanno undici, i piùantichi Poeti , che ne’ miei mauuscrittiio trovi , che gli componessero
, sonoPierozzo di Biagio di Strozza Strozzi ,
che fiori nel i38i. nel qual anno fuImhasciadore de’ Fiorentini a Verona, efece poscia molle altre simili imbasce-rie, come a Perugia, a Città di Castel-
lo, a san Miniato, a Cortona, a Geno-va , a Bologna , a Padova ed a Siena ;
e nel i3g4. fi\ Podestà di Arezzo, e fi-
nalmente mori in Firenze nel 1408. Aquesto Pierozzo aggiungo Niccolò Sol-
danieri ,Tommaso de' Bardi
, MaQeode Libri, messer Bruzzi Visconti, Fran-
co Sacchetti , Antonio Pucci , ser Do-menico Salvestri, Adriano de'Bossi, ser
Piero da Monterappoli , Marchione di
Matteo Arrighi, Stefano di Cino , Ma-netto da .
Filicaja ,Filippo de' Bardi
,
Dante da Votterrà , messer Marabutti-no dCArezzo , e Ottavante Barducci. Eperchè non ei’a ancora ne’ primi tempibene stabilita la forma de’ sonetti colla
coda,perciò in un mio manuscritto ne
trovo alcuni pochi di Autore incerto ,
-Digillzed by Coorte
i qaali, dopo i quattordici versi di ua-
dici sillabe , hanuo il verso «li sette , e
dopo di esso quattro altri versi di uu-
dici sillabe. E tra’ Poeti di Monsig Al-
lacci non solamente se ne legge un si-
mile di ser Angiolo da san Gimiguano,ma vi sono ancora sonetti di Gillio Lelli
colla coda , aventi diciassette versi, chehanno il sestodecimo di sette sillabe, e
tutti gli altri sedici versi di undici sil-
labe. I primi inventori furono costantis-
simi a non passare i diciassette versi
,
cioè a farvi una sola coda di tre versi.
11 Burchiello, che fiori nel 1480. fu dei
primi a passar questo segno , e quegli
che vennero dopo di lui , molto più di
lui lo trapassarono, e si stesero in mol-
te lunghe filastrocche di code. Quantun-que i sonetti colla coda sieoo per lo più
burleschi e familiari , nulladimeuo i
primi compositori ne fecero qualcunointorno a cose serie; ed un mio testo apenna ne ha ventotto tutti sacri di Au-tore incerto , ed in un inanuscritio del
sig. conte Lorenzo Magalotti ve ne so-
no di Feo Beìcari, e di Banco di Ben-civenni da Firenze. Gli antichi sonetla-
tori solevano alcupa volta con ischerzo,
per cosi dir puerile , con la prima let-
tera de' versi del sonetto accennare il
loro nome , o quello delle innamorate,
o altra cosa , che più loro fosse sudataRedi. Opete. Vol. /. . td »
I
‘ a grado , come si può vedere in quelsonetto , che Dante da Majano scrisse
per risposta a Monna ?iina stampatonel testo de’ Giunti a car. 140. e osser-
vato dal diligentissimo Ubaldini; e co-
me io ne osservo altri di simil narra ne’
manuscrilti aiiticlri \ e potrei protlurne
esempli di Dello' da Signa , che Dellodella Signa è nominato neiriiidice stam-
pato da Monsig. Allacci de’ Poeti ailli-
chi ,che si conservano ne' codici Vati-
cani ,Chisiani e Barberini , di Alberto
Frate , di liosso da Messina , e di al-
tri. Questa fanciullaggine la trovo an-cora in alcune (Joble ' Provenrali. Mache ? Talvolta ha servilo a prodnrrequalche noliria. bd in verità , che oggi
non «apremmo forse, chi fosse rmuWredell’ antico Fnlgar izzamento di Hasisconservato nella làbreria di s. Lorenzo
al Banco settantatrè , >se alcuni- Tersi
, scritti nel fine del Cotlice non ciimaiii-
feslassero , che egli fu sere ZuccharoBencivenni
,
conciossiacosaché colla pri-
ma lettera d’ ogni verso viene scritto il
- di lui nome nella seguente maniera :
Zertanamente vi dtcov%'ollio esser vostro amico ,
Ke Ke di me voltiate;
'
. . e non f>uò f amistate
rimaner tra noi due ;
I or *utn vi dico piue.
Digitized by Googic
Ben volilo in veritade
,
entra noi t amistade
non 'volilo ,che falli punto
con fino amor congiunto
intra noi due dimori :
villania ne sia fuori,
e ogne malusanza’.
non volilo ci abbia mancanza :• •'
non fa mestieri, più dire:
Io son vostro al ver dire.
Elia CaJanetto volle anch’ esso scherzar
colle lettere ,onde
,come si legge nel
testo a penna della Libreria di sau Lo-
renzo : . ' '
Tres letras del a, b. c.
Aprendez : plus non deman :
A. 'V/. 'A car aitan
Uolon dir, com am te.
I ,
Termino cpiiesti uojosi rancidumi , de*
cjuair”vòglio sperare, che mi abbia^ad
frnpelral’ perdono" raiincliita senipiejg^
"hérabìTèJ an^' nelle "co^ frivole,. E.-
forse di essi potrà valersi qualche va-
lentiiotno per dar lustro a qualche sua
scrittura;perchè queste colali cose, co-
me certi pezzi d^ anticaglie ne’ nostri
edifici tramesse , con altri ornamenti
moderni con giudizio:, e con modo-, e
Come graziosamente .disse quella giova-
ne Greca' tanto celelu'ala nelle poesie ,
ig6seminate colla mano , e non col sacco
,
danno grazia.
Pag. 14. V. 29. Fiori scambievoli’ Fiore in questo sigiiilicato si è un
breve scherzo in rima, che si costuma
nelle veglie , e ne’ balli del contado , ecomincia : Foi siete un bel fiore , a cui
vien risposto: Che Jtorel ec. Lo scherzo
è noto , e l’ usanza di questo schérzo èantichissima , e se ne fa menzione in
una poesia manuscritta di ser Bello an-
tichissimo Poeta:.
Quando eo ve dico Fai sete una flore.
Ne pur alzate li occhi a spuardar me ,
Ne volliate saper, che bella flore ,
E con silenzo mostrate odiar me.
In un Libro scritto 1’ anno i5g2. dove
tra l’altre poesie son copiati molti fiori:
P. Foi sete un bel fiore.
R. ( he fiore ?
P. Un fior di mammoletta.
R. Qualche mercede il mio servire a-
spetta.
rag- i5. V. 4. MammoloE una s|>ezie d’ uva rossa notissima
nel contado di Firenze. Mammolo vale
ancora bambino , fanciullo,
giovanetto.
Pecor. giorn. 10. uum. 1. Tolse segreta-
Digitizcd.by Gopgic
tminte questi mammoli, e andonne alla
marina (parla di due bambini di na-
scita. ) È appresso : £ poi mandò perquesti due mammoletti. E giorn. num. x.
La mammola ebbe paura , e disse : io
noi farò più. E giorn. 4. num. 2 . Forse
la mammola non se ne contenterebbe.
Parla sempre di fanciulle da marito.
Di qui ebbe etimologia il nome delle
\mle mammole. £ mamfnolo in signifi-
cato di bambino ebbe origine da mam-ma, o mammella', quindi gli Spagnuoli
hanno ancor oggi la voce antica ma-rnante, che vale bambino che latta; c
se ne servono per esagerare qualchemoria di guerra , o di peste , dicendo j
No quedara piante , ni marnante , cioè
come dice don Sebastiano de Covarru-
vias nel Tesoro della lingua Castiglia-
na: No ha de qnedar cosa viva.
Pag. i5. V. g. Onde f antico EsoneDiè nome e fama al solitario monte.
Allude a Montisone , dove in tempodi state fa la sua villeggiatura il signor
conte Lorenzo Magalotti
,
ed è unamontagnuola, nella quale ha la sua sor-
gente il fìumicello Antella , che dà il
suo nome al paese,per lo quale passa
fino a mette!' foce nell’ Emai JacopoSoldani nella Satira a Motisig. Venturicontro il lusso de’ suoi tempi :
igS
\ Se fosse più magnifea la villa «
La qual mi porge bere al puro fontoLe lacrime dolcissime <C ntiUq
;?
O Monsignor, con quanta allegra fronteV' accorrei qui, doye Tj^tiaa—RsijqeDiè nome e fama al solitario montel
5Così pariraeme scherza sul nome dL
\monte Senario Andrea Dazji Lettore
• delle Lettera Greche nello Studio dt Fi-
'irenze, chiamaudolo monte Sinai, quasi
da Sinai fosse stato detto Sinaju, e poi
corrottamente Asinajo , come lo nominòil Boccaccio nel Proemio della quartaigioroata :
Perpetua stai mole rigens , et vertice
celso
AEtherias sete Synais mons tollit inauras ,
Cujus in extremo cingentibus widique
sylvis
Christiparae stani tempia jngo.
Simile altresì il Ronsardo, ncU'Inno di
Pacco , scherza sopra una collina del
paese di Vandomo sua patria, chiamata la
Deiiisìere, quasi ella fosse cosi chiamata
da Denis, cioè Dioniso, ovrero Bacco :
j£f Id ta main proigna urie haute coutiere^
iQui de ton nom Denis eut nom la De-• nisiete.
Digitized by Google
Pag. r^/T. il. Questo nappouna pozzanghera
che sembra
Ateneo ,libro undecimo disse , che
non gli sembra che dicaa male quegli,
che a un gran bicchiere danno il nomedi }iozzo d’ argento juù, pos Soxovtn /te»
,
ytiv ov xaxóf , ol (pàffxovxsi xò ptyaxairipiof (pfiéap. àprvpov* tlvat.
vin si forte ^
e si possente»
Orazio:
' Aufidius forti miscébat mella Falerno.
Nel Maestro Aldobrandino , e nei Libro- della cura delle malattie si trova soven-
temente questo epiteto di forte dato al
•' vino in signiHcato di vino grande e ge-
• nerosn. E ueil' antichissimo Trattato ma-nuscritto delT Intendimento si- legge: Il
peccato di lussuria , che è spento perastinenza e per asprezza, le buone 'vi-
• vande e i firti vini lo accendono^ Oggiin Firenze tra ’l popolo vin forte' ai dice
del vino che ha pigliata Ja panta,.cioè,
che ha cominciato a inacetire.; mai tra
gli Aretini vin forte vale lo stesso chevino puro, e non innacquato', o' coode
-• assi dicono, non indacquato.. . j. <ii -1 ;»-»
,i !it
•
Pag. i5. T. i5. Quoti ben gonfio, e rapidatorrente
Urta il palato
Orazio disce , che i Tini orgogliosi apotenti assordano il palato, quasi comeuna grossa e romoreggiaute piena :
r
. Peri’ida quod suhdjle eccucdant vino pa-
\ l„mn,. ^jPag. i 5 . 22. Verso T occhio del sole
È cosa trita , che da’ Poeti sia attri»
huito l’occhio, che tutto vede, al sole;
e ne sono esempli in Omero, in Eschi-
lo , in Ennio ed in Virgilio. PindaroneirOlimpie, ode .3 . strofe 2. dette l’ oc-
chio alla luna ; Catullo attribuì il ve-
dere alle stelle; ed è nolo il Greco epi-
gramma di Platone sopra Stella amicosuo riguardante il cielo , in cui esso
Platone desidera di esser cielo, per po-
ter mirar 1’ amico suo con più occhi,
Pag. , 5 . V. 22. Il fianco innalza
Catone, citato ancora da Plinio, par-
lando del sito delle vigne : Qui locus
vino optimus esse dicetur , et oslentus
solibus.
Pag. i 5 . V. 27. Ed io lui sano preseri’o
Mnesiteo citato da Ateneo lib. 1. af-
ferma , Bacco in ogni luoga chiamarsi
—Digiti^ed h
2©I
medico, e che l’oracolo di Apollo Del-
fico ordinò ad alcuni , che invocassero
Bacco col nome SHyf^te ^ cioè di con-
servatore della sanità, drò xat xaXtlff^at
TÒv dtóvt «TO» srarrajijow larpòv. ^ Si Wvdì
ti/nixé Tin Siófveov vytdrtiv *«Astv. Al-
tro oracolo fu riferito da Fulvio Orsino
nel suo Virgilio illustrato sopra quelle
parole frigus opacum dell’ egloga primajn due versi greci ,
che da Gabbrielo
Faemo cosi furono voltati in latino:
Vigiliti ante canem , totìdem post ordì-
ne luces
,
Umbrosae intra sepia domus modico
lUere Baccho,
Elia di Berzoli, manuscritto Frane. Redi;
^ra pose eu estar alegres e jojos ,
Bacch adolza medesia mi maL
Pag. i5. V. ult. Ma del via di vai di Botte
Possessione de’ PP. Gesuiti del Colle-
gio di Firenze.
Pag. iG. V. 7 . Il mio Sahiin eh' ha tante
lingue in bocca11 sig. Anton Maria Salvini gentiluo-
mo Fiorentino Lettore della lingua Gre-
ca nello Studio di Firenze , oltre unavasta e recondita erudizione
,possiede
ancora le più celebri lingue dell’ Europa.
\
Digìtized by Goov \^ii
202Pag. 1 6. T. lo. Con la ciotola in. man Jard
miracoli
Macedonio nel lib. 2. »lel l'Antologia,
colla giiaslada in mauo non ha jiaiira
de’ signori , o di ijiialsisia grande:
ovd' àXtyiio%òv j(^ptxriuy vndrov , (pid^i^v xa~
che Geraldo Buchohl tradusse :
Ref;cs
Non moror auratos poetila piena tenens.
Pag. i6. V. 1
1
. Co splendor di Milano il
savio Maggi11 sig. Carlo Maria Ma^ segretario
del Senato di Milano, Professore di Let*
tere Greche nello Studio di quella cit-
tà , Poeta celeberrimo del nostro secolo,
e mio riveritissimo amico, il quale puòfrancamente dire con Lucrezio ;
y4via Pieridum peragro loca nullius ante
Trita solo
E con Orazio :
- Libera per vacuum positi vestigio prin-
ceps ;
Non aliena meo pressi pede.
Digìtized by Google
2o3
Pag. i6. V. ao. E sarla veramente un capi-
tnnoj. n?
^
iSaturale77a imitata (ia qaella di Plau-\
' to Del Penulo, at. 3. se. 3.
Rex sum ,si e£;o illum hodie hominem
ad me attenterò. a ’) <,
Pac. i6. V. ai. Del suo Lesmo il vino
” Lesmo, villa deliriosa del sig. Carlo
Maria Maggi poste nel Milanese.
Pag. i6. V. a6. Con le gote di mosto e tin-
te e. piene * .
*
Cosi il Dio Como presidente de ba-,
gordi e dell’ ubriachezza , onde è hittoi
il verbo nopàittv, in latino corr^ssan,.
se si crede Fiìostrato ne Ritratti , e di- •.
pioto dal medesimo, rosso dal- vino ;
ipv^pòi iirò èhv. E Bacco era rappre-•
sentato con le gote rosse, e come tinte; .
e i Satiri, greggia di Bacco, son riti atti
« dallo stesso Filostmto èpvZftol , nai os-
injnótie. Vermigli in viso, e ca*'! sma- jlj
scel latitisi per le risa ,che tutti i denti
j j
• si potrebbon lor trarre. > ' "’
,*
Pag. i6. V. ay. Il pasfor de Lemene I
11 sig. Francesco de Itemene gentil-
uomo ijodigiano, e celebre Poeto del
nostro secolo , come chiaramente , '.fra
r altre suo nobili Opere ,fa. conoscere
il Libra intitolato Iddio stampato In Mi-lano l’anno 1684. in quarto.
Pag. 17. V. 6. Il purpureo liquor del »uobel colle
La collina Hi san Colombano nel ter-ritorio di Lodi abbondantissima di ogniaorta di frutti, ed in .spezie d’ura e difichi dove il sig. Francesco de Itemenesi ritira nell' autunno. Quivi, tia gli al-tri vini, se ne fa un rosso, il quale daipaesani si chiama Pignuolo
, e per la\ soavità e per la generosità
, secondo il
I giudizio di ess i paesaggi, è creduto pò-t tere stare a tavola ritonda con ogni al-' Irò vino d’Italia.
Pag. 17. V. fz. La VernacciaVendemmiata in Pietrafuta
Parla della Vernaccia di san Gimi-;nano , i pregi della quale son molta>en noti in Toscana.
17. V. 16. Fu^a via dal mio cospettm
Il Chiabrcra :
'V
S" alcun giudice strano
Divulga altra sentenza,la mia presenza^
Digilized by Googli
3o5Pag. T. 17. E per pena sempre ingozzi
l^in di Brezzi f di Quaracchi e di Pe-retola
Simile è quello che Ermippo citato daAteneo lib. i. fa dire a Bacco, il quale
!
dando pregio di l(KÌe a un ' certo vino'
odorosissimo chiamato Sapria couchiude,'
che di questo bisogna darne a bere nei’
banchetti agli amici suoi; ma a’ nemicivuol che si dia del vino di Pepareto ^
che dovea essere un viu debole e cat-
tivo :
Tovt» ipii irapé^eiv Jtivti* iv x^oij
ToiffiP ipoiai (piXoK xoh; B’ kj(PpoÌi i*^
vtxapiq^x.
E per ap]K>rtare un esemplo d’un modernoautore ; Boileau Satira d. nella liue :
)
Je consens de bon coeur,
ppuzL punir I
ma folie ,
Que tous les vins pour moi deviennent \
vins de Brie.
E veramente il vino di Brozzi, di Qua-racchi e di Pereto)a è vino di vilissimo
prezzo. E questi sou villaggi del pianodi Firenze , in vicinanza de’ quali si
trovano le villale di san_ Domnino e di[
pecore, e tutte insieme proverbialmente|
2o6I
sou dette le cinque terre di Toscena, a)[
distinzione delle cinque terre del (ìeno- '
Tesato , che producono vini mollo pre- (
ziosi. La sentenza data dal Collegio de-,
r gii' Osti in Firenze contro agli Accade^ t
mici della Crusca l’anno ihgS. in una ,
, Cicalata dello 'nferif'tio , fatta in occa- •
sione del solenne stravizzo di detta Ac-'
cadeinia si è questa : t'iiìalmente, dopo
lunghe dispute , riepilogate più d’ unavolta tutte le cose , risolverono , e sen- !
tenziarono , che mai a, ninno di nostra >
brigata , che. capitasse loro alle mani
,
^
non fosse dato altro vino, che di quello
delle cinque Terrai e si cercasse 'anco •
ilei peggiore, e che sapesse di botte, di
secco , di muffa , di le.no , di cuojo ,' di
marcorella ; e fòsse ribollito , e cercone,,
e più fiorito che aprile e maggio, e que-
- sto sotto gravissime pene fu a tutti co-
mandato ,ec. Del resto, il sopraccitato
Ateneo nel lib. io. fa menzione d’ unLeveraggio ilato per pena. E questo era
quando ne’ conviti si proponevano col
vino in tavola gl’ indovinelli : chi gli
scioglieva aveva delle carni un pezzo
di più;chi non gli scioglieva era fatto
ingozzare -un bicobier di vino mescola-
tovi aceto e sale , con chi si marinava-
no i pesci; e lo doveva tracannare sen-
za ripigliar tìnto. Hei' confermazione cita
un certo Antijane nella favola intitola-
la Ganimede, E simili, peue > come il
Digitized by Google
Io7• bere una biioil* giiantiti d’acqua, se-
condo Esir.hio> rderilo dal Casaubono
- lib: II. caj). ib si doveaii praticare ia
. tal giuoco degl’ indovinelli, dagli -anti-
' chi' chi.imali Griphi. <’ 11 Berni- per una
tal pena di bevanda :' •
Datepili a bere a pasto acqua di vite. T
Pag. 17. . 18. J^in di lìrozzi
Lr' etimologia di bro/zi la somministra
il Ferrnrì. (Uiesti dando T origine della
voce Breda ,colla (piale i Lombardi, e
particolarmente i bresciani chiamano il
contado vicino'ulla città, incidenteinen-
• te viene a dare quella di Brozai, o per• dire , come dice egli ,
di tìiozzo ; per-
ciocché stima, che quando il Villani da
lui a tal proposito citalo nel lib. 9. dice
n. bando campi, brezzi e tutte le filiate
iV intorno , il Villani non abbia voluto
intendere nomi piOprj di VÌllato,«o di
altri luoghi,de’ (piali uno è chiamalo
Campi, e 1’ altro Brozzi , ma abbia vo-
luto intendere campi generalmente col
nome di campi ,e poderi col nome di
brozzi ; il qual brozzi egli origina da
piacdinm, e praedium essendo stato gua-
sto in bradium ; e ne cita gli statuti di
Padova;può esser benissimo stato tras-
formalo 111 brazzo , e poi in brozzi, sio
come ,dico io , da medium , si è fallo
mezzo con moltissime altre voci toscane.
io8nelle quali il <1 si muta in t. Nella s(e»>
sa maniera dunque , che campi nomeappellativo, e comune a molli si è fat-
to nome proprio di luo»o particolare,
cosi può darsi il caso, eoe sia avvenutoa Brozzi.
Pag. 17. y. Di PentolaIl villaggio di Peretola è nominato
per gli alloggiamenti di Castntecio nel' i3a5., il qual Castruccio come riferisce
Gio. Villani , a^ldl 4. di Ottobre fecein dispetto e vergogna de' Fiorentini cor-
rere tre pala dalle nostre rnosse injino
. a Peretola. Ma più nominato , e piùcelebre si è
,per esservisi rifuggito e
nascoso nella casa de’ Signori del Benequel Diavolo della Novella , che da Fi-
renze fuggiva la persecuzione de’ suoi
creditori.
Pag. 17. V. 20. E per onta «
11 Bembo nel primo libro delle Pro-
se. E medesimamente tjuadnllo vocePnrì'enzale , onta ,
piarle, ec, Pe-
riol d'Àlvernia, manuscritto di ssfa Lo-
renzo :
Dompna,per cui eu chan
,
Una ren vos dirai
Se l vostr amie deschai ,
Ontas naure e don.
**9Tfaimeric di Belleaot
, manuscriuoRedi:
Onta eu n ai gazanbat ^ « gran despit.
Osservo per passaggio nel nome di que-sto Poeta Nairnerico, che vale Amerigo^che nella lingua Provenzale ad alcunevoci, che cominciano per lettera vocale
era costume di aggiuguere in principio
la lettera n, come per esemplo in vecedi Ugo dicessi Nuc , e in vece di Al-fonso , o di Anfolso scrivessi Nanfos.Vita di Nuc di Sam Sire: Pois cn Ca-talogna, et en Aragon, et Espugna colbon Rei Nanfos de Lion. Vita di Nai-
merico di Pepugnan : Presentollo al ReiNanfos de Castella. Quindi è , che ser
Brunetto Latini nel Tesoretto , secondola maniera Provenzale :
Esso Comune saggio
Mi fece suo messaggioAir alto Re di Spagna ,
Cli' era Re d"Alamagna ,
E la corona attende ,
Che Dio non la contende \
Che già sotto la lunaNon si trova persona ,
Che per gentil legnalo ,
Ne per alto bamoggtoTanto degno ne fosse.Con» esto Re Nanfuse.
Redi, Opere, Voi, I, *4
aioE Giovarmi T'emani lib. 7, 102. LasciòRe tfAragona Namf'us suo primogenito.
E appresso: Con tutto che'l detto Narrt-
fus vivette. poco , e succedette il reameal Suo fratello Giamo.
Il Boccaccio usò ninfemo per infer-
no : nahissare per abissare , il che fu
osservato ancora da Franco Sacchetti', e
Giovanni Villani con Ricordano Male-spina disse Santa Maria Nipotecosa ia
rece di Santa Maria Ipotecusa : se pe-
rò co’ migliori e più eruditi Antiquarjon si volesse affermar quello che que-sti due autori scrissero , cioè che la
chiesa di Santa Maria Nipotecosa fosse
veramente edificata in Firenze da’nipoti
di UQ tal Cosa degli Adimari
,
da cui
ebbe origine 1’ antica famiglia de’ Cosi
consorti de’medesimi Adimari. E se be-
ne nell’ alto del muro della cantonata
di essa Chiesa si legge a grandi lettere
questa inscrizione: àyia papié, inrore-
nwffa, nulladimeno per non esser tale
inscrizione d’ incavo , ma di scrittura ,
verisi mi I mente , anzi senza dubbio si
può credere più moderna del titolo del-
la Chiesa , e forse inventata da alcunmoderno , che non arrivando a sapereil significato di quel vecchio nome Ni-potecosa l’abbia voluto far apparire dal
Grec > vxoTS xovea
,
che in latino si ren-
derebbe aggiustatamente puerpera. Maper tornare alle voci, che nel loro prin-
Digitized bv Googl-
1
211cipio hanno la giunta della lettera n
,
osservo, che questo vezzo era talvolta in
uso nell' aulica liugua Merboiiese, o di
Linguadoca. Nell' aulico libro, che si
conserva nell' archivio principale di To-
losa ;delle Lostitazioni delLi Giojcz, ov-
vero Premio ìT amore , compilato daGtujUel'no V/o/<«ier Cancelliere di esse
Costituzioni , e citalo da Pietro FabroAgonist. lib. 2. cap. 4. al capitolo di quellibro , che ha per titolo : Cui , so es , a4jui deu hom juejar , e donar joja
; tro-
vasi la voce nauta in vece di auta ,
cioè alta, E si hom troia dos; o mays
dictatz ayssi netz la un, coma C autre\
deu hom attendre, et gardar qual es demelhor , et de plis nauta > sentensa , et
am mais bos motz, et notables. Appres-
so gli Sgagnuoli 1' arancia ^uasi da un
latino aurantia non si dice in altra ma-
niera , che naranja. Il dottissimo ed eru-
ditissimo mio amico slg. Anton MariaSalvini saggiamente va opinando , che
r origine dell'aggiunta della lettera n ai
nomi proprj possa esser tale, cioè, che
dicendosi don Amfus, come si trova in
Giovanni f^illani lib. 7. cap. 124. Clic
,promise a don Amfus Re rtAraona
,
che, ec. E lib. g. Prilla di Chiesa, cheera assediata da don Amfus-, e dandosi
universalmente il titolo di dompno
,
ov-
vero di don dagli Spagnuoli, e da' Ca-talaui a' principi , a' conti e ad alti i si-
Bjsgnori , non larebbe gran fatto
, cbe la
lettera n raddoppiata in Donnarnfus, e
, Donnaimeric, ed in altri, toltone via il
don fosse rimasa al nome semplice Am-. fus, Aimeric, come appiccata ; e quanto. a’ nomi appellativi può benissimo, come
egli pur dice , essersi distaccata dalla
preposizione in , e aggiuntasi poscia al
nome, rimanere attaccata con esso, co-
me per esemplo , da innabissare fattosi
nabissare
,
e quindi nabisso. E da in in^
femo può esser nata la storpiata voce
ninfemo. E nauta per alto nel soprac-
citato libro Tolosano può essere stato
fatto dal verbo ennantir usato da’ Pro-venzali, che vale lo stesso che innalza-
re^ ovvero altire
,
come disse Guido. Giudice nelle Rime antiche del testo a
penna di Pier del Nero citato dal Vo-cabolario della Crusca. Arnaldo di Ma'
• raviglia :
Per ennaUr 'Giostre cor, e ondrar,
A VOI mi rend ; c om mielz non pot
amar.
Pag. 17. V a3 . Del vecchierei Sileno
Sileni erano detti generalmente tatti
i Satiri attempati, come afferma Paùsa-
nia, forse dal primo Sileno, cbe tenne-
ro gli antichi essere stato balio e pre-
cettore di Bacco , e secondo cbe scrive
Pausauia paiiayejfói, col qual
- ***'> Vtòme eraho chiamati i Servi, che aveaa
cura di allevare e d’ instruire i padrooi
• giovanetti.
Fag. 17. V. 3o. Bestemmia' Bestemmi», oltre il significato di at*
• tribiiire empiamente a Dio quel che
non si conviene ,ovvero di rimuovere
• da lui quello che a lui conviene, signi*
^ fica altresì in lingua toscana biasimo ,
• detrazione ,maldicenza , imprecazione e
*• maladizione. Gio. Batista Gelli, Capr.
Boti. car. 180. Lasciti però tu tanto of-
• fuscare dalC ira, che tu bestemmi gli an-
t ni, ed il tempo come tu fai! Vanto di
• Rinaldo da Mont'Albano ,manuscritto:
Bestemmiava Gano , e lo giorno in lo
quale ebbe nascimento la setta Maganezese. Nel Cicalamento di Maestro Bar-
tolino dal Canto de'Bischeri-, In questa' lingua il canchero è bestemmia , e nonè vivanda. In tal significato di maladi-
zione , r usano i Napoletani frequente-
mente. Nell* introduzione del Cunto,jÌg i
li Cuii^ Sto Prencepe è cfnamato Tad- \
deo ,10' quale pe na jastemma de nd ì
Fata , avenno dato T utema ntano a lo '
Quatro de la vita , è stato puosto dintoj
una sebetnfa-, e appresso; Io pe vedere^
me dileggiata e coffiata da vuoi , v’ ag-
gio data sta jastemma. Bestemmia vien
proprio dal Greco pXaarpi^iHa. Dal Gre*
co dunque,
che usarono anco i Latini
,più bassi t cioè blasphemiai i TfapoleUnt
iti rerò jatte>n>na
,
e i Toscani antichi
biaslt-mma ; e da biastem»
miare. Nov. ani io. 54- Sicché molti lo
scilifavano quanto più po''cano, e molti'
li biastcmmiavano, e diceano : menatelo
a' fossi , u cani e a lupi; e ap]>re$$o :
E molti il biastemmiavano , e ciascunoflicea la sua. Il Vocabolario porla que-st' ultimo esemplo delle Mov. anlìc. alla
voce hiastemmare, e, come si vede qui, hada dire biaetemmare
,
se però il Vocabola-
rio non seguita in questo luogo il testo
stampalo più anticamente, nel quale si
ha biastemmare , e non biastemmiare ,
come nello stampato da’ Giunti. Tra gli
Aretini, e particolarmente nel contado,
si continua all’ usanza antica a dire
biastimmiare, e biastimmia.
Pag. 17. V. 29. E lo giunga di vendemmiaQuesta otribile bestemmia. 1
Il tempo di vendemmia appresso gli
antichi era tempo di libertà ; e pareva,,
che in quello non si disdicesse il dir \
male , anzi vi usavano assai di licenza, 1
^ nella maniera clic in tale stagione si 1
. usa ancor oggi a Napoli. E da vedersit
il luogo d'O/azio del lib. 1. delle Satire,^
satira 7.
^ag. 18. V. 5 . Che ne' vetri zampilla,
Salta, spumeggia e brilla.
Digitized by Google
ai5 t
' Tiptoteo nel Ciclope ^jmao Atenwlllij_u—
E %9tvt ift't^rV'Sri dé-xa^ xianvov (teXai~
ya( (TO|'ó)’o( à(t^i)óra( à(ppà ^pvàiot. l
- Jn bicchier d" edra infuse
Nere stille immortali
,
Ond io vidi fiorir altera spuma.
r
Antifone ne’ Simili disse un bicchiere
.pieno e spumeggiante xXppSf àppi^or.
! Enbolo ne metti tori di Dadi xvÀixa
. vxepaippiiovaaf calice sopraspumeggiante.
Pag. i8. V. 7* E (filando in bel pareggio
. Lf ogni altro vin lo assaggio
Foraggio, lo stesso che il latino com-
. paratio. Alla spiegazione però, la quale
si dà nel Vocabolario a’ Cavalieri di pa-
reggio menzionati da Giovanni Villani
lib. 1
2
. cap. 66. cioè valorosi a ogni pa-
ragone, pare , che se ne possa aggiugne-
. re un altra piu proporzionata , se si ha
punto di risguardo a ciò ,che dittusa-
mente scrive di tal sorta di cavalieri
r eruditissimo Du Fresne nella Disser-
tazione terza sopra l’ Istoria di san Lui-
gi , ove mostra cavalieri di pareggio es-
ser quelli , che sono di gran parentado,
e posseggono nobiltà di sangue e di
schiatta da' Legisti detta generosa. E uo-
mo di alto pareggio , e di basso pareg-
gio prova coir autorità di vecchi romanzi
aiGfran7.e$i non essere altro se non uomo
• di alto, o di piccolo affare; di alta , o
di bassa nascita.
Pag. i 8. V. 22. Capribarbicomipede fami-gita.
Di queste composizioni di parole biz-
zarre e capricciose convenienti a materia
comica e ditirambica se ne leggono presso
gli antichi Latini , e principalmente in
Plauto nel Milite glorioso , e altrove; ed
hanno imitato i comici Greci: ma quel-
lo, che passa tutti è un epigramma à'E-
gesandro contro i Sofisti , Ossuto tutto
di simili parole lunghe un miglio com-
poste a capriccio. L’ epigramma è ap-
presso Ateneo lib. 4« c 8a Giuseppe Sca-
ligero nelle sue Cognettanee sopra Var-
- rone fu felicemente volto in latino:
Siìonicaperones ,vibfissasperomenti,
Manticobarbicoìae , exterebropatinaex
Planipedatqueìucemitui , suffarcinamictif
Noctilavemivori , noctidoìostudii
,
Puìlipremoplagii ,subtelocaptiotricae
,
Rumigeraucupidae , msgicanoricrepL
Hanno voluto imitare questa maniera
alcuni Poeti ditirambici toscani; ma se- 1
minando tali voci non colla mano , macol sacco , son ventiti a perder quella !
grazia , che si studiavano di ottenere. ,
i. vedi Benedetto Fioretti ^ o , come egli^
217volle chiamarsi , Udeno Nisieli nel vo-
lume quarto de’suoi Proginuasmi cap. 35.
36. 3g.
Pag. i8. V. 24. Tutti affoohiam la sete
Il Ronsardo nell' Elegia del Bicchiere
canta , che egli fu inventato per affidar
la noja:
- O foli verre , oserai-je hein dire ,
Cotnbien je t" aime, et combien je iad-mire ?
Tu es heureus;et plus heureus celai.
Qui t'inventa pour noyer nostre ennui.
E altrove :
Il me plaist de noyer ma peine
Au fond de cesU tasse pieine.
Pag. 18 . V. 28. Per ricomprarne poco mu~schio ed ambra
Qui ricomprare vale lo stesso che
comprare una mercanzia col ritratto
deir altra. Orazio :
Vina Syra reparata merce.
Vini ricomprati colle mercanzie soriane*
cioè co’ danari fatti da quelle. In latino
parare e comparare vuol dire compera'
re , comprare. Reparare,ricontprare.
si8Pag. Tg. . 3. Cuntiara
È nome di ogni vaso, ove si tenga la
cuii7.ia preparata con odoii per uso di
profumar l’aria delle stanre. Blla è per
Io più a foggia di catinella di cristallo,
o di porcellana, o di altre tetre nobili,
e più comunemente di quella di Savo-na. Cunzia è voce Castigliana
, e signi-
fica una spezie di giunco di radice lun-
ga, odorosa, molto ben nota a’Semplici-
sti, e conserva in Italia lo stesso nomeCasligliano per esser venuta di Spagnaquesta maniera di profumo, che noi più
che in ogni altro tempo amiamo di sta-
te, non tanto come riconosciuto delizio-
so , che come immagiii.-)to salutifero e
ricreativo del respiro. SI concia la cun-
zia in diversi mMi secondo il gusto, ed
ancora secondo la possibilità di chi vuol
servirsene : ma convengono tutti in que-
sto, che scelgono le più grosse radiche,
le rimondano da quelle minute escre-
j
scenze ,o barbuzze, che gettano intorno
la guisa di peli; poi le ammaccano gen-
tilmente tra due pietre, e a quel mo<Io
i ammaccate ,o lasciandole intere, o fen-
j
dentlole per lo lungo , le tengono per
I molte ore in infusione nello aceto bian-
i co del più forte; cavandole poi, e pro-
t sciugandole cm un panno, le untano o
',di zibetto, o di balsamo nero, o di
jqiiintessenz.e odorose, o di altre confe-
zioni più o meno riccamente alterate
\
\Digitized by Google
aigéon muschio c con ambra ; ed a quel
'
‘ modo preparate le pongono nella cun- ì
1 ziera a suoli a suoli, spolverizzando lar>[
gamente ogni suolo col belgivino, o con '
altre varie polveri odorose, come di spe- !
zierie ,di buccheri di Eslremoz , di le-
j
gni aromatici , e ancora di pastiglie rioj
che da fuoco ; ed il tutto ricuoprouo
,
con aceto bollente , o almeno caldo !
quanto lo può comportare il vaso , ài ì
qual vaso immantinente lo cuoprono
coÈr~gran diligenza, acciocché non isva-
- .pori , e non lo scuo))rono finché non sia
TOn raffreddato: quindi a misura «he'
l’aria va becndosi di quello aceto, ne
rinfondono dell’altro, acciocché la)
sia stia sempre coperta ; e non solamen-,
le rinfondono del puro aceto , ma del '
profumato^’ o..'con infusione di fiori, o
con varie decozioni odorose , non man-
r.cando di quelli , che, per fin^entiUre
l’acutezza di esso aceto, lo tagliano di-
scretamente cun acque di fiori stillate ,
ed il lusso è tant’ oltre pervenuto, e per
così dire a tanta superstizione , che al-
cune delle più principali dame voglio^
no , che 1’ acque de’ fiori sieno stillate ,
nelle campane di oro , ovvero colla j
nuova invenzione del reticino. i (
Pag. 19. V. i 5 . Odor, che a^uagU il gran’-
de odor del vino \
Il Ronsardo afferma il sole odcre dell
230
j-vino farlo un brarìssimo intenditore dei
' "Versi d’Omero,
il qual Poeta,
perchèloda tanto il vino, naosira che fosse un
• buon bevitore. 1 versi del RonSarcìo* sono :
' Jo , je Tentens , chere troupe :
‘ ZjO seu/e ofitfur de cette coupéM'a fait un rapsodo paillard,
I Pour bien entendre ce vieillard.
E veramente l’odor del vino è lodato
gentilmente da Omero nell’ Ulissea , co*
me altrove ho acceunato.
Pag. 19. V. 19. Celabro
E voce antica ; ma ne’ bisogni 1’ han-no usata ancora i moderni
, tra’ quali
Mons. AzzoUni nella famosa Satira r
I
Perchè la voce , che- va intorno è que-
sta ;
t Ch' allora ti svani tutto il celabro
,
Quando Minerva ti scappò di testa,
\
Pag. 19. V. zy. Perchè a berne sul popone- Se de’ nostri poponi, e della dolcezza
loro avessero notizia gli antichi Greci e
Latini non è cosi facile lo affermarlo
con certezza, ed è stato in controversia
' tra’ litterati. Tra’ mamisci itti della mialibreria conservo uii erudito Tiattatello
latino intorno ad essi poponi, compilato
S2(
da Alberto Rimbotti celelire medico' Fiorentino. Nel cap. i6. e i8. afferma
quest’ autore , che sul popone si dee ber
vino generoso, puro e fresco; e lo con-
ferma con molte ragioni , e con molte
autorità. Qticsto Traltatello meriterebbe
di essere dato in luce colle stampe.
Pag. ig. V. 3i. Stare a tavola ritonda
Maniera proverbiale nata dall’ antico
Romanzo di questo titolo, che si con-
serva manuscrilto nella libreria di san
Lorenzo ,in cui si legge , che due sono
state le tavole ritoude, una del Re Uter
Pandragone ,1’ altra del Re Artù: que-
sta si chiama la nuova ; e quella la
vecchia.
Pag. 20 . V. 12 . Alto dominoCosì Tarquino per Tarquinio diceva-
no gli antichi. INel contado di Firenze
è rimasa la voce dimlno, Xa qu^l^iqlatrovo nell’antico Libro della cura delle
malattie, in alcuni Poeti antichi, e nel-
la Tavola Ritonda citata dal Vocabola-' rio; e nella Tavola Ritonda venne forse
dal Franzese domaine,vedendosi chia-
ramente essa Tavola essere traslatata dal
Franzese, imperocché vi si trovano mol-
te voci di questo linguaggio, come per
esempio la pitetta Brettagna per la pic-
cola Brettagna , e trinciar la testa per
tagliar la testa, ec.'
sxtl^ag. 20. T. x3. Tja ru^ada di r>thino .
Pindaro oeU’ Oliianiade <ptó,Xa,w \
sajff'Air X(S^ ^Aor^(;(Otty opàcso, vaso bpumeg- !
filante [CI la rugiada delia vite. £oi~ i
ìeau sat. d. i
\
Et le vin en rubis brilloit de toutetj
paru.I
Pag. 20. V. 3 i. Mi sollevo
^ovra i gioghi di Permesso
Bacco ha che fare ancora in Parnaso ;
Catullo nelle nozze di Peleo :
Stoepe vagus liber Parnassi vertice sommoThyadas effusis evantes crinibus egit.
Lucano ebbe a dire di Parnaso :
Mons Phaebo , Bromioque sacer.
E il vino è detto cavallo del Poeta ^
perchè lo fa alzare, e sollevare nella
poesia. Nell' epigramma Greco della An*tologia , citato ancora da Ateneo^ efatto sopra Gratino poeta della vecchiaGreca commedia, il.quale era gran be-
i vitore:
I
Olvot^ Tot ji^apitvTt fciXst ftéya( txxofàotiiè.
Digilized by Google
223
D» Jone Chio poeta appres»o lo stesso
Ateneo il vino fu nominato àepnxvvf
quasi sollevante gli spiriti. Il cnncuisi'
di vino ,essere un sollevare la fantasia i
lo afferma Ronsardo nell’ inno sopra '
Bacco :
Par toi. Pere, chargis de ta douce am-
brosiej
Nous elei->->ns au del f humaine fan- |
tasie I
Portès dedans ton char .... 1
Pausania nelle bellezze del paese Laco*
nico racconta , che gli Amiclei sopran-
nominavano Bacco ypiXav , e i Dorici
dicono alle penne: volendo signi-
ficare con questo soprannome di penna,
o pennuto che Bacco ,cioè il vino , è
un dolce incarico, che solleva le menti
degli uomini, in quella guisa che fan-
no le penne agli uccelli.
Pag. 21. V. r. Che preUndo, e mi do vanto
Gareggiar con Febo isteuo ,
Il vino mette un cieco amore di loro
stessi negli uomini, e gli rende vanta-
tori più assai del dovere. Orazio nel-
l’ode a Bacco:
.... saeva tene cum Berecynthio
224Coma tympana , tfuae suhsequitur cae-
cus amor sui,
Attollens plus nimio gloria verticem.
Nel convito di Senofonte i convitati si
vantano chi d'una cosa, e chi d' un’ al-
tra ,facendo per così dire , una spezie
« di siuoco : e Platone nel Cratilo, comeanche osservò Ateneo lib. i. poco dopoil principio
,pone che il vino , oifog '
• sia cosi detto, quasi òtófvt
,
perciocchéci empie la mente di falsa stima di noi
\medesimi , la quale stima da' Greci di-
' cesi Che perciò i briachi non la
cedono ad alcuno; tutto il mondo è lo-
ro. Addis cornua pauperi, disse Orazio ;
e Anacreonte di se stesso IIavo ì’òkov-ta !>vpS, Graziosissimi sono i vanti in-
trodotti nel convito di Senofonte , comeproprj della mensa, e del vino.
Pag. 2f. V. 8. E più grati di quel cK è
Il buon vin di Gersolè.
Per osservare il costume antepone la
soavità de’ suoi versi a quella del vino
di Gersolè. Pel contrario il Caprajo di
f Teocrito nell’idilio i. volendo lodare il
canto di Tirsi, lo antepone alla dolcez-
I
za dell’ acqua :
\ Adtot o xMpàr
,
TÒ jeòv pliof
,
^ tò' xara^es'
Digitized by Googic
2>5T^/ «orò ró^xétpa^ Kona^ei^evat vtj/o-
Ste9 idop.
E parimente san Paolino vescovo di
Nola a Joviano :
Tane te divinum vere memorabo Poe-tam ,
Et quasi dulcis aquae potum tua car^
• mina dicam.
Pag. 21. V. (). Gersolò
San Gersolè è una villa poche miglia
lontan.a da Firenze in vicinanza deirim-pruneta, ed è cosi detta dal nome della
chiesa della stessa villa, che è intitolata
san Giovanni in Gerusalemme di pa-
dronato della nobile famiglia de' Ghe-rardini. Gli abitatori del contado stor-
piano facilmente, e corrompono i nomi;
quindi avviene , che la chiesa di santa
Maria in Coeli aula della diocesi Fio-
rentina la dicono Cilicciaulii san Gerva-sio fuor delle mura di Firenze san Cen-
bugio; il monte di santo Lucio presso
Artimiuo san Talluccio ; san Cajo sanGaggio
; sant'Ansano sanU» Sano ; san-
t’El igio, ovvero Aloeo santo lò\ il bo-
sco di san Luxorio in vicinanza di Pisa
san Rossore. Troppo lungo sarei, se vo-
lessi allungarmi in cosi fatta materia
,
essendo sempre stato, per cosi dire, do*
Redi. Opere, Vol. I, 1 5
aa6stino delle tocI , é particolarmenle di
quelle de’ nomi pioprj, Tessere storpia-
te stranamente,quando passano d' ana
lingua in un'altra.
Pag. 21. V. IO. GhirondaLa Ghironda è uno strumento musi-
cale , che si suona coT girare una ruo-
ta, e da quel giramento ha preso il
nome di Gironda, o Ghironda, secondoT opinione del sic. Egidio Menagio nel-
le Origini della Lingua Italiana. Oggi
è poco in uso , e si vede solamente ia
mano de' pitocchi oltramontani.
Pag. 2 1 . V. II. CennamellaStrumento musico, che si suona colla
,bocca. In alcuni luoghi di Toscana, e
particolarmente tra gli Aretini dicesi
Ciaramella. Ciaramella parimente disse
l’autore della vita di Cola di Rienzocap. 25. Ora ne mengon buffoni senza
fine , chi sona tromme ,chi cornamuse,
chi ciaramelle, chi mesi cannoni. Dal
tuono e dalle voci di questo strumentoehhe forse origine il verbo ciaramellare,
che significa cicalare con avviluppamen-to di molte parole. Tra gli antichi Pro-venzali caramelar vale lo stesso che so-
nare la cennamella. Plella GrammaticaProvenzale del testo di san Lorenzo :
Calamela fstala canit. E nelle cliiose
Piovcnzali dello stesso testo Caramelar,
Digitized by Gooslf
237eum JUtiilis eanere. Ne* più vecchi rima*tori franzesi si trova cìialemel^ e chaU-melle. Ovid. manascritto:
Puis prent fresteaux, et refresielle ^
Et c/ialemaux,et chalemelle ,
Et tabour,et fleutt.
E ivi medesimo:
Li chalemel de comovaille.
Il dottissimo sig. Du Fresne dopo aver
Jorlati dae esempli di challemelle
,
ei challemie del Romanzo manuscritto
in versi di Bertrando du Guesciin, scris-
se , che Dante nel 22. dell’ Inferno di-
cesse cannamella , e non cennamella.
Può essere , che nel Glossario sia errore
di stampa ; imperocché Dante disse cen-
namella , e non cannamella , siccomedissero ancora tutti quanti quasi ^li al-
tri autori toscani. Ho detto quasi tutti
gli altri autori toscani, perchè ve ne fu-
rono di quegli, i quali dissero cemba~nella , e tra questi Bernardo Giambul-lari nella Continuazione del CirifFo Cal-
vaneo lib. 2. stanza 228. del mio testo
a penna :
Tante trombette e sveglie e cembanelleE tamburacci e nacclteroni e comi.
E Antonio Alamanni , rim. buri.
Sonando cornamuse e cembanelle.
»
Benedetto Varchi disse cemmanelle nel-
rErcolano a carte 267. Ne i cembali^
ec. ne le cemmanelle,che si picchiano
r una coir altra. Qui però debbo av?er-
tire , che le cemmanelle del Varchi so-
no strumenti totalmente differentissimi
dalle cennamelle de’ soprammentovatiautori.
Pag. 21. . 17. Un ceìeno ^
eli è velen d"almo liquore
Gajo Giureconsulto lib. 4. ad LegemdiHvderim Tabnlarum, ne’ Digesti al tlt.
de vei'horum siguificatione alla legge 226.
Qui 'venenum dicit , adjicere debet ,
utrum malum , an bonum ; nani et me-dicamenta 'venena sunt
,quia eo nomi-
ne ovine continetur,quod adhibitum
naturam ejus , cui adhibitum est , mu-tai : quian id quod nos venenum appel-
lamus , Graeci pdppax»» dicunt;apud
illos quoque tam medicamenta,quam
quae nocent , hoc nomine continentur ;
unde adjectione alterius, nomine distin-
ctio Jit\ admonet nos summus apud eosPoetarurn Homerus
; nam sic ail :
fbippuxa, iToA^à pÈv ècr^Xà, pepiyuétfa ,
7ioÀ,?à, di Xvypd.
DigilizcQ b;
229Negli epigrammi Greci lib. 2.
A^Àa, (UH mdx^oio ^tXtjdofov Svrve tmna*Touto YÀp ejTt xaxàv (pap^axav àrzi-
doTOV.
Chiama qui il giocondo liquore di Bao>co un farmaco antidoto
,cioè un vele-
no buono contro a’ mali, e agli affaniii.
Nel libro della cura delle malattie :
Perchè si ee il vino uno ottimo veleno• contro V veleno di simili funghi.
Pag. 21. V. 22. Già nel bagno tf un bic-
chiere
Orazio lib. 4. od. 12.
non es'o te meis
Immunem meditor tinguere poculis.
' Tinguere, OTvero tingere nel latino èpropriamente bagnare ; onde i battezzati
da Tertulliano son detti tincti ,colla
qual parola volle esprimere la greca
pt5ax7lonirot
,
tulTati, bagnati. Virg. 3.
Georg.
Quid tantum Oceano properent se tin-
gere soles
Hibemi
l^aonde Orazio quando disse meis tin-
g7tere poculis è come $e avesse detto
tuffare , bagnare nel bagno de’miei bio.cbieri. E bella la fantasia del Ronsar-
• do ,ì\ quale per dare una lode grande
al suo bicchiere , dice , che crede asso-
lutamente , clic Bacco fosse lavato ia
' quello, allora che sua madre tocca dal
fulmine si sconciò , mandandolo fuora
intriso di sangue , e pieno di polvere
della saetta ; e che da quel tempo iaqua essendo rimasa nel bicchiere qual-
.che scintilla
, e avanzo di quel fuoco
,
metta in chi vi si attacca una voglia' inestinguibile di bere :
Qite dirai piasi par esprtuve je croi,
Que Bachus fot jadis lavò dans Coi,
Lors que sa mere atteinte de la foudre^
En avorta, plein de sang et de poudrviEt que des lors quelque reste du feu
j
Te demoura ; car quiconques a beu' Un coup dans toi , tout le tans de sa
f'vie
j
Plus i reboit,plus a de boire envie.
Pag. 21. v. 23. Arianna idolo amato ^
Mi 'vo' far tuo cavaliere ,
Il Boccaccio nella Novella del Re\ Piero, e della Lisa: Vogliamo, che co~* lui prendiate per marito , che noi vi da-’
remo , intendendo sempre , non ostantm
questo f vostro cavaliere appellarci.
Digitized by Googl
aS*Pag. a I . V. a5. Cavaliere sempre bagnato
Allude airaulicliissima milizia de'Ca*
valieri Bagnati. Di questa stessa volle
intendere il Medico appresso il Boccaodo nella Nov. y. della Giom. 8. quan-do da Bruno , c da Buffalmacco gli fa
detto: La contessa intende di farvi ca-nralier bagnato alle sue spese. Per intel-
ligenza delle ({uali parole scrissero Pin-
frascritte notizie quei val^tjjomjxiii eh®dal Serenissimo Granduca furono depu-tati alla correzione del testo del Boc-caccio l’anno iSyS. .nelle loro douissi-
me annotazioni. Erano dunque allora i
cavalieri bagnati i primi in onore, e si
dava questo grado con grandissima pom-pa , ec. Perchè v' intervenivano cirimo-
nie assai, e bilie, e pregne di regole e
costumanze cavalleresche : e di questa
la prima era che in un bagno per que-
sto solennemente apparecchiato in chie-
sa erano da altri cavalieri, bagnaci,
che erano i patrini in quesi atto , e di
quindi tolto lo riponevano in bianchis-
simo letto , con tutte queir altre parti-
colarità, che si leggono nella Novella
di messer Ugo di Tabaria, quando alla
richiesta del Saladino , che n ebbe va-ghezza , lo fece , secondo questo nostro
costume , cavaliere : nè ha molto ,che
uscì fuori del cento antico. E Giovan-
ni Ùillani parlando di Cola di Rienzo,
quando fu fatto Tribuno, e fu vicino
i>v GoogUI
a far gran faccende in Roma , e pertutta Italia , scrive , che egli
;ma met-
tiamo he parole sue, Fecesi il dello Tri-
buno far caTalier al Sindico del Popol
di Roma all’altare di san Pietro. E pri>
ma per grandezza si bagnò a Latcranonella conca del Paragone, che v’è, ovesi bagnò Costantino Imperadore , ec. Il
che medesimamente si legge , e pocomenoy che con le medesime parole nel-
le Istorie Pistoiesi. Messer Luca daPantano molto nobile e onorato cava-liere cosi scrisse di se, quando fu fattocavaliere T anno i36i. Il magni ileo M.Pandolfo Malatesta, in nome, e vicendadel Comune e Popolo di Firenze , mifece cavaliere armato in su la porta dei
Priori : e prima la notte dinanzi in sanLorenzo di Lamberto Soldanieri al pontea Grieve , mi bagnò solennemente M.Guelfo Gherardini , e M. Giovanni di
M. Bartoloromeo de'Mangiadori, cc. Mae non fu forse discaro a Lettori, udire
le parole proprie della istoria di Coladi Rienzo , siccome elle sono in quella
lingua Maremmana , o Romanesca an-tica. Allora fu celebrato un solenne ufi-
zio per lo Chiericato, e puoi l’< Micio,
entro nel Vaguo, e V-agnaose nella con-ca dello Imperadore Coslanliiio; la qua-le ene de porfiosissimn par.Tgone : stu-pore enc c|uesfo a (licere: iii<>!l<> fece lalente favellare. Uno cilladiuo di Roma
2.33M. Vice Scuotlo caTalìere li cienze laspada
,puoi se adorni io en un venera-
bile lietto, e iacnue in quel luoco, chese dice le fonti ai sau Janui. E nellaTavola Ritonda
, che mostra T usanzamolto antica. Trist.ino se ne va nellagran piazza della città
, e quivi lo Relo bagna, ec. Fino a qui le annotazionide’ Deputati , alle quali mi sia lecito
alcuni altri particolari esem-pli , che dimostrano c 1’ antichità diquesta Milizia
, e le diverse cirimoniee solennità costumate nel prenderla.Giovanni Monaco di Marmi'nslier nelprimo libro della storia di Goffredo Du-ca di !Norman<lia
, volendo raccontare ,
che Goffredo figliuolo di Fulcoe conte<li Angiò fu fatto cavaliere l’anno 1128.da Arrigo I Re d’ Ingliilteri'a , cosi nescrive : Gaufp-edus , Fnlconis comitis
ude^avonirn,post Jerosolymonim Re-
ffis , ftlins , adolescentiae primaevo florevemans
,quindeeìm annomm factus est,
Henricns primus Re.v y/nglornm vnicamfìliom Icffe conntihii jun^ie affectar
hat. Repia vohintas Falconi in pctitio-nihus sifit innotescit. Ipse Regis pelitio-nem effectui se mancipatunim gratulaneter promisit. Datar utrinque fides , etres sarramentis firmata
, oninem Jubie~tatis scrupulum tollit. Ex pruecepto in~
taper Regis exai tum est a comite , utfUium suutn nondum Militem ad iptam
imminentem Penteeostem Pothomagtmthonorijìce miuertt
,ut ibidem cum co-
aequaevis arma suscepturus , regalibits
gaudiis interesset. Nulla in his obtinen-
dis fuit dijficiiltas. Insta enim petitio
facilem meretur assenswn. Ex imirerio
itaque patris, Regis gener futurus, cum
quinque Daronihus , multo etiam stipa-
tus milite , liotliomagum dirigitur. Rcxadolescentem multiplici affatur alloquio,
multa ei pmpones, ut ex mutua confa-hulatione respondentìs prudentiam expe~riretur. Tota die illa in gaudio etexul-Catione expenditur. Illucescente die al-
tera , Balnenrum usus , uti tyrocinii su-
spiciendi consnetudo expostulat, paratus
est, Post corporis ablutionem ascendens
de Bulneonim lavacro, lysso retorta adcamem induitur, cyclade auro texta
superxestitur , cìdarryde conchylii , et
muricis sanguine tincta tegitur, caligis
holosericis calciatur,pedcs ejiis sotiìla-
ribus in superficie leunculos aureos ha-bentibus muniuntur. Talibus ornamentisdecoratus Regius generi adductns est
miri decoris equus ; induitur lorica in-
comparabili,quae maculis duplicibus in-
texta, nullius lanceae ictibus transfora-
bilis haberetur, Calciatus est caligisfer-
reis, ex maculis itidem duplicibus com-pactis. Calcarihus aureis pedes ejus ad-stricd sunt. Llypeus leunculos aureos
imaginarios habens collo ejus suspendi-
Digilized by Google
aS-,
tur. Imposiia est copiti ejus cassis mul-to lapide pretioso relucens
,quae talis
temperaturae erat , ut nullius ensis ictu
incidi tvel falsificari valeret. Aliata est
basta fraxinea ferrum Pictavense prae-tendens. Ad ultimum allatus est ei en-sis de ihesauro Regio ab antiquo ibi-
dem signatus, in quo fabricando fabro-Tum superlativus Galanus multa opera,et studio desudavit, Taliter erso arma-tus Tyro noster , novus militiae post-modum flos futurus , mira agilitate- inequum prosilU. Quid plura ? Dies illa
lyrocinii honori et gaudio dicata^ toUiin ludi bellici exercitio , et pmeurandissplendide corporibus elapsa est, septemex integro dies apud Regem f^ rocinii ce-
lebre gaudium contìnuavit. Da una an-tica cartauecora, ebe si conserva tra le
scritture ael sig. Prior Francesco Setadi l'isa , ho copiato il seguente narra-mento dell’ Ordine di Cavalleria, che fadato nella città di Arerzo ad un tale
lldibrando Giralasca a spese del Comu-ne e popolo Aretino.Cum Domino. Anno 1260. die octava
Aprilis in Consilio generali congregatomore solito
, ad sonum campanac , ettubarum
, Domini Domini constituerunt,quod secando Dominica mentis Alaj fa-ctus esset Miles ad expensas publicasnobilis
, et fortis vir Ildibrandus vocatusGiratasea. Venta igitur die secundi Sa-
l?(>
hatl mensis Maj valJe mane praefatut
nohiìts , et strenuus vir lldibrandus be-
ne ,et nobiliter indutus citm magna
masnada suorum ingreditur Paìatium ,
et juravit Jtdelitatem Dominis Dominis^
et Sancto Protectorì civitatis irretii in
manits Notarli , et super sanata Deievangelio : postea honorifìce ivit ad Ma-trem Ecrlesiam , ut hahe.ret henedictio-
nem, et prò honnre ejus adfuemnt se.c
domicelli de Palatio , et sex tibicines
de Palatio : in bora prandii fuit adprandendum , ex deliberatione Domino-rum , in domum Domini Ridolfoni. Proprandio fuit panis et aqua et sai , se-
cundum legeni mHitiae, et commensales
fuerunt cum eo dictus Ridolfonus , et
duo eremitae Camaldulenses ,quorum
senior post prandium fecit illi sermonem
de opificio et obligationib s Militis. Post
hoc lldibrandus ingiessiis est cubiculum,
in quo stetit solus per horam unam, et
postea ingressus eit ad eum Senex Mo-
nachus sanctae Florae ,cui devote et
burniiiter confessus fuit peccata sua , et
accepit ab ipso absolutionem ,et fecit
poenitentiam impnùtam His peractìs in-
greditur cubiculum barbitonsor, qui con-
cinne caput, et barbum ejuK ruravit, et
postea ordinavit omnia,quae necessa-
ria erant ad Balneatinnem. Rebuf sic
stantibus ex deliberatione Dominorivn
venerimi ad domum Ridolfoni qualuor.
Digitizéd by Google
strenui Milites Andreassus JUius Mani-buetini ,
Albertus Domif^ianus , Gilf're-
dus Guiduternus , et Ugus de sanato
Polo cum masnada nohilium Domicel-
lorum , et cum turba Jocularium, Me-
nestretiorum et Tihìcinam. Andreassuset Albertus spoilaverunt Ildibrandutn ,
et collocaverunt eum in Balncuni-,
()il~
fredus aiitem Guidotemus , et Ugus desancto Polo dederunt illi optima do tt-
menta de munere,et officio novi Mdi-
tis, et de magna dignitate. Post horamunam Balnei positus fiuit in ledo man-do in quo lintea eranC albissima et fi-
nissima de mussali ; et papiho et alia
necessaria lecti de drappo serico albo
erant. Permansit Ildibrandns per horamunam in lecto , et cum jam nox oppro-
pinquaret , fiat mest tus de Mediaianaalba cum caputio
,et fuit cìnctus cirv
ctara coriacea, òumpsit refectionem e.v
solo pane et aqna ; et pnstea cum Jti-
dol/òno, et quaCuor supradictis ivit admatrem Ecclesiam, et per tutum noctemvigilavit in cappella
,qtme est a mams
dextra, et oravit Dcnm
,et Sanctissi-
mam Matrem Pirginem , et sanctumDonatum , ut fanercut eum bonum rni-
litem , honoris plenum et justum. Aditi-
terunt illi per totam noctem cum ma-gna devotione duo sacerdotes Ecclesiae,
et duo clerici minorcs ;item quatuor
pulcrae , et nobiles domnieellae, et qui*-
238cuor nohiles domnae stniores nobiliter
indutae,quae per totam noctem orave-
runt Dcurn, ut haec Militia esset in ho-
norem Dei, et Sanctissimae Matris ejus
l^irginis , et sanati Donati, et totius
Sanctae universalis Ecclesiae, Ridolfo-nus , et quatuor ahi suprudicti iverunt
ad dormiendum ; sed ante auroram re-
dierunt. Orta jam aurora Sacerdos be-
nedixit gladium, et totam armaturam agalea usque ad solerettas ferreas\ posteacelebravit Missam, in qua lldibrandus
accepit a Sacerdote humiliter, et curri
magna devotione sanctissimum et sacra-
tissimum corpus et sanguinem DominiI^ostri Jesu Christi. Post hoc intiilit Al-tari unum magnum cereum viride , et
libram unam argenti honorum denario-
rum Pisanorwn-, item obtulit prò redem-
ptione animarum sancti Purgatorii li-
bram unam argenti bonorum denariorum
Pisanorum. His peractis portae Eccle-
siae apertae fuerunt, et omnes redierunt
in domum Ridolfoni , in qua domicelli
de palatio nohilem ,et divitem refectio-
nem praeparaverant ;ponendo sopra
unam tabulam magnam, magnam quan-
titatem trageae , diversa genera tartara-
rum, et alia similia cum optima Guar-
naccia et Tribbiane. Facta refectìonm
lldibrandus ivit aliquantum ad dormien-
dum. Interim cum esset jam bora rede-
undi ad Ecclesiam, novus futurus miles
Digitized by Google
289surrexiù e ledo , et Jiu't indutus emdrappis omnibus albls sericeit cum cin-
Ctura rubra auro distincta et cum simili
stola. Interim Tihicines de pulutio, et
Joculares et Menestr ìii tangebant suainstrumenta ;
et canebant varius stam-
pitas in laudem MUiiiae, et novi Juturi
Mihtis, Postea omnes iverunt ad ma-trem Ecclesutm cum magna turba mili-
tum , et nobihum 'domiceUorum, et ma-
gna (fuantitate plebis voaferantis T'^ivat
Vivai. In Ecclesia incepiC Mitra ma-gna et solemnis. Ad Evangelium teruie-
runt enses nudos, et elevatos Ludovi-
cus de O.'lomeris , Antonius a Mammi,Cercaguerra illorum de Conoolis , et
Guilletmus Miserangeschi. Post Evan-gelium Ildibrandus juravit alta voce ,
quod ab illa bora in antea foret Jìdelis
et vassallus Dominorum Dominorum Co-
munis civitatis Arretii, et sancto Dona-to. Item alta voce juravit
,quod jujcta
suum posse defenderet semper Domnas ^
Domnicellas,pupillos , orplumos et bo-
na Ecclesiarum conira vim, etpotentiam
injustam potentium homimim, et cantra
illorum gualdanas ju-rta suum posse.
Post hoc Amphosus Busdragus cinxit
Ildibrandum calcare aurato in pede dex-tro ; et D. Testa dictus Lupus cinxit
eum calcare aurato in pedo sinistro.
Post hoc pulcra nobilis DomnicellaAlionora Jìlia Berengherii gladmm illi
Digitized by Google
cinxit. Postea Ridolfonus de more de~dii Uli Gaatatiiìii
, et dirÀt Hit : Tu esMiles nohilis Militiae equestris, et haecGautata est in recordationem illius, quite armavit militem
, et haec Gautatadehet esse ultima injuria, quam patien-ter acceperis.
Finita celebratione sacrosancti sacri-
Jicii Missae , cum tuhis et tympanis re-dierunt omnes ad domum Ridolfoni.Ante portata D. Ridolfoni stabant duo-dccim pulcrae et nobiles domnicellaecum guimaldis de floribus in capite te-
ncntes, in manibus catenam ex floribuset herbis contextam, et hae domnicellaefacientes serralium nolebant
,quod no-
vus miles intraret in domum Ridolfoni.
Tiovus autem Miles dono dedit illis di-
vitem annulum cum rosa aurea, et di-
uùt^quod juraverat se defensurum esse
domnas et domnicellas; et tane illae
permiserunt illi ,ut intraret iri domum ,
in qua a dornicellis de palatio magnumprandiutn paratum fuerat, in quo multirnilites et seniores sederunt. In medioprandii Domini Domini miserunt divitem
donwn novo Militi, scilicet duas inte-
gras et fòrtes armatnras ferreas, unarrt
albam cum clavellis argenteis, alterarn
vitidem cum clavellis et omamentis au-rata , duos nobiles et grandes equosAlemmanicos unum album, alterum ni-
grum\ duos roncinos-, et duas nobiles et
Digitized by Google
»4«omacas vestes armaturae superìmponen-
das. Inter prandendum projecta fuit eja
Jènestru ad populiun , qui erat in sura^
ta , magna quantitas Irageae , multi par
nes mustacei, multae gallinae et pipLo-
nes , et magna aucarum quantitas i un-de magna, et incredibili! laetitia in to-
ta illa centrata erat : et populus excl»mabat Vivai Vivati orabat, utfrequer»tius haec festivitas fieret^ cum jam es-
seni plures quam vigirUi anni, quod fa-età non fuisset. Post prandium nova*Miles Jldibrandus armatura lUa tota
alba,quae benedicta fuerat in Missa
ad auroram, armatus juit, et cum eoarmati fwrunt multi nobiles Aomines.
POStea Ildibrandus ascendit in equumalbum , et ivit ad platea/n positus in
medio a JLuchino Tastonis supranominedieta Pescolla, et a Farolfo Catenac-
cio vacato Squaràna cum omatis scu-
tiferis lanceas, et scutos deportantibus.
In platea praeparatum erat magnumtomeamentum ,
multaeque domnae et
domnicellae in fenestris erant, et multaturba populi in platea. Sex Judices tor-
neamenti fuerunt Bmnus Bonajutae »
Naimerius de Totis , Ubertus de Pai-miano dictus PoUezia , GuidoguerraMontebuorms, Bertoldus oìim Cenci vo-
catus Barbaquadra , et Nannes de Fa-talbis vocatus Man^abolzonus. HasHlu-
Redi. Opere. Voi, I, i6
*4»dium prius factum fut de torpore odcorpus cum lanceis absque ferro acuto ^
sed cum trappellis obtusis, in quo no-
vus Miles bene, et fortiter se gessit, etcucnrrit primo de corpore ad corpuscontea Jacobum a domo Bovacci , se-
cando contra Inghilfredum Gttasconissupranomine orucatum Scannaguelfos ,
tertio contra Qodentium Tagliaboves,Postea flit factum tomeamentum cumevaginatis ensibus
, et res fuit pulcra etterribilis, et tanquam vera guerra esset,
et per gratiam Dei nihil mali, ve! dam-ai accidit , nisi quod in bracchio sini-
stro leviter vulneratus fuit Philippus iì-
lorum a Focognano. Magnam autem vi-
rilitatem monstravit Pierus Paganellus ,
cui rum ex ictu ensis projecta esset ga-
lea de capite ,et remansisset cum capi-
te nudo , et absque birreto ex maculis,
noluìt tamen ex tomeamento exire , uthnneste poterai ; sed intentus ad beneagendum , et ad gloriam acquirendamscuto cooj>eriehat caput suum, et in ma-jori folta pugnantium sese immiscebat.
jdppropinquante jam vespere cum magno’ strepita tubarum indictus fuit finis tor-
neamenti ; et Judices primum premiumdederunt novo Militi , secundum Piero
Paganello, tertium Fico de Pontaneto,qui corren: de corpore ad corpus cumToniaccio illorum de Bostolis ,
lanoeaillum de equo projecerat, licei multi di-
"Dipizod by Coogic
243eerent, quod hoc non fuit ex deferta
Coniarci , sed equi ipaius;tarnen To~
niaccius de Boslolis non potuti sese exi-
mere quin depertaretur in barella deri-
soria facta de fusUs. Novus autem !di-
les swim premium dono rnisit per duos
omatos srutiferos nobili^ et pulchrae
domnieellae Alionorae,quae in Eccle-
sia cinxerat ipsi ensem militiae, et prue-
mium fuit unum braeiuni de drappo se-
riceo vermiculato. Post hoc, catti jamesset nox alta, novus miles lldibrandus
curn quant tate luminatium, et cum tu-
bis et buccitiis rediit in domum Ridol-
foni ,ubi caenavit cutn atnicis et con-
sattguitieis , et post caenam distribuit
honorifica mutiera Eidol/ono ,et omni-
bus illis.qui aliquam operum praestite-
runt. Habuerunt etiam sua munera do-
mnae et domnieellae,quae in nocte vb
giliae Ildibrando abstiterant , etc.
Haec scripsi ego Pierus Jìlius Mattel
a Pionta clericus anno aetatis meae òo.
qui vidi aliam similem solemtiitatem
,
quando anno millesimo ducentesimo, et
quadragesimo donino Papa Gregorio se-
dente , et dornno FrUlerigo imperatore
Serenissimo Imperante, Jactus fuit Mi-
les Corradus Masnaderius in Ecclesia
sanai Pieri ; sed illa solemniias non
fuit tam magnifica, quam fuit ista do-
mini lldibrandi,quae vere fuit magnifi-
eentissima ,etc.
/Deìlii «egnente scrittura che racconta
come in Firente furon falli cavalieri
Giovanni e Gualtiei-i Pancialichi ne so-
no stato favorito dal sig. conte Lorenzo' Magalotti t
che ne conserva copia in
un libro di diverse scritture antiche
raccolte da uno de* suoi nobilissimi an-
tenati.
i388. die 25. Aprìlis i388. presenti-
hus ser Dominico , ser Salvi , frate
Geòrgia.
Dominifecerunt Sinàicum ad tnilitiam
domini Joannis de Panciatichis et Gual-
tieri Jìlii Bandini,postra nominati do-
mini Bandini, et ad omnia et omnesactus et ceremonias dominum Gabrie-
lem Aymo de VenetUs capitaneum Po-
puli.
Die 2$. Aprilis i388. indictione ii.
presenlibus Aghinolfo D. GualterotU »
Bliccolò Nicolai, Laurentio D. Palme-
rii, etc. Franciscum Nerii Fioravantis
in Ecclesia sancU Joannis.
I. Caput et barbam sibi faciat fieri
pulcrius quam prius esset, etc. et voluit
prò completo haberi factum per domi-
num Capitaneum hoc modo ;quod ma-
nu tetigit barbam.
2. Intret balneum in signum lotionit
peccati, et cujuslihet vitii, etc. puritatis
prout est puer,qià exit de baptismate,
Commisit, quod fieret per dominum Phi-
lippum de Magalottis ,D. Michaelem
Digitized by Google
>4*'de MediciSf et D, Thomatium 'de Sac-
chettis , et per eos balnearetur ; et sio
halneatus fuil.
3. Statìm post balnewn intret lectum
pwum et novum in signum magnae qui»tis
,quam quis debet acquirttre virtuto
miUtiaey et per militiam, Missus in le-
cium per predictos Commiss. etc.
4. Aliquanlulum in lecto stratus; exeot^
et vestiatur de droppo albo et sericeo
in signum nidditatis , quam debet
stodire Miles libere et pure. De manda'to capitanei inAitus albo : et sic ilio
sero remansU inter tertiam et quartamhoram noctis.
5. Induatur roba vermilia prò sangui-
neyquem MUes debet fundere prò ser-
vitto Domini nostri Jesu Christiy et prò
Sanata Ecclesia. Die 26. dicti me’nie
de mane in dieta Ecclesia praesertibu»
supradictis de mandato et commissiona
capitanei exutus est ^ et indutes verm»
Ho per dictos Milites.
6 . Calcetur caligis brunir in signum
terrae , quia omnes sumvs de terra , et
in terram radibimus. Factum est de c»ligis nigris de sirico successive per dictos
tres Milites.
7. Su/gat incontineftti, et cin^tur unacinctura alba in si^um virginitatis et
puntatisyquam Miìes rmiUian debet ir»
spicere , et nuUtum procurtaa • ne fedeà
34® . .
corpus suum. Factum est , et cinxit eum' capitaneus.
8 De calcare aureo ,sive aurato in
SÌgnum promptituàinis servitii militaris ,
et per miìitlam requisiti,prout volumus
alias MihU‘S esse ad nost.ram jussioncm.
Dieta die 26. super Aren^ìteria factum
de mandato, ut supra ;per D. yannem
de Castellanis , et Nicolaum PagnozzLg Cingutur ensis in iignum seasnta-
lis contea diabolumi et duo tallii signi-
ficant directuram ‘et legalitatem ,prout
est defendere pauperem contea dtvitem^
et debilem cantra fortem. Factum per
dominum Donatum de Acciajolis.'
10. Alba infoia iti capi^ in signitm^
quod, prout debet facere opera pura et
bona, ita debet reddere animam purarn
et bonam Domino nostro, Onussiunfuitf
quia non erat infida. '
i\. Alapha prò memoria ejus,qm
Militem Jecit. Non debet Miles aliquid
v'dlanutn,vel turpe facere timore mortis,
veì carcer,s. Quatuor generalia faciat
‘M'ies. Primo non sit in loco ,in quo
falsurn judicium detur. Secando non de
proditionc tractare ,et inde discedere ,
nisi alias posset resistere. Tertio non
ubi dama ,vel damigella exoonsilietur ^
sed consulere recto, Quarto jejunare die
yeneris in menioriam Domini nostri etc.
nisi valetudine , vel mandato superiorist
etc, vel alia justa causa eie.
Digitized by Google
Dieta die a6 . 'Aprilis factus fuit Mi-les armatus Gualteriux's pnstea oh me-moriam Patrit dictus Di,minus Bandi-nus , et factus fuit per capLtaneum Sin>
dicum j etc Cah iatus calcarihus perDom. Robertum Pieri Lippi, et Dum.Baldum de i atalanis , et cinctus enseper Dom. Pazzinum de Strozzisi omniain presenzia DD. et plurium aliorumMilitum , et popoli multitudo maximafuit.
D. Joannes promisit, et juravit pròse , et prò D. Bandino , et promisit
<juando esset legitimae aetatis , infra
1 annum coram LiD. ratifìcuret , et jura-
ret.
L’ anno i3^g. a sau Dionigi in Fran-cia dal Re Carlo \l. furono falli cava-lieri , Luigi 11. Re di Sicilia . c Carlo
suo fialello, e figliuoli di Luigi I. Redi Francia colle segueuli cirimonie; co-
me si legge nell’Aulorc di una Cronacamanuscrìtla compilala ad istanza di Gui-do di Monsù , e di Filippo di Vilelte
Abati di san Dionigi , la qual Cronica
fu cominciata l’anno lòdo, e dura fiuo
al 141 5.
Ad celebritatìs fumam oris remotior»
bus di'vul^andarn in Alernunniam , et
Angliam longe ^ ìateqne per Rtgnumcursores Regi dinguntur, et nuntii, qui
utnusque sexus ingt rn.itatem ou.culo
vivae vocis , et apicibus invituìont ad
DigitizeO by Google
348.solemnitatem in villa sancii Dionisii
prope Parisidi peragendam.
Prima die mensis, qnae fuit dies sab-
bathi^ Sole jam suos deUtciabiles radios
abscondente , Rex ad locum deditum' solemnitati accessit. (^uem,\modico tem^
poris spatio interjecto , Regina Siciliae
secata est. In curru de ParisUs exiviteum ducum , miUtum et baronum mul-tìtudine erniosa
^quam etiam duo ejus»
dem Jilii Ludovicus Rex Siciliae, et Co-rolus adolescentes egregii equestres sine
medio sequebmntur, non tamen simili
apparata, quo prius soliti erant equità-
re. Nam scutìferorum priscomm cerem»nias gradatim ad ayronum ordinem a-scendentium servantes , tunica lata ta-
lari ex griseto bene fosco uterque indù-
tus erat, Quicquid v&o ornamenti eo-
Tum equi , vel ipsimet deferebant , aura• penitus carebat. Ex simili quoque pan-
no , quo ambo induti erant,quasdam
porduncidas complicatas, ac seUis equo-
rum a tergo alligatas deferebat, ut ar-
migerorum antiquorum peregre profici-
scentium speciem denotarent. In hoc sta-
tu cum matrem usque ad s. Dionqrsiumconduxissent , in secretioribus locis rmdi
in pmeparatis baìneis se mundarunt.Quo peracto circa noctU initium adRegem redeunt salutandwn , a quo be-
nigne suscepti sunti et tuno ad Eccle-
siam festinans , eo sequi se praecipit
moiOf qui tequitur. IndumentU •prue-
dictis exuti mox vestimentis novae Mi-ìitiae adomantur. Ex oloserico rubino
vestimento duplicia minutis variis fode-rata deferebant , unum de subtus rotun-
dum , ad taìos usque protensum ; alte-
rum ad modum imperialis clamydis , ascapulis ad terram dependentis. Quo ha*
hitu distinetif et absque caputiis ad Eo*etesiarn sunt adducti. Insignium virorumcomitiva praeibat, et sequebatur. Domi-ni duces Burgundiae et Turoniae adlaevam, et ad dextram^ Ludovicum Re-gem SicHiae deducebant, Dux etiam
Borboniensis y et D. Petrus de NavarraCarolimi deducebant. Et hi omnes cumRege ante Martyrum corpora sacrosan-etOy peracta oratìone cum pompa y quavenerant ,
caenaturi ad aulam regiamrediemnt. lune in mensa Regisy ReginaSiciliae y duces Burgundiae et Turoniae^
ac Rex drmeniae sedem superiorem te-
nuerunt. Ad laevam Rex Siciliae , et
frater ejus Carolus consederunt. Celebri-
que coena factOy omnibus Rex vale di-
cens, ad quiescendum perrexit. Insignes
vero adoìescentes praedicti habitu eo-
demy quo prius , ante Martyres redu-
euntuT'y ut ibidem y sicut mos antiquitut
inolevit y in orationibus pemoctarent,Sed
yquia tenera aelas amborurn tanto
labori minime correspondebat y ibi mo-
25odica mora facta , reducuntur , ut quieti
• indul^erent,
lUucesrente aurora futurorum Miìitum' ductorcs' praenominati ad Ecclesiam ac-
cedenteSf adoìescentes Reffos prosCratos
onte pignora Martyrum sacrosancta re-
peremnt^
quos ad dvmum reducrntes' e.rpectare Missarum solernnia praecepe-
runt. Hate yintissioderensis Episcopuscum convento monasterii celebrando su-
^sceperat , ut noi>ae militiae insignia•' sanctius '' conferrentur. Ad quod etiam
decentius peragerulum^ Rex brevi nobi-' lium vallatus multitudine ad Ecclesiam•
' pervenit. Duo armigeri corpori ejus cu-‘ stodes praecipui evaginatos enses per
cuspidem dejèrentes , in quorum summi-tate "laurea calcaria dependebant
y perclaustri portam Ecclesiam sunt ingressi^
quos Rex longo , et regali epitogio in-
• duCusy ac postmodum Rex Siciliae cumfratre , ordine , quo prius , sequebantur.
Qui cum ad altare Marty rum penenis-sent y ac ibidem Reginas Franciae et
Siciliae y ac caeterorum Domiruirum in-
signe contubernium expeclassenty juben-
te Rege Missa solemnis inclmatur. Hocperacto , Episcopus protinus Regem adiity
et in ejus praesentia ambo adolescentes
flexis genious petierunt , ut tyronum ad-
scriberentur numero;
qui cum eis jurm-
mentum sohtnm exegissel , eos nox'iter
accinxit baltheo militari jet per Domi-
Digìtized by Googlè
25imrm àe Chawiniaco calcoribus deaura-
tìs eos jussit Rex Carolus insignirì. Inhoc stato ' prius tamen uh Episcopo be-
neàictione perct pta , in aulam Regiamreducuntur , ubi cum Rege prandium, et
coenam acceperunt utriusque sexus evo-
cata nobilitate assistente,quae ineJJ'a-
biliter congaudens trìptidiando perno-etavit.
Die Lunae subsequente , circa dici ho-
ram nonam, sicut condictiim fuerat, Rexviginti duobus electis militibus spectatae
strenuitatis indici jussit Hastiludiorum
spectaculum,
et cum quanto apparata
possente et scirent, illud redderent glo-
riosum, Quod , et peragere maturarunt.
Nam mox in equis cristatis , auro fui-
genttbus armis et scutis vitidibus insignì-
tis, qiios etiam sequebantur qui lanceas,
et galeas solemniter vectitabant, ad Re-
gem pervcnerunt, et ibidem insignem ca-
tervam Dominarum,quae ipsorum duc-
trices existerentf dignum dixerunt ali-
quandiu praestolari. Eoe jussu Regis adnumerum Militum praeelectae , vesti-
mentis similibus ex viridi valde foscocum sertis aureis oc gemmatis culto Re-
gio phaleratis ad ejus praesentiam ad-
ducuntur. Et sicut instructae fuerant ,
de sino suo funiculos sericeos extrahen-
tes ,dulciter praidictis militibus porre-
xerunt , et eorum sinistris lateribus ad-
haeserunt cum lituis , et instrwnends
o
/
aSxmusìcis eot usque ad campum agonitea»
rum deduccnCes. junior inde martiuslitum oninu s incita tut ^ ut ref>etitionm
ictuum lancearum usque ad òo/is acca-rum laudis et probitatis tUulos mereren^
tur. '/ um dominae, quorum ex arbitrio
sententia bravii dependebat, nominaruntquos honorandos et praemiandos singu-
ìariier censuerunt. Quorum sententiamgìalanter Bex audiens, et ipsam muniJirentia solita cupiens adimplere
, prae-Jatos viros egregivs, prò qualitate meri-
torum , donis donavit ingentibus. Et ir^
de coena peracta, quod reliquum noctit
fuit , tripudiando transactum est. Mili-tari tirocìnio peraeto ^ sequens dies adsimilia exercenda vigintiduobus elecUs
scutiferis assignatury et pari pompa , utprius , a toti^m domicellis in campumducti fuerunt, ubi alternatis ictibus mu-tuo usque ad noctem conflixerunt. Coe-
naque lauta regio more est peracta ,
cum dominae nominassent quos super
coeteros elegerant praemiandos.
Quia exercitium illud mUiiare per tri>
duum statuerat exerceri , die sequenti ,
priore tamen ordine non servato , iadi/i-
ferenter mililes cum scutiferis ludum làu-
dabiliter peregerunt , et ut prius virtutU
proemia receperurU qui judicio domina-rum se habuerunt fortius : sio nox quan-
ta finem dedit choreis.
Digitized by Google
*53Sequenti die regia rejkciione percepì
ta , kex prò cujuscumque merito milites
et armigeros Liudavit non sine fliuoumunenim , mimijìcientiaeque regali ma-num porrigens liheralem, dominas et dom-nicellas atmillis , et munenbut aureis^
et argenteis, holosericisque donavit insi-
gnioribus, omnibusque cum pocis oscu-
lo valedixic , et concessit licentiam re-
deundi.
Mon sarà forse discaro agli amatoridelle antichità il soggiugnere qui lamaniera antica usata nei Regno d’ In>gbilterra, contenuta nella seguente Scrit-
tura , la quale fu data prima in luceda Edoardo Bisseo nelle sue note soprail Trattato di Niocolò Upton de Studio
\ ,
Militari, stampato in Lonara Tanno 1664. \ ./
in foglio , e poscia dal sig. tarlo Du- XPresne nel suo famoso Glossario Latino- ^ \barbaro. Io ne ho una antica copia ma- \nuscritta in carta pecora.
Cy opres ensmt Tordonnance et ma-niere de creer et /aire nouveaulx Che-nsaliers du Baing au temps de paix , se-
ìon la costume etAttgleterre.
Qiuxnt ung escuier vient en la Courpour recevoir Tordre de Chexalrie entemps de paix selon la costume d"An-gleterrei il sera tresnoblement receu parles officiers de la Cour, cormne le Se-neschal, ou du Chamberlain, s'Uz soni
'
presens ; et autrement,par les Mares-
chaulx et huhsters. Et ottone seront or-
donnez deux escuiers et onneur saiges,
et bien aprins en curCoisitìS, et nourri-
tures ,et en la maniere da fuit de che~
valine ; et iti seront escuiers et gouver-
neurs de tout ce qui appartient a cel-
luy ,qui prendra t odre dessus dit. Et
au cas,que Cescuier degne devant dts-
ner ,il servirà le Roy de une escuelle
de premier cours seulernent. Et puis les
diets escuiers gouverneurs admenerentr escuter
,qui prendra f ordre en sa
chambre sans plus estre veu en celle
tournee. Et au vespre les escuiers go-Verneiirs envcq eront apres le barbier, et
ili appareilleront ung Buiiig gracicuse-
ment appareille de tenie, aussy bien de-
dans la cuve,
que dehors. Et que la
cave soit bien couverte de tapiz , et
manteaulx,pour la froidure de nuyt.
Et adoncques sera f escuter rez la bar-
be, e les cheveulz tonde. Et ce faict les
escuiers gouverneurs yront au Roy , et
diront : Sire il est vespre , et T escuter
est tout appareille au Baing, quant vous
plaira. Et sur ce le Boy commanderaa son Chamberlan
,quii admene avec-
ques luy en la chambre de Tescuter les
plus gentilez et les plus saiges cheva-
lier, qui sont presens
, pour li^ infor-
mer et conseillier , et enseigner t ordre ^
et le fait de Chevalrie. Et semblable-
ment,que les autres escuter de Costei ,
Digilized by Google
255avec les menestrelx , voisent par devant
les chevaliers, cliantans , dansans et es-
batans,jusques a tuys de la chambre
du dit escnier. Et quant les escuiers
gouvemeurs orront la noisse des mene-
strelz j ilz despouilleront fescuter, et^le
meCironr. tout nu dedons le fixing. Maisa C entree de la chambre les escutere
gouvemeurs feront cesser les Menesirelx,
et les escuiers aussi pour le temps. Etce fait les genttlz saiges chevaliers etv-
treront en la chambre tout c.oyxment
sans noise faire : et adoncque les che-
valiers feront rrverence F un a f autre ,
qui sera le premier pour conseilUer Ces-
cuter au B.àing f ordre , et le fait. Etquunt ilz serene accordes dont yra le
premier aut Baing, et ylec s'agenoillera
par devant la cave eu disant en secreti
Sire a grani honneur soit il pour vous
cet Baing; et pois luy monstrera le fait
de r ordre , au mieux qu il pourra , et
puis mettra de F cave du Baing dessus
Fespaulles de Fescuter , et prendia con-
gie. E F escuiers gouvemeurs garderont
les costes du Baing. En mesme maniere
feront touts les autres chevaliers F unapres F autre , taitt qu ils ayent touts
fait. Et donc partiront les chevaliers
hors de la chambre pour ung temps. Ce
fait les escuiers gouvemeurs prendront
Fescuiers hors Baing, et le mcttront
an son Ut tant qiiil soit sechie, et soit
le dit lit simple som courtine* , E$quant il sera sechie , il leverà hors dulit, et sera addurne et vesti bien chauUdement pour le veillier de la nuyt Etsur tous ses draps il vestirà ime cotte
de drap rousset^ avecques unes longuesmanches y et le chapperon a la ditte
he en guise tC ung hermite. Et tescuieraùui hors du Baing, et attorne, le bar-
hier osterà le Baing , et tout ce quiia entour, aussi bien dedans camme da-
horsy et le prendra pour son Jle ensem-ble pour le collier ; camme ensi, si cest
chevalies soit conte , baron t, banerec ,
ou baehelier, selon la costume de lu
Coitr. Et ce fait , les escuiers gouver^neurs ouurerorU V t^s de la chambre ,
et feront les saiges chevaliers reentrer
,
pour mener tescuier a la chappelle. Etquant ilz seront entrez , les escuiers ,
esbatans et dansans seront admenes pardevant Tescuier avecques les menestrels
faixans leurs melodies jusques à la chap-
pelle. Et quant ilz seront entrez en la
chappelle , les espices y et le vin seront
prestz a donner aux dits chevaliers et
escuiers ; et les escuiers gouvemeurs ad-
meneront les chevaliers par devant Tes~
euier pour prendre congioy et il les mer-cira touts ensemble de leur travail ,
honneur , et courtoisies qu ilz li^ ontfait. Et en ce point ilz departiront horssia la chappelle. Et sur ce Ut etaUera
/
•Di§itize^y Google
gouvemeiirs farmeront la porte de la
chappello ,et ny demourera force les
escuiers ses gouverneurs , ses prestres ,
le chandelUcr, et le guet. Ut en ceste
guise demourera Cescuter en la chappeUle tant quii soit jour, tousiours en orai-
Sons , et prieres;
requerant le puùsantSeigneur , et la bennoite Mere
,qtte de
leur digne grace luy donnent pouvoir ^
et confort a prendre ceste haulte digni-
te temporelle en t honneur et lo vengo
de leur, de sainte Eglise, et de tordre
de Chevalrie. Et quant on verrà le pointdu jour
,on qiterra le Prestre pour le
confesser de tous ses peches , et orra
ses matines ,et messe , et pitis sera oc-
commuschie f s' il ‘ veult. Mais deptùs
T entree de la chappelle aura ung cier^
ge ardant devant liy. La messe com-inencee
,ung des gouverneurs tiendra
la cierge devant Cescuier jusques a [e-
'vangile. Et a Tevangile , le gouvemeurbaiUerà le cierge a C escuier jusques ala fin de la ditte evangile •. rescuier gon-vemeurs osterà le cierge , et le mettradevant C escuier jusques a la fin de la
ditte Messe \ et a la levacion du Sacra-ment ung des gouverneurs osterà le
chapperon de tescuier , et apres le Sa~crament le remettra jusques a Pe vangi-le In principio. Et au commencernentde la principio le gouverneur osterà le
Bedù Opere- VoU, *7
chapperon de tescuter, et le fera oster,
et lui dannerà le eteree en sa main :
mais quii y nit nn^ denier aii plus presde la lumiere fchie. Et quant ce -vient.
Verbum caro factum est, C escuter segenoillera , et offra le cier^ et le de-nier, Cest a savuir, le cierge en fon-neur de Dien , et le denier en Conneurde luy
;qui le fera Clievalier. Ce fait
,
les escuiers gouverneurs remeneroni Ces-cuier en sa cliambre , et le metront enson Ut jusques a haulte jour. Et quantil tera en son Ut, pendant le temps deson reveillier , il sera amende
, cest as-savoir avec ung couverton d'or, appellasigleton , et se sera Iure du carde. Etquant il semblera temps atta: goa-ver-
neurs,
ilz yront au Roy , et lui diront :
Sire, quant il vous plaira nostre mais-
tré reveillera. Et a ce le Roy comman-dera les saiges Chevaliers escuiers et
menestrelx dfaler a la chambre du dit
escuier pour le reveillier, attourner, ve-
stir et admener par devant lui en sasale. Mais par devant leur entree , et
la noise des menestrelz oye , les escu-
iers gouverneurs ordorvieront toutes ses
necessaries pres/s par ordre , a bailUer
aux chevaliers pour attourner , et vestir
rescuier. Et quant les Chevaliers seront
venus a la chambre de F escuier, ilz en-freront ensemble en licence , et diront
a fescuier . Sire,
le tres bon jour vqìss
25$'soit donne , il est temps de vous lever
,
et adrecier\ et avec ce les gouverneursle prenderont par les brazy et le fèrontdrecier. Les plus gentil, ou le plus sai-
ge Chevalier donnera a Pescuiersa che-
mise, ung autre lui buillera ses bragues’,
le tiers lui donnera ung porpuintj ung
autre lui vestirà avec ung Kirtel derouge tartarin. Deux autres le leveront
hors du la, et deux autres le chaulse-
ront : mais soient les chaulses denouz,
avectfues semelles de cuir. Et deux au-tres lasceront ses manches ; et ung au-tre le ceindra de la sancture de cuirblanc sans aucun hamois de metal. Etung autre peignera sa teste', et ung au-tre mettra la coiffe ; un autre lui don-nera le mantel de soye de Kirtel derouge tartarin atachiez a vec ung lazde soye blanc avec une paini de gansblans, pendus au bout du laz. Mais les
Chanccllier prendra pour sort Jìes tousles gamemens avec tout Farroy
, et ne-cessaries
, en quo)' C escuier estoit at-tournez
, et vestuez le jour qu il entraen la Court pour prendùre F ordre. En-semble le Ut
, en qui il coucha premier-ment apres le Raing , aussi bica avecle singleton
,que des autres necessices.
Pour les quels Jìefs le dit Chanceliertroverà a ses desperu la coiffe, les gans,la ceinture et le las. Et puis ce fait les
saiges chevaliers monteront a cfteval,
et aàmeneront tescuter a la sale, et le*
menestrelx tous jours devant,fuLtans
leurs melodies. Mais soit le chevai ha-hillie, camme il ensuit. Il aura urte tei-
le couverte de cuir noir, les arzons de
blatte fusi , et esquartes , les estriviers
noires , le fers dare* , le palerai de coirTtair avec urte craix patee daree pen-dartt par devant le piz du chevai , etsans croupiere , le frain de noix a lon-
gues cerres a la guise de Espagne, et
urte craix patee au front. Et aussi sait
ordonne tmg jeune Jovensel escuiergen-
til, qui chevauchera de^rant Pesctòer.
Et il sera dechapperortnè , et pareràT espee de P escuier avec ies esperons
pertdans sur les eschalles de P espee, et
soit Pespee a blanches escltalles faictes
de blanc cuir , et la ceinture de blatte
cuir sanz Itarnois; et le Jouvencel tien-
dra P espee. par la poignee , et en c»point chevauclterartt jusques a la sale
du Ro)\ et seront les gauvemeurs presta
a leur mestier. Et les plus saiges che-
valiers menaut le dii escuiers; et quant
il vieni par devant la sale , les mare-schaulx , et huissiers se seront presa es
Tencontre de Pescuies , et lui dirons De-scendez, et lui descendra. Le Maresca.1
prendra san chevai pour fie , ou C. S.Et sur ce les chevaliers admenerent Pe-scuier en la sale jusques a la haultetable
,et puis il sera dresciez au cem-
Oigitized by Googl(
mènctment de la tahìe seconde jusquet
a la venite du Boy, les chevaliers de
coste lu^' t le Jouvensel a bout , [espeO
estant par devant luy par entro les diti
deux gouvemeurs. Et quant le Boy sera
veni* a la sale , et regardera C escuter
prest de prender la hault ordre de di-
gnità temporelle , il demanderà f espee
avecques les esperons. Et le chamher*’
lain prenera C espee, et les esperons duJuvencel « et les mostrerà au Boy \ et
sur ce le Boy prendra Fesperon dextre^
et le haiìlera au plus nome et plus gen-
til , et luy dira: Mettez cestuy au tal-
lon de tescuier. Et celhy sera agenoiU
He a Tun genoil, et prendra Fescuierparla jambe dextre^ et mettra son pied sur
son genoil , et fichera F esperon au tal-
lon dextre de Fescuter. Et le seigneur
faira croix sur le genoil de Fescuier, et
liy baisera. Et ce fait viendea ung au-
tre seigneur, qui Jìchera F esperon autallon senestre en mesme maniere. Endonques le Boy de sa ttes grande cour-
toisie prendra F espee , et la ceindra aFescuier. Et puis F escuter leverà ses
braz en hault, les mains entretenans
,
et les gnns entre le pous et les droiti
et le Boy mettra ses bras entour le col
de Fescuier , et lievera la main dextre,
et frapperà sur le col , et dira : Soyes
bon Cnevalier, et pois le baisera. Etadonques les saiges Chevalies adrrtene
ront le nouvel chevalier a la chappeUea tres prende melodie jusque au haulù
autel. Et ilecques se apenoillera^ et met-
tra sa destre main dessus Vauteì. Etfe-ra promisse de soustenir le droit deSancte Eplise tonte sa vie. Et adoncquesoy mesme deceindra tespee avec gran-de devotion , et prieres a Dieu, a Sain-
te Eglise , et Toffreira en priant Dieu,et a tous set Sainets
,quii puisse gar-
der rordre,
qii il a prins , jusquez a la
fin. Et ceo acompliz prendra une soup-pa de 'vin. Et a la issue de la chapelle
le maistre queujc du Roy sera prest deoster les esperons , et les prendra pourson fie , et dira : Je suis vena le mais-tre queux du Rc ' , et prens vos espe-^
rons pour mon fie , et si vous faites
chose cantre T ordre de Chevalrie ( queDieu ne vueille ) je coupperay vos es-
perons de dessus vos talons. Et puis le
chevaliers le remeneront en la sale. Etil commenceta la table des chavaliers.
Et seront assis entour luy les cheva-liers ^ et il sera seny si camme les au-tres ; mais il ne mungerà
, ne ne boira
a la table ^ ne ne se mourra, ne ne re-
gardera ne deza ne de la, non plus
que une nouvelle mariee. Et ce JeU ^
ung de ces gouverneurs avra ung cueverchef en sa main qu il tiendra par da-
• vant le visage, guani il sera besoing
pour le craisier. Et quant le R<y}'' sera
'•teve hors ile sa table , et passe en sa
chambre', adoncques le nouvel chevalier
sera mene a grant fàison de chevaliers^
et menestrelx devant Iny jusqucs a sachambre. Et a tentree les chevalters et
menestrel.x prendront congie , et il rraa son disner. Et les chevaliers departiz^
la chambre sera fermee et le nouvelchevalier sera despouille de ses pare-
mens, et il seront donnes aux Roysdesheraulx , s'ilz sont presens , ou si non ,
aux autres heraulx , s'ilz y sont , autrc-
meni -aux menestrelx, avecques ung
mare di' argent, s' il est bacheler, et si
il est bacon, le doublé. Et le rousset
cappe de niyt sera donne au guet, aU'
trement au noble. Et adoncques il sera
revestu tTurte robe de bleu , et les man-ches de custote en guise (T un prestre
,
et il aura n t espaule senestre ung laz
de bianche soye pendant.. En ce blano
laz il porterà sur tous ses habellemens
qii il vestirà au long de celie journee,
tant quii alt gaignie honneur, et renom(T armes , et qu il soit recordes de si
' hault record ,camme de nobles cheva-
liers , escuiers et heraulx ef armes, et
quii soit renomme de ses faitt darmes,
comme devant est dit , ou aucun haultPrinc
, ou tros noble dame de pouvoircouper le laz de t espaule du chevalier
en disant'. Sire nous avons ouy tant deurt^' renom de vostre honneur, que vous
avez fati en diveries partìes , au tret
grand honneur de Chevaìrie a vous mes-me ^ et a cehy qui vous a /ait cheva»Iter, que droit. veult, qua cast laz voussoit ostes. Mais apree disner les clteva-
lier tf honneur , et gentil hommes vian-
dront aptes le chevalier, et le admene^
ront en la presence du , et les es~
cuiers gouvemaurs par devant luy. El Is
chevalier dira : Tres noble et redoubteSire, de tout ce, que je puis , vous re-
mercie , et de touts ces hormeurs , cour-
toisies et bontez,que vous
,par vostre
tres grande grace, rnavoiz fait, et vous
en merde. Et ce dit, il prendra cangiadu Roy. Et sur ce les escuiers gouver-
ncurs prendront congie de leur maistre
en disant : Sire , cela nous avons fait
par le commandement du Roy , ainsi
corame nous feusmes obligiez , a nostre
pouvoir. Mais s 'd est ainsi, que nous
vous q)'ons deplu par negligenze , oupar faict en cest tamps , nous vous re-
querons pardon-. tTautrepart, Sire, comrme uray droit est, selon les coustumesde court , et des royaulmes anciens ,
nous vous demandoru robes et Jies aterme de camme escuiers du Roy, com-paignons aux bacheliers , et aux autres
seigneurs. Fra Jacopo da Cessole Domi-nicano , nel suo libro del Giuoco degli
Scacchi al capitolo del cavaliere , testo
ft penna della Libreria del sig. Dottor
Digìtized by Googl
a65Oinseppe del Tef’Iia , fa menjHotae par*
ticolare de’ cavalieri bagnati , e de’ mi-
steri contenuti nelle cirimonie , che si
costumavano nel ])rendersi quell’Ordine
di cavalleria. Questi . colali cavalieri t
ifuaruio si formo cigaera la spada della
cavalleria , se si bagnano in prirruif ac-
ciocché menino nuova vita e novelli co-
stumi. Vegghiano la notte , che sonobagnati , in orazione , addomandandoda Dio , che per grazia doni loro quel-
lo che manca loro dalla natura. Permano di Be, o di Principe son fatti ca-
valieri novelli , acciocché da colui , di
età debbono esser guardiani ^ ricevano la
degnità e le spese. In loro dee averesapienza , fedeltate, liberalitate
, fortez-
za , misericordia ,guardia de' pupilli «
telo delle leggi ; acciocché quelli , che
sono armati di' armi corporali , sieno
splendienti di costumi-, perocché quantola degnità de' cavalieri avanza gli altri
in reverenzia e in onore , tanto dee egli
più rispìendere di costumi e di virtudi
,
e di soperchiare in ciò V altre persone ;
conciossiacosaché V onore non è altro
,
che rendimento di reverenzia in testimo-
nianza di virtudi. Guglielmo Caradenonella sua Brittannìa afferma , che era
totalmente andata in disuso cosi fatta
maniera di cavalieri. Milite^ balnei, di-
ce egli,qui niultis balneorum , et vigi-
liarum caeretrwniis adliibitis,
patrum
memoria creati fuerunt , setens omitlo «
quod hic ordo jampridem exolevisse vi-
detur. lo non so quel che fosse ne' tem-pi , ne* quali vivea il Camdetto\ so be-ne , che il Re d’ Inghilterra Carlo fra-
tello del regnante ne* giorni della suacoronazione fece molti e molti cavalieri
bagnali, o del bagno, colle solite anti-
che cirimonie , e non mollo dissimili
dalle sovraccennate.
Pag. 21 . V. 25. Cavalier sempre bagnato
Plauto nel Pseudoio alt. 5. se. r. fa
diré a rseudolo, che si accorge di esser
briaco. Profecto aedepol ego nane probeateo maduìsg. Paolo 1’ abbreviatore di
Pesto gramatico alla lettera M. Madusa
( che lo Scaligero da Plauto rassetta
Madulsa ) ebrius , a graeco paìfàt de-
ductum (che vuol dire bagnare, annaf-
fiare) vel quia madidus sit vino. E ve-
ramente i briachi , e quei che aveanbevuto a sodo da’ Latini cran chiamati
madidi , e madore l’ esser ubbriaco
,
o aver bevuto assai . Tibull. lib.
eleg. I. — 2 .
Vina diem celebrent, non festa luce
madoreEst ' rubòr i errantes et male ferre
pedes.
I
Digitized by Google
267E nello stesso lib. 2 . éleg. 5.
j4t inadidus Boccilo sua festa Palilia
'postar
Concinet
Ovidio nel terzo deU’Arte :
Turpe jacens mulier multo madefactaJj^aeo,
Uvidns disse ancora Orazio lib. 4. od. 5.
ad Augusto :
Longas o utinam , Dux bone , ferias
Praestes Hesperiae , dicimus integro
Sicci mane die : dicimus avidi^
Quum Sol Oceano subest,
Uguccione Pisano manuscritto del testo
antichissimo del sig. Anton Maria Sal-
vini alla voce Uva : Sed humidum est
quod exterius habet hnmorem ; uvidum^quod interius , et operatur. Uvidi ap-presso Orazio vale lo stesso , che pieni
mezzi di vino ; e asciutti pel coritrario,
quando non s’ è ancor bevuto. Da Lu-ciano nel Bacco ^t^aarJurpéyoi viene ado-
perato nello stesso senso di madidus , edi uvidus
,
cioè d’ imbriacato , e concio t
dal vino; onde nel Ditirambo si è detto
Cavalicr bagnato ad imitazione della
(rase de' Greci e de' Latini.
s6BPag. 2 T. T. 2.^. Cavalier sempre bagnato
Che il vino bagni il polmone fu ere*
doto da’Filosofi , e dello da’Poeli, comeho accennato verso il principio di que-ste Annotazioni. Il Ronsardo si vuol farbagnare da esso vino il cervello:
Et sovent haigner mon cerveauDans ìa liqueur tTun vin nouveau.
E forse in un certo modo lo prese daquello , che si legge presso i Latini :
multo perfusus tempora Baccho. Seno-fonte di più nel Convivio fa al vino ir-
rigare , e innaffiare T anima tà yó.potti ò oìfoc àpdap ìpvxàf, rà( aèv Av-«ràc , o(Txtp ò pavdp^ópat avjpóxvt
,
tcoipiies ; Poiché in effetto il vino innaf-
fiando r anime , siccome la mandragolaassonna gli uomini , così esso le cure.
Mnesiteo Medico Ateniese presso Ate-neo lib. II. esorta per la sanità a bere
qualche volta più liberalmente del soli-
to , a fine d’ innacquare gli acidi , chelascia nel nostro corpo il soverchio man-giare
; xatavi^tTou. yàp tò aòpa roti
olvoii, poiché, dice egli, viene a ba-gnarsi , e lavarsi il corpo co’ vini.
Pag. 21. V. 26. Per cagion di sì belt or-dine
\
Guitton d’Arezzo , manuscritto Redi :
Digitized by Google
Pt'acemi Cavaìier ,cìie Dio temendo ,
Porta lo nobil suo Ordine bello ;
E piacemi dlbonare donztdlo ,
Lo cui desio è sol pugnar servendo.
ig. 2I.T. 2g. Potrò seder col mio gran
padre a mensaUn antico costume de’ Longobardi noa
permetteva, che i figliuoli del Re si tro-
vassero a mensa col padre, se prima
non erano siati armati cavalieri. Paolo
PParnefrido de Gest. Longobard. lib. j. \
c. 2Ì. Cum peracta victoria^ Longobardi|
ad setles proprias remeasscnt , Regi suo {
Audoin suggerunt, ut ejus Alboin con- *
viva fieret, cu/us viitute in praelio, vie- '
toriam cepissent ; utque patri in peri-
culo , ita et in convivio comes esset.
Quibus Audoin respondit^ se hoc face-
re minime posse , ne ritum gerUis infrin-
geret. Scitis enim, inquit, non esse apudnos consuetudinem , ut Regis cum patre
Jìlius prandeat ,nisi prius a Rege gen-
tis externae arma suscipiat. In una ce-
na , che fece in Parigi Carlo V. Re di*'
Francia a Vincislao Re de’Romani figli-
uolo di Carlo IV. Imperatore F anno
1878. alcuni Duchi non poterono esser-
vi ammessi, perchè non aveano l’onore- '»
volezza dell’Ordine di Cavalleria. Au-tore della Cronaca intitolata : Entreveve
de Charles IV. Empereur, et de Charles'
V. Roy de Fruuce: Le Rqy mena soùp- .
J
per avec luy le Roy des Romaint, et
les ducs , seigaeurs et chevaliers, qui
estoient venus uvee luy\ et eut trescanti
soupper preste de gens ìT estat. Lt futt assietta ielle qu il ensuyt. L' Evesque
de Paris premier , le Roy , et puis le
Roy des Romains , le due de Berry\ le
, diìc de Brabant, le due de Bourgogne^
le due de Bourbon et le dite de Bar.
Et pour ee que deux autres dues n es-
, toient pus chevaliers ,ils mangerent en
un autre table, et leur teint compaignie
messire fils du Roy de Navarre , le
comte d‘ Eu , et plusieurs autres sei-
gneurs.
n ^
Pag. zr. . 3i. Fatta meco immortai, ec.
Nel Codice Teodosiano Ub. a. tit. i,
leg. 7. Mulieres honore maritorum erigi-
mus ,et nobilitamus. Ulpiano Giurecon-
sulto nel lib. 6. de’ Fidecommissi citato
ne’ Digesti al titolo de Seualoribus : Fae-
minae nuptae clarissimis personis cla-
rissimarum personarum appellatione cory
tinentur. E nello stesso titolo al princi-
.pio lo stesso Ulpiano lib. (iz. ad Edi-
ctum : Consulares autem faeminas dici-
mus Consularium uxores.
Pag. 22. Y. 2. Il sangue che lacrima il e-
invio, \
‘ Parla di quei vini rossi del Regno di ,
' Napoli , che $on chiamati lacrime » tea|
-Digitized b^Googl^
.
^7 *
le quali stimatissime son quelle di Som*ma, e di Galitie. Le lacrime d* Ischia ,
di Pozfuolo, di Nola, d'Ottajano, di No-
cella e della Torre del Greco son tenu*
te in minor pregio, ancorché sieno mol-
to gagliarde e putenti. II Chiabrera cou'
impareggiabile graziosissima gentilezza
scherzò intorno al nome della lacrima :
Cìà fu àc contadini il si indiscreto,
Cìi a sbigottir la genteDiede nome dolente
' Al 'vin , che sovra gli altri il cuor falieto ?
Lacrima dunque appellerassi un riso^
Parto di nobilissima vendemmia ?
t
Nel secondo libro dell'Antologia il vinovien chiamato lasrime della vite.
t, V t -Os •* ‘ *V "
Pag. 22. V. 6. La Verdea soavissima cCAr-cetri
La migliore Verdea che faccia intor-
no a Firenze è quella della collinetta
di Arcetri. Di essa volle intendere il
Rinucetni :
I
Lascia il Trebbiano ^ e la vendemmiaancora
,
Onde cotanto Arcetri oggi s* onora.
E dopo lui Romolo Bertini Fiorentinonelle Poesie manoscritte:
V
i
Digìtized by Gooj^'
>7» ì
Versate ornai versate,
Anfore preaose in questi vetri ,
Manna^ di Chianti , e nettare dArcetri,\—* -
I vini , che da’ nostri anticlii Toscani si
chiamavano vini verdetti erano moltodiifcrenli da quello , che si sia oggi la
verdea. Imperocché per vino verdetto
intendevano qualsisia sorta di vino bian-
co , che non fosse dolce , anzi fosse bru-
sco ; e lo raccolgo dal Maestro Aldo-brandino partii. I. cap. 3. del Bere. Ilbuon vino naturale si è quello , ec, cheha savore intra dolce e amaro e ver-
detto. E appresso : Molte nature sono ,
che amano meglio vino Verdetto , vioébruschetto. E nel cap. dello stomaco :
Deesi guardare di bere vino troppo al-
to e potente , ma bealo verdetto e pic-
cioletto. Forse di tal fatta sono oggi i
verdischi e i verdischetti di Napoli , e
Sue’ vini altresì , che da’ Frauzesi sou
etti verds e verdets. Pasquier nelle Ri-
cerche della Francia. 8. 43. Enlanibò^nous eusmes des vins infirùment verds.
Ma la verdea di Toscana non è cosi
chiamata dal sapore verdetto, ma bensì
dal colore pendente al verde. I Latini
parimente , ed Ì Greci aveano vini di
color simile. Plinio lib. 14. cap. 1. favel-
lando de’ vini : Hic purpureo nitent co-
lore , illic fulgerU roseo ,nitent^ue viri-
di. Euripide nel Gclope: Oix otn
Digitized by Gaogic
pai ^on elei vin le verdi sul-
le. E Fiitreatiao uelle Geopouicue lib. 6 .
fa tneazloiir; il’ uaa speziti d’uva biauuanomiaata cioè verdetta.
Pag. ZI. V. 6. D'Arcetri
Ne’ canti caruescialeschi è detto Nar-cetri-, forse dal dirsi sau Matteo in A.r-
cetri è venuta l’n. della particella in a
restare addosso all’ a. della voce se-
guente.
Pag. 22. V. 8. LapperòVilla deliziosissima del Serenissimo
Principe Francesco Maria ài Toscana^dove s’ imbottano vini preziosi di diffe-
renti maniere per la diversità de’ viti-
gni, e per l’ artifizio secondo il costumedi varie nazioni.
Pag. 22. V. 12. Mezzograppolo, e alla Fran-cese
Vin Rullato, e alla sciotta
Fiorentino , uno degli autori Geopo-nici , insegna la maniera di tare il vinoalla Tasia ; e Beruzio ,
ciu^ un Geopo-ico da Baruli , la ricetta per fare il
Tino alla Coa : in Catone similmente èil modo di fare il vino alla Greca al
capitolo , che ha per titolo : VinutnGraecum quomodo fiat.
Redi. Opere. Vol.l,’ i8
»74Pag. 22. r. 14. Soleggiato
Il modo di fare il vino soleggiato
trovasi appresso Didimo nel libro sesto
degli autori Geoponici descritto cosi :
Nella provincia di Bitinia cosi fannoalcuni il vin dolce. Trenta giorni avanti
la vendemmia torcono il tralcio che hagrappoli, e lo spampanano affatto per
modo, che percotendovi il sole consumi
T umido : e fa dolce il vino ,come se
fòsse posto a bollire al fuoco. Torconopoi i tralci a fine di staccare i grappoli
dalt umidità , e dal nutrimento della
vite ; e non piglino f umido di essa.
Ma alcuni dopo aver nudati i grappoli
dalle foglie ,e che cominciano ad ap-
passire , vendemmiando P uve,pongono
ogni grappolo dispersè al sole, finché
tutte si appassiscano. Poscia levandole
sulla sferza del caldo, le portano al ti-
no ,e ivi le lasciano il restante del gior-
no, e tutta la vegnente notte; e la mat-
tina vegnente le pigiano. Soleggiato an-
cora era il vino che si faceva alla ma-niera Tasia, Geo|)od. lib. ottavo.
Pag. 32 . . tfl. Gavazzandoli FeiTari alla voce Gavazzo cita le
Glose Latino-greche , in cui Gaviso
jiaipe. Sicché dal Ialino Gavisare
,
che
gli Spagnuoli dicono gazar, sì è fatto
gavazzare.
Digitized by Googlc
P«g. 22. T. ig. Gareggiamo a ehi più ùn~botta
11 Poliziano nella favola d’Orfeo :
Voi imbottate come pevere ;'
.
'
r vo bevere ancor mi. ’•
Pag. 22 V. 20. Imbottiam senza paura ^
Senza regola, o misura
E più sopra :
Tracanniamo a guerra rotta,
Macedonio nel lib. secondo dell’An-tologia :
X(tr9ovÓTOit at^Xtfrilptf ììkj^h
'£pYa, (xriaopsr iiXaaei~
Ltapiv axitSovTtf dpti9da dopa Xvaiv.
Tracannare è j(av9oxiyreh>. A guerrarolla ; corrisponde a quello xvxtXXopà-
eìXaxititt, Senza regola , o misuraspiega queir àtpezdéa dopa Xvaiv.
Pag. 22. T. 24. LuiUn yalen^omo ha voluto affermare
,
che lui, uou si jSossa dire agli animaliirragionevoli , ed alle cose insensate
, esenza auima. ?(ulladimeuo si trova tal-
Tolta osato negli autori del buon seco*
lo. Il Petrarca son. 107.
Unirne belle , e di virtute amiche
Terranno il mondo , e poi vedrem lui
farsi
Aureo tutto y e pìen delC opre antiche.
E son. 114,
Pommi ove il sole uccide ifori e ferite,
O dove vince lui'l ghiaccio e la neve.
E son. (84.
Così mi sveglio a salutar f aurora
,
B 7 sol , cA’ è seco , e più f altro ondeio fui
Ne'primi anni abbagliato, e sono ancorai
r gli ho veduti alcun giorno ambeduiBevarsi insieme , e'n un punto
, e 'n
uri ora
Quel Jar le stelle , e questo sparir lui.
E canz. Sg.
Se già è gran tempo fastidita, e lasse
Se di quel falso dolce fuggitivo ,
Che il mondo traditor può dare altrui ;
A che ripon più la speranza in lui 7
11 Boccaccio giorn. 5. noT. 9- nuin. n.
Qli forse agli occhi il suo buonjalcon^^
ìt t/uata nella sua salletta viac sopra là
stanga. Perchè non avendo a che altrò
ricorrere ,presolo , e trovatolo grasso t
pensò lui esser degna vivanda di cotal
donna. Dante nel Conviv. Il perso è uncolor misto di purpureo e di nero , nuà
vince il nero , e da lui si denomina»Vit. sant. Ànton. Trovoe uno antro mol-
to scuro cavato nel monte ^ e fissando
gli occhi entro di lui , comincioe a darbaci. Anco del pronome addiettiro co-stui vi fu chi scrisse, che non si dire1>
‘ be di cosa inanimata , nè di animalefuor della spezie dell’ uomo , e pure il
Boccaccio nel Filocopo lib. 5 . 67. farei*
landò dell’uccello Smeriglio: leggiamola Jìne di costui , s' egli avrà tanto vi-
gore, che da tutti la difenda. E lib. 6,
parlando di un anello: Z/a virtù di co-
stui credo , che il mio periclitante legno '
ajutasse. E nell’ antico rolgarizz. della
Bibbia manuscritto Genes. cap. B, Noèaperse la finestra dell arca , la qualeaveva fatta , e si mandò fiori il corba,
ec. Ma Noè dopo costui mandò la co-
lomba,
Pag. 22. T. 25 . La spranghetta
Aver la spranghetta si dice di cdlord^
i (fuali avendo soverchiamente bevuto
,
sentono gravezza ,o dolore di testa nel*
lo svegliarsi la mattina seguente dal son*
no. Cosi fatta spranghetta vien disegnata
Digilized by Google
*78. da Plinio , OTC de* vini Pompe)ani del• regno di ISapoli favella nel lib. 14I cap. 6.
Dolore edam capitum in sextam horamdiei sequends infesta deprehenduntur.
Pag. 2S. V. 27. V anatomico Bellini
11 sìg. dottore Dorenzo Bellini Letto>
re di Notomia nell’ Università di Pisa ,
e celebre per tante belle e dottissime
opere Anatomiche e Mediche , le quali
ha stampate ; è celebre altresì per lasua forte e robusta maniera di poetare.
Qui si allude al libro intitolato GustusOrganum.
Pag. 28. V. g. P'ite bassa e non bronconeVite bassa in Latino si direbbe forse
vids capitata. Broncone vitis brachiata ;
onde forse è detta broncone. Ma il
cabolario della Crusca più veridicamen<
te la fa venire da bronco. Columel. deRe Rustie, lib. 5 . cap. 5 . ydlii capitata^
vineas , alii brachiatas magis probant.
In queste ultime si lasciano più occhi,
e si pota lungo : nelle prime si potacorto, e si lascia uno, o due occhi soli
nel ceppo della vite.
Pag. 28. V. 12. Villanzone
Con isponde alla parola, colla Cjuale
son nominali da'Latini gli abitatori del-
le rupi, villani nati sulle montagne ra-
pices f rupicones.
Digitìzed by Gopgl
279;
Pag. 23. V. 17. Maritolla ad un broncone
,Maniera noiissimaT' usata ancora da’ t
Latini. PHn. lib. 14. cap. 1. delle viti.
• In Campano <7»ro populis nubunc, wa-
ritastfue complexac, atque ramos earumprocacibus bracìiits genirulato cursu scan»dentes , cacumina aequant. E lib. 17.cap. 24. Maritare ni\i 2>alida^ inimicum,enecante veloci vitìum incremento. Oraz.lib. 4. od. 5 .
• Rt 'vitem viduas ducit ad arhores.
-xT'
Pag. 23. T. 22. E ne scaccia senza strepito
Ogni affanno . ..
^
yinacreonte disse , che quando Bacco!eli viene in petto, ev9vmr ai pepipvai.\'-<
Ed il vino da un Poeta citalo da Ate~^neo fu detto srawirtAwTof quasi Posa/-^
fanni,
Pag. 28. V. 24. GiaraVaso di d istailo senza piede con due
manichi per oso del bere. È voce por»
tata io Italia dagli Spagnuoli. 11 Covar-
ruvias nel tesoro della lingua Castiglia*
na : Jarra , vaso ventrudo con dos asas.
E ivi medesimo: jarrìlta , yjarrillo,far
ros perqitennos E appresso: farro comu-nemente se toma por el vaso de tierra,
an que echamos vino , o agita; y dezi-
mas un farro de vino , o un farro de
r
•V
|V
/\
3
Digitized by Google
I
yvJ \
yA
280
afiua. Un gentilissimo mio amico , e ai*
giiore mi ha severamente, e ad alta vo-ce sgridato
,perchè io permetto a Bacco
bere il vino ad una giara ^ e mi ram-menta , die la delicatezza e la civiltà
moderna vuole , che le giare sicno de-stinate a bevervi Tacque, e non il vi-no. Ha ragione, e parla secondo la gen-tilezza del suo spirito nobilissimo
; mai bevoni
,quando son già imbarcati ,
non guardano a tante sottigliezze : cosapiù ]>Iebea è lo attaccar la bocca al fia-
sco , ovvero bere al boccale; e pure i
bevoni soventemente vanno cantaudo quel-la notissima canzona :
// buon vin non fa mai maleA chi'l beve allo boccale.
Ed il coro di Bacco appresso il CavalierMarino nell’ Idìllio delTArianna :
Ma di gioja io vengo meno ^
Se'l tracanno a sorso pienoNella fiasca col crò crò ,
Fa buon prò.
I
E come si legge nelle Cento No^ìelleantiche nov. 22. Andando lo 'mperadorFederigo a una caccia con vesti verdi
,
siccome era usato, trovò un poltrone insembianti a piede iT una fontana , edavea disteso una tovaglia bianchissima
I
Digitized by Googit
' ju terba verde ^ ed avea suso un tomonoie con vino , e suo mangiare molto
polito, ho 'mperadore giunse , e chieseli
bere. Il poltrone rispose con cìte ti da-re' io bere ? A questo nappo non ti por-
rai tu a bocca’, se tu hai corno, del vi-
no ti do io volentieri. Lo 'mperadore ris-
pose,prestami tuo barlione , ed io be-
rò per convento, che mia bocca non vi
appresserà. E lo poltrone li le porse , etenneli lo convenente. E poi non II le
tendeo, anzi spronò il cavallo, e faggiocol barlione. In questo luogo delle No-velle antiche osservo quel bere per con-
vento
,
che vale bere senza toccare il
vaso colle labbra , come ottimamentehanno spiegato gli Accademici della
Crusca nel nuovo Vocabolario della ter-
za edizione , che presentemente sì stam-
pa , il che non osservarono in quello
della seconda. Vant. Rinal. Montalb. Si
trasse la barìlozza da cintola, e porsela
allo cavaliere, che per grande pulitezza
volle bere per convento. Guitton d’Arez-
zo lett. 5z. ho bere per convento allo
nappo altrui non ee tuttogiorno mon-dezza : lo vino sovente si spande gii^
per lo seno. 5S-Pag. a 3. V. 27. Chi ambrosia e nettar non
invidio a GiovePaolo Silenziario nel secondo libro
deH’Antologia in proposito del vino si
Digitized by GoogU.<3
2^2assicnra a dire, che gli pince tanto, chepurché d’ abbia sempre , lascia ad unaltro r ambrosia :
àfi^ponfiv d’àAAoc «;!;«>’ idéXot.
Pag. a3 . V. 29. Di vigne sassosissime To-scane
Virg. Georgica :
Mitis in apricis coquitur vindemia saxis,
Giovanvettorio Soderini nella Coltivazio-
ne Toscana car. 2. Tutti gli agricoltori
convengono in parere, che i sassi sieno
amici alle viti. E car. 1 1. Tutti i terreni
sassosi in qualunque sito o di piano, odi poggio, ec. ricevono le viti lietamen-
te , e generano saporiti e gagliardi vini.
Alberto della nobile famiglia Fiorentina
de’Rimbotti celebre Medico dc’suoi tem-
pi soleva dire : vino nel sasso : poponein terren grasso.
Pag. 24. V. 6. Acqua bianca
0 per la limpidezza, o per cagione\
della spuma , ad imitazione di Omero , \
che nel 2Ì. dclFIliade, nel r|uinlo del- \
l’Odissea, e nella Batracomiomachia die- /
de tal epiteto di bianca all'actiua vdaat^
^evxò, che pure nella stessa Bafraco- >
miomachia ben due volte, e nell’inno \
< secondo di Pallade chiamò purpurea '
Digiiized by Google
283
v9(t<n voppvpémffi- itop<pvpéot(.
^ppoUonio Argon. 4. vcrs. 916 . ad imi-
tazione d’ Omero :
9è •xoppopéoio 9'ot9uaTOf . . ,
E Furio antico Poeta Latino appresso
j4gelUo criticato da Cesellio indice gra-
matico, e difeso dal medesimo Agellio'.
Spiritns Euronim viridcs dum purpurat
undas :
quasi forse volesse dire /«? yà hiancìie ,
e spumanti per T af^itazione , e per lo
scambievole frangimento. Si può adat-
tare alla spiegazione contraria , comesoggiugnerò qui appresso. Orazio col
chiamare purjiurei i cigni, che sono
bianchissimi , h.a data una gran fatica
a’ suoi Commentatori, tra* quali l’anti-
co Porfìrione: Quomodo purpurei dicun-
tur , cum albi sint potius ;sed purpii-
reum prò pulchro poetae dicere assueve-
rune , ut J^irgilius :
Et prò purpureo poenas dot Scylla cO“
pillo.
Et alibi:
Jn TTUire purpureum violentior affluit
amnis.
Ma sia detto con pace Porfuion» ;
E
284non mi pare, ebe alcuno di questi doéesempli provi il suo intento. Perciocché,quanto al primo ; è nota la favola diNiso e di Scilla , e si può vedere dalPoema di intitolato CeirU dalnome dell’ uccello, in cui fu convertitaScilla, in pena di aver tosato il capellolorporino
, che si vedeva sul capo delle Niso suo padre
; ove si preude il
colore di porpora in realtà , e non permetafora : e Tibullo mostrando quantograndi sieno le forze de’ versi dettati da’
ininni Poeti , che fanno credere ciò chevogliono di coloro, cui essi imprendonoa lodare :
Carmine purpurea est nisi coma : carmi»na ni sint ,
Ex humero Pelopis non nituisset ebur.
Onde siccome fu un trovato di Poeti
,
che Pelope avesse una spalla posticcia
di avorio ;così ancora che Niso avesse
quel suo crine di por|H>ra vera e reale.
Quanto al secondo esemplo di Virgilio
addotto da Porfìrione, non è manco fal-
so, che mare purpureum voglia dire ma-
re belìo ;anzi vuol dire tutto ’l contia-
rio ,cioè mare torbido e nero per la
copia delle ac<jue , che in lui s’ ingros-
sano: che così spiega Didimo il xopipv-
peo* d’ Omero , cioè che JtOit(pvprov si-
gnifichi pfXav in que’ versi dell' Iliade
Dlgitized by Google
285
lib. I. 48 *' ® 48>- Ed Emtazio
deir edii. Romana a car. i3j. nel fine,
ne rende la ragione dicendo, che sicco*
me il sangue si dice purpureo , così an-
cora il fiotto del mare;
per essere il
rosso fondo tirante al nero. Le parole
sue sono: ctopfvptop 3t tcvfia , àìxì
xov (téÀav. àtFitsp xai alfia xopfpvpfov.
toixan yàp orde ipfo tà jj^óuara.
Ijrei iyyvi (itXaviaf ««ri tó xopfvpovf.
E SuMa alla lettela E. è<pv^paivetau
ui7{,aittrai. Quindi è che Omero in tre
luoghi dell’lìiade chiama purpurea to-
lendo dir nera:
’EMafis %op(pipeo( àdfaroc:
E noi Toscani contrapponghiaroo al vi-
no bianco il vino vermiglio , che i La-
tini dicono atrum, il che è rimase agli
Aretini , i quali ancor oggi al vino ver-
miglio ,o rosso dan nome di nero; sic-
come fu dato r epiteto di nero al san-
gue in molti luoghi dell’Iliade, nel ter-
zo dell’Odissea e negl’inni. Poteva con
più accortezza Porfirione, jper provare ,
che purpureo in lingua de’^Poeti valeva
lo stesso che belht addurre il luogo del-
r Eneide :
lumenque juventae
Purpureum^ et laetos oculit ajflarat ho-
npret.
286Sebbene gli si sarebbe anche in questopotuto rispondere, che il Poeta per lucevermiglia di gioventù intende il fiore
del sangue più brillante; e che purpu-
reo per se stesso non vuol dir bello, se
non aggiunto a quella luce, che è ma-dre della bellezza e della venustà; la
qual luce per avventura Virgilio stimò,
<me consistesse nel sangue; e perciò
chiamolla purpurea.
Sbrigatomi da, Porfirione 'non voglio
tacere di Acrone altro antico commen-tatore di Orazio
^
il quale per un ordi-
nario suol dire meglio di Porjìrione;
anzi quel che ha di buono Porjìrione ,
sembra che lo abbia tolto da Acrone.Dice dunque cosi; Purpureis ales olori-
bus. Nitidis aut pulchris , aut ReginaeVeneri dedicatisi ut prò regno purpu-reos dixerit. Questa è una lunga trac-
cia , che il sentir nominare la porporaabbia subito a far venire in cognizione
d’uno de’ titoli di Venere, cioè Reginoi
e che,
per essere i cigni i cavalli del
suo reai cocchio, abbiano perciò ad es-
ser detti purpurei , se non avessero, co-
me i cavalli de’ gran signori , le cover-
tine di scarlatto. Ma ciò non mi reca
maraviglia, quando considero la straor-
dinaria licenza de’ Poeti , i quali nomi-nando, per cagion di esempio, aristas
y
vogliono, che nel nostro cervello si fac-
cia tutta ([uesta filastroccola di nomi ;
Digitized by Google
per reste s’intendano le spighe del gra-
no, per le spighe si vengano a intende-
re le ricolte; per le ricolte le stati; per
le stati gli anni. Ma quello spiegare di
Acrone jnrpuri is per nitidis , aut pul-
chris mi sembra molto natui ale; poiché
siccome Venere , |er esser tenuta Dea -
della grazia, bella, amabile, perfetta,
è chiamala soventemente da Omeroà(ppodÌTi] dalla bellezza e splen-
dore e pregio deH’oro; cosi noi Tosca-
ni diciamo a una persona compita, av-
venente , di garbo ;eli’ è una coppa
d’oro, un signor d’oro, e similmente
un libro d’ oro (presso i Latini aureo-
lus libellus) nella stessa guisa, giacché
il vestire di porpora era cosa appresso
gli antichi magniBca , e da Re, e comedicono i Greci Xafnrpà
,
i Latini e i
Toscani splendida , si senti Orazio trat-
to a chiamare i cigni , che hanno piu-
ma si vaga, netta e rilucente col titolo
di purpurei. Se però non si volesse cre-
dere ,che ne’ secoli antichi trovavast
una sorta di porpora bianca da Plutar-
co mentovata ,come osservò il dottissi-
mo Tanaquil Fabro.
Se non fosse un trattare un Poeta da f
troppo pratico , anzi disperato cacciato- \
re, potrei dire, che Orazio chiamò i ci-
gni purpurei non per alcuna delle sud*
dette ragioni; ma bensì perchè in realtà
si trova una razza particolare di cigui,
Digìtized by Googlc"1
*88i quali hanno il capo , il collo ed il
petto coperto con penne bianche sin alla
base ^ ma che tutte nella loro punta , oestremità, son tinte d’ un colore dorè, orancialo, il qual colore è molto più ac-
ceso , e talvolta rosseggia in quelle delcapo. Sembrerà strano questo mio detto
non essendovi stato alcuno Scrittore, chelino ad ora abbia osservata questa se-
conda razza di cigni , come 1’ ho io
molte volte veduta, ed osservata nell’oo-
casione di trovarmi alle cacce del Sere-
nissimo Granduca mio Signore. Due so-
no le razze de’ cigni. Quegli della pri-
ma razza sono di tutti gli altri maggiori
di corpo e di peso , ed arrivano alle
trentasei , ed anco talvolta alle quaran-
ta libbre fiorentine , che hanno dodici
once per libbra. E questi portano nella
parte superiore del rostro verso la base
una pallottola nera , e grossa quantouna ciliegia; e tal pallottola da’ caccia-
tori è chiamata il cece ; e da esso cece
vien creduto dal volgo , che i cigni sie-
no stali da’ nostri antichi appellati ce-
\ ceri. Hanno questi tutte le loro pennebianchissime ; ma i piedi son neri , edil rostro , che pure è nero , alquanto
rosseggia. I cigni della seconda razza
son minori di corpo , e meno pesanti
,
giacche tanto tra’ maschi,quanto ancora
tra le femmine , non ne ho mai trovato
alcuno che arrivi al peso di veatisette
aiviLioogle
libbre: ma tutti si trattengono dalle 22.
alle 26. Questi non hanno alla base del
rostro quella pallottola, o cece nero, edil loro rostro , ancorché sia nero , egli
è tempestalo tutto di macchie gialle : e
questi son quegli , che nel collo, nel
capo e nel petto hanno le penne tinte
di quel color d' arancia matura, che
forse fu cagione di fargli nominare pur-
purei. Ma,
per dire uno scherzo , nonvoglio tralasciar d' accennare , che for-
se quegli uccellacci^ destinati al carro
di Venere non erano veramente cigni
,
ma bensì grotti , bianchi come i cigni,
toltone alcune penne dell’ ali , che son
nere ; i quali grotti , avendo pendente
.
dal rostro quella loro grandissima e stei^
minata giogaja di colore d* accesissimo
schiatto , dettero occasione ad Orazio
di nominargli purpurei. >Se i commen-tatori volessero credermi questo scherzo,
potrebbon poi farsi onore , col soggìu-
gnere , che i grotti meritamente, e con
|
gran misterio furono destinati al servi-|
zio di Venere: imperocché essi non han- '
no voce, ed ancorché sieno grandi quasicjuanto i cigni , contuttociò hanno unalingua così piccolissima , e la portanoCOSI nascosa , e lontana dalla gola , chefa di mestiere usar diligenza per ritro-
varla ; onde alcuni Scrittori hanno cre-
duto che non 1’ abbiano. £ cosi non|
Redi, Opere. Vol.I, ig
n-jitized by Google
39®,
avendo lingaa, nè voce , non avrebbonpotuto rilevare le segrete galanterie del-
jla padrona. .
Pag. 24. V. 7. TonfanoRicettacolo di acqua ne’ fiumi lè do-
ve ell’è più profonda.
Pag. 24. V. 7. O ne tonfani sia brunaNe* tonfani 1’ ac(|ua sembra nera , o
bruua per la profondità, onde jipollo-
nio nel quarto deH’Argouaut. vers. 617.
ìraraftòf,
cioè fiume nero per la profondità. Evers. 1574. dello stesso libro:
Keiffi ptv xórtoio iiriXvnt , ifHa pi~Xttra
Bsv^oC àxivfitov psXavti.
Appresso di Teocrito il fanciullo Ila ,
attignendo l’ acqua dalla fonte per la
cena di Ercole e di Telamone cadde,tiratovi dalle tre Plinfe nell’acqua nera,xarripiirs 9 ’
è( péÀ,av v<top. Tralascio dimentovare Coiaio Smimeo nel terso li-
bro vers. 576. siccome ancora Omero , \
che in più di dodici luoghi dell’ Iliade,|
della Odissea e degl’ Inni chiamò nera[
1* acqua non solamente del mare , ma <
«quella altresì de’ fiumi e delle foutaaci1
Dlgitizedby Google
intorno a che è da leggersi lo Scoliasce
Didimo , ed Eustazio. 11 colore dell’ ao<
qua detto da' Latini aquilus è spiegato
per bruno. Pesto Pompeo: Aquilus color
est fuscus et subni^r, a quo aquila
dieta esse videtur, quamvis eam ab acu-
te volando dictam volunt. Aquilius au-
tem color ( che forse ha da dire aqui-
lus') ab aqua est nominatus. Lo ScalU
gero su questo passo cita il Glossario
,
che dice: Aquilum, (sé^oiv , \uxiX-ÀOi ;
quindi adduce due versi di f'^ar-
rone nel libro della fine del mondo:
Atque AEgeus Jluctu quam laiùt anteaquila ,
Saevus ubi posuit Neptuni filius urbem.
E dottamente aggiugne , che l’ aquilus
Jluctus di Varroue suona lo stesso , cheil vàop di Omero. Ma il nostrotnaggjor Poeta per altra cagione diedetitolo di bruna all’ acqua nel ad. delPurgatorio :
Tutte r acque , che son di qua piàmonde»,
Parrieno avere in se mistura alcunaPresso di qtiella, che nulla nasconde'.
Avvegnaché si muova bruna brunaSotto r ombra perpetua
,che mai
Radiar non lascia sole ivi, nè luna-
>92Pag. 24. T. 2?. ZoA' pur F acque àel Nilo
Filostrato nelle immagini, ovvero pit-
tare , descrive una certa storia , che si
contava delle maraviglie di Bacco fatte
nell’ isola d’Andros. ^gH Andrii ^ dice
egli, per virtù del Dio Bacco, la terra
pregna di vino scoppia , e fa loro na-
scere un fiume , il quale, se tu lo con-
sideri , come i fiumi ordinarii , non giu-
gno ad esser grande : pensando,che è
vino , sembreratti un grande e divino
? fumé ;poiché altri , attignendo da quel-
l lo ,può dispregiare con ragione il Nilo,
\ e F Istro tutto quanto , e affermare di
I essi , che molto parrebbero migliori , se
più piccoli fossero , ma con tali acquecorressero.
Pag. 25 . V. 16. U acqua cedrata. Sia sban-deggiata
Pel contrario nel Ditirambo delFA-rianna inferma io ho detto :
Corri, Nisa, prendi una concaDi majolica invetriala-.
Empita , colmala d' acqua cedrata;
Ma non di quella , che il volgo si cionca-.
Ma se vuoi, Nisa, farti un grande onore.Togli di quella , che iF odor si pierux
Serbasi per 1 1 bocca del Signore ,
Che te contrade delt Etruria affrena.
Questa ò F idolo mio , e il mio tesoro^
È questa è il mio ristoro -.
Digitized by Google
E mentre cìl io la bevo , e cK io V in-
gozzo,
E, per dir più, la mastico e la ingollo.
Fatti di conto ,io ne berci un pozzo
;
Ma come un pozzo vorrei lungo il collo.
Pag. 25. T. a5. DelTAlosoiaBevanda costumata dagli SjMgnuoli, e
introdotta in Italia. 11 Covarruvias: A-loxa es una bevida muy ordinaria en eltiempo dCEstio, becha de agua, miei, yespecias. Vedi quivi.
^
Pag. 25. V. 25. Del CandieroE una sorta di bevanda moderna men*
te inventata. Fu per ischerzo gentilmcn*te descritta nella seguente maniera dal*l’illustrissimo sig. conte Lorenzo Maga-lotti :
Tuorli uovo cotti appenaSbatti in tersa porcellana
,
E se vuoi cosa sovranaQuanto sai sbatti, e dimenaiPoi metti zuccheroPiù assai ét un pizzico'.
Torme un gran bucchero i
Non fare a spizzico !
foco nuischio , ed ambra in chiocca ,Penti , otiirita ei hotmni .
Monda un par di limonciniSol per ggasa. dellà~^occa ;
*94Poi lastia stara
A riposare.
Finché r orlare
Fien tutto fuorp ;
Aliar con flemma"
( Cosa importuna ! )Trascegli , e leva
Ad una ad unale bianche foglie
De' gelsomini ;
Le verdi spoglie
De' limoncini ;
Indi i adacrfua
Con dimoifacqua
,
E rimaneva , S\Finché si veggia \ p. JIncorporato ^Eimescolato ^
Quel soave ojorosetto*
Gentilissimo brodetto
Proprio degno di Ciprigna :
Per finissima stamigna
Che forensi anche puivagne,Mentre in breve puoi vederla f
Digilized by Google
Si:
/ ‘-
.
X
E di giefcangiarsi in neve.
Or di questo bel lavoro
D' assetati almo risWffSul mezzo giorno^ j, /
Bella trincierà‘
jilsane intorno
La soirbettiqrjii
E quando vedi ,
'
Che intorno intorno
Gelido nastro
Fa ’l vaso adorno ,
Con un cucchiajo in man di terso or-
genio
Tosto il distacca
E il ridistacca ^
Perchè'l vedrai rifarsi in un momento %
Finché bel bello
Rimescolando ,
Questo con quello*1 0
Tra gelato , e non gelato ^ )
Vedrcù farsi in pià (T un loco ,
E serrarsi appoco appoco
Come un latte ben quagliato \
nominato'j
Tal chiamollo il Siciliano ^
Che pria V fe contro la sete
Del signor di Carbognanot
Pag. 25. T. ult. E non par mica vergogna
Tra' bicclùeri impazzir sei volte F annot
II Maestro Aldobrandino pari, i . cap. 3.
Non dee t uomo bere tanto ^ che diven»
ga ebro , tutto sia ciò che molti filosofi
dicano , che esser ebro due^ voltejl me»^
je è santade, perciocché dicono, che la
Jorta del vino distrugge le superfiuitadi
del corpo , e le purga per sudore e perorina. Tibull. lib. 2. eleg. i.
. . . . non festa luce madereEst rubar, errantes et male ferrepedes.
y Impazzire fu chiamato il bere da Ana-\^creante', e Bacco stesso si chiama •
vópevot come scrive Ateneo sol bel prin<
cipio del lib. i 5 . Yedi.Qraz. lib. 2 od. 7.
lib. 3 . od. 28. lib. 4. od. 12. Plin. lib 14.
cap. 22. e Seneca de Tranquillitate
,
che disse : Aliquando vectatio , iterque
vigorem dabit,conmctusque
, et libera^
lior patio ; nonnunquam et usque adebrietatem veniendum , non ut mergat
non', sed ut deprimat curas : eluit enimcuras , et ab imo animum movef. et ut
morbis quibusdam , ita tristitiae mede-tur. Vedi Platone lib. 2. e 3 . delle leggi.
Vedi Agellio lib. i 5 . 2..
* ’
Pag. 26. T. 4. Avallo questo , e poi queir^
'.. r altro vaso
1 Franzesì dicono avaller un verre.
ella stessa formula si valsero i Pro-
venzali antichi. 11 Maestro Aldobrandi-
cd by Google
297no frequentemenle costumò di servirsi
del verno avallare in significalo di be-
re ^ d inghiottire , <T ingollarci Avallare
è quello che Seneca , ma in proposito
di mangiare, disse demittere. Sed ardeof
tes boietos,
et raptim condimento suo
mersatos demittunt pene fumantes, quosdeinde restinguant nivatis potionibus. Enella materia del bere il Poliziano ;
Ognun gridi Bacco Bacco ^
E pur cacci del vin giù.
Pag. 26. V. 8. ZamberluccoE una lunga e larga veste di panno
colle maniche strette, la eguale, invecedi bavero , ha un cappuccio cosi largo,
che può coprire la lesta , anco quandovi è il turbante de’ Turchi, o il caqiac*
co de’ Greci : e se ne servono i Turchie i Greci portandolo sopra tutte l’ altre
vesti in tem])o di freddo , o di pioggia.
I Turchi in lor lingua lo chiamano .7ia<
murluk donde è nata la voce zamber-lucco degl’italiani, che da poco io quahanno comiuciato ad usare una tal ve-
ste nella stagione più fredda.
Pag. 26. V. i3. Quali strani capogiri
IVel Cicalamento di Maestro Bartolinodal Canto de Bischeri fatto in uno de’
solenni stravizzi dell’ Accademia della
Crusca : Domandatene Purcograsso , e
ig8yannaccena, il qual» nel suo libro DequalUatibns , et proporCionibus dice , il
vino sovente esser cagione di parla^ia^
parletichi e capogiri , ed in somma di
moie altre girandole.
Pag. a6. T. i 5 . Pormi proprio^ che la terra
Sotto i piè mi si raggiri.
\ / Il Cìclopo briaco appresso Euripide :'
%!
O d' ovpavóc poi avppepiyjiévof 9oasij
T17 yq (pépsaSttu. j
Pormi che 7 cielo colla terra unito
Con essa lei si giri.
II Mureto nel Galliambo sopra Bacco;
tJideri ut nemus odalo procul ùnpete
rapitur ?
Humus ut tremens frequenti salit acta
tripudio ?
Pag. 26. . 19. Lascio la terra , mi salva
nel mare* Fa qui a proposito la storia raccon-
tata da Timeo di Tarmino , e riferita
da Ateneo nel lib. i. di coloro nella
città di Gergenti in Sicilia , che per
r ubbriachetza impazzati, gittavani dal*
: le finestre le robe della casa , credendo
idi essere ia mare jiericolando, e perdi
convenir far petto delle mercanzie; on-
de la casa loro fa nominata Tpii^ptK
,
come se noi dicessimo la nave, o la ga- /
lera.
Pag. z6 . V. 20. ^ara vara quella gondolaVarare vale propriamente tirare il
navilio da terra in acqua , come si puòleggere nel Vocabolario della Crusca ^
ed in tal significato se ne servirono an-
cora gli antichi Provenzali. GramaticaProvenzale manuscritta libreria di san
Lorenzo: Varar, mittere navem in pela-
gum. Quindi parrebbe forse credinile
,
che varare sia detto da vadaer', e Vir-
ilio nell' Eneida dà il nome di vadaall' acque del mare :
.... sulcant vada salsa carinae.
Ma, ancorché varare significhi tirare il
navilio da terra in acqua, nulladimenoLuca Pulci nel cant. 4. del Ciriffo Cal-
vaneo 1' usò per accostar la nave alla
terra, acciocché le persone di essa navepotessero sbarcare :
Venne la notte , onde di nuovo afferra
Il porto ; e i venti lo sen’on leggieri ;
Varò la barca, e'I pover mise in terra
Con quei cavalli, e con tutti gli arcieri.
E nel vanto di Rinaldo da Montalbano
3oo- manuserìtto Redi : Essendo già vicini
alla terra, vararono la nave quasi sdru-
cita , e smontarono nello lido deserto.Con questi esempli si può correggereMorgante 2o. 49* testo stampato ia
Firenze dal Sermartelli , dove si legge :
Greco surgeva , e varcava la barca :
Orlando lo pagò cortesemente.
dee leggersi varava, e non varcava.
Pag. 26. T. 21. Ben fornitaFornita in questo luogo vale provve-
duta , corredata di tutto quel che biso<
gna. I Provenzali se ne servirono nello
stesso sentimento. Gramatica Provenzaledella libreria di san Lorenzo: Fornir,necessaria dare. Onomast. Provenzaledella stessa libreria. Fornir , dar quelche bisogna.
Pag. 26. V. 28. Diporto
Trovo la voce dij^rto ne’ Poeti e ne*
Prosatori Prove)izali. Periol
,
o PietrodAlverina libreria san Lorenzo :
Ben ai aimaìs qeu sospir, e qeu piai-
gnaiQab paoc lo cor non pari
,qan me ro-
cori
Del bel solaz , del ioi , e del deport.
Digitized by Google
3ot
Giraldo di Bomello ael priaciplo di
una sua canzone :
De chantar ab deport
Me /or en toz lassaz :
Mas guani soi bea irati ,
Estenc r ira ab lo can ,
£* vau me conortan.
Storia della Bibbia In lingua Provenza»
le , manuscritto di Francesco Redi : L>a
mullber del Rei ffarabo anaves ab sos
J/ils deportan per a guella orta, e vee-
ren a guella caxeta.
Pag. 27. V. 5 . Oh beir andare
Ber barca in mare.
Finge Euripidea che al Ciclopo imbrlacato |
* da Ulisse pareva di andar per mare a|
sollazzo , come una barchetta.|
t
Pag. 27, V. ig. Passavoga, arranca, arranca
Ottimamente il Vocabolario della
Crusca. Arrancare. Da anca. Propria-
mente il camrmnare , che fanno con
fretta gli zoppi , o sciancati ; dicesi al-
tresì delle galee ,guando si voga di
forza , che è lo stesso , che andare avoga arrancata. Gramatica Provenzale :
Rangueiar claudicare. Kella St<)ria della
Bibbia in lingua Provenzale del mioantichissimo testo a penna : Li^tant Ja-
3o2cob ab r angel , donali tangel una fo-nda en r amjua , si qise la li encodor-mi, e per a quella farida fo Jacob ren-qualos. E di qui prese 1’ etimologia la
voce ranco ia signilicato di zoppo
,
quando se 'ue desiderasse un’ altra dif-
ferente da quella accennata nei princi-pio di questa annotazione. Trovo la vo-
ce ranco nell’ antico libro della curadelle malattie. (Questi son ranchi e stor-
piati per lungo tempo , non ae rimedio,
Pag. 27 . V. 28. MandolaPuò esser forse che sia detto dal la-
tino Pandura, sorta di strumento musi-cale. La voce nella primiera sua origi-
ne è Assira , siccome ancora 1’ inven-zione dello strumento , che era di tre
corde : e ne fa testimonianza Giulio Poi-luce nell’ Onomastico dedicato da lui aCommodo Imperatore lib. 4. cap. g.rpij(pp<iov Se, oxep àmrvpiot xavUovpavÓv6pa4<y> > intitoir d’ xai tò evpqpa.Di qui si fece il verbo pandurizare
,
di
cui si servi Lainpridio nella vita d’EIio-
gabalo. Ipse cantavit, saltavit, ad tibias
dix.it,tuba cecinit, pandurizavit
, orga-
no modulatus est, come da molti è sta-
to osservato. La Pandora de’ modernimusici è strumento di dodici corde in
sei ordini. 11 Mandolino ha sette corde,
e quattr’ ordini.
3o3Pag. 27* V* 28. La eucciarucù
Canzone così detta, perchè in essa si
replica molte volte la voce del gallo; ecantandola si fanno atti
, e moli simili
a quegli di esso gallo, come si può ve-
dere nella Tiorba a Taccone di Felip-
§0 Sf'ruttendio da Scafato stampata inapoli nel 1646. e ristampata nel 1678.
alla corda nona in quella canzonetta, la
quale comincia :
Ferma su. Mosto Paziezo,Ca facimmo na Lucia.
1 due grandi Oratori della Grecia Ipe-ride e Demostene, volendo rappresenta-re la voce ed il verso che fa U gallo,dissero xoxxv^ei» , come afferma Pollucelib, 5. cap. i3. La maniera di rappre-sentare co’ moti del «orpo animali di-versi fu assai , ne’ loro scherzi
, Umilia-re agli antichi ; e facevano il lione
, lagru e la civetta, come pur testifica /»o/-luce nel lib. 4. cap. 14. dove raccontale varie spezie di saltazioni co’ nomi lo-
ro. E ve n’era una, che dal conlralfarsiin diverse forme di animali
, lacendoatti e smorfie a ciascuna ragione di essiappropriate , si chiamava fiopipao/ióf.Vedi Benedetto Fioretti nel volumequarto de’ suoi Proginnasmi cap. 37.
3o4Pag. 28. T. 22. Soatenossi tempesta fieris-
sima
Bellistiimo è l' epigramma di Callima-
eo riferito da Ateneo nel libro secon-
do, dove si dice, che il vino eccita nel
nostro cor{)0 una tal tempesta,
qualesuol essere nel mare della Libia.
Pag. 28. V. 24. SbuffaNella Gramatica Provenzale. Bufar,
ore insufflare. (Jnomasi. Provenz. Bu-far, buccis inflatis insufflare. Himar.Pmvenzale. Buf, idest insufflatio. Diqui ha origine la voce buffone in signi-
ncato di vaso di vetro tondo, gontìo di
cor|H) , e cortissimo di collo per uso di
mettere in fresco nell’ acqua le bevan-
de: e parimente buffone, cioè giullare:
e buffetto in sanificato del colpo di undito, che scocchi di sotto un altro dito,
e suol darsi nelle gote gonfiate : e buf-
fetto altresì aggiunto di pane: e bufera
e rabbuffare e rabbuffo. Tra gli Aretini
bufare vale lo stesso che nevicare conTento. Vedi quel che accennai nelle
Origini della lingua Italiana del signor
Egidio Menalo alla voce beffa stam-pate in Parigi l’anno 1669. appresso Se-
bastiano Mabrc Cramoisi in quarto , e
quelle deir ultima impressione dell’ an-
no i 685 . in foglio.
Digilized by Google
« 3o5Pag. 28. t. 32 . Gitta spere ornai per poppa
Gettare spere. Fare spere. Mettere spe-re è termine marinaresco de’ nostri an-tichi. Morg. cant. 20 . 35.
Subito messori per poppa due spere ^
E 7 mar pur sempre di sopra su passa,
L’Ariost. cant.. 19 .
Rimedio a questo il buon nocchier ri-, -aei,
.
trova
,
Che comanda gettar per poppa spere^E caluma la gomona ^ e Ja prova
~~
Di due terzi del corso rattenere.
«Nella Tavola ritonda
, manuscrittodella libreria di s. Lorenzo : Niente gio-vava loro gettare ancora, ne potevanometter rimedio ne per timoni, ne per
, vele calare in orza, di che li marinari,per lo migliore
, facevano allora spera,
e la nave si lasciano andare alla vo-lontà, e alla signoria de' venti. Vita s.
Anton, manuscritto: Per lo ultimo rime-dio si risolverono a fare spera, e poi siabbandonarono allo mare. Messer t'raa-cesco da Uarberlno ue’ Documenti diAmore :
t, 't
'
Jn luogo di timoni
Fa spere , e in acqua poni.
Redi. Opere, Voi. l.
*
. •
\
Digitized by Google
3o6Sopra di che le Chiose dello stesso cita*
te da Federigo Ubaldini. Speras. Ugan-tur enim plures fasces ,
et proijciuntur
in a/fuas retro naves,ut non sic naves
currant fractis themonibus;et dicuntur
tperae yquasi res quae faciwit tardare
progressum. Può essere, che si dicessero
spere,
quasi che fossero 1’ ultime spe-
ranze nelle tempeste. Che gli antichi di*
cessero alcune volte spera invece di spe-
ranza ne può essere testimonio ArrigoBaldonasco ,
manuscritto di FrancescoRedi:
Chi al suo presio si prova ,
Ogni altro va morendo:Però tutto mi arrendo :
A lei ,eh' è la mia spera :
' Spero in leiy che si trova, ec.
Lo stesso Poeta nello stesso manuscritto:
Amor novellamente
M' a preso in tal mamera ,
- Ke con tutta mia spera
M' a fatto servidore
Di voi, donna piacente,
£ di gran senno altera.
Ruggierone da Palermo, mannsorittp
Redi:
£ tutta la mia spera è posta in lei.
Digitized by Google
I Poeti Provenzali dissero esper^ cbe
vale totalmente lo stesso di spera de’nostri Toscani. Emblanchacet nella can-zone che comincia : Lonzament m'antrabaillat, e mal mes , ses nul repausAmor en son poder^ ya dicendo ‘ del me-desimo Amore ;
Mais el me tea gai, e en bon esper.
Giraldo di Bornello, manuscritto di
sau Lorenzo :
Per lo gmt, e pel comanDeh treis
( cioè degli occhi e del cuo-re ) e per lor plazer
Nais amor ,<7’ en bon esper
Vai SOS amics conjortan.
Raimondo Giordano Visconte di san-t’Antolino :
E pìaz mi molt, car sai, car vostromso ;
Qiins bon esper de vos mi ten iauzen ;
Qab bon seignor nos perd ricz guazerdo,,Qui gen lo serf.
Tra le voci della marineria moderna viè il cavo della speranza
, che è un ca-napo grossissimo, serbato nelle navi pergittar r ancora negli estremi bisogni* Ilsig. Anton Maria òalvini avendo cuusi-
3o8dcrato , che ^ttare spere è termine ma*rinarcsco liell’Adriatico , e avendo letto
elle Origini del Ferrari, Spera. Suppo-situm , turunda ad solvendam alvum ,
quod in spitam convoìvatur, va conget*
turando, che, siccome la cura, o sup-
posta vien chiamata spera, per essere
un volgolo , cosi possano essersi dette
spere quei fasci legati e avvolti, che si
gittano in mare per arrestare , e ratte-
nere la nave , dal latino, spira. Greco,tnrtlpa
,
con che si signilica ogni cosaravvolta , c che abbia giri.
Pag. 29. V. I. Orcipoggia,
Messer Francesco da Barberino ne*Documenti di Amore :
Manti, prodani e pioggia ,
Poppesi ed orcipoggia.
Le Chiose. Orcipoggia. Furtes,
quibusvelae Irahitur, cum nimium vend
essent. Nel Vanto di Rinaldo da Mon^talbano del mio testo a penna si leggeOrzipoggia.
Pag. ag. v. 9. StoniMesser Francesco da Barberino ne*
Documenti d’Amore :
P se un Sion repente
J'ient che subitametUe
Digitized by Google
Rontpe , spezza e rivoìge ;
Ben fa ì se a Dio si volga
Oirni anima : che solo
El ti può torre duolo.
Credono i marinari , che il Sione noni
sia altro, che una guerra di due , o dii
più Tenti d’ uguale , o poco differente\
possanza tra di loro , i quali urtandosi»
e raggirandosi in allo aggirano ancora I
le nuvole;
quindi con esse nuvole ca*
landò in mare , e raggirando 1* acqua , I
e assorbendone molta , stimano , che ilj
Sione vada crescendo e rigouiìando, e
che sia possente in quel ravvolgimento L
a far perire il vascello. Son da vedersi
r opinioni de’ Filosofi del nostro secolo.
Delle ridicolose e vane superstizioni co- i
stumate da’ marinari per tagliare, come /
essi dicono, il Sione, sarà bello il ta-
cere.
Pag. 29. V. 12. I cavalli del mareCavalli in termine marinaresco si di-
ce a que’gonfiamenti dell’ onde, quandoil mare è in fortuna, che con altro no-
me son chiamati marosi, fotti di mare,ec. ed oggi più comunemente son detti
cavalloni. Giti lo Giudice Storia Troja-
na: I.e disavventurate navi s' avviluppa-
no tra gli ondosi cai'alli. E quivi me-desimo : Cavalli del mare da venti si
levano in ffranài montagne ; dorè forse
volle esprimere quel di Virgiììo :
. . . insequitur praeruptus aquae mons.
Pag. 29. V. i5. Che noi siam tutti perdutiSan Giovan Crisostomo , o coi si sia
il rappezzatore dell’ Omelia contro la
gola , e contro l'ebbriachezza , intitolata
%ef>ì yatTpi(iapYÌOi<;, «ai /tedile , chiamal’ebbriachezza con nome di naufragio.
I luoghi son degni d’ esser veduti,per-
chè queir Omelia veramente è un rap-pezzamento, e un ricucimento di varj
passi di più Omelie del Santo , tutti
concernenti alla stessa materia.
Pag. 2g. V. 20. Ma mi sento un pò più sca-
rico
Pel contrario carico si dice di chi habevuto di soverchio. Antic. annotar. Bibb.
manoscritta : Oloferne era un po carico
dal vino. Firenzuol. Asin. lib. 3 . Tor-
nando jersera un poco tardetto da ce-
nar fuor di casa ,essendo assai ben ca-
rico , ec. cosi del cibo come del vino.
II lesto latino : Quum a coena me se-
rius aliquanto reciperem potulentus. Untal caricarsi volendo spiegar Virgilio
disse impleri :
Implentur veteris Bacclùy pinguisque fa-
rinae.
Digitized by Google
3it. E Plauto alla comica disse saburrali
preadendo la metafora dalla zavorra
,
con cui si caricano le navi. Cistell. at. i.
. scen. I.
Idem mihi , magnae quod parti est vi*-
tium mulierum ,
- Quae hunc quaestum facimus ; quae ubi
saburrale swnusyLorgiloquae extemplo sumus : plus lo--
quimur quam sat est.
£ appresso :
- Quin ego nane » quia sum onusta meaex sententìa ,
Quìaque adeo me compievi flore Làbari^
Magis libera uti lingua conlibitum est
mihL
I Fiorentini soglion dire cena leggiera.
Andar leggieri a letto , e simili.
Pag. 29. V. 2r. Io già rimiro
Mirare , rimirare vale lo stesso, che
guardar fissamente ,guardar con atten-
zione, L’ etimologia del verbo mirare è
da leggersi nelle Origini Italiane del
Ferrari. Appresso i Provenzali antichi
mirar significava lo stesso, che guardarnello specchio. Nella Gmmatica Pro*
vernale del testo a penna della libreria
di san Lorenzo : Mirar, in speculo inspb
3ixcere. Nel Vocabolario Tolosano: Mirail»
là, mìrer, regarder au miroir. Quindimi fo a credere , che la voce miratore
usata nel Tesoro di ser Brunetto Latini
2 . i8. IjUca tanto vale a dire quantomiratore, e lucente, non significhi colui,
che mira , conforme scrissero i Compi-latori del nostro Vocabolario della Cru-
sca ; ma tengo , che debba interpretarsi
specchio ; e ne ritrovo un simile esem-pio nel mio testo a penna delle Lettere
di Fra Guittone dtArezzo, lett. 5. Cre-
do , che piacesse a lui di portar voi tra
noi per fare meravigliare, e perchèfoste{specchio e miradore , ove se provvedes-
se , e agienzasse ciascuna piacente e va-
lente donna. Lo stesso Guittone \c\X. i3.
invece di miradore disse eziandio mira-
glio. Carissimi, del mondo miraglio sie-
te voi ; tutti nel mondo magni ; a cui
s' affaccian tutti i minori vostri, e dela forma vostra informan loro. Ma il
verbo smerare, che si trova negli autori
più antichi vale depurare , nettare, pu-
lire: siccome raddictlivo smerato signi-
fica netto , limpido e trasparente. Nel-
r antico Trattato della Sapienza, manu-scritto : Quella fontana è si chiara e sì
smerata , che 7 cuore conosce , e vede
se , e suo Cteatore ; siccome t uomo si
vede in una bella fontana ben chiara
e ismerata. Queste voci capitarono in
Toscana dalla Provenza. Himar. Provenz.
«
/
3i3• della libreria eli sari Lòrenio : Esfnera
,
depurai', e di qui forse venne smeriglio,’
pietra , colla quale si brunisce 1’ acria-
* jo , e si puliscono i marmi ; se però- non fosse un volgarizzamento del greco
ffUiptf.
Pag. 2q. V. 24. SantermoDicono i marinari ,
che nelle più spa-
ventose fortune di mare suole sovente-
mente verso ’l fine di esse apparire unacerta luce , o splendore
,il quale si po-
sa sopra gli alberi, o sopra l' antenne,o sopra le pale de’ remi del navilio ; e
questo splendore è chiamato da essi ma-rinari la luce di Santermo, ovvci’o di
Santelmo. Gli antichi greci e latini fa-
voleggiando crederono , che fossero le
stelle di Castore e di Polluce, e altresì
di Elena. Alcuni de’ moderni pensano,che sia una esalazione spiccatasi dalla
moltitudine degli uomini del vascello.
Altri dicono essere un genio buono, cheannunzi il fine della tempesta. Altri ungenio cattivo , che , dando speranza di
salute a’naviganti ,brami d’ essere ado-
rato. Certuni s’ immaginano , che quelpoco di barlume di luce
, che al volgo
stordito dalla paura par di vedere sugli alberi e sull’antenne, sia un effetto
de’ raggi solari , che percuotono sull’an-
tenne,o sulle funi incatramate ,, nelle
quali dopo la tempesta,
soglioa rima-
3i4nere quasi sempre molte Iwlle d’acqua,
che a guisa di specchietti sodo abili a
rendere alcuni ri dessi luminosi. Cert’al-
tri ,ancorché abhian navigato tutto il
tempo di lor vita, affermano non essersi
mai imbattuti a vedere cosi fatta cosa ;
e la credono un trovato del semplice e
credulo volgo, il che fa molto a nro|K>»
sito i)cr confermar 1’ opinione dell’anti-
co Metrodoro citata da Plutarco nel 2.
de Placit. l marinari cristiani , come
che venerano per loro protettore san-
t’Elmo vescovo Siciliano, tengono fede,
che sia un soccorso del santo loro pro-
tettore. 11 Covarruvias nel tesoro della
lingua Castigliana crede, che questo no-
me di Santelmo sia nome abbreviato di
santo Erasmo; e di qui può esser nata
la voce Santemio.
Pag. 3o. V. 4. Sarà sempre il mio miffnone
Mignone significa amico, intimo, fa-
vorito; e non è voce nuova in Toscana.
Fra Giordan. Pred. ,manuscntto. Fol-
gele occhi della mente a Patroclo
. mifftone del Re Achillrs , e a Efer.tìo-
ne , che fue mignone del Re Alessan^
dro.
f Bem. OrhI
1 Or fatti liberar dal tuo mignone.
Digitili- ay Google
3i5
Luigi Pulci fMorg.‘ 24* 5o«
Disse Ulivieri : a te si vorrè dare
Tanto in sul cui ,che diventasse rossQ ,
E farti a Gano il tuo mignon frustare.
Che ^ ha sempre trattato , come uomgrosso.
Duca Pulci, Cirifft CaWan. cani.
Cosi dair altra parte par che attenda
Il Re Luigi al suo mignone, o cucco.
Niccolo feniani nelle Rime piacevoli
stampate in Venezia sotto nome dell’>^c-
cademico Aideano fa dire al suo gatto:
10 fui mignon del mio signor molti anni,
11 dottissimo e diligentissimo Carlo Dur
Fresne nel Glossario alla voce Minna
cita un certo Maestro Isone
,
il uuale
,
facendo le chiose a’ versi di Pruaenzio,
dice:
Ardor ; amor , minna.
Furores
,
minna.Ignem
,
amorem ,minna.
La prima di queste chiose è aggiustata
su quel verso del libro primo di Pru^
denzio contro Simmaco , ove trattando
t
3i6degli amori di Ercole con Ila sno mi-gnonc disse :
Herculeits mollis pueri famosus amoreArdor.
Spiega queir ar^/or con due tocì , uualatina, e l’ altra germanica. Ardor ^
amor^ minna. Dissi minna voce germa*nica
;perchè il Kiliano scrive nel suo
Dizionario , come riferisce il medesimoDu-Fresne , Theutonibi*s minnen est
amare , diligere atque adeo venereis vo-
luptatibus frui , amare , amori litare ;
maxime superioribus Gennanis. Nel giu-
ramento scambievole de’ due fratelli di
Francia Luigi e Carlo in Argentinal’anno 842. riferito nel 3 . libro della
storia di Nitardo , c citato dal IJpsio ,
e dal Presidente Claudio Fauchet nel g,
libro dell’ antichità delle Caule c. 6. e
da Ottavio Ferrari nel proemio alle sue
Origini, quelle parole in lingua Tedesca,
In godes mìnna^ si espongono nell’altra
parte del giuramento prò don( ovvero
deu ) amnry cioè prò Domini , seu Deiamore. Da tutto questo si può con fòn-
damento raccogliere, che il mionon de*
Franzesi, e da loro a noi Toscani vcri-
similmente tramandato, sia una di quel-
le voci , che aliignarano nella Callia
• portatevi da’ Franchi, popoli di Germa-nia ,
che a quella regione dì Frauda
diedero il nome, le quali al parere del
famoso Legista Francesco OUomannonel libretto de Franco-Gollia
,
compon-
gono un terzo della lingua Franzese
,
poiché da minna, amore, e da minnem^
amare; voci antiche germaniche, hannofa'to a mio credere i Frauzesi mignon
il cucco, il favorito. E mignonne disse
il Ronsardo a donna leggiadra, vezzosa
e amata , che pur anco disse all’usanza
de' latini, amie, m' amie. E mignard
vezzoso. Mignardelet presso gli antichi
per vezzosetto; imperocché la grazia, la
gentilezza ingenerano amore. Veggasi il
Femiri nelle (.Irigini, ed il Covarruvias
alla .voce Menino. Veggasi altresi Egi~
> dio Menagio nelle Origini della lingua
Franzese, nelle quali questo valentuomo
si persuase da prima,
che mignon de*
Francesi fosse nato da mignoun
,
che
presso i bassi Brettoni vale amico , eposcia mutaudo parere .volle credere ,
che si originasse dallo Spaglinolo ninno,
ovvero mi ninno,
1 Greci mignone lo dicono rà naidixà.
I Latini deliciae, arnores. E siccome t*teaiSixà si usò presso Piatone, ed altri
in sentimento onesto di giovane amico
,
e di favorito ; cosi presso gli Storici
molte volte si trova in sentimento osce-
no. Ovidio disse:
Veait amicitiae nomine tectus Amor.
3 i 8. ricguardando al costume degli amanti
,
che cuoprano più che possono la diso*
nestà coir onesto nome di amicizia. Di(^ui è nato , che ai nome di vùgnonesia intravvenuto come a quello di dru-do, che essendo per se nomi d’amicizia
e di fedeltà , si sono tratti ad esser no-mi d’ amore , e d’ amore impuro ; nelqual sentimento VAzzolini nella celebreSatira :
Si si, che éCUlpian tcampino i lacci
Lene e mignoni,
Pag. 3o. V. 8. Purché sia molto grandissimoFu costume de’ nostri Scrittori antichi
Toscani 1’ aver dato sovente 1
’ accresci-
mento a’ superlativi. Gio. Vili. lib. 7.
c. 100. Assediò la terra di Margotto in
Soria, la quale era della magione dello
spedale di san Giovanni, ed era molto
fortissima. E cap. 101. Andonne consua oste infino a piè delle montagnadette Pirre molto altissime. £ lib. 4.
cap. 16. dove nello stampato: Quivi di-
ligentemente servia a Gesù Cristo, e
molto crebbe nella grazia di Dio, e di-
venne santissimo uomo : in alcuni de*
miei lesti a penna si legg^ motto san-
tissimo uomo. Nell’ antico libro mann-Bcritto della cura delle malattie : Usiquesto collirio ,
che è molto buonissimo
a rimuovere lo panno dagfi occhi. Nel-
Digitized by Googl
rantlco YolgaiÌ7.7.amento di Mesae, ma-nuscritto: Empiastro d'Archigene molto
agevolissimo a guarire li letargici. Nel-
le cento Nocelle antiche ve ne sono• esempli assai , come osservò il PadreDaniel Bartoli nel libro intitolato : Il
torto, ed il diritto del non si può cap.
102 . che è da vedersi ;siccome son da
vedere il Cavalier Lionardo Salviati
negli Avvertimenti voi. 2 . 1. r. e Ude~no Nisieli nel terzo volume de’ Progin»
nasmi Poetici cap. i5g. Anche i Latini
aggiungono particelle accrescitive a’ su-
perlativi : qitam maximus ; longe maxi-mus ; multo maximus. E i Greci altresì
ó( ftiyurtai, rpuruéjunoi. E nell* Ora-zione a Demonico attribuita ad Isocrate
vi è xoÀv péyieTO(.
Pag. 3o. V. 10 . Ad un piccolo bicchiere
Epigene nell* Eroin.a appresso Ateneolib. XI. fa un graziosissimo lamento in-
torno a’ bicchieri piccoli, e fatti a foggia.
AXX' ov9è tetpapérvin fvf tovi tiav!tdpv(
fi -rdAav, èxeivvg rovi àdpovi , taneivck
9èSai fXa/pvpà, xderti , eaxtp avrà %o-
Ttipia
Ov ròt dlrop ntvópsvot ....
Quei cantari oggi più non si lavorano.Quei cantari gagliardi , ahi lasso , ma
320Bicchieretti galanti c piccolini
;
Quoti i bicchieri y e non il vin si bea.
Pag. 3o. V. ij. E quei gozzi strangolati
U’ un bicchieie fallo per bizzaria colcollo torto fa menzione Ateneo nel sud*detto libro, citando Tenpompo nella fa-
vola delle Soldatesse: £/ò yczp xà^ovotix axptijfa‘e](^évot xioipav , tò» rpa^tiXo»àvaxexXaepéppf. Che il ( asaubono l'a-
. ceudovi r interrogativo traduce : Egoneut e cothone curvicervice bibatn
, cui
. collum obtortum, et resjlexuml
Pag. 3o. V. i8. ArnesiTommaso fìeinesio nel cap. primo del
terzo libro delle varie lezioni accenna ,
che questa voce avesse origine dalla la-
tino-barbara ìiernasium usala dagli scrit-
tori Tedeschi ; e hemasium avesse forse ori-
gine da faruy che nello stesso significa-
to di arnesi, come egli afferma, si suol
trovare nelle leggi Longobarde. Ma conpace di questo eruditissimo litterato fa-ta nelle leggi Longobarde , e ne’ libri
d’ alcuni autori non significa arnese,
ma belisi famiglia ,generazione
, linea ,
discendenza. £ fu osservato dal Maglinelle Notizie de’ vocaboli ecclesiastici, e
dal sig. Du-Frestie nel (} lussa rio. Pietro
Bembo l’ha per voce Provenzale. Il Ca-
,stel-vetro lavora di sottigliezza d’ inge-
gno. Perdicone Poeta Provenzale :
Digitized by Google
321VaivassoT rie et poderosa
Ke tien rics et bos ameis.
Egidio Menagio nelle Origini della lin-
gua Franzese fa venire liamois dall’lta-
uano arnese , e questo dall’Alemannoamisch. Questo gran letterato , e vera-
mente di grandissima fama, avendo let-
to in Parigi questo mio Ditirambo della
prima impressione, volle onorarmi co’
seguenti suoi versi , da lui fatti stampa-
re piuttosto in riguardo della nostra an-
tica amicizia , che di alcun mio merito.
Redi. Opere. Vol, /. 21
/
FRANCISCUM REDIUIVI
ACaDEUICU» FLOaENTlNU*
Magni Elruriae Ducis Archiatrorum Comiiem
EUCHARISTICON
JEGlDll MENAGIl
Pro eximio ejus Italico Carmine, cui tituluf.
BACCO IN TOSCANA.
xterrwm hunc, mea Musa , mihi con^
cede faroorem.rrt r
Res est carminihus digna ,TftaUa ,
trUUe ___
Dicendus REDIUS i REDIUS , mea
fervida cura
.‘
riigitized by Goógle
323
T^nheni REDIUS pars venerandaChori.
Sed quibus aut verhis^ aut qìta tu voce
canendus ,
Docce REDII laudes ordiar undetuas ?
Conantem terree laudian seges ampiatuarum.
Cunctantem et duhium me meus ur-
get amor.jludendum : audentes comitatur gloria i
dignas
Audenti vires ipsa Thalia dabit.
Si mihi non alio merito spectabilis esses^
(^uam quod pars Tusci tu mihi notaChori ;
Non te non ‘cultu possem , non prose-~
qui amore :
Sic sibi devinxU me Chorus ille tuus.
Doctrina at propria^propria virtute re-,
fulges :
Ipse tuo luces lumine , docte REDI.Hetlados et Latii et spoliis Orientis
onustoMille cibi ornatus , mille Cibi veneres\
Ipse suas ultra cessit libi Delius artes :
Stat Stygii per te cymba quieta senis.
Nec solam Phoebus panaceam : ipsos
amaranthosEt tibi Pierio carpere monte dedit.
Tu potcs , ut vitas , extendere nominain aevum :
Nomina tu tenebris eripuisse potes
824Largìor ut nulli ; fas verum dicere ;
nulli
Contigit Aoniae purior haustus aquae.Testantur celebrata novo Uhi cannine
Vino :
Accendunt avidam quae mihi potasitim.
O blanda , o grata , o Jucìmda ,o dui-
eia vina !
Vina^ quies curii, et medicina malis.
Q^uae Ubi, quae tanto referam prò mu~nere dona ?
Qui dederit nectar, dona minora dahit.
Pac. 3o. V. i8. Sono arnesi da ammalatiFerecrate Comico ap|)rcsso Ateneo
lib. ir. nella Commedia intitolata la Co-rianno, se però il titolo non è guasto:
Et "kiOo ... mi tÒ9 *vXiir»ri9 ;
pòc ,
Mtaepdiye. setneirat yàp tv^éc pai,
£| ovxep éxiov ex TOtavrqt <pàppaxo9.
Vuoi eh' io U porti il caliceIto T no.Piccolo egli è , e muovemi lo stomaco ,
Sovvenendomi, che dentro un jì JattoLa medicina io bevvi.
Pag. 3o. V. 27 . Scarabattole
Fogge di stipi , o studioli trasparentida una, o più parti, dove a guardiadi cristalli si conservano tutti i [generi
32^
,di minute miscee, cui ]a rarità, la riocliezza , o il lavoro rende care, jireziose,
o stimabili : e sono per lo più airedi e
gale per gli appartamenti delle dame «
a divertimento e trastullo delle quali
pare , che fossero inventati in Ispagna ,
di dove nc abbiamo ricevuta la moda.Diconsi in Casligliano ejca/wmzej, dal-
la qual voce ebbe origine tra noi, jcn-
rahattola e scarabattolo , e appresso apoco su questa stessa aria di corruttela
altre simili voci dello stesso significato
in altri paesi d' Italia. Ne' tempi , cheverranno
,quest’ etimologia sarà forse
stimata un sogno ; e si vorrà credereche scarabattola abbia avut’ origine dal-
le minute bazzecole, o miscee, che peraltro nome son chiamate carabattole.
Pag. 3o. V. 3o. FedireSon dette per ischerzo le donne di
bassa condizione, perchè vanno a piede:
o è tolta r appellazione dal giuoco di
dama , e degli scacchi.
Pag. 3o. V. 3i. In quel vetro, che chiamasiil tonfano
Ateneo nel lib. ii. fa menzione d’imdetto , col quale alcuni solevano affer-
mare , che un gran bicchiere è un yovzo di argento, vedi quivi.
> i K
Pag. 3i. V. 6 . O come P ugola e baciami
,
e mordemP.Sileno presso Euripide beve furtlra-
i
mente il vino al Ciclope : il Ciclope se )
n’ avvede , e addrizzandosi a lui,
gli
dice :
OSto: , ri 9pài ; xòv oX*09 èxaiveiz
^pui
Olà, che fail cionchi di furti il vino!
Sileno mettendo la cattività in ischer*
zo , risponde :
Ov* , àAA’ ip,' ovToc éxvat*- Sxt tukXòp.
^Xéno. '/
Non io , signor , ma ben costui bacia* I
^vanii
,
\
' Perdi ho cortese il guardo , e dolce\
miro.
Pag. 3i. V. 7. O come in lacrime gà' occhidisciogliemi
!^
Bastiano de' Rossi in una sua Cicala-|
ta fatta nello stravizzo deU’.<^ccn</emiaj
della Crusca 1’ anno i SgS. Quel chiaro,j
limpido , brillante,pien di rubini
,gu- I
stoso , odorifero , saporito e schizzantej
KV negli Occhi, il quale ti faccia bevendolo i
/ \ ìagrimare per la dolcezza.
Digiti?^ by Google
3r. T. 9. £hilio
Estatico in questo luogo risponde al
latino exteTTiatus , uscito fuor di se , il
che è cagionato dalla -violenza dell’ af-
fetto dominante, o del piacere presente.
Apuìejo lib. 3. Sic extematus animi ,
aUonitus in amenlia vigilans somma-barn. Il Firenzuola qui': E fuor di meattonito e balordo vegghiando sognava.
Sebbene extematus nel latino convienemeglio a chi è per dolore , o per altra
cagione trista , che per amore , o perallegrezza forsennato. Catullo disse adArianna compassionandola :
Ah misera , assiduis quam luctihus ex-temavit
Spinosas Erycina serens in pectore cu-ras !
Ma Celio 'Aureliano Celer. passion. 1 . 15.
verso la fine: in ebrijs enim nlienalio exmultitudine poti vini facta perspicitur.
Sorano , il quale in questi libri è lati-
nizzato da Celio , dovea verisimilmente
nel greco aver usata la parola
la quale in latino otlimamcnte fu resà
alienatio. Gli Spagnuoli, volendo signi»
ficare una persona astratta di qualsisia
astrazione ai mente, si vagliono della
voce embevecido, tratta la metafora dnl-
l' iibbriacbezza. Piella traduzione della
fatto estatico vo in visi-
3a8Opere 'di santa Teresa si legge imhevi»
merito^ o astrazione ^ colie quali dueparole volle per avventura dar ad in-
. tendeie il Traduttore ciò, che nello Spa<
.gnuolo forse si dice con una sola em-bevecimiento astrazione, estasi.
Pag. 3i. V. g. in visibilio
Nella contraria maniera, che da eie àpi-
MOK di Omero disse Virgilio intuirne
facendo di due parole una , nel che ,
per usar la frase del Bemi , ei prese
un granciporro, la plebe Fiorentina dainvisibilium y parola del Simbolo Nicenoda lei , siccome moli' altre , male intesa
e storpiata, ha fatto invisibiliom, e })OÌ,
come se fossero due parole in visibilio.
Onde andare in visibilio per andare in
estasi quasi strasecolato , cioè fuor di
questo secolo , e nell’ altro mondo. Manon si userebbe se non per iseberzo.
Pag. 3i.v. 19 . isonne
Vale lo stesso che a ufoy cioè a spese
altrui, senza propria spesa. L’etimologia
à' isonne' SI può leggere per iseberzo nel
Cicalamento di Maestro Bartolino dalCanto de Bischeri. Io non voglio im-
. brogliarmi in cosi fatte facezie. La ve-
rità è , che qucH’Autore la fa nascere
da un certo Maccario da Isonne , e
conta una certa Novella piena di equi-
Digitized by Google
voci di non buoni sentimenti , de’ qua-
li , come diceva Dante-.
Più è tacer t che ragionare ones^.‘
Pag. 3 1 . V. ao. «Si sdrojoron suW erbetta
Virgilio lib. g.
• i
. . . .passim somao ,
vinoque per
herbamCorpora fusa vident.
Era cosa solita tra gli antichi rappre-
sentare i Satiri in atto di dormire pro-
fondamente ; e gl’ intagliavano per lo
fiù ne’ vasi da mescere^ o da bere.
lin. 34. 32. trattando de’ bravi Inta-
gliatori nomina un certo Stratonico fa-
moso per un tale intaglio ; e Platone
nel lib. 3. dell’Antologia fa menzione
di un tal Diodoro, che avea scolpito in
argento un Satiro , che apparisce di
dormir forte.
Pag. 3r. V. ult. Tutti cotti
Cotto qui significa lo stesso che uh-
liriaco.
Morg. 19 . i3i.
£ quand'egli era ubbriaco e ben cotto
^
Ei cicalava per dodici putte.
/
ZSoAntonio Alamanni ne* sonetti alla
Burchiellesca :
Vorrei costì dal Tihaldeo sapessi
,
S'un crudo senza legne esser può cotto.
Pier Sulvetti nel Brindisi manu*scritto :
Oimè quasi per gli occhi
Escomi 7 vin , che pur mandar di
sotto.
E non so adesso qual umor mi tocchi
Di far da Lonzo cotto.
Vant. Rinald. da Mont<ilb. E poco ap-
presso quaii cotto dal molto bere , e
imbavalliato dalT oppio sie si addor-
mentoe sì forte , ec.
In Diomede Gramatico si leggono di
Petronio questi due anacreontici , i
quali son posti nella Raccolta de’Fram*menti dello stesso Petronio dietro al suo
Satirico :
Anus recocta vino
Trementibus ìabeìlis.
Pag. 3i. V. ult. Tutti cotti come monne.
Monna coll’ o stretto è lo stesso clic
scimmia , o bertuccia. Esser cotto come
'"•i’od by Googlek
33t
una monna. PigUar la monna , che si-
gnificano esser ubbriaco , e imbria^r-
si ,non solamente son modi di dire
usati da noi Toscani, ma ancora da al-
tre nazioni. Bernardo Giamhul^ri nel-
la Continuazione del Ciriffo Calvanee
lib 3.
•
ji Ciriffo gli piace , ® il vetro succia
,
Senza lasciar nel fondo il centellino ;
Ed è già coUo ,e presa ha la Bertuc-
E dice I che vuol fare un sonnellino.
Jiel Vocabolario Tolosano : Mounard
singe . Mounino ,guenon ,
guenuche
.
Prenè la mounino ,s' enyvrer
.
Gou-
delin nel Ramclet Moundi ; segound
llonret :
Countent ; et frane de lout souci ,
Sounque de prenè la mounico.
Don Sebastiano de Covarrnvias Orozeo
nel tesoro della lingua Casligliana^ alla
voce mona dopo aver accennata 1 ori-
gine di tal Toce , soggiugne : Estas mo-
nas appeteeen el vino , y las sopas
mojadas en el ^ y aze dijèrentes efetos
la borraches en ellaSy porqua unas dart
en alegrafe mucho , y dar muchos sal~
tos , y bueltas ; otras se encapotan , y^
332• se arrùnan a un rincon ; encuhrìenàese
la cara con las Tnanos. De a qui vinollamar mona triste al homhre borra-
cho,que està melancolico
, y caldo ;
y mona alerte al que canta , y baila ,
' y se huelga con todos. Questi due di-
versi effetti deir ubbriachezza, cosi be-
ne accennati dal Covarruvias non furo-
no ignoti agli antichi latini. Lioberio
nella Citerea citato da Nonio Marcelloalla voce ebriulari : Ebriulad mentemhilarem arripiunt. Pel contrario Plautonel Cureulione : Operto capite calidumbibunt tristes , atque ebrioli incedunt.
Da questo ebriolus di Plauto , e dalverbo ebriulari ebbe origine la voce
brillo in significanza di awinazzato , o
cotticelo, E forse ancora la parola brio^
che esprime una ilarità , o espansione
di cuore e di fronte , e una certa com-mozione e vivacità di spiriti simile aquella allegria , che dona il vino in
qualche buona quantità assaggiato, ^onè però che la voce greca ^pvXXov , Col-
la quale Aristofane ne’ Cavalieri in-
tende uno>' che abbia cioncato più del
dovei'e , e che perciò sia allegro piùdel solito , non si accosti molto alla
voce toscana brillo , e particolarmente
se r ypsilon si dovesse pronunciare alla
moderna,come un i
, e non come l' ufrauzesc
^Quei varj , e pazzi effetti del
Digiti^- i by Google
333vino , che fa la monna allegra , e la
monna malinconica , sembrano adom-brati da Orazio lib. 3. od. ai.
'
O nata mecum Consule Manlio,Seu tu querelas , sive geris jocos ,
Seu rixam, et insanos amo es ,
Seu facilem,pia testa , somnum.
I
/
I
Digitized by Go<
335
INDICE
delle cose più notabili,
X DEGLI AUTORI CITATI.
^Avviso de^i Editori pag. tyita di Francesco Redif scritta dalFAba-
te Salvino Salvini ix
Delle lodi di Francesco Redi Accademicodella Crusca , Orazione d'Anton MariaSalvini xxiX
Racco in Toscana pag. x
V
Digilized by Googlt^
336
A
A in vece di e. e seg.^
Accademico Aideano, vedi Niccola fen-
iani.
Achille Tazio 55.
Acqua bianca 282. purpurea 284. perchè
detta bruna 2qo . cedrata 2<42.
Aerane Cnmmentator d"Orazio 286.
Adrianna per Arianna 3iL e seg.
Adriano de’ Rossi Poeta, antico manuscrit*
to di Francesco Redi 188 icj2.
'Agellio 43 i85 ifiQ aq6.
Agnolo Firenzuola 810.
A isonne 828.
Alberto di Sisterone poeta Provenzale i6q.
Alberto frate poeta, antico mauuscrilto di
Francesco Redi ig4 -
Riesser Alberto degli Alblzzi poeta, antico
manuscritto di Francesco Redi igi.
Alberto Rimbotù 221 282.
Alceo 48.
Maestro Aldobraudino , testo a penna di
Francesco Redi g6 oQ_ 124 272 2q6 e seg.
Alena per Elena 12S.
Padre Alessandro de Rodes ^2.
Alessandro Tassoni i83.
Alimento per elemento 128 124.
Aloscia ,bevanda Spagnuola 2q3.
Amorozzo da Firenze poeta , .antico manu-
scritto di Francesco Redi i85.
’ 337yinacreonte 46 54 lijr L4® ^70 296»
yintlare in visibilio oz^.
u^ndrea Cesaipino 102.
Andrea Grijio poeta tedesco ififl.
Audrea di messer Biodo de’Bardi poeta an*
fico manuscritto appresso Frane, nedi iQìL
Aadrea Carelli da Prato poeta antico ma*
nuscrilto appresso Francesco Redi 191.
Andrea Dazzi 198.
Andriana per Ariana 28 89.
Angelo Canini 128.
Angelo Monosini qi.
Angelo Poliziano i3g 164 275 297.Ser Angelo da san Gìmignano poeta antico
manuscritto appresso Francesco Redi iq3.
Annibale Caro i''g.j
Annotazioni anticue alla Bibbia tèsto a^renna appresso Francesco Redi 3io.
Antifane 206.
/intorno Alemanni 228.
Maestro Antonio da Ferrara poeta antico
manuscritto di Francesco Redi 188.
Antonio Pucci poeta antico manuscritto
di Francesco Redi 124 192.
Messer Antonio da Siena poeta antico
manuscritto di Francesco Redi 188.
Anton Maria Salvini 49 82 97 i 5o 2QI 267.
Antologia 3S 49 97.
Apollonio 283 290.
Apulejo 827.
Arcetri 2ji 278.
Archestrato 109.
Aristofane ^ 332 .
liedi. Opere, f^ol.L ai
I
\
2T Digitized by Google
Arlotto ^ e suo signijicabo l35 o sogg.
Arnaldo Daniello poeta Provenzale , testo
a penna della libreria di san Lorenzo
149 rSo i7»> _ ,
ArnSdo di Maraviglia poeta Provenzale ,
manuscrilto della libreria di san Loren-
zo 212.
’jirnese ,e sua origine 3ao.
jinancare 3oi
Arrante per errante Lzfi.
Arrigo Baldonasco poeta antico manu-
scritto appresso Francesco Redi i^o doli
3o7.riesser Arrigo di Castruccio poeU aulico
iganuscritto di Francesco Redi iSS*
Aspino di Napoli (Ll.
Padre Atanasio Lhircher 9^ n .
Ateneo 42 46 05 71 ^ 1 1
1 ^AvAlare in significato di bere 297.
Autore della Storia Filosofica attribuita
a Galeno qS.
Azone Giureconsulto 64»
B
Bacciarone di messer Baccone da Pisa poe-
ta antico del testo a penna di Fran-
cesco Redi 191.
Bacco medico 200 20l pennuto aa3. ba-
gnato per briaco zOiL
Balli ad imitazione di animali 3oa 3o3.
Banbillonia per Babilonia 3q<Banco di Bencivenni da Firenze poetaamico manoscritto del conte LorenzoMagalotti iq 3.
Maestro Bandino d* Arezzo poeta antico
manoscritto di Francesco RediBarbarossa sorta di vino 2^Bartolommeo d"Erbellot 67.
Bartolommeo Giorgi poeta Provenzale 169.Bastiano de' Rossi 4^ dzS.
Belìicone sorta di bicchiere , e sua origi^
ne 46.
Ser Bello poeta antico manoscritto diFrancesco Redi ip6.
Beltramo dal Bornio poeta Provenzale
,
manoscritto della libreria di san LoremZQ io3.
Bembo i5i 178 174 i85 ao8.
Benedetto Fioretti ii3 216 3o3 3 iq. vedi
Udeno Nisieli.
Benedetto Varchi 228. i
Messer Benoccio poeta antico manoscritto
di Francesco Redi rgi.
Bere per rimedio 268.
Bere per convento 281.
Bernardo /Accolti Aretino iÌZ.
Bernardo Navagiero 180.
Bernardo Giambullari 38 44 33i.
Bernardo del Ventadorn poeta Proveozalet
testo a penna della librerìa di san Lo*renzo , e di Francesco Redi 172.
Semi II li iig 149 i55 207 814 828.
padre Beret Gesuita 78.
Bestemmia, e hiastemma 2 t4»
Bevanda se cali nel polmone ^ 49.
Bevanda data per pena né conviti 296 207.
Bianco epiteto deli acqua
Bicchiere coronato loi. chiamato bagno
229 23o. pozzo di argento 325 ,piccolo
319.
Biodo Bonicbl da Siena poeta antico ma-
nuscritto di Francesco nedi 19 ••
Blancbacet poeta Provenzale del testo a
penna di san Lorenzo io4- i42 3ofi òo’].
Botoli Giardino del Serenissimo Grandu-
ca i 33.
Boccaccio 63 iq3 128 l3i 162 1.82 if)0
280 276.
’Boileau poeta Franze.se ^ i.3i 2q5 ,
Bombababà 159.
Bombola , e sua origine l2t.
Bonifazio Calvi da Genova poeta Proven-
zale iGq.
Bersela da Perugia poeta antico 190»
Boscano poeta Spagnuolo 168 iSo,
Braccio Bracci poeta antico manascritto
di Francesco Redi 188.
Braccio Vacca, vedi Meo Abbracciavacca.
Brillo in significato ili briaco 332 ,
Brindisi 144. poesia di Pier Salvetti 33o.
Brio , c sua origine 332<
Brodajo nome proprio i 38 ,
Broncone , e sua derivazione 278.
Brezzi , e sua etimologia 207.
Ser Brunetto Latini 126.
841
ilftfjjer Bruzr.i Visconti poeta antico ma-
nuscritto di Francesco Redi
Bufare. Bufera. Buffetto. Buffone, e loro
origine do4-
Buonaggiunta Urblciani da Lucca poeta
antico mauuscritto di Francesco Redi 170»
Buranese. Burlano sorta di vino SS»
Burchiello 190 iq3.
Burgundio Burgunzio 63 6^
C
Cacao frutto 78 74 0 segg.
Caffè 9^ •
Calascione , e colascione i_56 io7»
Candiero sorta di bevanda aqS.
Canini SS»
Canùnplora^ e sua origine tifi»
Canto anteposto al vino , e alla dolcezza
dell acqua a 24-
Capre nemiche alle viti 5l 5a»
Carlo Clusio 102.
Carlo Dati ^ IZO.
Carlo Maria Maggi ao3.
Carlo Du~Fresne
,
vedi Du-Wrcsne.
Cartabello , e scartabello òQ.
Casaubono itz.
Castelvetro Szo.
Catone zoa 273 .
Catullo ^ ^ ZQQ 222 3^7» '
Cavalier bagnato a3x»
Cavalli Hel mare cavalloni Sog.
Cavo della sperante 807.
Cece nel rostro de cigni 188.
Celebro 22H±
Celio Aureliano 827.
Cembalo antico differente dal moderno 147.
Cennamella , ciaramella , cannamella 228
227 228.
Cervogia q5 .
Cesellio Vindice 288.
Chiabreia 40 46 72 204 271.
Choc-nar ,bevanda de' Persiani
g3 .
dà, e sua bevanda ^Ciaramella , ciaramellare 226.
Cicalamento di maestro Battolino dal can-
to de' bischeri 2_i3 297 828.
Cicalata dello 'Nferigno
Cigni chiamali purpurei da Orazio 288 e
segg. sono di due razze loro peso
a88. col cece nel rostro, e senza, e per-
• chè detti ceceri 288.
Cilicciauli , e sua etimologia 225 .
Cioccolatte 78 74 c segg.
Ciotola 72.
Cirimonie e costumanze nel fare i cava-lieri del Bagno z3j_.
Cisrranna de’ Piccolomini poeta antico
del testo a penna dì Francesco Redi188. a
ClaudianoJ(6.
/
Claudio Dausquio 128.
Claudio Fauchet 816.
Cobbola , cobola e cobla 166.
Digìlized by Google
Codino i 5o.
Coitilo Smimeo ac)o.
Columella 278.
Composizione di parole mi Ditirambi 2^Contento ,
sostantivo usato dagli antichi
128.
Contessa de Digno, o de Dia poetessa Pro^
ventale ,manuscritto di Francesco Redi
Costui in significato a cose inanimate a??*
Coronar le tazsc i iq.
Cotto ,ubbriaco 829
Cotto come una monna 33p 33
1
.
Covarruvias 94 LaJ tSy 197 279 298.
Cristofiano tendini 1 1.2 .
Cronaca Pisana del testo a penna di Fran*
ccsco Redi i35 tifi.
Cronaca del Velluti manuscritU l33.
Crotalo 147*
Cocciniglia canuta 1 Q2.
Cucco di Valfreduzio poeta antico 191.
Cuccurucù ,canzone
Cunzia ,cunziera aiiL
D
D mutato in 2 208.
Dalecampio i34.
Padre Daniele BartoU 1*9Daniel Einfio 189.
344Dante 4l S5 56 ixs n4 uS
170 178 187 227 —Dànte da Tolterra poeta antico manu-
,
acritto di Francesco Redi iq2.
Dello da Signa 'poeta antico manascritto' di Francesco nodi ifiS iq4 -
Contessa de Dia poetessa Provenzale, ma*nuscritto di Francesco Redi 122 171.
Demostene 3o8 .
Dente della capra dannoso alle viU 5i 52 .
Deputati alla correzione del Boccaccio z3 i.
Dialetto Pisano 187.
Dialoghi filosòfici del Prior Rucellai 67.Didimo 284 .291.
Diminutivi, e loro uso 108.
Dino di Tura'Bastajo jioeta antico del te-
sto a penna di Francesco Redi igi.
Diofane GeoponicoDiomede Guidalotto i 5 i. gramatico 33o.Diosippo 48.
Diporto 3oo.Messer Dolcibene poeta amico del testo apenna di Francesco Redi 188.
Domenico Magri 820.
Maestro Domenico di Maestro BandinOd’Arezzo , testo a penna di FrancescoRedi 48,
Fra Domenico Cavalca , manuscritto diFrancesco Redi 3q.
Ser Domenico Salvestri poeta antico ma*nuscritto di Francesco Redi iqz.
Domino per dominio 221.
Dante da Majano
Digitized by Google
3^Donne partecipi delTonor de' mariti 270.Druderia in significato onesto 1 13.
Drudo sustantivOf e suoi significati 1 12 3i8.
Drudo addiettivo 118 nome proprio 119.
Duchi , che non erano cavalieri non si
ammettevano alla mensa ‘ del Re di
Francia 269.
Du-Fresne 67 q6 ifìi 116 iSi 2iS 3i5 820.
E'
E cangiala in a 124 e se^^Egidio Menagio S3 ^ ^ 78 94 98 ioa
ul5 120 128 i38 i5o ijg 180 804 3i7321 322.
Egipani su' trampoli i54.
Egesandro 218.
Elia di Berzoll poeta ProTcnzale del testo
a penna di Francesco Redi 201.
Elia Cadenetto poeta ProTenzale, testo a
penna della hbi’eria di s. Lorenzo igS.
Elias Carel poeta Provenzale, testo a pen*na del Senalor Carlo Strozzi 171
.
Elimento per elemento i23.
Emblanchacet poeta Provenzale , testo apenna della libreria di 8. Lorenzo. VediBlancbacet.
Empedocle 41 q5.Engrestara quasi ingrastaria 65, «T ondeprenda origine 65.
Ennio 200.
346Enrico Ahrincense q6.
Enrico Spehnannn i^Enzo Re poeta antico testo a penna di
Francesco Redi i6q.
Epigcne 3 rc),
Epistole d’Ovidio. Testo a penna di Fran-cesco Redi dfi.
Epistola di 8. Girolamo a Eustocliio , vol-
garizzata da Fra Domenico Cavalca. Te-sto a penna di Francesco Redi 89.
Eratostene 48.
Ermippo 2o5.
Eschilo 200.
Esichio 122 123 207.
Esiodo, come voleva che s' innacquasse il
vino ^ 45 .
Estatico 327.
Etimologico magno iqq.
Eubolo 2i5.
Evoè i 3q.
'Eupoli^o.Euripide 42 48 78 110 189 272 2q8 Stf
826.
Eustazio 48 a85 291.
F
Facezie del piovano Arlotto. Testo a pen-na della libreria di s. Lorenzo i 3C.
Fare spere 3a£LFazio degli liberti 117 i88.
Zirr
Federigo Uhaldini i 5q i£6 l8l » suo shd-
gUo ifìa
Felippo SgruttenOio da Scafato Qi i5b
Feo Beicari poeta antico del mannscritto
del conte Lorenzo Magalotti iq3.
Ferecrate comico 3a4»
Ferrari vedi Ottavio^
Festa Pompeo 2qi.
Figliuoli del Re^' Longobardi non sede-
vano a mensa con padre se non erano
armati cavalieri 269 270»
Ser Filippo degli AWizzi poeta antico iqi.
Filippo de’ Bardi poeta antico. Testo a
renna di Francesco Redi 192.
Filippo Scarlatti poeta antico. Testo a pen-
na del conte Lorenzo Magalotti 189.
Filistione Locrense 48.
Filostrato loA 292.
Fiore, spezie di componimento poetico rqS.
Fiorentino Qz fi3 147
Fioretti di san Francesco. Testo a penna
di Francesco Redi 3q.
Flemmingio poeta Tedesco 180.
Folchetto di Marsilia poeta ProTenzale.
Testo a penna della libreria di san Lo-
renzo 114 iliq.
Forbito 122.
Forese Donati poeta antico. Testo a penna di
Francesco Redi 191.
Don Francesco di Andrea ^ fio.
Francesco Cai-letti , e snoi viaggi. Testo a
penna del conte Lorenzo Magalotti 74.
Don Francesco de Quevedo 47.
848Francesco Maria Gualterotti 4^Messer Francesco da Barbelino iSg 166
168 170 181 187 8q5 3q8.Francesco di messer Simone Peruzzi* da
Firenze Poeta antico. Testo a penna di
Francesco Redi 178 191.
Francesco Malerba poeta Franzese 179.
Francesco de Lemene 2o3.
Francesco Ottomano 3 i 7 .
Franco Sacchetti poeta antico. Testo a pen-na di Francesco Redi 188 192.
Frediano da Pisa poeta antico. Testo apenna di Francesco Redi 178.
Frotta. Frottola, e loro significato iSz i 53.
Fulvio Orsino 201.
Furio poeta Latino 283.
Galeno 41 corretto 122.
Galletto da Pisa poeta antico. Testo a pen-
na di Francesco Redi 17S i 85 .
Ganselm Faiditz poeta Provenzale della
libreria di s. Lorenzo 114Gano da Colle poeta antico. o a pen-
na di Francesco Redi 188.
Garzilasso della Vega fu de primi , che
facessero sonetti in bnffzaSpagnuola itto.
G
Gabbriello Posano 62.
Gabbriello Faemo 201.
Gajo giureconsulto 238.
/
by Gpogle
349
'Gavazzo 274«
Ceraldo Bucold 202 t_
Ceri Giannini Pisano poeta anUco. Manu-
scritto di Francesco Redi 190-
’Cersolé , e sua etimologia Z2^Gerusalemme del Tasso in lingua Napo^
letana ^ . tx-
Geronimo Tcrramagmno Pisano poeta an-
tico. Testo a penna di Francesco Kedi
168 175. ,
Ghiaccio per rinfrescare il bere quando
costumato i3o i3 { i2Zi
'Giachetto Malespini izj.
Giacomo Bornio 9^Giacomo da Lentino poeta anUco. Manu-
scritto di Francesco Redi iM.
Giamhullari i 35.
Gian Alessio Ahhattutti Q2 1^ ino.
Giannizzeri 94^[Giara 279.
\CigUo, o GiUio LclU, poeta antico 190
198.
Giolito Ii3 54._ T» j- i. 'T »
Fra Giordano da RiTalto. Prediche. Testo
a penna di. Francesco Redi ^ 58 814.
Giovanni MaVotolo poeta antico. Manu-
scritto di Francesco Redi 1681
Giovanni d’Arezzo poeta antico. Manu-
scritto di Francesco Redi 18S i85.
'Giovanni Boscano. Vedi Boscano.
Messcr Giovanni da Prato poeta antico.
Testo a penna di Francesco Redi igt.
Gio. Battista Golii 2iiL
35oGiovanni monaco di Marmomtier a.'ì3.
Padre Giovanni Maffeo 92.
Giovanni Linscot 9^ ^'Giovanni della Casa 1 14»
Giovanni di Meung udì.
Giovannantonio Paganini Milanese i35.
Giovanni signore di Foinville 149 i5i.
Giovan Battista Marino 280.
Giovanni Villani 124 127 129 i.S3
14.2 l5o 208 210 2JL1 2 i 5.
Giovanni èCArces 82.
Giovanvettorio Soderini 282.
San Giovan Grisostomo 3io.
Giovinezza e giovanezza 58 5£.
Girolamo Aleandro 7^San Girolamo gg.Giraldo di Bomeil , o di Bomello poeta
Provenzale. Manuscritto della libreria drs. Loreuzo 172 i83 3qi 807.
Gittare spere 3o5.
Giudice Ubertino poeta antico. Testo apenna di Francesco Redi 168.
Giuliano Imperadore 97.
Giulio Polluce. Vedi "Polluce.
Giulio Cortese i56.
Giuseppe del Papa 43,
Giuseppe Scaligero 216.
Glossario Provenzale. Manuscritto di Fran-cesco Redi 1 14 123.
Gnaccare , voce eneziana i5i.
Gobola ififì.
Gonnella degrinterminelli da Lucca poc-
35i
ta antico. Te*to a penna di Francesco
Redi liiS.
Gotto ,e suo significato i_M.
Goudelin poeta Guascone io.t 33 1 .
Gazar 274.
Gozzo t vaso da bere OZQ^
Gra malica Provenzale. Manuscritto della
libreria di san Lorenzo LZd ai6 agt)
3or 3o4 Sii.
Grasta , voce usata dal Boccaccio 63*
Graziole da Firenze poeta.antico. Testo a
penna di Francesco Redi 168.
Gre , e suoi significati 14^.
Grotto, uccello z8<j ha la lingua piccolis^
sana , e senza voce a8q.
Guglielmo Britone y8 l6j.
•Guglielmo au courb, nez ij_3.
Guglielmo di Lorris ,autore del Romanzo
della rosa u6 i79-
Guglielmo Monilier 164 gii,
Guglielmo Camdeno 263*
Guido d’Uzez poeta Provenzale. Mauuscrit-
to Strozzi loS.
'Guido di Touinaut i_i5.
Guidoufel poeta Provenzale. Testo a pen-
na della libreria di s. Lorenzo 137.
Guido Cavalcanti jtoeta antico ijjcj 170.
Guido Guinizzelli poeta antico. Manuscrit-
Uì di Francesco Redi t68 170.
Guido Orlandi poeta antico. Testo a pen-
na di Francesco Redi 188
Guido della Rocca. Manuscritto di Fran-
cesco Redi 188*
«5*Guid* Gindice dell» Colonne .Storia Tro-
Testo a penna di Francesco Redi
d’Areno. Manascritto di FrancescoRedi 126 168 ITO ini 17S i 85 igi loa268 281
'
jana.
3oq-
GaiUon
1
Beato Jacopone da Todi ^ ri3.
Jacopo CorbinelU 120.
Jacopo Mostacci da Pisa poeta antico. Tc*sto a penna di Francesco Redi i85 .
Jacopo Soldani Satire. Manuscritto di Fran-cesco Redi iq7.
Jacopo Sport
Fra Jacopo da Cessole Dominicano 264.
Jamblico i4o-
Jatnurluh 2Q7.
Jmbriacarsi per sanità 2q6.
Impazzire trct bicchieri 296.
Impiria , voce Verteziana So.
Jridrudire in signijlcato onesto »t3.
Indovinelli proposti ne' conviti 2*6.
Inghirlandar le tazze 119.
Inguistara 65. <
Innacquare il vino come costumavanantichi 145 .
Intendenti de' vini 62 63.
Intendenza. Intendimento io3 .
Intonare per mettere in musica i 5 r.
d5SImitare a bere Z19.
Jone dito 228.
Iperide oratore 3o3 .
Ipocrate 4B L22 i44«
Jpponatte ii i.
Isidoro qS.
L
Lacrima spezie di vino 270 271. \
Lamporecchio villa de signori Rospigliosi120.
Lanfranco Cicala Genovese poeta Proven-zale i6q.
Lapo Gianui poeta antico. Testo a pennaai Francesco Redi 5S.
Lapo Salterello poeta antico. Mamiscrilto
al Francesco Redi i£8 i85 . ;;
Lapo detto Lupo di Farinata degli liberti
poeta antico i 5q.Lappeggio ,
Leone Allacci 168 170 188 104,.
Laporeambi ,sorta di versi iÓ5.
lettera rna/uscola
Lettere di Fra Guittene d’Arezzo. Testo apenna di Francesco Redi 126 178 3i2.
Libertà di parlare in t^po di vendenvnia
Libreria manuscritta del Senator CarleStrozzi
Redi.,
•re. Voi. L 23
854Libro antico della cura delle malattie.
Testo a penna di Francesco Redi ^ 2293 i8 3 i q.
'
Libro dellAmhasceria delle Provinci» Urti^
te alt Imperador delia China qg.
Jjìnhidine per libidine 3j.
Leonardo Salviati 128 3 ip.,
Lippo d’Arerzo poeta^ antico. Mauuscrittodi Francesco Redi ''118 170.
Lodovico Ariosto i 3 i.
Lodovico Dolce i8i Leporeo i 85 .
Lorenzo Bàliini 278.
Conte Lorenzo Magalotti 76 76 >89 19729I.
Luca Pulci if3 laS 199 3 t.5 .
Luca di Grimaldn da Genova poeta Pro~. vernale 169.
Luce di Santermoy che sia 3 i,3 .
Luciana i3q 267.Lucrezio ao2. - • ' -
Lui dato 0 cose insensate » irrogionevoH
275.Luigi Alatnanni 44 71 142.
Luigi Camoes poeta Portoghese i 63 .
Luigi Froes qz.
Luig Pulci 38 184 i35 t 38 199 3o5 81 5.
Luigi Rucelltti priore di Firenze 67.Luissimo superlativo 56 ,
Lumaggrà giuoco i43 >
M
8SS
Macedonio 48 202 276. -
Macrobio 42 48. > ... ^Madere essere^ìBbriaoo 288. '
Maffeo de’ Libri da Fìreaze poeta aulico.
Testo a penna di Franc<»co Redi IQZ.*,
Majusculo , « minuscolo. . Vedi lettera mAjuscula.
Malvagia di MorUegonii ^ del Trebbio
14*- ' • •• s ' . •
^L
Marnante voce Spagnuola iqjt ,.
Alammola. Mammolo J196 197.
Mandola, Mandolino 3o2. ><
Iddoetlo da FUicaja poeta antico. Testo apenna di Francesco Redi 192. '
Mani lavate nè conviti oon facqua neva-
ta i3 i e seg.
Mantenitori della Gioja StAmore 164.’
Manoscritto antico, in cartapeoorà della
libreria di s. Loremo tema titoli di au-
tori 65.
Mare purpureo , e suo significato 384. .
Messer Marabuttieo d’Arezzo poeta antico.
Manuscrilto di Francesco Redi (92.
Marchionne di Matteo Arrighi poeta' anti-
co. Mauuscritto di' Francesco Redi iB8192. • .
• • .
Maritare 279. *
Marsilio Cognato ^ Ficino i66- • *
Martino Opizio 180.
Sf!6
JAartìaìé for. JTAuvergne ie4.
Mnsarello da Todi poeta antico. Testo
penna di Francesco Redi 168.
Matteo Parisi 161. Ricci estmonaste-
riense gg 162. • s.
-
Mattinolo 148.
Meo Abbracciavacca poeta antico. Manu»scritto di Francesco Redi 168.
Metrodoro 814.
Mettere spere, termine marinaresco 3o5 .
Maestro Migliore da Firenze poeta anlicow
Manuscrilto di Francesco Redi 188.
Mignard. Mignordelet 817.
Mignotte , e suo significato 814.
Minna, voce Germanira 8 1ó.'
Mino del Pavesajo d'Arezeo poeta antico
del testo a penna di Francesco Redi 1G8.
Miradore , miratare , miraglio 81 1 812.
Mirare , rimirare,guardar nello specchio
Mnesibeo 200 268.
Monnldi Cronaca manusnritta tq5.
Monna. Pigliar la monna 881.
Monna briaca, allegra, malinconica 33 t 882.
Monosini 6lìi
Monsignor della Casa 118.m M . t n
Mottetto , e suo significato iGn.
Motto componimento poetico i5i,
Mureto 298-
Muitum potnalium gg.
8i L
1
S57
N
'tf ag^unta iii'olcune voci ^ aog aio ai i
l’j'L
Nocchent. Nacchere 148 e segg.'
Naimerico di Belleooi poeta Provenzali;
del testo di Francesco Redi 309.
Nappa. Nappo , e sua origine Sj.
Narcetri per Atcetri 278.tiatuccio AnquinO Pisano poeta antico.
Testo a penda dì Francesco Redi 190.
NepetUe 67 98.
Nero vino , sangue a85. acqua a55 a56.
Niccola Villam io6.
Niccolò Einsio i8q.
piccolo Soldanieri poeta antico. Testo apenna di Francesco Redi 188 191.
Ninfemo per inferno 2*0.
Hocco di Cenni poeta antico. Testo a pen*
na di Francesco Redi iq'ò.
Nonio Maroello 33a.
Novelliere antico ^
0
'Occhio del sole e della luna adc>.
Odofiedo Gitueconsulto G4.
Odor del vino, e suoi effètti ai 9 aao.
Digitized by Google
3»Omelia di i> Gio. Grisostomo. Test* a pea-
na di Francesco Redi 127.
Omero 48 ^ g3 110 1 19 144 200282 287 2qo.
’
Onesto Bolognese poeta statico 170.*
'
.
Onomastico Prorenrale. Testo a penna del-
la libreria di s. Lorenco 3oa 804.
Onta , voce Provenzale 209. 1 ‘ !
Orazio 46 Si 1% 146 am *1^ ai^ aaS22Q 267 27^ aHd 2^ 3.hX
Caviuier Orasio Ruceliai Prior di Firenre,
e suoi Dialoghi filosofici , e sonetti. Te-sto a penna appresso il Piior Luigi tuofigliuolo 67.
Orcipo^a fUrz^oggia 3o6.
Origine del sonetto lyq eOrosio della libreria di s. Lprerao 4S.
Ostico i 38 .
Ottavante Barducci Fiorentino poeta anti-
co del testo a penna di Francesco Re-
di 192^
Ottavio Ferrari 5o 53 66 94 ioq 144i 56 274 3 i I 3 i 6 .
Ovidio manuscritto. Testo di Mmisù Con-rart 1 16 267 3 i 8 .
P
Ser Pace Notajo poeta antico. Testo a pen-
na di Francesco Redi i 85. . . --
Palladio 52 147.
Digitized by Google
^pait huffeUbi e sua origino 804.
Pandette 49.Pandora. Pandurizzare 3q2.
Pannaccio dal Bagno Pisano poeta antico.
Testo a penna di Francesco Redi 175
»77 IQO-
Panzirolo 63 64^
San Paolino vescovo di Nola aaS.
Paolo Abbreviatore di Pesto x6fi. Silan~
ziano 281. PPalnefrido 269.Papia 33.
Paraggìo , lo stesso else in latino Campa*ratio 21 5 .
Passera della Gerniinella poeta antico. T»' sto di Francesco Redi 188 190.
Pasquier 272.
Pausania 212 228. . .
Peccherò loi.
Pedina 32.^.
Peirol, o Periol d’AWemia poeta Proven-zale. Manuscritto delia libreria di s. Lo*renzo 208 172 3oo.
Peretala 208.
Perdicione poeta Provemale. Testo a pen-• na di Francesco Redi 320 .
Petrarca 38 lq8 i 52 169 171 188 190 276.Non fece sonetti con la coda 190.
Petronio Arbitro 3 lo.
Pevera. Pevere. Pevera, Peverada So..
Piacitella,giuoco 148.
Mi ‘ “
36dPierozzo di 'Biagio di Strozza Strozzi po«t»
antica. Testo a penna di Francesco Re-
di 192.
Pietro Crtscenzio 63 6^ Jarrie Fabro
!
164. 211.
Pier Andrea Portoni 8§ 141. Bembo vedi
Bembo.'Pietro della Rovere Piemontese poeta Pro~
vernale 169.
Piero Bremonte poela Provenzale. Testo
della libreria di s. Lorenzo 184.
Piero Salvetti Fiorentino poesie. Testo di
Franceseo Redi 33o.
Pietro Bellonio IQZ l^Z±
Ser Pietro da Monterappoli poeta antico.
Manuscritto di Francesco Redi 192.
Pigliar la monna 33i.
Pindaro 56 200 222.
Pippo di Franco Sacchetti poeta antico.
Manuscritto di Francesco Redi i8fi.
Pisciando. Pisdarello sorta di vino 5&Platone 48 i65 2^^ 817.
Platone poeta ago 829.
Plauto ^ iiQ IM ^ ^Plinio 40 58^ ^^ 67 72 401 Ì09 IIP
141 144 148 20p.
.Plutarco 145 287 814.
i^Poesia del Padre Tommaso Strozzi sopra
A i7 Cioccolatte 79.
''^Di' Pier Andrea Forzoni 89.
Poesie che puzzan tT olio I72.
Poeta Provenzale incerto del testo a penna
della libreria di s. Lorenzo i36.
Digitized by Google
36i'•
Polibio 108. ‘
Poliziano. Vedi An^lo Poliziano.
Polluce 121 145 3q2 3o3.
Polo di Castello poeta antico. Testo a pen-
na di Francesco Redi i 53 .
Pomada 93. *
Pons de Ca}idoil poeta Provenzale. Testo apenna di Francesco Redi ifix.
Porjirione Comentatore dOrazio 288 285.
Porpora bianca 287.
Pozzo , nome di hicclùere 199.
Prediche di Fra Giordano da Rivalto. Te-
sto a penn^ di Francesco Redi 814. 've-
di Fra Giordano.Pretto , e sua origine 120.
Pronunzia delle lettere Greche 36. De'Pi-sani 187.
Protagora 48.
Protogene gramatico 48.
Proverbi di Salomone i4o-Prudenzio 3 i 5 .
Pucciandune Martello da Pisa poeta anti-
co. Manuscritto di Francesco Redi 168
170 178 i86 187.
Puegibot poeta Provenzale. Testo a pennadi Francesco Redi 167.
Purpureo , epiteto delt acqua 284. dtt Ci-
gni 283. del mare 284. delia morte 285 . .
36a
K
Rabbuffare. Rabbuffo^ e loro origine 3e4..
/. Raffaello Magiotei fifl.
Raimondo Giordano poeta Provenzale. Ma»nuscritto della libreria di san Loretizo
ifìd 307.Rarabaldo de Vacheras poeta Provenzale.
ManatcriUo della libreria di s. Lorenzo,e di Francesco Redi loz 1 14. 1
Ranco .3o2,,
Ranieri de’Samaretani poeta antico. Testo
a penna di Francesco Redi i53.
Re de Longobardi non facevano sedere
alla loro mensa i figliuoli se non etano
!armati cavalieri 269.
7 Redondillas 167.
Re Enzo poeta antico. Manuscritto di Fran-
cesco Redi 160.
Re Riccardo poeta Provenzale. ManuscriUto di Francesca Redi i£fL
Abate Regnier des Marais , e sua tradu-
t sione di Anacreonte in verso Toscano
Remondo lorda. Vedi Raimondo Giot-
Romanzo di Bertrando di Guesclin. Testo
a penna di Francesco Redi 1 18.
* Anno. ,^
Ricordano Malespini 127 129 i,33.
Rimario Provenzale. Manuscritto della li-
Digitized by Google
86SRomanzo di Florimondo. Di Guido di
Tournat. Di Guglielmo au courb. nez.Della Rosa li 5 .
Romolo Bertioi Fiorentino, poesie manu-scritte del testo di Francesco Redi 4044 *7 »^
Ronsardo poeta Franzese 35.gS i63 igS
217 aig ^z3 23o 2ò8 317.Rosso in significato di nero 285.Rosso da Messina 'poeta antico. Manuscrit'
to di Francesco Redi 194.Rugetto da iMcca poeta Provenzale 169.
.
Ruggicrone da Palermo poeta antico. Ma*nuscritto di Francesco Redi 3o6.
S
S come pronunziata da'Pisani 187.Sabino Poeta 42.
Saffo i 83.
Salvarlco di Malleone poeta Provenzale.Manuscritto di Francesco Redi 161.
/ Samuel Bodarto 140.
Sandro di Pippozzo poeta antico. Mana-scritto di Francesco Redi 188.
Santa Maria Nipotecoso 210. . .
Santermo, e suo significato 3i 3.
Sapria , sj>czie di vino 2o5.Sasci ^ amici alle viti 282,Satire di Monsig, Azzolini. Testo a penna
di Francesco Redi 220 3 18.
864òbujfar*\ e sua origine 3o4 .
Scaligero 58 .
Scarabatlola , e sua origine 3 z!i.
Sdoppio I j4.
Scoliaste d‘Aristofane 56.
Sebastiano Covarruvias. Vedi Covarruvias.
Seneca 64 i3 i.
, Sidro 32 96.Sileni «tzi.
Simbuoao Giudice poeta antico. Manu-scritto .di Francesco Redi 160.
Simone Pauli 92.
Sione , che cosa sia 809.>Padre Sirmondo 1 16.
Smerare. Smerato SLlJL
Smeriglio , e sua origine 3x3.
Sonetti di quattordici versi indentati dagli
Italiani 168. sonetti de' Provemali, checosa fossero 169.
Sonetti Toscani di più versi, che quattot’
dici 172 173. sonetti, rinterzati iqi 174.
doppi *75 e segg. di due rime i 85 . conle rime nel mezzo de' versi 184 | 85.
leporeambi i 85 . sonetti come si trovino
scritti ne'testi antichi 184. sonetti di di‘
•verse quantità di versi x38 fìiio a 195.
con le quartine di cinque versi per cia-
scuna IQ2. sonetti , che con le primelettere de' versi accennano il nome del-
rAutore 194. sonetti col ritornello , ccol ritornello doppio 178 190. sonetti
quando cominciati in Francia ed in
Mgiiized by Goo^le
365
Spagna i8o. con la coda , e loha
ariane 130 e segff.
Sonetto j e donde abbia avuta origine 180*
Sonetto di Dante non più stampato del
testo a penna di Francesco Redi 187.
,Sonetto di Pucciandone Martello da Pisa
scritto secondo la pronunzia Pisana. T#»
/ sto a penna di Francesco Redi ifiS*
'/^Sonetto del priore Orazio Rucellai 7^\Sorano Bay.
Sordello Mantovano poeta Provenzale
Spera. Gittare spere. Fare spere dfiS
lo stesso che speranza óo'j.'
Spran^ietta cagionata dal vino 277.
Stampite de' Provenzali 167.
Stare a tavola ritonda jproverbio 231 .
Stasino poeta 46.
\Stefano Pig^elli ^ Paschiere ifiiL
Stefano di Cino poeta antico. ManuscrittO
di Francesco Redi 192.
Stessissimo superlativo
Storia della Bilibia in lipgua Provenzale.
Testo a penna di Francesco Redi 3oi.
Storia INarnonese . ManuscrittO appresso
Francesco Redi 129.
Strambotto, strammotto, e sua Orione iSi,
Sveglia ,sveglione i 56.
Snida 43 ab gg 121 28S.
Superlativo con V accrescimento 3 i 8.
^abalU-e timballi 149.
lalahalacchi i55. uunburacai l56.
TAnaquil Fabro a8y.
Tanghero lOO.
Tavola ritopda» Manuscritto della libreria
di san Lorenzo iz6 181 321 a3i 3o5.
Tè , « sua bemanda 93.
Teocrito 2i 224» , . «
Tericleiy vati da bere >
TertuUiano 229.
Tibaldo di Sciampagna poeta arUico Frati-
zete i6d.
Tibullo il 141 266 284 396.
Timeo di Taormina 298.
Tommaso de’ Bardi poeta antico. Testo apenna di Francesoo Redi 193.
Padre Tommaso Strozzi Gesuita 79.
Tammaso Reinesio
Tonfano 390. • '
Torquato Tasso 146.
Trattato del governo della famiglia.
Testo a penna di Francesco Redi ifii.
Trattato latino de’ pontoni di Alberto Rim*
botti. Manuscritto di Francesco Redi 220.
Trattato dell’ Intendimento . Manoscritto
appresso Francesco Redi 199.
Trattato della Sajiienza. Manoscritto ap-
presso Francesco Redi 812.
Trecce, delle vigne mS 109.
367
Trescare iSt.
Trojano poema in ottava rìnoa. Manu-•ccitlo appresso Francesco Hedi uiL
Y
Vallombrosa , e Valembrosa 129.
Vanto di Rinaldo. Manoscritto diFranccsc*
Redi aid aSi 299 3ogVarare , e suo doppio significato 299.
Varrone "jZ i d8 291.
Udeno Nùielo. Vedi Benedetto Fioretti,'
Vendemmia tempo di libertà 214»
Verde vino 272. vetdea 271.
Verdetto ,verdischeUo ,
verdisco vini 272.
Vermicciuoli per tignerà in cremisi laa.
Vermiglio 102^. usato nell esequie 104. ,
Vemaccia di san Gimignano 204.
Versi de' Greci come scritti anticamente
184. i 65 .
Vespe ghiotte dell uva moscadella 63-
Vetritsola in significato di bicchiere 72 7^Vetro per vaso da bere 44.
Ugo da Massa di Siena poeta antico. Ma*tiuscritto di Francesco Redi 166.
Uguccione Pisano Graraallco , del testo apenna di Anton Maria Salvini 267.
Viaggio del vescovo di Berit alla Goccine
cina 9^ .
Vigna, per lo stesso che vite 64. ;
Villanzone 278. Vincenzio Borghini
flirto tangue delt uva 4^ fa buon sangue.
È un ra^io del sole 41. la poppa dei
vecchi^ amaro suoi colori 14,1 142.
come innacquato dagli amichi 144. da-
to nelle febbri da Ipocrate 144. vino
grande fatto dalt uve nere 147 148. for-
te ,e suo significato 109. cavallo del
poeta J22. solleva la fantasia zz%L fagli uomini vantatori 223 . veleno dè'ma^
< il 229. innaffia t anima 268. posaffanni
279. fatto nel sasso 282. eccita tempe-
ste 304. suoi effetti differenti nelle mon-
ne 2^ 332.
Vino di Lecore So 2l_i Albano loi. di
Lesbo T IO. di Brozzi ao5 . di Pepa-
reto , e delle cinque terre di Toscana edel Genovesato 2o5 206. di Lappeg^.Rullato. Alla Sciotta. Soleggiato. Alla
Franzese. Alla Greca %l\ 274. alla Tor
sia 274. Pompeiano 278.
Viola mammola 136 197.
Virilio ^ 119 140 200 229 282 aS3
284 285 299 3 io 329.
Virgilio manoscritto della libreria di s. Lo-
renzo 48-
Visibilio óz8 .
Vita di Ganselin Faiditz poeta ProTenzale.
Manuscritto della libreria di sau Loren-
zo 147 161.
Vita di Guidousel poeta Provenzale. Ma-nusoritto della libreria di aan Lorenzo
127 166.
369Tìta della Beata Uotiltà. Testo a penna
di Francesco Redi i3o.
.Vita di Lanfranco Cicala poeta Provenza-le. Manuscritlo della libreria di s. Lorenzo 166.
Vita di Nuc de Sam Sire poeta Provenza-
le. Testo a penna della libreria di sanLorenzo 166 209.
Vita di Rambaldo di Vacherà poeta Pro-
venzale del testo manuscrilto della li-'
breria di s. Lorenzo 167.
Vita di Riccardo Berbesm poeta Provenza-le, del testo manuscrilto di san Lorenzo184.
Vita di Naimerico di Pepugnano poetaProvenzale del testo a j>euua di s. Lo-renzo 209.
Vita di sam Antonio. Testo a penna di
Francesco Redi 277 So*).
^Viia di Cola di Rienzo stampata za6.
yite bassa 278. vite trapiantata in paesi
differenti produce vino differente 9^ j'r*
tifino lot.
^J^t/lisse Aldovrando 148.^ ^Vlpiano Giureconsulto l’jo.
'^Vocabolario della Crusca So 53 ^ 112
147 ifiB at 5 278 zSi 299 Sol 3i2.
'Vocabolo! io Tolosano 3i2 33i.
Volgarizzamento aulico di Rasis. Manu-scritto della libreria di s. Lorenzo X94.
.Volgarizzamento antico della Bibbia» Ma-” mesco Redi ^77.
S70
z/
Z mutata in d »o8.
Z come pronunziata da Pisani 107»
Zaccaria vescovo di Crisopoli 99.
Zamherlucco 297.
Zucchero Sencivenni Fiorentino 67 170
17^ *94- ^ „ KftZucchezzù, Zuco Zuco 100,
tlóógle
ERRORI CORREZIONI
Ay. Uh,
I i3
*9 *9
24 6
2g I
46 2126 27201 14
22g ult.
262 ig
353 21
pralto prato
spiriti spi I ti
o fresca, One’ o fresca,
L’ arcipoggia orcipoggia
Nelle Annotazioni.
Auacreonte AnacreonteTo-Iontà TO-luttà
medicotiu-gere
domnicellis
Laporeambì Leporeambi
,
modicotin-guere
domicellis





















































































































































































































































































































































































































































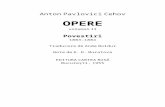









![Opere di Francesco Redi [electronic resource]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63365079d2b728420308455e/opere-di-francesco-redi-electronic-resource.jpg)