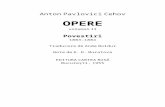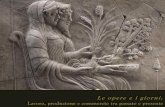La sistemazione della teoria dei nomi divini nelle opere di Alano di Lilla
Transcript of La sistemazione della teoria dei nomi divini nelle opere di Alano di Lilla
gavsl4
418rT
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMIDrvrNr NELLE opERE Dr ArANo or rrriÀ-
LIIIGI CATALANI
Estrafto Aa:STT]DI FILOSOFICI
UII - 1999
4
I
BIBLIOPOLIS
Lurcr Cerer.r,Nr
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMIDIVINI NELLE OPERE DI ALANO Di TILLA
Tra le molteplici questioni teologiche ed apologetíche su cuiAlano di Lilla ebbe modo di concentrare la sua atteîziore di perua-tore cistiano; uno spazio tutto particolare occupa il problema aà Un-guaggio teòlogico: la ferma volontà di fissare e precisare il vocabola-rio della scienza di Dio, di dissipare i rischi di equivoco più fre-quenti, di risolvere i casi in cui l'ortodossia cristiana pareva minatadall'applicazione delle regole logico-grammaticali, di pùntualizzare ilsenso, il signifícató delle espressioni bibliche piùr ambigue, è una co-stante che emerge lungo tutta l'opeta del maestro, proponendosicome una delle chiavi di lettura più efficaci nel lavoro di interpreta-zione dei suoi vari e molteplici scritti.
Nelle due opere più speculative e sistematiche, vale a dire laSutnma Quoniam honinesr e Ie Regulae theologicae2, il maesúo diLilla espone in maniera chiara e dettagliata una questione che si pofjesenza dubbio al centro del problema, vasto ed articolato, del linqpLig: rgio teologico, costituendone l'espressione più interessante e signíìica-tiva: la critica dei nomi divini.
Queste due opere, che costituiscono il vertice teoretico più spic-cato nell'ambito della tradizione filosofico-teologic a porretanat, rap-
1 Plur Gr.onleux, 'La Somme Qaotúam homhes d'Alan de I-t\le", Archioesd bhtoìE doctthdh a litt&aite du Moyex Age;20 11953), pp. 113-)59.
'zNIcHorAs N. HÀurc, Magister Alani Regulae celestis iws, Atchioes tlti-stoift doctriîtah et littéîahe du Mogex Age,48 (1981), pp. 97-226. L'opera è presenteanche in PL 210, coll, 617-688.
, Tale radizione fa capo nel suo insieme all'opera ed all'insegnamento di Gil-belto di Poitie$ (1080 ca, - 11541 ed ai suoi Commextarìa agli Opuscula Saoa boe-ziani. All'interno di essa si possono però distinguere almeno tre gruppi di maestri
STUDI FILOSOflCIxxII (r9r9)BIBLIOPOLIS
LUIGI CATALANI
presentano una tappa obbligata e decisiva nell'evoluzione storicadella riflessione sul tema dei nomi di Dioa, in quanto raggiungono unelevato grado di organicità e di matura e precisa, seppur non definitiva, sistemazione del problema in questione.
Gli interessi culturaii di Alano furono così ampi, e l'insieme deisuoi scritti così influente, che i posteri lo designarono "Doctor uni-versalis ". A questo suo eclettismo, a questa sua capacità di passarecon disinvoitura da un genere letterario all'alto, corrispose un carat-tere poco incline alla celebrità e per nulla attîatto da| prestigio dellecariche ecclesiastiche. Forse a ciò è dovuta la scarsità di informazioniche ci sono giunte sulla sua vita: nacque a Lilia intorno al 1120, si{ormò in giovane età agli interessi filosofici della scuola di Chartresstudiando con Gilberto Porretano e Bernardo Silvestre; dopodichépossiamo solo immaginare un suo soggiorno a Montpellier prima dellasua permanenza, di cui abbiamo testimonianza, a Parigi in un lassodi anni compreso tra il 1160 ed il 1180. Nel frattempo s'avvicinò al-l'ordine cistercense, al quale aderì una decina d'anni prima dellamorte, awenuta a Cîteaux rcl 120213.
Un cenno particolare merita lo schema teologico complessivo en-ffo cui tovano posto le numerosissime opete di Alano: egli stesso hastabilito numerose divisioni interne alla sctenza teologica, dalle qualipuò essere utile prendere spunto per dare un elenco ragionato deisuoi scritti.
Alano accoglie innanzitutto la divisione tra teologia spetulativae teologia pratica, che in sostanza equipara alla distinzione tra theo-Iogia rationalis e theologìa rnoralis. Compito della teologia specula-
"porretani": 1) gli anonimi autori delle opere della cosiddetta "prima scuola porreta-na", scritte poco prima o immediatamente a ridosso del concfio di Reims (1148),2)un ristretto numero di maestri e teologi (tra cui lo stesso Alano) i quali, puÌ non essendo veri e propri allievi di Giiberto, manifestano una parenreìa assai srretta con ilsuo pensiero, J) una serie di fedeli discepoli di Gilberto, raggruppati sorto letichettadi "piccola scuola porretana", che, sul {inire del Xll secolo, s inpegnarono tenace-mente nella difesa delle sue reorie, messe sotto accusa daglì anersari.
a Su questo specifico itinerario storico filosofico ci ripromertiamo di tornare infuturo con un'analisi più approfondita e completa all interno ci un volume monogra-fico dedicato intetamente a tale questiooe. La scelta di iraugurare questa linea di ri'cerca con ia disamina delle opere di Alano si spiega non soio con il modo particolar-mente innovativo e rigoroso con cui egli ha affronrato ii tema, ma soprarturto con lasua capacità di portare alla luce le molteplici tradizioni filosofiche e teologiche chepresiedono alla sua accurata sistemazione.
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 9
tiva e razianale (detta anche superior o celestis) è studiare le naturedivine ed angeliche, mentre la teologia pratica (morale) è detta pureinferior o subcelestis e s'interessa della condotta degli uomini. Leopere di Alano possono essere fatte rienÚare in una serie inÚicata dinodi e di sovrapposizioni tra i diversi piani e livelli della teologiat, inmodo da essere così ciassificate:
a) opere letterarie, quali il De Planctu Naturae, I'Anticlaud.ianus(le sue due grandi opere di teologia poetica), il Rhythnus de Incama-tione et de septem artibus, il poema V/x nodosun;
b) opere di teologia speculativa vera e propria: la Sumna Quo-niam homines, due Questioni sulla fede, le Regulae Theologicae, laHierarchia Alani, okre al De fide catholica, che, diversamente dallealre, ha uno scopo di opposízione alle eresie, essendo schierata cor-tra haereticos, Valdcnses, Iudaeos et paganos;
c) opere di teologia morale, teoreticamente intese, quali il Deoirtutibus, De uitih, De donis Spiritus Sancti ed un Liber patabolarum;
d) opere di teologia speculativa, ma intese questa volta da unpunto di vista pratico, possono dirsi le Distixctiones DictiorumTheologicaliun (" Summa Quot Modis"), |'Elucìdatio in Cantica Can-ticor rz, úna Glosatura super Cantica, un'Expositio del Padre No-stro, le Expositiones del Credo di Nicene e del Credo Apostolico,un Poema sul Credo Pseudo-Atanasiano e |'Exposiùo Prosae de An-ge lisl
e) opere di teologia morale in senso proprio: lo scritto Quodnon est celebrand.um bis in d.ie, tl Liber Poenitentialh, I De Sex A/isCberubim, I'Ars Praedicandi ed una serie di Sermoni6.
Nell'opera di Alano, dunque, la speculazione teoretica va di pàripasso con l'intento più schiettamente morale ed edificante: la stessacritica dei nomi di Dio, che noi apprezzeremo specialmente per I'acu-tezza dell'analisi filosofica e la ricchezza di patrimonio teologicomesso in campo) contiene un'evidente potenzialità apologetica, voltaa confutare gli erori linguistici (e dunque teologicí) delle conentieretiche del tempo.
' Cfr. G.R. Er^Ns, Ahn of Lille. The frortier of tbeolog in the kte htelftbce tury, C^rnb dge 7983, pp. 12-19. Per la nozione di "teologia" in Alano, cfr.M.T, o'Arvr*r1 " Alain de Lille et la theologia", in L'homme dèvaxt Dieu, Il, Patis1964, pp. 1ll-128.
ó Per l'ìnsieme completo delle fonti ed una serie di utili 9 dettagliate informa-zioni sulie opere di Aìano, cfr. M.-T. o'Alvnnrv, Aiain de Lille. Textes ixèdits auecfle ifltrcd,uctìatt sut sa oie et ses oe ures, Paris 1965, pp. 32-184.
' 1 0 LUIGI CATALANI
Va notato che una delle due opere su cui ci soffermeremo, laSurnma Quoniam honines, si ptesenta, seppur incompleta, come unvalido tentativo di offrire una visuale sulf intero campo delia scienzateologica, dalla speculativa alla pratica, dalla tazionale alla morale,dalla proposizione delle proprie tesi all'opposizione contro le teorieeretiche. ln ogni caso, il suo inserimento tra le opere di pura teologiaspeculativa è piìr che giustificato, come testimonia con chiarczza lasistematicità ed il rigore metodologico dell'analisi svolta sulla que-stione dei nomi divini.
Il Trattato De diainis noninibus nella Sammo Quonian homines
Il grande valore storico-filosofico di qresta Suffina è statomesso nel dovuto rilievo già prima che P. Glorieux ne assegnasse de-finitivamente la paternità ad AlanoT e la pubblicasse pei la pnmavolta nel 195J; iI testo era inÍatti stato segnalato in precedenza daM. Grabmanns, poi studiato da J.M. Parente e da O. Lottinro. Laconvincente argomentazione messa in campo da Grabmann per risol-vere defínitivamente il problema della paternità dell'opera ci è utileper rilevare lo stretto legame che sussiste tra la Surnma e le altreopere di Alano 11.
7 P Gronrrux, " L'auteur de la Somme Qaoxiam homines", Reclletches deThéalogie axcienne et médi6ale, 1l (1950), pp. 29-45.
3 M. GRABM^NN, Ein neuarfgefaxdenes Bruchstick der Apologia Abaekrds,Múnchen 19J0, p.28, n. 1.
e J.M. P^RENr, "Un nouveau témoin de la théologie diooysienne au XIIe siè.cle" , Aus der Geistesueb des Mittekben (Bàtùge z / Geschichte der Philosophie des Mit-tekhets, Stpplementband III, 1'2), Múnster 1935, t.1, pp. 289-J09. Lo studioso facevagiustamente risalire I'opera alla seconda metà del XII secolo, notava notevoli rassomiglianze letrerarie e dorrrinali con gli scitti teologici di Alano (ma non la attibuiva di-chiaratamente ad esso) e sí dedicava soprattutto a mettere in luce l'ispirazione dionisia-no-eriugeniana, colta in modo indiscutibìle nei temi dell'inconoscibilità divina, dei li-miti della teologia positiva, della superioritàL del metodo negativo.
10 O. LorrÌN, "Les théories du peché originel au XIle siècle. - IL La réactionabélardienne et porrétaine", rn Recherches de Théologie aflcienne et nédibale, 12(1940 ) , pp .78 -101 .
Glorieux ha preso le mosse dalle indicazioni degli studi precedenti per mo'strare la veridicità della sua tesi in base all'unica analisi filoÌogico-filoso{ica possibile:queila dei confronto ua I testo della Sumna e le altre opere di Alano. Egli ha noratoinnanzitutto una somiglianza di fondo nel contenuto dottrinale: remi come quellodella semplicità divina, dell'incomprensibilità di Dio o degli stessi nomi divini (citia-
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIV]NI 1 1
La serie di annotazioni, sulla cui base Glorieux ha potuto asse-gnare ).a Surnma ad Alano, aiuta a cogliere il carattere paradigmaticodi quest'opera e c'introduce ad un'altra questione di primaria impor-tanza, vale a dire il problema della datazione.
Una volta assodata la paternità dell'opera, il dibattito citico srè concentrato specialmente sul rapporto cronologico tra essa e le Re-gulae, le quali propongono un contenuto simiie, ma espresso in unimpianto formale del tutto distinto; alla ricca argomentazione dellaSurnma, conisponde la rigida serie di assiomi delle Regulaet2.
mo i casi per noi più significativi) sono sviluppati con la stessa cura analitica nelleRegulae tùeologicae, seppur in una veste formale diversa. Non solo ie tesi,cardinedella Sumna, ma anche nurnerose tesi secondarie ritornano in alue sue opere con evi-dente tegolarità: in primo luogo le varie diramazioni del problema della terminologiateologica. La strettissima parentela è confermata inoltre dall'uso e dalla scelta dellefonti: accanto ai-llondamentali Agostino, Ilario, Gerolamo, Dionigi e Boezio, rtoviamo - nella Sutzma come altrove - i piìr rari e quindi più significativi ErmeteTrismegisto, Calcidio, Platone, Giovanni Scoto Eriugena, Porfirio. Anche sottoI'aspetto formale, Ia Summa rlrchiama alcune caratteristiche del tutto peculiari all'in-sieme deÌle opere di Alano: particolarmente indicativo il ripetersi di termiú tecniciassolutamente tipici del maestro di Lilla (un esempio per tutrir l'uso recnico della pa-rola rcgula, tn termine che è indicatote, come vedremo, di una precisa e rivoluziona-ria metodoÌogia teologica). Da sottolineare infine il ripresentarsi di una duplicità distile (uno piìr elevato, I'altro piìr corrente) che è altrettanto catatterizzante, visto ch€se ne ha ttaccia nel Libet poenitentialis come nel De fide cdtholica o ielfe Distiî1ctio-na theologicae. Parole, formule ed espressioni varie ritornano, da un'opera all'altra,nella medesima forma, assieme ad altre caratterGtiche stilistiche.
12 Il problema è stato di capLe quale delle due elaborazioni fosse stata scritraprima: ambedue 1e tesi disponevano di argomenti piìr o meno validi ma non di provedecisive (un rapido cenno a questa disputa si trova in Lauge Olaf Nrrlsnt, TÉeolog1,atzà Philosophl in the Twelfth Century. A Stuà! af Gilbelt Poîreta's thinking and theTbeological Expositions of the Doctrìne of the Incamatíon daing the peiod 11301180, Leiden 1982, p.343); occorreva avere innanzitutto delle prove cette sulla datazione della Summa per cercare di capire se essa fosse figlia o madre della "teologiain assiomi " delle Reguke. Una ricerca di O. Lortn (" Alain de Lille, une des sourcesdes Disputatìo1îes de Simon de To'atnai", Recherches d,e Théologie ancienne et méàié.oale, 71 (1950), pp. 175'186) ha mostrato come Simone di Tournai si sia isprratonelle sue opere fondamentali Ala Summa di Alano per ciò che riguarda il problemadel peccato originale: poiché Simone adopera testi pubblicati intorno al 1160, questasarebbe la data approssimativa della stessa Sunma, di coiL le Rega&e rappresentereb-bero un'elaborazione successiva, piùr matura e " stilizzata ". Non della stessa opinioneGlorieux, il quale, seguito da Vasoli, ha creduto di fissare Ia data della pubblicazio.ne dd)e Regulae qualche anno prima dspetto alla Sumna: cfr. Cesare VAsoLt, "Stu-di recenti su Alano di Lilla", B letti o Istituta storico italiano pet il Medioao. At-chiuio nututoia o, 72 (1960), pp. -35-89. Tunavia la datazione di entrambe le opere non può essere definita con sicruezza, né tantomeno con precisione: l'unica im
LUIGI CATÀLANI
La sistematicità della Samriaa, il suo rigoroso ed ambizioso pro-getto, emergono dall' impianto stesso dell'opera, il quaie suddivide il te,sto in fte sezioni: solo la prima, consacrata a Dio ed alla Trinità, cr egiunta interamente nei due manoscritti superstiti, menfte la seconda,dedicata alle creature inferiori a Dio, ci è giunta in parte, e delTa terza,concernente la restaurazione dell'uomo, non abbiamo alcuna traccia lr.Questo articolato piano dell'opera, presentato nel Prologora, viene so-stanzialmente rispettato lungo il corso del testo: tuttavia la presenza dialcune ripetizioni e di qualche lacuna fa pensare ad una redazione, le-gittimamente imperfetta, di un corso di lezioni piir o meno lungo, edoggetto di continua elaborazione da parte del maestro lt.
pressione certa è la stretta concordanza tematica rra le due opere, che fa supporrecon ogni probabilità che Ie due elaborazioni apparrengano allo stesso arco di anni_Cfr. Giulio o'Oronnro, " L'età boeziana della ìiologia", jn Stotia delk teologia ,te/Medioeuo, 11- La grande fioritura, Piemme, Casale Monferrato 1.996, pp. )i8 3j9128)-3911: " non a caso è possibile stabilire parallelismi moÌto significativi dal puntodi vista del conrenuto tta la dottrina esposta nelÌe Regu/ae e qte11a che lo itessoAlano ha affidato, più o meno negli stessi anni, alla Summa " euoiiam homines', l.nafattazione sistematica, discorsiva e ordinata, della riflessione razionale sulla fede:come se, parallelamente alla produzione di un trattato espositivo de1la dortrina crr_stiana, egli abbia voluto proporne anche una rielaboraziott. .o.t.uitu ad arte secondoun procedimento di enucleazione concettuale disciplinato da una applicazione rigorosadei formalismi tecnici della dialettica ai principi peculiari del sapire teologicÀ, chesono poi gli enunciati della fede". Evers, Akn af Lille, pp. 15-16, ritiene che laSamma sita la prima grande opera pubblicata da Alano e chi le Reguke siano sratescritte all'incirca nello stesso periodo, ma evidentemente qualche anno piir tardi. È lo
"tesso periodo d:ranre iJ qrale i l mae"rro di LiJLa avrebbe soggiornaro a l ;r igi (assie.
me a Pietro Cantore e Simone di Tournai): il forte carattere pofietano delli Summa(evidenLe nel la definizion. de]U unitas e neJla dortr ina Lrinirariat e Lre r l- :are al lusionialla Senna e a Montmartre rinviano infatti all'ambiente oarieino.
1r Gronreux, "La Somme", p. 115, .tferma però che il trxttaro De utttrrDus)De ritiis, De donis Spiitus Sancti , edito da O. LoînN, Medieaal Studics, 12 (1950),pp.20,]6 aÌtro non è che un ampio frammenro della parte mancante dell'opera.
tn Summa Quoxiam honines, ed. P. GLoRIEUX, p. 120: " nos ergo rerum ordinitractatus otdinem conformantes, primo ad creatorem, secundo ad cieature creatio-nehJ tertio ad eiusdem recreationem styli vertamus officium,,.
. I t Gronmux, "La Somme", p. 117: " la construction de Ia Somme euonram
baînífies n'est pas sans quelques faibÌesses_ Le plan assez préck dans les débuts dechaque part ie .e relache a mesufe que 1on orogresse, er bien des problème. se
"uivenl alors sans Ìien rrès logique Assez soLrvent aussi des questions incidentes sevoient aborder au risque de couper ou du moins d'alourdir la suire de la démonstra-tion". D'ALVERNv, Alain de Lille. Textcs ìnèdìts, p. ó1: "il s'agit, nous sembÌe-t-il,d'une collection de notes de cours, assez hativemÀnt rédigées, eììes correspondent àun enselgnement qui s'esr peut,etre étalé sur de longues années ".
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 1 3
Il Prologo, seppur breve, ci offre anche qualche utile indica,zione di metodo. Alano reputa un compito fondamentale per il teo-logo quello di conoscere l,a Íorza, 1l valore delle parole che usa: tale{orza consiste nelia loro ricchezza semantica, all'interno della quale ilteologo deve saper scegìiere il significato piùr appropriato per ognicontesto in cui vengono adoperate. Questa preoccupazione, che è na,turalmente alla base dell' interesse per la questione dei nomi divini, èayanzata con Eîande chiarezza e corroborata dall'autorità di llaric,.
Et quia, ut aristotelica tuba proclamat, qui virtutis nominumsunt ignari, cito paralogizantur, dum illi in theologicorum scien-tia deficiunt, diversas erroris imposturas conficiunt, ignorantesquod sicut res divine natura preeminentes miraculose sunt, itaet eas nomina non naturaliter sed miraculose significant. Undesummus testatuf HiÌarius: Sermo nature succumbit, et fem utest verba non explicant 16.
La scarsa conoscenza delle potenzialità semantiche dei terminiinduce dunque a commettere una serie di errori, a cadere in paralo-gismi, in vizi formali del ragionamento che, in ambito teologico,sono decisamente gravi: un esame superficiale del senso dei vocabolipuò infatti condurre ad imperdonabili distorsioni della dottrina cristiana e dei suoi dogmi, quindi a tesi eretiche. Non bisogna mai con-fondere, ammonisce Alano, il piano della realtà naturale e quello divino; sulla scorta di Boezio egli afferma quest'importante concetto.con poche ma signi{icative parole: "cum enim termini a naturalibusad theologica transferuntur, novas significationes admirantur et anti-quas exposcere videntur " li,
Le parole che hanno un determinato significato nell'uso quoti-diano ne acquistano uno totalmente nuovo nel campo delia scienzateologica: la tendenza delle parole - o meglio, di chi le usa - vareil vecchio significato è il pericolo dinanzi al quale Alano mette inguardia i teologi, che devono spiegare i misteri della fede attraversol'uso accorto del vocabolario " naturale ". Poiché non si può elaborareex ltoto an dizionario che sia esclusivamente e degnamente " teologico" (ogni parola ha infatti la sua origine nel mondo fisico), occorrepuntualizzare il senso, la trasformazione, I'elevazione semantica dei
16 Summa Quoniam honines, ed. P. GlomÉux, p. 119.t] Summa Quaniam homines, ed. P GLoRrEUx, p. 119.
1 4 LUIGI CATAL,A.NI
termini che vengono presi in prestito da un campo toralmente di-stinto da quello divino 18.
La scienza teologica sembra dunque porsi come obiettivo prima-rio quello di dare delle regole precise al discorso su Dio, piìr ancorache ricercare le verità della fedele
r3 G.R. EvANs, "Alan of Lille and the threshold of theology ", Analecta Cisterciensia, 36 \1980), pp. 129-141, si sofferma appro{onditamente sul rapporto tra lateologia e le regole delle arles nelle opere di Alano. Il tema della regolarizzazronedella normazione del linguaggìo teologico è infatti tta i favoriti del maesto di Lilla.La EvANs pone un quesito fondamentale: "can we use the rules of the artes to an-swer theological questions? ft would seem, on the face of it, that Alan thinks not,because theology is clea y not subject to the rules of the artes". E tuttavia "his theo-logical writings, like those of many of his contemporaries, are {ull of technical termsof the arta - indeed, they are notably rich in such technicalities. But Alan has ananswel to the problem which permits him to make full use of the skills he posses,even though he believes that theology cannot be subject to these lorver regulae". Lasoluzione di Alano, debitrice verso il De Tinìtate boezi^îo, è quella di segnate conpreclsione la linea di demarcazione che divide le a$i dalla teologia: le scienze dellatagione umana hanno l'importante compito di condurre l'uomo fin sulla soglia dellascienza divina, oltte la quale però non possono categoricamente andare, pena la pcrcolosa colfusione tra il piano naturale ed il piano trascendente. La Evars fa inoltreun interessante confronto con la posizione di Gilberto Porretano, il quale, soppri-mendo ogni nooa sìgnifrcatio, 4veva spostato più in avanti la sogJia,limite pet le artes:"Alan preferred to celebrate these novel meanings, to th-row them il'lto relief; by em-phasising the stupefaction of human reason and the arts of ianguage he tried to re-fÌect glory upon the mysteries of theology which are beyond reason. It is not that Gi-lbert is not aware of the existence of what Boethius calls the secreta theologie altiois.It is'rather that he has more confidence than Alan in the oower of the liberal arrs ropeneffate those mysteries. He would ser Boethius' th-re;hold, rhe finit conltit trîbeyond which the altet caíîol go, rather higher than Alan proposes to do ". Da no-taîe, tÌa l'altroJ il cenno all'istanza celebrativa, che rappresenta una traccia significa,tiva della tiscoperta del discorso di lode pseudo-dionisiano.
" J. Cnanuon, "La mèthode théologique d'Alain de Lille", rn A,t.Yv., Ahinde Lille, Gauthiet de Chàtillon, lakenart Giélée et leal temps, Actes du Colloque deLille (oct. 1978), a c. di H. RousseL-F. Sulno, Lille 1980, pp. 47-60 (e in Io., Dlv-d.ore d.e Sèaille à Saixt Tbomas d'Aquin, Etudes d'histoire et de theologie, London,1985), p. 53 "la science théologique apparait donc ici comme la grammaire du di,scouis sur DieuJ'. Chatillon riprende la tesi del primato della grammatica da Marie-Dominique Cnrrvu, "Un essai de méthode théologique ar XIIe slècle", Rewe clesScíences philosophiques et théologiques, 24 (1935), pp. 258.261. !,Iaín De l,raare,'Logiqne et Théologie dans la Samma Quaniam homizes d'Alain de Lile" , ln Gilbertd.e Poìtet et ses colltempatuiîts. Arx oigines de h logíca fltodemo h?; Actes du
".p-tieme symposium eùropéen d'HistoLe de la logique et de la sémanrique médiévales,Poitiers 17-22 Juin 1985, Bibliopolis, Napoli 1987, pp. 4i1-469, ha mostralo invccecome I'apporto della logica sia altrettanto decisivo per lo sviluppo del pensiero teo-losico di Alano.
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 1.5
Accanto a questa precisa indicazione metodologica, preludio diuno sviluppo approfondito dell'intera quesrione, trova posto un'altrapeculiarità della speculazione di Alano, presente con particolare evi-denza nella Summa: si tratta dell'esigenza sistematica e toralizzarrre,che spinge l'autore a costruire una serie di schemi e di sistemí serar-chici, entro cui {ar rientrare l'intera trama della realtà. da quella di-vina a quella terrena2o. Questo progerro non può che riÀandare,come lo stesso Alano ammette, al sistema speculativo eriugeniano.
Lo schema presentato dall'autore si fonda su due tipi di classifi-cazioni poste in relazione reciproca: la distinzione delle facoltà men-tali e la gerarchizzazione della teologia. Thesis ed extasis sono le duefacoltà mentali che si distinguono in base alla loro potenza: la primanon oltrepassa i limiti naturali in quanto consideta l'uomo nella suacondizione temporale, finita, mentre la seconda è in grado di elevarel'uomo al di là del mondo fisico e di fareli intuire i misteri rrascen-denti:
TheoÌogia in duas disringuitur species: supercelesrem et subcele-stem, sive apotheticam et ypotheticam, ut testatur JohannesScotus super Hierarchiam. Istae autem due species origínem ha-benr ex duabus potenti is animae. Animae enim variae sunt po.tentiae; una quae dicitur thesis, scilicet ratio, secundum quampotentiam homo in suo sLaru consideratur, n"" ruorn rtutuaegreditur quia ea humana et tellena considetat; alia est quaeextasis nuncupatur, cuius specu.latione homo exfta se constitr.{i-tur 21.
f però la distinzione interna all'extasis quella che induce Alanoa considerare il duplice piano della conoscenza teologica2z. All'in-
20 M. Arrorr,t, Ia tealogia d.el peccato in Alano di Lilla, Edizioni Augustmus,Palermo 1986, pp. 51,52: "l'intera opera letteraria di Alano esprime bene la strutturaunitada del sapere. Sia le opere teologiche sistematiche, sia le poetiche, sono co-struite secondo un rigoroso sisrema unitario, e formano come i tàsselli di un unicomosaico. L'autore, consapevole della complessità ma anche dell'armonicità della realtàda abbracciare, tesse una tela che con la vastità della sua trama eli consente di co-gliere i vari asperri deLla realrà '.
2t Summa Quoùam homines. ed. P. GLoRrEUx. p. l2l.22 La stessa distinzione è presente nelle pagine iniziaii deJJ'Expoitio prosae de
angelis, it o'Ar,vn*nu, Ahíx de Lille. Tetctet iflèdits, p. 195r " apotherica est illa spe-cies theologiae quae de unitate Trinitatis et tiinitate Unitatis speculationem pollice-tu-r. Unde et aporherica quasi superposiLiva dicirur, quia in ea dà supercelesribus agi
16 LUrGI CATALAN.T
terno di tale facoltà si distinguono infatti un tipo inferiore, che con-sidera l'uomo "infra se", ed un tipo superiore, che conduce l'essereumano al di là di se stesso. L'exlasis superior, a sua volta, contempladue distinte potenze conoscitive, I'intellectus e I'intelligentia:
Sed superioris due sunt species: una quae dicitur intellectus,qua homo considerat spiritualia, id est angelos et animas; se-cundum quam homo fit spiritus, et ita supra se fit. Alia est
. quae intelligentia dicitur, qua homo trinitatem infuelur; secun-dum quam homo fit homo deus, quia per hanc . speculationemquodammodo deificarur. Unde er illa speculatio aporheosis,quasi divina censetur2r.
. Dùl'intellectas, dunque, attraverso cui l'uo1no considera solo lerealtà spirituali (gli angeli e l'uomo), deriva la theologia ypothertca osubcelesth meîtîe dalf intelligentia, con cui l'uomo si awicina allacontemplazione del mistero trinitario, deri.va la tbeologia apotbetica osupercelestit,la quale timanda al tema della deificazione2a. Dolla thesis(ratio) deiva invece la filosofia natur.ale, la considerazione delle cose
slc_ne ".
tut. Ypothetica vero dicitur illa theologiae species qu4e celestium spirituum velciuium spondet doctrinah. Unde et ypothtica quasi subpositiva dícitur, quia creatrspiritus speculatioÀem prosequitur ".
2t Summa Qaoxiam bomines, ed. P. GLoNEux, p, 121. :2a Ev,tns, " Alan of Lille and the threshold ", pp. ú9-147, ha scritto delle ín-
teressantissiúe pagine sulla d,eificatìo, atahzzando le fonti (in pxticolate l'Asclepìus)che Alano ha usaLo per la tlatrazione di quesra questione.
25 At-Iottt, k teología, p. 51, riconduce ad un unico schema il complessodelle distinzioni e delle dassificazioni contenute in quest'esordio ddla Samna
1. Tbesis (utio): pbilosophia xaturalis, 2, EJ.tash:
a. Infeiot:- S ens ua litas : ph i logea- Obstixatio ix nzlitianz: philokbia
b. Supetior:bt tellectus : the o logìa tpo thetica
- Irtelligentia: theologia apotbeticaCfr. C. V,r.sor,r, "La teologia apothetica di Alano di Lilla ", Rioista citica di
Stoia d,elh fi.losofi4, 16 (1961), p. 167 [15J-188 e 278-)141: " tutta la gamma dei pro-blemi antropologici, psicologici, morali; conoscitivi, metafisici, è così risolta nell'ord!nato sistema della distinzione alaniana. E il compito dd rzagisler consistetà appuntonel mostrarc l'articolazione e il nesso teologico di questi ptoblemi, la loro genesi nel'
LA SJSTIMAZIONE DELLA TEORI,A. DLI NOMT DIVINI 1 7
Il primo libro della Sunrna è consacrato proprio alla teologiaapotbetica ed è composto di due parti: una dedicata all'essenza divinaconsiderata nella sua unità (all'interno della quale trova molto spaziol'analisi dei nomi divini essenziali) ed un'alra che si concentra sullapluralità delle persone, e di conseguenza sui nomi divíni personalinelle loro molteplici specie. Il secondo libro considera invece alcunequestioni fondamentali della tbeologia subcelestis, quali la natuta degliangeli, la creazione dell'uomo, la condizione umana in seguito al pec-cato originale, dopodiché il testo s'interrompe. È sul primo volumr-noso libro che si concentra la nostra attenzione, in quanto esso con-tiene l'analisi sistematica dei nomi di Dio e dei problemi ad essi con-nessi.
Tale analisi è svolta da Alano sulla base di due tipi di fonti,vale a dire le opere dei Padri della Chiesa e gli srittí dei filosofi pa-gani, ma soprattutto sulla base di una serie di "ragioni necessarie"26,le quali costituiscono anche il {ulcro della teologia assiomatica delleRegulae tbeohgicae.
L'unità è dunque il primo attributo divino ad essere preso lnconsiderazione da Alano. L'unità di Dio consiste nell'assenza di com-posizione di parti al suo intetno, nella sua indivisibilità; in base adun'argomentazione certo non nuova, il maestro spiega che occorrestabilire come principio prímo delle realtà naturali un unico essetesemplice incausato2T. Dio non è solo uno, ma è I'unità in sé, la mo-nade immutabile e sempre identica a sé stessa. Il nostro intellerro,abituato a distinguere ed a separare, trova molte difficoltà ad intuirqla semplicità dell'unità divina: è perciò costretto, se vuole concepirlain qualche modo, a pensate a qualcosa di completamente estraneoalle realtà fisiche. Il metodo di conoscenza più adeguato consistetàquindi nel sottrane attributi positivi all'entità divina piuttosto che
l'ordine del Creatore e della creazione, e, soprattutto, il loro posto in una storiaideale di categorie e di essenze meta{isiche, poste tm l'Unità originaria e lapotlteosisfinale che riconduce la contemplazione mistica dell'anima all'immutabile 'Paradiso
delle origini' '.26 Summa Quonìam homircs, ed. P. Gronrrux, p. 122: "de qua hoc ordine
agendum est: primo, probando unitatem essentiae rationibus variis; secundo auctorl'tatibus variis gentilium philosophorum; tertio utendo auctoritatibus sanctorum pa'trum, tam vetetis quam novi testamenti, hoc rnodo",
27 Summa Qtonian homines, ed. P Grorueux, p. 12J: "causam autem ex quaalia procederent oportuit esse simplicem, relegato omni genere compositionis. Si enimaliquo modo composita esset, initium existentiae haberet, et ita eam alia causa preve-nhet: simiÌiter illam alia. et sic incurreretur infinitas".
1 8 T,UIGI CATAI-ANI
caratter\zzaîla ed aggettivarla come un qualsiasi ente fisico. La teolo-gia negativa dello pseudo'Dionígi Areopagita ritrova vigore e forzaespressiva nella lucida analisi di Alano:
Quia ergo universalis lerum causa omnimodam habet in se stm-plicitatem el ita in se nullam retinet formam, nec mensura in-rellectus concipi potest. Itaque immensus, incomprehensibilis,invesrigabilis, ini o te Lligibilis inrelligitur esse deus; et hoc solumde deo scire fatemur ut nihil de eo scire confiteamur23.
L'inconoscibilità di Dio (sapere di Dio soltanto di non sapernenulla) viene dunque posta in primo piano, assieme alla sua immensitàed aila sua semplicità. Ma un'altra serie di attributi accompagna que-sta prima importante definizione dell'essenza divina. Dio è ingene-rato (in quanto 7a geueratio altto non è che f ad.uentus forrxae ad nza-teian, e tale distinzione non può sussistere in Dio), è incorruttibile,immortale (in quanto la morte è il recessus formae a rnateria), è ím'mutabile, eterno ed infinito, è causa efficiente di ogni cosa, è dovun-que2e.
Alano riporta a questo punto una serie di autorità, pagane e cri-stiane, per corroborare la tesi dell'unità e incomprensibilità divina: leparole di Platone e Macrobio, di Agostino e dello pseudo-Dionigi(" superessentialiter est unus Deus inpartibilis inpartibilibus unitus si-bimetipsi et multis inconmixtus et non multiplicatus "), di MercurioTrismegisto e dell'apostolo Giovanni, setvono ad aÍfiancarc Ia Íorzapersuasiva delle rutiones. Dopo aver sgombrato il campo dalle tesi diAristotele e Platone, degii epicurei e dei manichei, che in maniere di-verse sembravano contrastare I'assioma-base dell'unità divinar0,Alano si concentra sull'attributo della semplicità. Nella sua argomen'tazione, il maestro trova l'occasione per esporre la sua precisa presadi posizione nei confronti della proposizione Deus nan est deìtas, di-stinzione che fu alla base delle accuse mosse a Gilberto di Poitiers daBernardo di Chiaravalle durante il concilio di Reims:
2s Sumna Quoniam homines, ed. P GLoNÉux, p. 1T Cfr Vincenzo Lrcceno," Conoscenza e inconoscibilità di Dio ne1 pensiero di Alano di Ltlla", Medioeuo,2(1976), p. 8 [1 20]: "questo modo di porre i l problema di Dio e la sua dimostrazioneè comune a diversi autori del secolo XIII caratteristico di Alano è il movimenro im.mediato del suo pensiero, con i1 quale egli deduce dalla teoria della semplicità drvrnala sua unicità e infinità, cioè la sua immensità, nel senso etimologico del termine ".
2' Samma Quoniam honines, ed. P. GLoRIÉrJx, pp. 12) 124.ra Summa Quoxiam hanìnes, ed. P. Gronreux, pp. l2t-114.
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 1,9
Si omnimoda simplicitas in Deo est, non est aliud Deus, aliuddeitas, sed ipse Deus est deitas. Si enim deitas esset in Deo etaliud quod Deus, ibi esset compositio et ita non plena simplicitasJ1.
.Boezio, Agostino, lsidoro ed llario sono le autorità più impor-tanti alle quali I'autore si richiama per riaffermare I carattere incom-posito dell'essenza divina, all'interno della quale non si può àistin-gúeîe L q od. est dal quo est o una parte dall'alÍa. Alano insiste aquesto punto sull'incapacità da parte del nostro intelletto di giungeread un'adeguata comprensione di quest'unico. e semplicissimo princi-pio pîimo, e 1o fa mettendo di fronte dei testi in apparente contrastofra di 1oro, alcuni dei quali disperano riguardo la possibilità di intel-ligere Dio, mentre altri mostrano maggiore fiducia in tal senso. Mer-curio Trismegisto e Dionigi l'Areopagita appartengono al primogruppo di fonti,2, mentre un passo di S. Paolo ("per ea quae factasunt invisibilia Dei conspici ") rappresenta bene la seconda tesi, Inrealtà, spiega Alano, la contraddizione tra queste autorità non sussi-ste, in quanto l'Apostolo non ha inteso affermarc la possibilità di co-noscere propriamente Dio, né di cosruire una vera e proptia scienzadi Dio, bensì di intuire la trascendenza divina a partire dalla suaopera $eatfice: "habetur enim de eo scientia per fidem, non per cer-titudinem ". La fede in Dio non può essere dunque considerata allastregua della conoscenza scientifiia di un ente fisico. L'intellezionedi Dio pone l'inteiletto umano in condizioni di notevoli difficoltà, rpdvato com'è dei suoi abituali tetmini di rifedmento e delle sueusuali categorie concettuali: :
Nihil enim intelligibile est nisi quod in eo genere concipiendiintelligitur quo animus rem aminiculo suae proprietatis pefcipit,et pefceptioni secundum vetitatem quam in compositione considerat, assentit; et existentia quidem aminiculis earum proptieta-tum quibus sunt ficta, non quibus aliquid esse fingitur, concipi
tt Summa Quoxiam homixes, ed, P. GroÈEtrx, p. 114.)2 Smme Qaoriam hottixes, ed. P. Gr,on:eux, p. 135: " unde Mercuius in ti-
megisto de Deo loquens ait: hoc ergo quod tale est, scilicet Deus, quod oon subicitutsensibus, infinitum, incomprehensibile, inestimabile est, nec sustineri etenih nec in-dagari potest; ubi enim et unde aut quomodo aut quale sit inceltuîn est. Item Diod-sius ait; Deus quantum est incomprehensibile mtrltum infinitum compreheodens om-nia, ipsum autem incomprehensibile ".
20 LUIGI CATALANI
possint. Deus veio null is proprietatibus subiectus esse polest;unde et si magnus, non tamen quantitate et si iustus non tamenqualitate, ei si durat non tamen temporerr.
L'attuale inconoscibilità di Dio non svanisce del tutto neanchequando l'anima umana titotna alla sua patria celeste: né i beati, négli angeli possono raggiungere una piena e compiura conoscenza diDio, così come Dio conosce sé stessor4.
Proseguendo sulla scia della tradizione teologica negativart("Deus non potest capi intellectu nisi per remotionem"), Alano nonha difficoltà a passare dal problema della conoscenza di Dio aila que-stione della sua nominabilità: "sicut probatum est Deum esse incom-prehensibilem, ita evidens est ipsum esse innominabilem, Ullum enimnomen proprie convenit Deo". Comincia così a prendere forma Iaposizione dell'autore sul tema dei nomi di Dio: su di essa hannoagito congiuntamente molteplici fattori, i più importanti dei qualisono certamente il riotilizzo del Corpus dionisianor6 nell'ottima ver-
rJ Summa Quoniam homines, ed. P. Glorurux, p. 1-17. VAsoLI, "La teologiaaporhetica", p. 178: "la conoscenza di cui siamo capaci nel nostro stato mondaflonon ci permette però affano di prevedere come sarà Ìa conoscenza beatifica, e in quaimodo I'intelletto dei beati riuscirìr a comprendere Dio senza |'adminiaiuzz dei sensoe delf immaginazione, indispensabile alla mente i, statu 1)ìatoit".
ja Sunma Quaniam homixes, ed. P Gronreux, p. 119: "quod aùtem Deus di-citur incomprehensibilis, ad tria referendum est: ad statum presentem in'quo com-prehendi non potest; ad alium modum comprehendendi, quia alio modo comprehen-ditur quam alie res; et ad naturam ipsius Dei, quia plenarie comprehendi non potestnec in via nec in patria; comprehenditur enim perfecte quantum ad statum rationaliscreature sed non quantum ad statum ipsius Dei, quìa nulla creatura potedt eum com-prehendere sicut est e! sicut ipse comprehendit se".
rt LrccARo, " Conoscenza ", p. 3, rinttaccia nel discorso di Nar'o sulla Sfen intel/lglóila (in o'Ar-veuv, Akin de Lille. Textes inèd,ns, pp.297-J06) una traccia ancora piùesplicita della scelta apofatica. Alano in questo scritto parla della simile dissomigiianza edella dissimile somìgÌianza tra la sfera intelliglblle, cuìus centtam ubique, circumfetentiantsqtum, e\e altre tre sfere della realtà; Liccaro commenta così: " l'idea di una sfera chenon ha circonferenza e di un centro che non si trova in un solo punto, ma dovunque, èimpossibile per la geometria; Alano sottrae nella metafora stessa con un'immediata ne_gazione l'affermazione che aveva precedentemente posto: ii pensiero resta quindi so_speso davanti all'idea dell'incomprensibilità e ine{fabilità di Dio ".
16 Sull'ingresso di Dionigi al fianco del1a tradizione boeziana cfr. CHENu, " l pla-tonismi del XII secolo", rn La Teologia nel XII secolo, rraduzione italiana di PaoloVrttt, Jaca Book, Milano 1986 pp. 146-152 [12) 159]: " la critica delle ldee, dei 'Nomi
divini', coniugherà frurtuosamente I'epistemologia boeziana con la reoÌogia negativa diDionigi: c'è di che riabilitare il sincretìsmo, al di là dej suoi facili concordismi ".
LA SISTEMAZIONE DELTA TEORIA DEI NOMI DIVINI
sione dell'Eriugena e la profonda incidenza, riscontrabile qià nel mae-stro Gilberto, delle dispute logico-grammaricali in ambito teologicoJT.
Alano si schiera sulla scia di Platone ("oportet nos habere ser-mones cognatos rebus de quibus loquimur, sed ullus sermo cognatusest divinae naturae, ergo nullus sermo proprie potest explicare divi-nam naturam"), di Mercurio Trismegisto, di Dionigi ("cum de Deoloquimur, potius quid non sit quam quid sit significamus; quasi dicat:nullo nomine quid Deus sit, proprie possumus designare "), di Ago-stino e di llario, ed afferma con la massima chiarezza il primato degliattributi divini negativi nei confronti dei nomi positivi, i quali, comenel caso descritto dell'attributo "iustus", implicano sempre una com-posizione tra soggetto e predicato:
Idem ignoramus superesseotialem Dei et invisibilem et ineffabilem in{initarem. lgirur negaLiones in divinis verae, aff irmatio.nes veto incompactae. Convenienter affirmationes theologicaedicuntur incompactae, id est incompositae, quia non significantcompositionem predicati ad subiectum quam tamen videntur si-gnificare. Cum enim dicitur Delrs est iustus non significarurinherenria iusLiciae in Deo, sed porius idemptitas. Deus enimita dicirur ìustus quod est ipsa iust i t ia. Negationes vero veraesunt; nam si attendas negationis proprietatem, vere et ptoprieremovetu! iustitia a Deo, ut cum dicitur Deus non est iustusr3.
,7 Cfr. V,a.soù, "La teologia apothetica", p. 179: 'pochi pensatoli hanno.avuto, come il maestro di Lilla, una consapevolezza così chiara e precisa della neces-sità di fissare regole rigorose del linguaggio teoiogico e, al tempo stesso, della radicaleinadeguatezzt di una scienza costretta a servirsi sempre di un discorso 'improprio' edi termini'translati'da un campo linguistico del tutto diverso"- Giuseppe Alceurvr,L'ortodossia e h gnmnatica, UniversitàL Gregoriana Editrice, Roma 1972, p. 142: " fitsopnttutto la consuetudine con gli scritti dello Pseudo-Dionigi che catalizzò lo svr-luppo ddle questioni relative alla conoscibilità e alla nominabiiità di Dio, come in gc-nerale 1o svluppo che ebbe la trattazione sui 'nomi' divini. In tal senso f influenzadello Pseudo-Dionigi operò in direzione convetgente rispetto all'affermatsi del me-todo dialettico-grammaticaìe presso gli autori di indirizzo porretano'.
ts S mtta Q otiaî\, hamines, ed. P. Gr-onreux, p. 140. Cfr. Cr:a:ru_or,r, 'La
mèthode théologique " , pp. 54'55: " lorsque on dit de Dieu qu'il est juste, il ne peur yavoir ici ni composition ni division, car on ne peut attribuer le prédicat "juste " à unDielr qui serait distinct de sa justice. Il n'y a 1à qu'un jugement d'identité, et d'uneidentité englobante, qui ne laisse place à aucune distinction entre Dieu et sa tusttceou entre la justice de Dieu et tout autre attribut divin. Le discours affirmativ, lor-squ'il s'agit de Dieu, est donc toujours impropre et équivoque. Le discours négatif,en revanche, est toujours approprié et vrai, parce qu'il refuse précisément 2r Dieu cequi ne peut lui ètre attribué par mode de composition ". Un altro esempio proposto è
21,
22 LUIGI CATALANI
Per spiegare meglib come awiene il passaggio dall'affetmazionedelf ineffabilità divina al riconoscimento della sua innominabilità; iImaestro di Lilia si sofferma sulla distinzione sussistente tra l'essere,l'intelletto umano e il linguaggio. L'intelletto è in gtado di cogliete larealtà delle cose, mentte il linguaggio deve esprimere i.l contenutodelf intelletto: c'è tuttavia una disuepanza tra i.tre livelli, in quantol'intelletto ha una portóta piìr ampia rispetto al ìinguaggio, ma restainferiore rispetto alla realà. " Ergo cum divina essentia incomptehen-sibilis et investigabfis sit, citra veto intellectum temanet sermo, di-vina essentia nrllo nomine proprie designatur":
Un motivo ulteriore sta alla.base dell'impossibilità di nominareDio come un ente qualsiasi: ogni norne è infatti assegnato'dall'uomoa parthe dal.suo ìntelbctus, e l'uomo può avere intèllectus solo dellefotme; poiché Dio non ha forma, nessun nome può essergli propda-mente assegnato:
Item, cum Deus omni caÍeat forma, ést enim causa sine causa,' quia causa catrsalissima, .et forma sine forma quia forma forma-
lissima; omne autem nomen ex forma datum sit, Iiquet nullumnotnen Deo proprie convenire,e.
Alano raggiunge a questo punto l'apice' della sua messa in operadelle istanze apofatiche di matrice pseudo-dionisiàna; poiché, nono-stante i limiti del linguaggio, i nomi del mondo terreno sono da sem-pre stati assegnati all'essenza divina, bisogna caphe attrav|rso qualepassaggio di significato ciò awiene. Occotre insomma stabi{ire, argo-menta l'autorel le regole di una corretta Úasposizione di lenso e divalore, .oltreché de1la pura indicazione semantica, dei tetmidl naturaliin diuinisq. È qoi-to Al*o prospetta.in quesio passo ffidamentaledell'opera:
quello delfattlibuzióne della vista o della cecita a Dio, su cui si era già soffetmatoI'Eriugena o praèter has auctoritates, Johannes enim Scotus volens probare quodDeus non proprie dicítur videns, sic ratiocinatus est: cilca quaîn relo locum non ha-bet privatio, actu vel natua, circa eamdem locum non habet habitus. Sed cecitas necacflr nec natura locum habet circa Deum. Ergo sicut proprie Deus Àon prcprie potestdici cecus, ita nec videns ". Summa Qaoxiatz homixet ed. P. GLoNEtrx, p. 140.
1e Sumna Quo am homina, ed, P. Gronrerrx, pp' 140-141.a0 Vasou, "l,a teologia apothetica ", p. 181: " nessuno dei procedimenti e delle
categorie linguístiche può mai 'convenire' alla natura divina, la cui'radicale ineffabi-lità resta fuori discussione. Ma se il nostro Jitrguaggio non ha modi per esprimere l'as-soluta unità e semplicità di Dio, non è però víetato alla parola umana di cetcarc, na-
LA SISTEMÀ.ZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI
Item dictiones ideo inventae sunt ad significandum naturalia;postea ad theologiam translatae. Itaque secundum primam insti-tutionem naturalia designant, secundum vero translationem di-vina significant. Itaque naturalibus proprie, divinis vero inpro-prie conveniunt. Auctoritates vero [omina transtulefunt a natu-ralibus ad theologica. Cum enim viderunt Deum totius bonita-rjs causam, totius originem iustitiae, totius misericordiaefontem, huiusmodi nornina: bonus, iustus, misericors Deo pcrcausam assignavetunLal.
Tutti gli attributi, dunque, come " giusto ", "buono", " misen-cordioso" sono nati per indicare le qualità delle realtà natutali: suc-cessivamente sono stati trasferiti a Dio in quanto fonte di ogni qua-lità, causa originaria della giustizia, della bontà, massimamente degnoquindi di questi attributia2.
In questo modo, pur essendo perfettamente semplice, Dio può es-sere definito, con tutte \e accottezze e le riserve del caso, con un'infi-nita serie di nomi in base ai molteplici effetti della sua opera creatrice.I nomi di Dio sono, come il loro soggetto, ineffabiJi, ma non nel sensoche sono svuotati di ogni forza significativa oppure che non possono
turalrnente con deficiente approssimazione, termini e parole che possano alludere allaÍatu-ra diviba. Parlare di Dio con nomi umani sienifica usare una rnisura e uflo sttu-mento del LurLo inadeguati al proprio oggetto: eppure l'unica via per intendere Dio at-uaverso le 'analogie' della mente umana consiste nel trasferire sul piano teologico inomi e i predicati del linguaggio comune, pet mezzo di una specie di altificio grammati.'cale, lecito anche a chi è perfettamente consapevole della 'superessenzialità'
divina ".at Samma Qaoxiam homines, ed. P. GLoREuJr, p. 141. 1a2 ÉeANs, Ala of Lilh, p. )), osserva mólto appropriatamente: " Alan sees thé
nooa sigxificatio as the 'theological' one and the axtiqua significatio as the'natural'.one. lle must make a distinction here between the actual order of evenîs and theprimacy of a higher sense over a lower one. A.lan accepts that in fact words are nor-mally first used for created things, at leasr in human experience, and that from a hu-man point of viev, they seem to be 'transferred' from the natural to the divine whenwe use theîn to speak of God. He sees a word as something rather like a human soul,a limited, created thing, which begins its life upon earth, but is intended by God toreach a higher level and to be, irt the end, quite at home in heaven. Only vhen itreaches heaven is the huma[ soul in its proper place. Otrly when it is applied to Godis a term used 'ptoperly', in the 'theological' sense of the word. This is a principie onwhich Alan builds 4 ve.y gteat deal, here and elsewhere in his writings. If it is theo,IogicaÌ language vhich is normal and co[ect, then it sets the standard of normalùsage even when it appears to break the rules of grammar and dialectic. That is notto say that the rules of these and the other arts have no force. Theoiogical languagcbreaks the rules by transceoding them, by setting ao altogether higher standard of'propriety', and in this vay it turns them into new, higher rules".
23
24 LUIGI CA.TALANI
essere compresi dall' intelletto umano, bensì in quanto debbono adat'tatsi e con{ormarsi alla natura divina, significano letteralmente I'ineffa-bilear. Gli stessi pronomi dimostrativi, " quae significant mel-am sub-stantiam ", e che quindi sembrano poter significare in modo proprio Ianatura divina, in realtà non sono in grado di farlo, in quanto l'essenzadivina, incorporea ed inteiligibile, sfugge ad ogni carafrerrzzazione e adogni predicazione in senso proprio.
Molto interessante è I'analisi dell'attibuzione dell'essere a Dio,in base alla celebre frase tiportata nell'Esodo: "Ego sum qui sum; etsi quaesierint nomen meum dic eis: qui est misit me ad vos". Ilverbo e$e sembra in effetti il modo piìr adeguato (o meno improprio)Der indicare l'immutabile. e semolicissima essenza divina:
Quod legitr:r in exodo: ego sum qui sum, et si quaesierint, etc.Aon est dictum ratione significandi sed ratione significati, nonproprietate dicendi sed proprietate essendi. Deus enim proprieesr quia immulabil i ler est. Quia ergo Deus proplie est et minusinproprie haec dictio " est " de Deo quam alia dicitur, ei specra-liter ascribituraa.
Naturalmente occorre precisare che l" 'essere" predicato dellerealtà naturali è ben diverso dall"'essere " predicato di Dio; in questosecondo caso bisogna intendere in{atti l'essere nella sua assoluta sem-plicità, pienezza ed originarierà e non l" essere qualcosa
'.
Chiarito il senso dell'equivocità dei termini, a seconda'che sianoriferiti a Dio oppure agli enti finiti, Alano spiega il metodo che oc-cotte seguire per abilitare il vocabolario naturale al discorso teologi-coat; la sua è anche una precisa indicazione lessicale:
{r LrccARo, " Conoscenza ", pp. 1}-14: " ìl Ìinguaggio umano si rrova dunque indifficoltà di fronte alla perfezione immutabile deila semplicità divina, cui non corn-sponde alcun termine esarto di riferimento o di confronto nel campo dell'esperienza.Riguardo ai molteplici elfetti deÌla causa creatrice divina, Dio può essere conosciutoin qualche modo secondo diversi nomi, ma questa moiteplicità di parole si trova nellenostre espressioni umane, mentre nell'essere divino vi è I'assoluta semplicità".
aa Sumna Quoniam hamines,.ed. P GLoRrEUx, p. 141.a' Cnerrror, " La mèthode théologique ", pp. 55'57, riporta la critica che Pre-
positino, discepolo di Pietro Lombardo, rivolse a1 procedimento teologico di Alano:" ce que reproche Prévostin à Alain c'est d'avoìr professè une équivocité des noms dr-vins qui, à la limite, rend tout discours théologique impossible. L'auteur de Ia Summa"Qrì prcdrcit uentos", en ce quì le concerne, se fait le défense,.rr convaincu d'uneunivocité selon laquelle les mots conservènt le mèrne sens, qu'il s'agisse d'un discours
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOM] DIVINI 25
In naturalibus enim ubi denominationes fiunt, aliud est quoddenominatur, aliud a quo denominatur; verbi causa, a[uJ estalbum quod denominatur ab albedjne, aliud albedo a qua fit de_nominaLio. In Deo vero non haber locum denominario quiaDeus est ipsa deitas. Cum ergo Johannes Damascenus ttansno_minationem iemovet a divinis, non translationem sed denomr_nationem intelligere voluit; transnominative enim pro denomi-native dixit. Transnominatio locum habet in divinis sed,r,indenominatioa6.
- In effetti la precisazione terminologica è molto preziosa e chia_rificatrice: dal piano abituale della denominatio (che pìevede aoountoIa distinzione tra un soggetto quod denomiflatur ed ina qtalitù-a r1uodcnominatur), occorre passare, se si vuole costruire un diicorso teólo-gico valido, al livello della trarsnorniratio, ossia di una totale reinter-pretazione, rifondazione semantica, degli strumenti linguistici con_sueti. La transnonifiatio è soprattutto un processo interpretativo, inquanto impone di considerare in una nuova e più elevata veste queglistessi termini che usiamo nel linguaggio quotidiano4T.
Alano, soffermandosi sull'equivocità dell'essere e della sostanzariferiti a Dio ed alle creature, spiega che, rrattandosi di due ambiticompletamente differenti ("aliam significationem habent vocabula rndivinis, aliam in philosophicis " rs), il predicato muta completamenteiÌ proprio senso in d,iuinis, viene appunto " transnominato &e. ll farroche l'uomo sia fatto ad immagine e somiglianza di Dio non significache possa esistere un termine, un nome che indichi entamÉi alfu
sur Dieu ou d un discours sur la créature. Ce n est pas que prévostin ignore les prègesqu'une stricte univocité risque de tendre aux rhéologiens. Mais il penie qo.... piè_ges porrrronr ètre évités si, par d auues procédltes, on alfirme clairiment i, rr"n"..o-dance et I ineffabilité divines>.
a6 Summa Qaoniam homíxes, ed. P GLoNÉux, D. l4J.a7 Cfr, Cueilu, " Grammatica e teologia', in la Teologia rel XII secolo, pp.
1t8-122 Í103-1221.as Summa Qaoniam homixes, ed. P Grorreux, pp. 144-145.ae fuccAao, uConoscenza", p. 15: " coioro i quali af{ermassero che il Creatore
e la cteatuta sono sostanze) di conseguenza salebbeio costretti ad aomettere che i.lCreatore e la creatura siano due realtà. Ad essi si potrebbe chiedere in che senso rn-tendano questo termine 'due'; né facilmente potrebbero fornire una spiegazione, senon nel senso di una certa dualtàL (nii íx significatione biraii).In quesio caso si am_metterebbe che tale duplice reaÌtàr consista dell'unità, che si attribuìsce alla crearura,e dell'unità, che è propria del Creatore, il quaÌe è la divína asia. La consesuenza ne_cessaria satebbe che la divina realtà verrebbe considerata come una parte-di ouestoduplice essere: ciò sembra ad Alano impossibile ".
26 LUIGI CATALANI
stèssa. mafiiefl: non è dunque credibile una reale omogeneità tra unaqualità predicata di Dio e la stessa qualità predicata dell'uomo.
Il rapporto tra Dio e le creatute è perciò allo stesso tempo im-pedito e permesso dai nomi divini: essi, non avendo la capacità di in-dicate in modo tazionale, scientifico, oggettivo Ia rcaltà a cui si rife-riscono, non instauÌano un lapporto dhetto tta gli enti ai quali nor-malmente si riferiscono e la realtà divina; tuttavia è grazie alla lotopresenza che l'uomo, privo di stumenti linguistici' realmente ade-guati a tale realtà, può intuirne l'essenza per analogia, per allusione.
Per spiegare i limiti di questo paragone tra le qualità divine e lequalità umane, Alano si sofferma su un tradizionale attributo divino:la bontà. Dopo avet notàto che la proposizione "Dio è migliore diun'altra cosa" è mal posta, in quanto stabilisce un confronto inade-gtl to tta due realtà assolutamente diverse, il maertro di.Lill4 ripattaquattro modi in cú. i\ bonan può essere predicato: 1) dc Deo esen-tialiter at cum dicitur Deas est-bonus,2) de creattaris non esser\ialìtersed denominatiie,3) ab asa oirtuth attde liomo dicinr b,oxus id' est iu-st*s, 4) id est utile, Neppwe quest'ultimo significato, utilizzato nellaproposizíone ,suddetta, può istitufue una reale somiglianza tta il Crea-tore e le ceature, nonostante Dio possa essete definito, da un puntodi vista creatuale, con nomi come bonus, utilis, rcfugiun, consolttio,
Queste, ultime considerazioni naturalmente non incrinano la tesideif innorninabilità di Dio in senso proprio, ma spingono Alano adassumere e classificare i vari tipi di nomi che, in manigra più omeno adeguata, possono riferirsi a Dio:
:
Ut ex omnibus praedictis pateat quod ullum norhén proprieconveniat Deo, sciendum quod nominum quae Deo-Jiribuunturalia dicuntur de Deo per causam' ut hoc nomen iustus, sanctus,pius, quia talium est causa; alia per similitudinem, ut hoc no-men splendor, ymago. Alia dicuntur per consequentiam ut no-mina antecedentium atlibuantur consequentibus; unde Deus di-citur irasci, id est punire, quia ex ira sequitur punitio; penitere,id est opus mutare. Alia per negationem ut, quamvis sit formaa{fumationis, tamen intellectus sit negationes; ut cum diciturDeus indurare cor Pharaonís, non quia induret sed quia nonemollirso.
5o Summa Quoniam hominu, ed. P. GLoNEux, P 149.
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 21
il primo gruppo di nomi, quelli detti per causam, hanno un va,lore particolare, in quanto indicano la sostanza divina ("divinamusiam"), mentre i nomi per sir,'tilitudinem ed i nomi per consequen-tiam predicano una relazione, ed i nomi per negationem de Deo nihilpraedicant. I nomi per causatzt si dividono anche tra quelli principaliao astratti (misericordia, pietà, giustizia) e quelli surupta o concrerl(pio, giusto, forte), i primi dei quali sono predicati in maniera menoimpropria rispetto ai secondi, fermo restando il valore esclusivamenteanalogico di ogni Lipo di nome.
Alano passa poi risolutamente a definire le possibilità di appli-cazione delle categorie alla natwa divina, vale a dire uno dei temrprincipaii del linguaggio teologicotl. Egli {a innanzitutto notare chele dieci categoríe útiizzate dalle scienze naturali si riducono a duesole in ambito teologico, vale a dire la sostanza (comprendente anchela qualità e la quantità) e la rcIazione (comprendente anche gli altrisei predicamenti) t2. Tra i nomi sostanziali vanno ulteriormente di-stinti i nomi che predicano I'essenza divina in maniera assoluta (Dio,gíusto, buono) e quelli che predicano piuttosto f identica esseÍrza, main base al rapporto partecipativo (collationem\ con le creature (creato-re, principio, autore). I nomi sostanziali inglobano al loro interno an-che i nomi che predicano di Dio una qualità o una quantità; il mo-
tr DE LTBEna, " Logique et théologie", pp. 439,4$, sti.ia brevemente le tappefondamentali dell'uso dei termine translatio: "les termes memes de 'transfert' ou àe''translation', abondamment atrestés chez Alain, ne sont pas, en revanche, boéciens. Onpeut, dans un premier temps, les rapprocher des \otlons de ttunslatio ou de hanssampfioélaborées par les logiciens et ies grammairiens du XIIe siede, ou encore, plus direitement, du thème - proprement théologique - dela transs nptio a naturalibus ad theologim facta cher à Glbert de Poitiers er à Thierry de Chartres. Gilbert n'est le oremierpromoteur de la problématique du transfert des catégories dans la praedicatio diìna. Latransformation de la rzutatía boécienne en tunslatio rcmontq en réalité. à l'un des au,teurs qu'Alain a le plus étroitement fréquentés, Jean Scot Eriugène Lnel Peiphyseox'translative' ha il senso di 'metaphorice'].
Cela étant, meme si le contexte apophatiquedionysiaco-ériugénien est, chez lui, d'une prégnance décisive - ce qui l'amène, contreGilbert, à souiigner Ì'impropriété radicale de tour discours affirmariv, fùt-il relevé par la*afissumpào -, Alain n'en reprend pas moins, comme Jui, les théories boeciennes descarégories et de la prèdìcation onto-theo logique. Alain de Lille reprend l'ensemble de larhéorie de Boèce en I inrégranr à la vision Gilbert ienne de la rranslat io .
t2 Sammna Quoniau bamines, ed. P Gro*rrux, p. 150: 'nominum vero quaede Deo dicuntur, alia dicuntur secundum substantiam, alia secundum relationem.Duo enim tantum praedicamenta in theologicis assignantur; praedicamentum substan-tiae,et ptaedicamentum relationis, sive praedicamentum quid et praedicamentum adqulo
28 LUIGI CATALANI
tivo è chiaro: quali{icare in qualsivoglia maniera Dio non significa al-tro che predicarne l'unica, immutabile, perfettissima essenza, senzaaggiungere altro che già non sia contenuto nella predicazione dellasua sostanza. Le restanti sette categorie vengono ricondotte a quelladella relazione poiché predicano qualcosa di mutabile, di estinseco alsoggetto, il che non si può avere in Dio.
La dichiarata volontà di Alano di regolamentare l'intero campodel linguaggio teologico emerge dal passo seguente, che può essereconsiderato una norma generale del trasferimento teologico:
Haec etgo in theologicis generalis constituatur regula quod om-nia nomina tam mathematica ouam concretiva Dertinentia adpraedicamentum substantiae, qualitatis et quantiiatis ad divrnatfanslata, divinam essentiam praedicant, et omnia in divinisconstituunt praedicamentum in quid. Termini vero aliorumpraedicamentorum ad theologiam translati, quasdam relationessive collationes pràedicant de Deotr.
L'autote condude ia prima parte del libro I analizzando una se-rie di termini che presuppongono una qualche relazione tra Dio e lecteature: viene in pratica messa alla prova l'applicazione delle catego-rie estinseche alla natura divina, con lo scopo di mosúare che nes-suna di esse può riferirsi direttamente a Dio, ma solo al rapporto traesso e il mondo. Alano si sofferma in modo più diffuso sulle catego-rie del luogo e del tempo.
Dio, data la sua immensità, non può essere localizzató: esso èquindi "dovunque', 'in ogni cosa", in quanto è la causa èfficientedi ogni cosa. Come si nota, la categoria dell'ubi, predicata d! Dio, ri-manda esclusivamente alla felazione con le cfeatuîe:
Cum igitur termini pertinentes ad praedicamentum ubi de Deopraedicalt relationem quamdam cfeatolis ad creaturas praedi-cant; itaque pfaedicamentum ubi ad theologica ftanslatum redu-citur ad praedicamentum ad aliquid. Cum ergo dicitur Deus estalicubi, vel Deus est ubique, intelligitur esse in rebus tamquamefficiens causa in suis effectibusta.
L"'essere in un luogo " può essere detto di Dio solo in manieracompletamente differente da come può essere detto di una ueatura,
tt Summa Quoxíam bonixes, ed. P. GLop:Eux, p. 151.5a Srmaa Qaoxìzm bomines, ed. P. Gronrrux, p, 154.
LA SISTEMAZONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 29
vale a dire in modo eccellente ed incommensurabile, degno cioè dellasua natura.
Anche la categoria temporale deve essere traslata, ridursi ad unacategoria di relazione, se vuole essere applicata alla sostanza divina.In linea di massima, il tempo non può essere predicato univocamentedi Dio e degli enti finiti:
Similiter dicendum videtur quod nec tempus quantitas de Deopraedicatur. Tempus enim est mora et motus mutabilium re-rum, Sed ulla mutabilitas, ullus motus est in Deo; nam stabilismanens dat cuncta moveri. Ergo de Deo non praedicatur. Itemtempus cum mundo incepit esse. Sed nihil de Deo praedicatursecundum divinam rraturam quod ab aeterno non praedicateturde Deo. Ergo tempus de Deo non praedicarur, IteÀ tempus estquantitas. Sed de Deo ulla quantitas praedicatur, nam Deus estsinq quantitate quantus, sine qualítate qualis. Ergo tempus deDeé non praedicarur55.
Alano spiega che come il termine ubi, applicato a Dio, ne pre-dica l'immensità, così il termine tenpas îe indica l'eternità. La sressaftase sempet asse ha un valore diverso a seconda che sia applicata aDio o alle creatutet6, e lo stesso vale per l'awerbio nancrl-.'
Qualche rapido cenno alle categorie dell'actio, della passio,dello statas e della positio - tutte da ricondurre al predicamentodella relazione e da trasfomare elevandole alla dignità teologica i-chiude questa sezione dell'opera, la quale prosegue con \a tratia-zione della pluralità delle Persone divine, e quindi dei nomi divinipersonali. l
tt Sumrr2a Qaoniaft homixes, ed. P GLoNE(x, p. 161.
_ t6 VLsou, nla teologia apothetica " p. 187: 'nel secondo caso, infatti, la pre-
dicazione istituisce una rclazione o collatio tra quella realtà e tutte le cose che fu-rono, sono o saîanno, e impone così la totale compiutezza di tutto il tempo. Maquando invece tali parole sono predicate dí Dio, non è piìr la categoria delletxpas-quaxdo che 't:rene ctiamata in causa, ma piuttosto, per così diire, quel)a della etemita*quanìlo, che si definisce nella collatio tta l'etetrutà. ímmutabile dell'essenza divina e rptocessi temporali cui sono soggette tutte le creature. Qnesta collatio è dunque infi-nitamente più ampia di quella che si può compiere secondo Ia categoria deL tempo;poiché, dire cbe Dio è eterno, non signíiica sohaoro affermare che è stato ib tuto ilpassato, è io tutto i.l presente e sarà dopo ogni tempo",
t7 DE hBER.t, " Logique et théologie ", p. 463: "Ie nunc dltin ne dit ni nevéhicule l'unité idéale des différents temDs. Le xanc divin ne dit oue I'absence detemps en Dieu, sa non-sempiternité ".
l 0 LUIGI CATALANI
Aiano af{ronta il tema trinitario iniziando con l'affermare riso-lutamente l'unità essenziale delle tre Persone divine e con il proporreun'analisi razionale del dogma, sulla base di uno sforzo linguistico eterminologico volto a chiarirne il significato in termini logico-filoso-fici. Tale sfovo si concentra principalmente su due nomi fondamen-tali per la comprensione della materia trinitaria: persona e tiùîas.L'autore, preoccupato daila povertà lessicaie della lingua latina, s'im-pegna nella dimostrazione logico-grammaticale della concordanza tra itermini greci usia, usiosis, jpostasis, prosopd ed i corrispettivi latiniessentia, subsìstentia, substantia, persona. Anche per questa serie ditetmini testa pienamente valida la regola della translatio, secondo cuiessi cambiano il loro significato se trasferiti dal piano naturale aquello divinots. L'unica coppia di nomi che non è trasferibile in al-cun modo a Dio è quella usiosis-subsistentia, mentre le altre possonoessere tfaslate, seppure con la dovuta accotlezza, come nel caso deltetmine " sostanza ":
Similiter hoc nomen substaotia, quia sicut in naturalibus nuncsignificat rem discretam nunc genus generalissimum, sic in divin i s nunc q ign i f i ca t pe rsonam. nunc us iam. Unde e t ve rum es tPatrem er Fi l ium et Spir i tum Sanctum esse tres substantias, idest tres ypostases, et efiam unam substantiam, id est unamusiam5e.
Particolarmente articolata è la discussione sul valore teologico
del termine persona, corredata da un buon numero di autórità patri-
stiche, in cima alle quali c'è Agostino. Il risultato di quest'analisi è la
53 SuJla trasposizione in d,ùtìnis di questi stessi termini, Alano si sofferma ab-bondantemente ancbe nel Liber in distinctionibas theologicalium (PL 210, coll. 685'1012), un repertorio alfabetico in cui viene svoka una seffata e dettagliata analisi deivati sensi (letteralí e simbolici) dei vocaboli usati nella Scrittura (" dignum duximustheologicorum verborum significationes distinguere, metaphorarum rationes assignare,occultas troporum posiriones in lucem reducere"). Cfr. i Prclogo aher dell'opeú,687: "quoniam iuxta aristotel icae auctori tat is praeconium, qui vir lute nominum suntignari cito paralogizantur, in sacram paginam periculosum est theologrcorum nominum ignorare virtutes, ubi pericLrlosius aliquid quaerìtur, ubi difficilius invenitur, ubrnon habemus sermones de quibus loquimur, ubi rem ut est s€rmo non loquitur, ubivocabula a propriis signi{icatibus peregrinantur et novos admirari videntur ". Cfr. sultema CHENU, "Il vocabolario teologico", in La Tealogia nel XII secolo, pp. 4II-4)2;C. V^solr, "Dio, uomo e natora in un dizionario teologìco del XII secolo ", Rruùlacitica di Stoia della Filosofia,2) 11968), pp. 311 )9A.
t1 Summa Qroniam honines, ed. P Gr-oRtEUx, p. 172.
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI' 3 1
conferma che la definizione, di matrice boeziana, di persona come er-sentia, ixd,iaidaa può valere anche in ambito teolo;ico, a Darto diescludere dal termine indiuidua il significato dí essàfia. di'l.ggeruiinvece i tre nomi personalie.
Per quanto riguarda il nome Deus, esso, .,quamvis sit appellati.vum ffiurn. personarum, tamen etiam deitatem appellat et ;; fte_quenter supponit"ól. L'analisi del nome trinias è posta in dfuetta re-lazione con quella del termine petsona, in quanto i suo reale significato e va.lore si manifesta proprio in virtu dell,accostam"nto
"oriqo._sto nome:
Sicut autem hoc nomen persona excogitatum est ut.in pluralicontta haereticos faceret" et in singularitatem esseniiae^ et inpluralitatem peisonae, sii hoc nomà trinit". ii""it". .*
".. in singulari faceret et in singularitatèm essentiae et in pluralita-tem pelsonaeó2.
_ _ I1 primo trattato della seconda parte dell.a Samma si chiude conla discussione di un termine di. st!"ita attualità, sul quale Alano giàaveva coflcentrato la sua attenzioie: tl nome deitas. euesto terminenon può.essere _usato per indicare una delle persone Íinitarie, bensìesclusivamente I'essere. comune ad esse. Lo dimostra, ad esempio,l'uso che se ne fa nella proposizione ., deus deitate est Deus,,:
Cum dicitur deus deitate est Deus, hoc ablarivo ,,deitate,, no;tatur quasi formalis causa, non formalis nominative, quasi foflmatum sed non formarum. Et ideo cum vera sit ibi siÀpficitap,non sequitur quod Deus non sit sua essentia6r. ll
A questo punto il maesro di Lilla abbando n lu.t utt*i'in!3i rymi divini legati all.a materia rrinitaria e presenta una classi_[icazione degli altri nomi teologici, ch. vengoio divisi in cinque
_ 60 Summa Quonizm homixes, ed. p. Gr.onreLrx, p. 176: . simliter cum dicitur
Pater est essentia individua, quamvis hoc nomen individua innititur huic nomtnressentia in similitudine accidentium et immediare, rrorì tamen suam iignification msignificationi eius atribuit sed supposìti, ut sit sensus: p"t.,
""t .rr"rría indioidu",
rd est ltarsr essentia quod est individuuJ, id est ab omoi re suo ploprio statuorusus . Lîr. ^NGEI-îú, L ortodostia e 14 grymbr4ticl, pp. l2o-7J6.61 Srmna Qaoniam homixes,.ed- p. Gioneux, p. ùt.
6? Sunma Quoxiam homines, ed,, p, GLor:Eux, ;, 1g4,6t Summa Quoniam homixes, ed. p Glonreu.x, o. tg+.
32 LUIGI CATALANI
specie6a, È I'occasione per approfondire meglio il signi{icato delnome Deus, il quale " dicitur essentiale ratione praedicationis et significationis. Pro qualitate autem significat natulamr Plo substantiavero significat personam; supponit autem pro persona, inproprle au-tem pro essentia " ót.
L'analisi di forme verbali come erl o existit, di aggettivi come sr-mi/is o coetemus viene condotta sempre in chiave ftinitaria ed unbuon numeto di questioni è dedicato ̂ lla ftattazi'one sistematica deinomi personali (distinti tra quelli che si riferiscono alle persone di-vine nomine et significatione e quelÌi che vi si riferiscono nornine tan'tum), sr:Jla base di un raffinato e lucido utilizzo della categoria dellarelatio, considerata nelle sue molteplici forme.
La serie dei nomi personali che si applicano alle Persone nomìneet non re contiene al suo interno attributi fondame ntali quali poten-tia, sapientia, bonitas, r quali, ricorda Alano, si riferiscono ognunoalle rispettive Persone solo norzinalmente e non di fatto (non vì ècioè un'appropriazione personale della res indicata da questi tre ter-mini), visto che esiste un'unica potenza, sapienza e bontà:
Quamvis enim una sit potentia ttium petsonarum, una saplen-
tia, una bonitas, tamen nomen potentiae appropriatur Paffi et
non res nominis; similiter nomen sapientiae Filio, nomen boni
tat is Spir i tui Sancto66.
6a Sttmma Quoniam homines, ed. P. Glonreux, pp. 198-199: " nominum autem theologicorum a/:7 sunt essentialia quae ita essentiam praedicant quod nullamdistinctionem conpredicant, ut hoc nomen Deus, deitas, essentia, natura, usia, sub_stantia, iustus, pius, fortis et similia. Alia cohessentialia, quae significant relationesaddictas divinae usiae, ur haec nomina dominus, principium, origo, causa. Sicutenim naturalibus proprietatibus relationes addictae sunt ut albedini, similitudo, it,rdivinae usiae relationes theologicae addictae sunt secundum quas Deus plincipium,causa, origo, dominus creaturatum dlcitt;. Alia partim personalia, partim essenlia_lia, quae scilicet praedicant principaliter usiam, compredicant autem personarum distinctiones, ut haec nomina persona, rrìnìtas. AIia personalía quae vel personalempropri€tatem praedicant, ut haec nomina: Pater, Filius, Spiritus SanctÙs; vel appel-lant, ut haec nomina paternitas, filiatio, processio. AIia compersonali.a, quae significant relationes addictas personalibus proprietatibus, ut haec nomina: distinctus,differens, alius ".
6t Summa Quoniam homixes, ed. P GLoRrEUx, p. 199.66 Summa Quonian homines, ed. P Gronnux, p. 226 CLî. Vasorr, " La teolo-
gia apothetica", p. Jo2: "'t cauto atteggiamento di Alano riduce così la predicazioneparticolare dei nomi alle persone ad un puro problema di analogia Ìinguistica, al difuori di qualsiasi conseguenza 'attribuzio nistica' ".
1LA SISTEMAZONE DÉLLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 33
Stirnolato da alcuni nomi divini tradizionali, come omnipoters,l'autore approfondisce alcune questioni di capitale importanza-per lascienza teologica, quali la prescienza, l'onnipotenza, la predeitina-zione, l'assoluta volonta divina, dopodiché analizza I'uao teologicodei nomi unitas ed equalitas rn modo da riaffermare il carattere dia-letticamente unitario della relazione tùrutaria. Se la pluralità dellePersone divine è una pluralità di fatto, non bisogna credere però dipoterle numerafe quantitativamente alla stregua di una serie di entifiniti: anche il numero, trasfeÌito in teologia, perde infatti il suo sr-gnificato originario e ne acquista un altro, più rispettoso dell'unitàdell'insieme: "cum nulla sit diversitas in personis, nulla videtur ibiesse differentia'67.
- -_ Con quest'ultimo esempio concreto dell'applicazione delle regoledella translatio al linguaggio teologico, in linea con la dichiarazione me-todologica e programmatica contenuta nel Prologo, si awia alla conclu-sione questa poderosa ed analitica sistemazione dei nomi divini, temache ha in pratica monopolizzato l'intero primo libro delTa Sunma. Inbase agli stessi convincimenti teorici ed alle medesime scelte filosofico-teologiche, Alano ha elaborato, o rielaborato, nelle Regulae caelestis iu-ris quest'identica materia in una veste esteriore completamente di-versa, la quale ha reso celebre l'opera: tuttavia la nostra attenzione nonè tanto dedicata alf innovativo aspetto formale dell e Regulae , quànto alsuo contenuto intorno al tema dei nomi divini, allo scopo di precisareancora meglio la posizione del maesfto di Lilla.
iLe Regulae caelestis iuris: la regolamentazione della ttanslatio norfli-num a naturalibus ad, theologica
'-.
Ciò che Alano ha espresso con abbondanza di parole e úcchezzadi argomentazioni rrclla Sumna Quoniam bomines, egli lo ripete inmaniera essenziale e dgorosamente consequenziale nelle Rega/ae cae-Iestis iuris, La torma concettualmente stfingata dell'opera e la sua ri-gida disciplina regolamentatrice fanno sì che il contenuto di ogni as-sioma appaia nella sua incontestabile verità e s'imponga nella sua lu-cida assolutezza68. Nelle intenzioni dell'autore ogni regola deve es-
6t Sumrna Quoniam homines, ed. P. GLoRrEUx, p. 251.s o'Ouornro, "L'età beoziana", p. ,58: " proprio perché hanno come scopo
comune la manifestazione dell'unità superiore del veto, tiltte le rcgtlae, singolarrúÈnte
34 LUIGI CATALANI
sere i.l naturale sviluppo della precedente e rimandate logicamentealla seguente; proprio come una concatenazione di assíomi matema-tici, con la dlfferenza sostanziale che l'argomento delle norme è DioLa spiegazione di ogni regola è affidata ad un succinto commento, ilquale ha l'obiettivo di giustificare la successione degli assiomi, manmano che l'esposizione si allarga ad abbracciare 1a vastità della mate-ria teologica6e. Quest'originale assiomatizzazione della teologia è ot-tenuta anche gtazie ad una precisa opzione in campo dialettico, piìrattenta all'esplicit azione " dal di dentro " di un enunciato che ad unadistesa argomentazione deduttiva e sillogisticaTo.
L'opera, composta da I34 tegole (tante sono nei manoscritti piùcompleti e nell'edizione critica di Hàring, dieci in più che nell'edi-zione riportata in PL 210), dedica le prime centoquindici esclusiva-mente alla teologia, le successive dieci alla filosofia naturale, ma conregole comuni alla teologia, le ultime nove al puto ambito della filo-sofia naturale. La prima sezione si suddivide a sua volta in tre parti;la prima consactata a Dio ed alla Trinità (I-LXVII), la seconda dedi-cata alle maggiod questioni di teologia morale (LXVIII-XCIX) e larerza alla cristologia ed ai sactamenti (C-CXV).
Come di consueto, il testo è introdotto da un Prologo, che an-che in questo caso ci aiuta a rintracciare le linee-guida seguite dal-I'opera. L'esordio del libro spiega donde è nata I'esigenza di assioma-tizzate \a materia teologicaTl. Stilare una serie di regole e di criteri
.prese, pretendono di avere una valenza assoluta, inattaccabile, in qùahto esprimonoun conoscere di tipo superiore e diretto ".
6e o'Ouornro, " L'età boeziana', p. 3571 " antinomie sapientemente giocate, ipo-tesi introdotte con precisione terminologica per essere subito accolte o eliminate, ridu-zioni all'assurdo, dimostrazioni per via di esdusione, definizioni e divisioni di concetri,e così via, consentono l'amplificarsi del rigoroso iniziale sistema di concatenazioni con-cettuali in un'esplicazione di pih ampio respiro del conteÍùto delle varie formule, sottoil cui ventaglio è però sempre possibile ricostruire il collegamento concettuale che per'mette al discorso enunciativo di procedere, in pratica, senza interruzioni ' .
70 D'ONoFRro, 'L'età boeziata' , p. 358: " Alano non dcotte nel suo argomen-tare a quelle norme con cui Ia dialettica fissa il procedimento del discorso dimostla-tivo-deduttivo, ossia delle concatenazioni di proposizioni e del sillogismo, quanto,piuttosto, degli insegnamenti elementari e formali della dottina relativa alla determr-nazione della ris significatfua dei singoli termini logici, come la composizione del si-gnificato dei nomi, la divisione, la definizione, le forme di predicazione, i predicabili,le categorie, i npoi, Ie con'tetgenze di norme grammarícali e valenze logiche, le va-riazioni sul predicato 'essere'
, la ttaxslatio dei significati ".7t Sull'importanza delle rcgulae ne)7a costruzione di un sempre più preciso e defi-
nito metodo teologico in senso "tazionale " e " scientifico ", cfr. Cxelu, "Un essai
LA SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 35
nomatívi,_ argomenta Alano, è una prassi comune ad ogni scienza: ladialenica ha le sue massime, la retoìica i suoí loci coàmun"_r, l,eti.ale sre senteúiae generalcs,la fisica i suoi aforismi, I'eÀtnetici i pon_srnata, 7a musica gli axiomata, la geomeria i theoremata,l,asffonomiale sue excellentiae. Tutte le scienze, dunque, a parte la grammatlca,che ha regole di origine convenzionale, ,i buruno su un" insieme dinorme che ne determinano funzioni e limiti.
Anche la reologia, secondo il maestro di Lilla, deve averne diproprie:
Supercaelestis vero scientia i.e. theologia suis non ftaudatutmaximis. Habet enim regulas digniores sui obscuritate et subti_litate ceteris ptaeminentes. Et cum ceteralum tegulatum toranecessitas nutet, quia in consuetudine sola est coniistens p.nesconsuetum natutae declusum, necessitas theoloqicatum maxima-rum absoluta est et irrefragabilis quia de his fidem faciunt quaeactu vel natura mutari non possunt?2.
. _Essendo-la teologia una scienza tutta particolare, anche le regoleche la riguardano saranno speciali, vale a dire assolutamente necessa_rie e sottilmente oscureTr; la loro superiore dignità emerge dai nomicon cui_sono state designate, parudoxa ed. aeflignata per il- loro valoretrascendente, ey.blern{a per-la luminosità del vero Àe emanano) en-thymenata, bebdomades per l'inattaccabile ceîtezza che le contaddistingueTa. Ne deriva che la comprensione di queste massime teologi-:
12 Reguhe caelestisiafr, ed. N.M. HÀRrNc, D. 122. ]
7r G.R. Evers, "The Borrowed Meaning: Ciammar, Logic and rhe problem ofAegfo^ei9a]-l1qryac;.in Xllth-_Century Schooti,, Tóe Donxsiie Retlew, iZ.q ttstsl,p, 170 1165-175] "from the first it is made dear that language ur.d óf Cod obeyispecial rules, bur thar tbese rules may be formulated in tf,e ionventional technicalterms ol grammar or rhetoric or dialecic. ln Alan,s view ve can do more than saythat theological language does not obey the ordinary rules of language; *"."orn"k"a usetut atrempt to explain rhe adapted rules of grammar and dialectic which theolo_grcal language obeys '. Etienne GrLsou, La filosofia nel Medioen- p. )76, ricorda cheanche nel De Jiàe catholica I obietúvo di Alano - in questo caso per cónuin..r. ;-refutabilmente gli eretici del loro eúoie - è ,,costiruire
la teologia iome scienzo, o,se si preferisce, di conferirle un rigore eguale a quello delle altri scienze, sottomet_renoola aue esigenze del loro metodo",
?a o'Olosmo, " L erà boeziana', p. 359, osserva che Alano riprende in questopasso la terminologia di Gilberro, anche se il teînine e tbj)rrrenata ,.mbr" .""o.usato ln senso opposto a quanfo aveva affetmato il maestro: ..con questo Lermine,però, ricollegandosi anche in questo alla rradizione altomedievale, egú inrende e"p.r_
36 LUIcI CATALANI
che sarà possibile solo ai sapienti, vale a dire a coloro che hanno unaprofonda esperienza della speculazione teologica e sono in grado dielevarsi ai misteri ineffabili della verità divina.
La sequenza ragionata delle massime inizia con l'assioma piìt uni-versale ed omnicomptensivo, con la 'communis animi conceptio " piìr
immediatamente evidente: " Monas est qua quaelibet res est una". Nelcommento, Alano atribuisce a Dio i predicati dell'unità, della sempli-cità, dell'immutabi.litìr, mentre nega che i concetti ed i nomi di pìura-
litir, numero, diversità possano applicarglisi in maniera essenziale.L'unità della natuta divina, che è l'unica ad essere ed esistere in sensovero e proprio, in quanto persiste eteinamente nello stesso stato, si ca-
talteti;za maggiormente nel confronto con l'alterità del mondo celeste(le nature angeliche) e la pluralità del mondo terreno, la cui fonte, si
legge nella II regola, è la stessa immutabile unità divina.La III regola (" Monas gignit monadem et in se suum reflectlt
ardorem") coincide con la prima regola del Libet XXN pbilosopbo'
rum75 ed af{ronta il tema delle telazibni trinitatie, in particolarel'azione dello Spirito Santo, definito ardor, amor, osculurn, connexiopatris et filiil6. La regola seguente ritorna sull'argomento attribuendol'unità al Padre, l'uguaglianza al Figlio e l'unione fra l'unità e l'ugua-glianza allo Spirito Santo.
La V regola si richiama invece alla prima ed affetma che la mo-nade divina è il principio originario e la meta finale di tutte le cose,pur non essendo essa stessa soggetta ad origine e fine, in guanto nonè in alcun modo composta. La massima successiva sentenaa che ogfl1essere creato è buono in quanto deriva dal principio sommamente
mete non un tipo di argomentazione, Íla una conoscenza enucleativo'concettuale di
tipo immediato; che avv'terre per conùaium (cioè per negazione diîetta del significato
espresso da uo termine-concetto). In esse sono infatti foÍnúlate vedtà che possono
"si.r. .olt. soltanto dalia patte più elevata dell'animo, la stessa che rrdla Sxrxma egli
chiama extasis, i'intelligenza supériore che trasporta I'uomo al di là dei limiti della ra'
zionalità, guidandolo ad intuire I'accecante luce ddl'utità divina, che la ngtone e la
logica norr sono in grado di esprimere se non ricorrendo alla sotuazione di determi'
nazioni signi{icanti che è propria della via teologica negativa ".75 Ed. F. HuDRY, Grénoble 1989 (Collection Krisis). Su quest'anonima esposi-
zione, anch'essa assiomatica, della dottrina cristiana, cfr. o'Olornro, "L'età boezia-
r^" , pp. t53-356.ù Reg*he caelzstis lzru, ed. N.M. HÀNNG, P. 128: "iste ergo ardor ita proce-
dit a monade i.e. a patte quod ipsum non deserit quia eiusdem est essentiae cum iPso
et in se alteNm i.e. filium suum reflectit ardorem i.e spiritum sanctum quia ita pro'
cedit a patre quod eius auctoritate plocedit a filio".
LA SISTEM,TZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 3 7
buono, mentre le creature razionali sono buone anche perché ten-dono coscientemente alla beatitudine. Corollario di queste regole èl'assioma secondo cui Dio può intendersi come una sfàra inteilì-gibileil cui centro è ovunque e ia cui circonferenza non è a nessuna par-teTi: un'immagine molto suggestiva che abbiamo già inconnato a pro-posito del discorso di Alano dedicato proprio alla Sfera intelligibile.
Poiché Dio è ciò da cui ogni essere ricava il suo essere, ne de-riva che ogni attributo che si predica di Dio, in parricolare i predica-menti di sostanza, qualità e quantità, non fa che indicarne l;unica emedesima essenzaT8- Affermare che Dio è forte equivale ouindi adire che Dio è paziente, è misericordioso, è Dio. Questo coÀcetto eespresso dalla formulazione della X regola: " Omnis praedicatio decreatione facta copulata est atque coniuncta": la predicazione pro-cede infatti diuisiae solo in ri{erimento alle creature, alle quali si pos-sono _assegnare molteplici attributi, ognuno dotato di una precisaqualificazione. La potenza divina, conferma la XI regola, non può es-sere considerata distinta dall'essenza dt Dio. I1 carattere delle propo-sizioni teologiche deve dunque tener conto della semplicità divina,dell'impossibilità di rendere soggetto Dio a qualcos'altro:
In propositione enim theologica non osrendiLur quid cui insiLsed quid quid sit. Cum enim dicitur: Deus est bonus, nonostenditur quid deus sit per insisrenriam sed porius quid sir peressentiam. Unde nulla propositio theologica de inesse est vel decontingenti sed de puro esse vel de necessarioTe.
Le cinque regole successive (XII-XVID si soffermano sul-l'aspetto puramente formale dell'essere divino, da cui ogni nome pro-viene ed a cui ogni nome può essere attribuito, a patto che perda lapropria qualificazione estrinseca e. indichi l'unica ed immutabile es-senza.
77 Évr.us, Alar of Lille, p.7l: "in the intelligible sphere the centre is thecteated world, which is 'everywhere' in the sense that all 'places' are themselves crea,ted things. The circumference is the immensity of God himsel{, and because he isnor cicumscribed by place, the circumference is said to be'nowhere,,,.
13 Regahe caelestis ials, ed. N.M. HÀRrNG, p. 1J2: " Deus cui quidlibet quodest est ornne esse quod est i.e. deus esr illud de quo, quocumque termino aliquidpraedicetur, idem omnibus aliis terminis de eo praedicatur"; p. _1jl:
'quicumque te!-mious in naturalibus praedicat inherentiam, de deo dictus praedicat essentiam. Uniuset eiusdem cause effecrus sunr diversi diversis nominibus significati cum dicLtur:Deus est fottis, est pius, prudens ".
le Reguhe caelestis iznr, ed. N.M. HiRrNG, p. 115.
38 ' LUIGI CATALANI
Dalla regola seguente, Alano inizia ad approfondire il modo in
cui il linguaggio può essere adoperato per indicare -Dio; recita in-
fatti la iVIII màssima: " Omnes affirmationes de Deo dictae in'
compactae, negationes verae". Sono parole che abbiamo già,incon-
tratà ne[a Sulnna: medesima è la fonte ispiratdce (lo pseudo-Dio-
nigi) ed identico è l'esempio proposto, quello - dell'attribuzione so-
stiiziale dell'attr ibuto iustus a Dio. Il discorso negativo è
oreferibile a quello positivo, il quale resta comunque legittímo in
t"re "llu
conrid.r"zion. di Dio come causa universale8o La XIX
regola si concentra sulla possibilità di attribuire alla stessa maniera
l'a"ttributo dell'essere al Óre"tore ed alle creatute: "Omne simplex
alio est et alio dicitur esse"sl. Anche l'essete, osserva Alano, è un
nome e come tale non può essere detto di Dio che impropria-
mente. Segue una classiflcazione dei modi atraverso i quali un
nome può -.sser.
rifetito alla natura divina, che ricalca anch'essa un
o"sso à.[a Summa: " Omne nomen Deo. conveniens convenit ei vel
caus"tiv. vel similitudinarie vel adiunctive vel negative-" 82'-'-
i, XXU regola è dedicata esplicitamente alla theologica.p.taedi-
catio ed alla divetsa applicazione delle prime tre categorie e delle re-
stanti setre al discorso teologico:
Omnes enim termini trium naturalium praedicamentorum' sub-,tuntia" ,rid"li..t vel qualitatis vel quantitatis, de Deo dicti de
ipso praedicant divinam substantiam et-€is ostendituf. Deus essequid. Terminis vero cetefolum praedicamentorurniostenditurDeus esse aliquid 8'.
so D'ONoFPro, 'L'età boèziana", p. )60: "in questo modo, in-una nuova com'
plementarità delle due vie teologiche pseudo-diorusiane, negativa e allermatrva' trova
il; d-;;;*ú"e il probl-ema, dpmmaticamente fondamentale per- la-teologia
Ji Gllb*,;, à.11" n...rritfdi introúurre distinzioni nella perfezione ineffabile di ciò
che è pura semp[cità"à'Regoln"
"a"lestís izru, ed. N.M H;iRrNG, p 1J7: " nullum nomen prcplre
convenit Déo et ita oone simplex i.e. tam parer qLlam filius quam spilitus sanctus
alio est ouia sua proprta essentn est et dio àicitur esse quia ab effectu' quem habet
in creatuiis, esse dicitur quìa, quicquid est a Deo tamquam a summo e-sse habet esse
et ita. quia'omnia esse faiit, Dèus esse dicitur, sua tamen essentia est" .--"--'"i l"coto" caelestis iuris, ed. N.M HÀRrllc, P tJS: " cum,enim nullum.nomen
proprie Deo conveniat, oportet nomen, dictum de ipso, hoc vel-dlo moclo drcr qùla
iiir". ìr *utaiuo, o-tè oo."n, quoà transumitur a sua propria significatione' ali-
guo ptedictorum modorum transumitu_ "$ Repulae uelesrts iuis, ed N M HÀnnc' p l)9'
LÀ SISTÈMAZIONE DELLÀ 1'ÉORIA DEI NOMI DIVINI 3 9
Solo due sono quindi le categorie teologiche: il praedìcantentumaui ed iI praedicamentum ad alìquìd, vale a dire la sostanza e la rela,ztone, la substantia e ciò che si rapporta direttamente con essa84.Alano precisa poi che i sostanrivi (deus, ueator, principium), úferitrall'unica essenza delle tre persone divine, sono predicati al singolare,mentre gli aggettivi vanno detti della Trinità al plurale (', Pater et fi-.Lius et spiritus sanctus sunt iusti vel potentes"): ogni termine derivainfatti il suo numero dalla consìgnificatio dell'oggetto al quale si rife-r1sce.
Nel commento alla XXVI regola, l'autore precisa il tipo di trar,shtio che si compie nel trasferimento di termini dal piano naturale aquello teologìco. In naturalibus esistono tre tipi di translatio: nornmuet rei (" Iinea est loxga"), rei et non nominis (" seges est leta"), notniniset non rci (" nonachus est albus"). Questo terzo tipo è quello che sitsa in dìainis:
Cum enim dicitur: Deus est iustus, hoc nomen iustus ttansfer-tur a sua propría significatione ad hoc ut conveniat deo sed resnominis non attribuitur deo sed potius ipsa iustitia divina deoattribuitur, non illa a qua datur[ est hoc nomen iusrus. Aliudenim praedicatur cum dicitur: Deus est iustus. aliud conpraedi,catur. Praedicatut enim divina iust i t ia. Conpraedicurrr. . i f . . .u.iust i t iae in nobis. Ut cum dicirur deus est i ;srus er fort is inter-ligitu idemptitas praedicati sed diversitas conpraedicatist.
3a Regulae caele*is lam, ed. N.M. HÀBrNc, p. 140. ,,quicumque ergo termtnus:igoificans substantiam vel substantiae circumstantiam et hoc subitantivo modo de:ribus personis dicitur singillatim et in singulad numero erc. Verbi gratia hoc norrrenìeus significat substantiam et modo substanrivo. Quare de tribus potest dici singilÌa-:im et in singulari numero ut dicatur: Pater est deus, filius est deus, spiritus sancrus:st deus. Et in summa ef in singulari Dumero ut: Parer er f i l ius.t r i i r i tur rrn.tu,:rnt deus ",
" Regulae caelestis lafs, ed. N.M. HÀRrNc, p. 142. EvANs, .The Borrowedìleaning", p. 171: "to say'God is 1ust ' is nor ro imply rhct he is just onJy as a man::ay be just; the ordinary reference of rhe rerm, rhe ordinary 'thing, to which it re-:ers, is not attributed to God wìth the borrowed term. God'sjustice-is understood to:e something quite independenr of the human notion of justice. This is the crux of:he problem of theological language. If we cannot know what it is that we are Lryng:he borrowed language to refer to, we cannor know what we mean. Alan sives na:rominence to the point. He is satisfied rhat rhe limitarion should be recosnLed and:iat it should be clearly understood that what he has to say about the usàÉulness of:ie rules of grammar and dialectic applies only to the namina themselves and not ra::re aouality or res which is God ".
40 LUIGI CATALANI
l l XXVIT assioma sentenzia che ogni nome o pronome determi-
nativo aoDlicato alla natura divina, si riferisce ad una delle Persone
se è al maschile oppure al femminile, mente indica l'essenza comune
se è al neutro, aorn. .aarg. dai seguenti esempi: "ut pater est alius a
filio, persona patris est alia a persona filii sed non aliud' Pater non
.tt inà qui .si filius s.d est illud quod filius". Sulla stessa linea, la
massima successiva alÍetma che nessun nome o pronome Partrtlvo sl
accompagn in modo adeguato ad un nome essenziale: flon sono
perciò' àrrette proposizioni del tipo " aliquis deus " o " quidam
deus". " solus deus', " iste deus"86.Alano sottolinea poi che i termini astratti (deitas, d'ioinias, na-
hlra, usia, substaxti:a) si applicano in maniera meno impropria all'es-
senza divina rispetto ai nomi concreti (dcus, iustus, misericors), tn
quanto ne indicano meglio la semplicità.Una nuova classificazione dei nomi divini si plesenta nel testo
della XXXII regola, che recita così: " Qmne nomen quod de Deo di
citul aut est essentiale aut coessentiale aut personale aut conpefso-
nale aut pattim personale aut partim essentiale " ' Ai nomi essenziali,
che corriipondono ai nomi astratti (nomina nathematica), si aggiun-
gono drlnqu. i nomi coessenziali, i quali indicano una certa relazione
éterna (principium, dominus) oppue e,ú tenzpore (crcatol, 4 ctor'
facto), i nomi peisonali, che si iif.riscono alle proprietà personali'(patemitas,
filiatio, processio) magari indicando una determinata Pet-
ion^ 1poi"i, fitius, 'spiritus
sanctus, gignens, genitus, ptocedens),.ed' i
nomi in parte p.tronuli, in parte essenziali, corne percona o -Trinitas'Alano oràcisa pi.o oltr" che nessun nome indicante in qrtalche modoprivazione, soÀg.rion. o violenza può essere applicato a Dio''
u xÎxii massima ha il compito di definire sinteticamente le
caratteristiche che dovrebbeto esseri proprie di ogni discorso teolo-
gico: "Omnis sermo theologicus debeL esse katholicus, generalis' usi-
i"tor, ub intellectu non dissonus, rei de qua loquimur consonus"'
Esso deve dunque essere rispettoso dell'ortodossia cristiana, com-
prensibile da un intelletto che sappia stare in guardia dal mero
só ClrsNu, " Orientale lumen', in La Teologia nel XII secolo,.p' 339.L125'3471
commentar " di;pute sottili, pe! noi sconceltanti, che rivelano la formazione molto
,oot.i.iài "
a"it""ri t"oÍoii n.lt" grammatica speculativa, [ondati come sono sulla
cònvinzione del parallelismo tra la costituzione delÌe parole e ù signdlc?to der con'
..iii' . ail"a fà g*mmatica svoige uo grande ruolo nella scienza teologica, a comin-
ciare dall'alta teologia dei 'nomi dívini"'.
LA SISTEMAZIONÉ DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 4 I
aspetto esteriore di un termine e costituito da vocaboli tadizionalied adeguati all'oggetto in questionesT.
Fatta questa doverosa ed importante precisazione, il maestro diLilla ritorna ad affrontare temi piìr specifici: gli assiomi successivi sen-tenziano infatti che i nomi sostantivi sono piìr adeguati degli aggettiviad indicare la natura divina, che i nomi positivi sono piìr appropriatidei nomi comparativi o superlativi (quìa substantia dei non suscipit na-gis rcl mirus), che i pronomi dimostrativi riferiti a Dio perdono il lorosignificato di dimostazione e si rivelano meno efficaci dei pronomi re-lativi (ma meno inadeguati di quelli possessivi), che i verbi sono piir im-propri dspetto ai nomi ed ai pronomi in quanto indicano più chrara-mente una composizione. La forma verbale "est" resta l'espressionepiù adatta ad indicare l'essenza divina88. È inoltre preferibile usare iverbi al tempo presente e non al tempo passato o futuro, in quanto me-glio esprimono l'assenza di tempo in Dio: per lo stesso motivo alcuniawerbi sono più degni di alti nomise.
37 Cuetu, " Il vocabolario teologico ", pp. 425-426: " nella sua definizione delleleggi del línguaggio teoiogico, Alano osserva, olrre la 'consonanza'
delle parole allecose, una duplice legge dell'uso come regola deJ ben parlare: I'uso cristiano, contro lenovitàr profane, I'uso umano, grazie al quale la teologia è inrelligibile, aperta, agliumani". Ev,rNs, "The Borol'ed Meaning", p. 172: " perhaps the most philosophi,cally importaot point he makes is to emphasize the universality of theoLgical lan-guage. The intention is that the theologian should have a stock of ordinary woros rnwhich he may, with care and with an eye to their appropriateness in context, spèakabout God as best he can. But it is clear that the special problem of talking aÈòutGod in human language could not be expected to yield to these relatively simÀle ion-trivances of the grammarians and logicians. Alan himself acknowledges ihe d;fficultyof determining what reference t}re nomina or names of God have to the /er, the rea-lity of God, or what they may contribute to ,ur understanding. rff/ords used of Godhave onìy a borrowed meaning'.
33 Reguhe caelestis izas, ed. N.M. HÀnrlc, p. 151: "hoc ebirn verbum norarsubstanLiam eL apud philosophos verbum temporali moru carens dicitur. Non enim sr-cut alia verba, quae actiones successivas significant in motu, habet significationemsed potius significat essentiam". Cfr. Vesou, "La teologia apothetica ", p. 183: ,,de-
v'essere ben chiaro che il verbo esl conviene, s), eqaiuoce alle creatture e al crearore,ma in sensi divetsi e distinti. Non v'è dubbio che quando diciamo che Dio e le crea-iure sono due 'sostanze', le parole 'sono' . 'rortrnr"
hanno un valore assolutoquando sono riferite a Dio che è'hoc ipsum quod est', e un valore assolutamente te-larivo quando sono invece riferite alle creature, il cui essere e la cui unità sostanzialeJipendono esclusivamente dall'essere e dall'unità divina>.
3" Evei.rs, 'The Borrowed Meaning , p. 172: " whenever Alan f inds a principle of discrimination rvithin the ruÌes of grammar whjch allows him to see a ieason:'hy one usage may be more suitable than another, he Doints it our ".
42 LÙIGI CATAI,ANI
Il discorso sull'uso degli awerbi si sviluppa meglio negli as-
siomi successivi, in cui Alano spiega, conformemente a quanto si
legge nella Summa, il senso teologico -degli awerbi di. luogo, di
t#po e di similitudine. Dettagliata è l'analisi dell'applicazione lz
dioliis sia della preposizione "in", che, a seconda dei casi,- può in-
dicare l'identità d.il'.rr.nru e la pluralità delle persone, la quasi-
diversità (per esempio ta Pater e deitas), la preordinazione, fiden-
tità, la causa efficiìnte o la causa {ormale; sia della proposizione
"secundum", che in teologia " aliquando notat ordinem causae, ali-
qo"ndo notut ordinem inielligentiae .. aliquando notat quasi e{{i-
cientem causam, aliquando quasi formalem causam, aliquando natu-
rae conditionem " eo'
In riferimento ai nomi divini tinitari, l'autote ricorda che ve ne
sono alcuni che si riferiscono solo a Dio, alti alle tre Persone, altri a
nessuna di esse, alÚi ancota sia all'intera Trinità che alle singole Per-
."*, AU infine ad una sola Petsona e non alle alre Il significato di
oueste distinzioni è approfondito nelle regole XLIX-LIII, la pnma
dele quali s.par" i nomì che si riferiscono ad una singola Petsona no-
nine it r" (Pat"r\ dal nomi che la indicano nomine et non re Qtoten'tia). fJn'analisi particolarmente attenta è riseffata' a titolo esemplifi
."iiuo, "l
no i Pot"r, di cui vengono enumerati diversi- modi.di rrti-
lizzo ín rn discorso teologico; esso può infatti riferirsi l) alla Per-
iona,2) alla proprietà p.rional.,3) alla relazione tra il Padre ed iì
Figli;, 4) "ll"
reLzion.-ta il Padre e le meature dal.punto di vista
d.lllu .t"uriotr., 5) alla relazione tra il Padrc e l'uomo dal punto di vi-
sta del)a reueatio.Ad uno dei nomi coessenziali, "principium", è riservato il me-
desimo trattamento analitico: si deve infatti distinguere, sentenzia
Alano nella LI regola, il caso in cui tale termine predica la paternità
(" Pater est princéium filii') dal caso in cui indica l'amore dello Spi-
.ito Sunto i'Put"i .tt plincipium spilitus sancti') o ancora il rap-
Dorto tra il Creatore e le sue creatufe ("Deus est pfincipium creatu-
iarum"). Tm i nomi poi che si riferiscono alle Persone óivine notnine
)lt ,i, u, n, sono alc;ni che sono dettlL per positionen (Pate/) ed akri
'0 " Magister Alani Regulae ", pp. 154-155 EvANs, " The Borrowed Meaning "'
o. tlZ, " ii ;s?ifflcr-'lt to s""-*huL h. -hop..
ro achieve bv this, except to give his rea
5.;' ; .";i;t;;;È .;nse ol usine Lheir Lechnical knowledge preciselv' and in such a
;;; ; i; ;;;; ,h;; th.v will b"" able to speak abo't God as little hampered bv the
[Àitations of human language as possible'
:.1 SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 43
)er abnegationen (innascibilis, ingenitus); questi nomi inducono l'au-rore a puntualizzare il discorso sulle affermazioni e le neg,azioni in di-t'ìnis:
Non enim parer dicirur innascibilis per positionem proprietatissed per abnegationem originis, ut sit sensus: Pater est innascr-bilis i.e. non est ab aliquo. Similiter hoc nomen ingenitus. Haecnomina speciaÌiter coÀveniunt patri ut non removeatur nativrtassed origo. Negationes enim plurium sunt negative quam posirio-nes positive. Unde spiritus sanctus non dicitur innascibilis necingenitus quia habet esse per originem. Potest tamen dici nongenitus vel non esse genitusel.
Anche la circonlocuzione Spiritus Saxctus è analizzata dal puntodi vista dei suoi diversi valori predicarivi: essa può infatti intendereia Persona (Deitas est spiùtat sanctus), oppure la proprietà personale,o ancora Ia relazione, (Spiritus Sanctus est spiritus sanctus patris\.
La trattazione assiomatica dei nomi divini volee al termine: ildiscorso si sposta sull'onnipotenza divina, occasion; per precisare,nelia LVI massima, che l'attributo " omnipotens " si può predicare diDio e solo di Dio, in quanto Egh potest non solurn quae sunt uel fieipossuxt sed. etiarrz ea quae fieri non possunt.
L'attenzione di Alano si sposta quindi su temi di teologia morale(quali l'insegnamento sulle virtù, la consistenza del peccato, Ia determi-nazione dei concetti di bene e2 e di merito, la libertà e la grazia, i prin-cipi etíci), a cui fanno seguito, come detto, i temi dell'incarnazione edei sacramenti. Tra le regole CXVI-CXXV, il cui valore si riflette siain campo naturale che in campo teologicoel, ve ne sono alcune interes-santi che si soffermano, pw senza aggiungere nulla di nuovo, sul lin-guaggio teologico, in particolare sui nomi divini assegnati a Dio inquanto causa e fonte di ogni cosa e, quindi, di ogni attributo.
Si conclude qui l'esposizione delle regulae theologicae concet-nenti il tema dei nomi divini, il cui commento è stato piir stringarorispetto all'analisi della Summa per almeno due ordini di motivi: in-nanzitutto perché le tesi di Alano si ripetono in maniera sostanzial-
e1 Regalae caelestis lzls, ed. N.M. HÀRING, p. 161.e2 Particoiarmente significativa è la LXVlli regola, in cui Alano si richiama
aila teoria sulla bontà degli enti presente nel De hebdomadibus boeziano: cfr.-{r:orr,r, l.a teologia, pp. 73-16.
'r A parte il CXVII assioma, valido solo íz xaaralibrs.
14 LUIGI CATAI-ANI
mente identica da un'opera all'altta, e poi in quanto è la stessa veste
forÀ"i. d.ll'op.tu, così incisivamente stllizzata' a suggerire annota-
,ì."i.t*"ii"ii, ,idott" ul minimo, destinate a concludere un pet-
;; ;;;;;il;itJo --
di per sé su{ficientemente autonomo - che
h;il;il;;;; di pr.naàr. confidenza con il nucleo teorico del
maeStro.---" - t'lon sarà stato tuttavia inutile ripetere qualche concetto in cam-
bio di una testimonianza sicuramente decisiva e' a suo modo' oerlnr-
;;ìil;;llil".tiion. d'i nomi di Dio: l'assiomatizzazlone' vale
u dir. lu ,irt.-urione piìr convincente ed inattaccabile.'- dei risultati
.^J*-i"*i aìU" *A.gi"'ai Alano, eteditaria. di secoli d'intensi sforzi
?tfi:"ft.t .J'Àù^*iii.ti intuizioni metafisiche' rappresenta in effetti
ii;;;;i;;ft;;? una meta, Io sbocco di un profondo lavoro spe-
culatívo in una rigorosa to'^uhi"uzion..- mateiiale' la risp'osta ad
unÉn.nru chiarifiiatrice e regolamentatÎice' I'ottenimento di un ri-
sultato, meglio: di una conquistaea'"*'-i;"-.:;óttra, tale decisivo passo in avanti della ri{lessione c-ri
tica sui norni di Dio, può essere apprezzata sotto quatffo Punú o1 vr-
sta princiPali:- la rinnovata e î\ntorzata dignità teologica della questione dei
nomi divini emerge innanzitutto da un punto di vista squisltamente
il;;l. ;-*É infani, tale u'go-t'ito occupa " materialmente "
""" t"tr.'*"fi" ampia nelle trafi;zioîi di Alano (la maggior parte
a.ff"Trit"-t.li"" e 'ó.ella
Summa, un buon numeto di tegulae tbeoh-
ìi*al ^ esso viene anche esaminato attraverso diversi proc-edtmentr
: .;íi i;.trtt ' ìi l.tt" a.i nomi di Dio è ormai a tutri gli effetti una
qilit ii' -tl-
r"l dirp,r,ur. ed arsomentate dialetticamente' un'occa-
sione per assiomatizzate. rtgol"i"nt"" le modalità dell'applicazione
;:;#;ii;;;;.uii in t.otJgiu, una materia da tratrarc alla stresua
dei dogmi {ondamentali della fede;
ea A. DE LIDERA, Stotìa delk fihsofia medieaab' ttad' it''.Jaca Book', Mìlano
tgg>. ,'jjll "l, ^,ti-t ai ar"no-iunío fotnito un arsenale di assiomi aí teologi
à"íî"ii" raìar*. ed hanno contribuito plù 9j:ill *,:-::'i::''^1,:Î"":Tffi"ffdell'antica scienza s'.ct^ \tacra pagi'al in un autenlica sclenza teologlca UPE
l'inizio del XII secolo. Attraverso "i'la'ì)iiit
massiccia dell'ontologia aristotelico-
i l ; ; i ; . ; , ; , , ; ; ì ; ' ." la general izzazione del l impiego del la, logica e delJa gramrnarica in
i..r."i"l'^ìit"ìàtr" rap"proronait"nto all" liiioione sullaitraduzione' \.rrashtio) del
;;il;;;;;;^i" 'ií'
ai"lni' in-iui l^ Giovanni Scoto Eriueena' Alano di Lilla
ha affermato la speciticrtà aa ptnt"'o medievale di )ingua hl1":--!i:1,i:U'*tt'
delle fonti arabe (Avicenna, Averroè) La sua opeta è la suprema testimoniaoza deila
;'"d#;; ;;;;i;; ;.11" fio'ori" greca, l'ultimà ptodotto dell'aetas boetiaxa
LTl SISTEMAZIONE DELLA TEORIA DEI NOMI DIVINI 45
- la preoccupazione terminologica è per Alano assolutamentepreponderante: accanto al desiderio di evitare quanto più possibileerrori ed improprietà che possono allontanare dall,oriodossia cristiana, giunge a piena maturazione una tendenza alla precisione logi_co-grammaticale che ha fatto tesoro delle indicazioni di Gilberto neisuoi commenti a Boezio; il risultato è una dottina che non può piùiare a meno di tenere strettamente legate la materia teologica e le re_gole delle arti del tril)iuru, in quanto un vizio di forma siammaticale:uò trasformarsi in una proposizione eretica ed ogni
-aflermazione
che attenta alla cristianità si basa in fondo sulla .i*ru .o.ror..rrr"ielfe arte s s erm o ci na les ;
- con ciò si spiega l'esplicita volontà di fissare una volta per:ttte Ie regulae che devono presiedere al trasferimento dei terminiial piano naturale alla teologia - tema in cui si riversa in pratica Ia:eologia dei nomi divini -: ecco dunque I'esigenza di sistematizzare,jj formalizzarc, di espore in una serie di norme-base i modi in curJeve compiersi tale tlanslatiot e tuttavia non solo i principiguida;engono canonizzati ed assiomatizzati, ma anche i casi meno ,,ordi:ati", gli usi più particolari, a dimostrazione di un,attenzione dav_;ero rigorosa per ogni espressione del sertno theologicus;
- a pafte ogni considerazione sui progressi in fatto di metodo eJ affinamento in fatto di tecniche formali, va messa in luce infinel'appartenenza di Alano ad una ricchissim a tradizione teolosico-filo--:fica, che la capo da un Jato agli Opascuk dì Boezio, coÀmenraticon una nuova mentalità scolastica da Gilberto, e dall,altro a quella.s:ecu.lazione dionisiano-eriugeniana che ha indubbiament. uulor.icndante nella storia della teologia dei nomi divini: il maesto dil:ila, dimostrando di aver accolto pienamente la lezione dello pseu_:o-Dionigi e del suo interprete-traduttore Giovanni Eriugena, riieste. mistero, di trascendenza, se non di misticismo, una discussione:i:e pue non è mai stata una mera pratica linguistico-grammaticale, e-z nnforza, la legittima dall'interno, l'introduce nella stetta cerchiajelle que.stioni fondamentali per il sapere teologico; la garunzia mi-lore della giustezza di questa linea di ricerca crediamo di poterla:ovare in questi versi trattí dal V lìbro dell'Articlaudianus, una dellej:e grandi opere dí teologia poetica di Alano"i, i quali ci riporrano=ciietro di qualche secolo e ci richiamano alla memoria le mirabili
" Cfr. G. Rcr.lauo DE L^cF, Ahih dc Litte poète àu XIIe siècle, Monffeal_pa_= 19 t1 .
46 LUIGI CATAI-ANI
suggestioni apofatiche pseudo-dionisiane da cui, per molti versi' que-
stit"inerario storico e teoretico ptende le mosse:
Qualiter ipse Deus in se caplt omrtla rerum
Nomina, quae non ipsa Dei natura lecusat;Cuncta tamen medi;nte tropo, dietante figura
Sustinet, et voces puras sioe rebus adoptat'
Ens iustum sine iusLitia, vivens sine vrLa;
Priniipium sine principio, .finis sine fine
Immeisus sine Àensura, sine robore fortis;
Absoue vigore potens, sine motu cuncta gubernans;
Absoue lolo loia cuncta replens, sine tempore durans;
Absoue situ residens, habitus ignarus habendo
Cuncta simul, sine voce loque$, sine pace quietus;
Absque novo splendore nitens, sine luce cotuscans'
rsrir"ll Pf;0YilictatI
7239A7
POTENZA