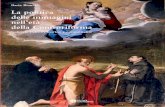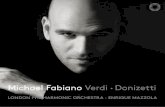Gabriele Moroni, La censura sulle opere di Verdi, CreateSpace, 2015
-
Upload
conservatoriorossini -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Gabriele Moroni, La censura sulle opere di Verdi, CreateSpace, 2015
SOMMARIO
Prefazione 5 1.
CENSURA TEATRALE E POTERE NELL’ITALIA DELLA RESTAURAZIONE
7
2. NORME E LEGISLAZIONE 17 2.1Regno Lombardo Veneto 2.2 Roma e lo Stato pontificio 2.3 Regno delle due Sicilie 2.4 Dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia 3. VERDI E LA CENSURA 55 3.1 Milano: Nabucco, I lombardi alla prima crociata, Giovanna
d’Arco
3.2 Venezia: Ernani, Rigoletto 3.3 Roma: La battaglia di Legnano, Il trovatore 3.4 Napoli/Roma: Un ballo in maschera 3.5 Londra: I masnadieri 3.6 San Pietroburgo: La forza del destino 4.
CENSURA AL QUADRATO (E AL CUBO): LA DIFFUSIONE DELLE OPERE DI VERDI
105
4.1 Rigoletto 4.2 Ernani 4.3 I masnadieri 4.4 Un ballo in maschera 4.5 Don Carlos e l’Inquisizione 5. APPENDICE 151 5.1. TITOLI ORIGINALI E ALTERNATIVI DELLE OPERE VERDIANE 151 5.2. DOCUMENTI 153 Piano generale di censura per le Province Lombarde: Titolo VI
(Teatri); Costituzione Post diuturnas: De iis qui praesunt publicis spectaculis; Regolamento da osservarsi nella Città di Roma (1851): Della censura e revisione; Progetto di Regolamento per la censura teatrale, Napoli 1849; Regno di Sardegna, Circolare 1.1.1852, n. 21: Istruzioni per la revisione dei Teatri; Regno d’Italia, Circolare 14.2.1864, n. 15: Riordino della censura teatrale
6.
ABBREVIAZIONI E SIGLE 165
PREFAZIONE
«Due cose e tosto … tua sorella e del vino!» Rigoletto, versione primitiva
Questo libro ha preso avvio come saggio sulla censura in Verdi, all’interno di un progetto collettivo dedicato al compositore. L’impostazione del lavoro, e la ricerca dei materiali consultabili, molto più numerosi di quanto si potesse sperare, hanno portato ad una fagocitazione del testo e alla decisione di creare un volume a sé. Al giorno d’oggi gli studiosi si sono concentrati soprattutto sul rapporto tra Verdi e la censura: di conseguenza ancora non possediamo un quadro sistematico delle leggi che la organizzavano nei diversi Stati e nemmeno un elenco completo delle persone che effettuarono il lavoro di revisione, elementi questi che meglio avrebbero aiutato a chiarire tale rapporto. Quanto alla censura sulle opere nel loro cammino di penetrazione nella penisola, molto dobbiamo agli studiosi d’oltreoceano, ma numerose domande restano senza risposta: sapere in maniera esaustiva quali opere furono semplicemente vietate, o quali versioni della stessa ebbero diffusione in quali aree geografiche è ancora impossibile, per la limitata disponibilità di fonti librettistiche e di cronologie teatrali, nonché di indagini sistematiche sulle fonti d’archivio che consentano di verificare l’effetto della censura sulla programmazione delle stagioni teatrali. Per far capire la difficoltà a comporre un puzzle i cui elementi non sono tutti presenti, basterà ricordare che da una parte aumentano in maniera vertiginosa i documenti disponibili online (testi ottocenteschi, leggi, ricerche ecc.), dall’altra i cataloghi di libretti a stampa e sul web normalmente omettono i nomi dei revisori teatrali, rendendo più ardua la definizione dei procedimenti di censura. Primo obiettivo è stato dunque collocare l’operato della censura su Verdi nel sistema di leggi che la regolavano, attraverso una ricerca che potesse essere rappresentativa, e si è pertanto concentrato lo sguardo sui tre Stati dove, almeno in Italia, hanno conosciuto la prima la quasi totalità delle opere
6
verdiane: il Regno Lombardo Veneto, lo Stato pontificio, il Regno delle due Sicilie. L’illustrazione delle leggi, la storia di alcuni casi di censura, la descrizione di quell’incredibile fenomeno che è la diffusione delle opere verdiane, considerato sempre in relazione alla censura, sono state sviluppate avendo questi tre Stati come riferimento. Brevi sezioni sono state dedicate alle norme in vigore tra Regno di Sardegna e Regno d’Italia, a Londra e in Russia, non tanto per allargare il quadro quanto per meglio illuminare, indirettamente, la censura italiana negli ultimi venti anni dell’Età della Restaurazione. Se questo lavoro tenta una visione a tutto tondo del fenomeno censura e Verdi, ha i pregi e i difetti di una trattazione di carattere generale: dipende in buona parte dalle ricerche settoriali ed ha perciò inevitabili lacune; al tempo stesso evidenzia aspetti e problemi che da quel tipo di ricerche non potevano emergere. Esso si appoggia su alcune linee guida che si spera acquistino forza durante la lettura: è fortemente limitativo se non fuorviante considerare la censura a prescindere dal potere di cui era espressione; l’analisi di questo fenomeno nell’Ottocento è fondamentale per capire il teatro musicale allora e non solo. Lo studio degli interventi della censura e del loro esito in effetti ci conduce dentro “l’officina” di Verdi, nei suoi procedimenti compositivi, e ci permette di capire opere che furono spesso il risultato dell’incontro/scontro tra quegli interventi e Verdi; la conoscenza degli aspetti, delle idee drammaturgiche cui Verdi non intendeva rinunciare di fronte alle richieste della censura contiene indicazioni per la regia attuale; lo studio delle numerosissime varianti testuali (e non solo) dei drammi che circolarono in Italia prima dell’Unità (considerato che furono ben pochi i libretti riproposti senza revisioni), si interseca con la storia del diritto d’autore ed è uno strumento utilissimo per conoscere il fenomeno della ricezione dell’opera.
7
1. CENSURA TEATRALE E POTERE NELL’ITALIA DELLA RESTAURAZIONE
Un giorno accadde che, invece di cassarmi solo alcune frasi, tirarono l’orribile riga su tutta quanta la lettera, eccettuate le parole: «Carissimo Silvio» che stavano a principio, e il saluto ch’era in fine: «T’abbracciamo tutti di cuore». Silvio Pellico, Le mie prigioni, Torino, 1832
Gli scritti dedicati alla censura sul teatro nel periodo della Restaurazione, in particolare quelli di carattere divulgativo e non specialistico, hanno spesso evidenziato le correzioni assurde, esilaranti e talora incomprensibili attuate dai censori. Come non sorridere di fronte alla sistematica sostituzione della parola «Dio» con «cielo», nel leggere che «angelo» diventa «genio» e la chiesa si trasforma in un parco, o nell’apprendere che Gilda a Venezia muore ma a Ferrara si salva? Quale necessità vi era di modificare l’espressione «quarant’ore» in «due giorni», e possibile che il censore, sostituendo «patria» con «sposa» nei versi «Amo la patria e intrepido il mio dovere adempio!» non immaginasse i possibili, esilaranti commenti del pubblico?1 È indubbio che il lettore che per la prima volta venga a conoscere gli effetti della censura nel periodo preunitario, e in particolare sui libretti musicati da Verdi rimanga sconcertato, colpito da scelte che appaiono spesso incomprensibili. Ciò è di fatto inevitabile quando si abbia un approccio al fenomeno che isoli per così dire gli effetti dalle cause, decontestualizzi le scelte dei revisori dai meccanismi che le determinavano e dalle leggi che ne erano alla base. Collocandolo però nel contesto storico, nell’evoluzione spesso tumultuosa delle vicende politiche, nei rapporti tra potere e gli strati sociali di cui cercava l’appoggio, nella particolarità del sistema produttivo teatrale italiano, si potranno capire molti dei meccanismi che hanno guidato i procedimenti di
1 Gli ultimi due esempi riportati sono tratti rispettivamente dalla voce (non firmata) Censura in Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, Unione editoriale, 1975, vol. 3, 406; e da Emilio del Cerro, Roma che ride. Settant’anni di satira (1801-1870), Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1904, p. 49, che collega il passo ad un non precisato melodramma e indica come artefice della correzione il revisore teatrale abate [Pietro] Somai. Questi fu oggetto di un sonetto satirico di Giuseppe Gioachino Belli, All’Abate Pietro Somai revisore teatrale, in Duecento sonetti in dialetto romanesco, a cura di Luigi Morandi, Firenze, Barbera, 1870. Gli altri esempi si riferiscono a Verdi, e saranno discussi successivamente.
8
censura, sebbene ancora oggi, spesso per la carenza di documenti, rimangano numerosi punti oscuri. La censura non era altro che una delle tante forme di controllo praticate, seppure in maniera diversa, in tutti gli Stati preunitari, e condizionava l’opera potremmo dire dal momento che addirittura precedeva la sua concezione fino a ben oltre la prima rappresentazione. Se un tale controllo era così severo e pervasivo, dovremmo aspettarci forme di avversione delle autorità di governo nei confronti della vita teatrale, per esempio nella definizione delle stagioni teatrali o addirittura nella costruzione di nuovi teatri. La realtà dei fatti è però totalmente diversa e ci costringe a vedere il fenomeno “censura” in una diversa prospettiva: l'opera nel primo Ottocento conosce infatti una diffusione senza precedenti, che non avrebbe potuto realizzarsi essendo ostili i governanti. Se diamo uno sguardo ai dati pubblicati nel 1868 per un censimento voluto da una circolare ministeriale, risulta che esistevano in quella data 942 sale teatrali, almeno 613 delle quali edificate tra il 1815 e il 1868 (in particolare nel nord e centro Italia); negli anni '90 dell'Ottocento sarebbero stati individuati, secondo un elenco pubblicato da Enrico Rosmini, 1055 fra teatri di prosa e lirica.2 Questa sorta di gara per l’edificazione di nuovi edifici teatrali riguarda tutta l'Italia; si manifesterà con proporzioni minori nel Regno delle due Sicilie, ma anche in quest’area l'autorità centrale, almeno fino alla soglia degli anni Quaranta, sostenne esplicitamente la costruzione di nuove sale teatrali. La realtà dei fatti è apparentemente sorprendente: in molti casi i governi non solo non ostacolarono, ma addirittura assecondarono o apertamente favorirono la costruzione di nuovi teatri, come nel caso della Toscana e ancor più del Lombardo Veneto. Se questi edifici fossero stati solo luoghi a rischio di tumulti e sobillazioni, perché i vari governi ne avrebbero accettato e anzi favorito la moltiplicazione? Il fatto è che il teatro nell’Ottocento veniva ad assolvere nuove funzioni: spesso concepito come un monumento ben visibile all'interno della città, diventava uno spazio, una struttura in cui si riconosceva la collettività; era un luogo di pubblico intrattenimento e di ritrovo che le autorità mettevano a disposizione dei cittadini, ora giudicato d’importanza primaria per la vita sociale. Quanto scriveva nel 1849 il Duca di Terranova soprintendente ai teatri di Palermo in fondo rappresentava un’opinione diffusa
2 La circolare ministeriale del 31 marzo 1866 aveva promosso una raccolta di notizie sulle sale teatrali esistenti, in relazione alla neonata legge sul diritto d’autore (25 giugno 1865). I dati furono poi comunicati dai prefetti al Ministero dell’Agricoltura, industria e commercio tra 1868 e 1869. SORBA, pp. 22-33, con elenco dei teatri alle pp. 267-296. A questo volume si rimanda per uno studio complessivo sul fenomeno della proliferazione dei teatri e sul nuovo ruolo che a questi veniva assegnato nell’Ottocento. Per i dati relativi agli anni ’90, cfr. Elenco dei teatri d’Italia, in ROSMINI 1893, pp. 843-865. Lo stesso nel 1872 aveva segnalato 944 edifici teatrali, cfr. ROSMINI 1872, II, pp. 579-597.
9
I teatri nelle città civilizzate si aprono e si conservano nell'interesse del Governo e per la morale del popolo, ossia del pubblico. Coi teatri poi si dà mezzo di sussistenza agli artisti, ai figuranti, ai coristi ed allo stuolo numeroso degli altri impiegati ed oltre all'educazione pubblica. I teatri dunque per tutte le circostanze politiche, morali ed economiche in tutto il mondo civilizzato nascono e si conservano sotto gli auspici del rispettivo Governo, da cui è sempre diretto l'andamento di tutte le operazioni teatrali.3 La sua struttura architettonica, nella stragrande parte dei casi concepita in maniera simile, con la platea, la gerarchia negli ordini di palchi, la presenza in numerose sale del palco reale, il loggione, in qualche modo codificava, rappresentava e "fissava" la struttura sociale, i legami della collettività con le autorità superiori e con i regnanti: la distribuzione dei palchi, il cui prestigio decresceva man mano che si allontanavano da quello reale, riproduceva per così dire una gerarchia sociale che vedeva al vertice il sovrano o l'autorità di governo. I regnanti o i loro rappresentanti (ad esempio il Delegato apostolico nello Stato pontificio), con la presenza nel palco reale mostravano una forma di benevolenza verso la città, testimoniavano un rapporto saldo con quella, costituivano un’occasione di contatto tra governanti e governati: ospiti illustri, principi e nobili di passaggio venivano ospitati nel palco reale, e quindi si manifestavano alla vista del pubblico. Luogo principale dei contatti sociali, dove celebrare la presenza di sovrani, dove esibire la città rispetto all'esterno, il teatro era il centro principale della vita sociale, un luogo di aggregazione collettiva come la piazza o la chiesa, nel quale però erano ben più evidenti le gerarchie di classe. Alcuni teatri erano controllati direttamente dal sovrano, come è il caso degli “Imperiali Reali Teatri” alla Scala (in cui videro la prima numerose opere verdiane) e Canobbiana a Milano, che dal 1814 al 1859 furono di proprietà imperiale. Considerati elemento di prestigio, furono costantemente oggetto di premure, perché lo scontento verso la qualità delle stagioni teatrali si sarebbe rivolta indirettamente contro i governanti. Il Teatro alla Scala, in quanto proiezione del governo che lo finanziava (durante la Restaurazione divenne il mecenate principale del Teatro, assicurando un finanziamento di 200.000 lire che arrivarono a 300.000 nel 1857),4 godeva di sovvenzioni tali da garantire stagioni d’opera di alta qualità. Si cercava in tutti i modi di evitare l’insoddisfazione del pubblico per la mancata messinscena di spettacoli annunciati o la cattiva qualità degli stessi; i contratti per gli impresari prevedevano che per ogni stagione vi fossero almeno due opere e due balletti nuovi per Milano, e tra questi almeno una prima assoluta. Dal punto di vista delle autorità era essenziale garantire l’apertura dei teatri: nel gennaio 1848, quando già si avvertiva la tensione che sarebbe sfociata nelle “Cinque giornate”,
3 TIBY, p. 69. 4 Per questi dati, cfr. SAEPEN, pp. 596 segg.
10
il governo intervenne con una sovvenzione straordinaria a favore dell’impresario Merelli (in difficoltà economiche tali che il Teatro alla Scala rischiava la chiusura), perché il teatro doveva rimanere aperto a tutti i costi.5 Fino al 1848, anno che segna una cesura insanabile tra governo e città, la Scala esprimeva un collegamento fra calendario teatrale e celebrazione della dinastia: il teatro veniva interamente illuminato a giorno a spese del governo per ricordare il compleanno e l’onomastico dell’imperatore, o all’opposto chiuso dietro ordine superiore per commemorare la morte di Francesco I e della sua seconda e terza moglie; autorità di governo o ospiti importanti potevano comparire nel palco reale durante la rappresentazione delle opere.6 A Roma, al centro di un’area geografica (l’attuale Lazio) povera di edifici teatrali, la stessa gestione delle stagioni d’opera era direttamente controllata dalle autorità di governo: si riteneva importante offrire una vita teatrale che attirasse i più alti strati sociali, che altrimenti si sarebbero diretti verso attività non controllabili. Il papato si preoccupava di garantire alla nobiltà, la classe sociale che più garantiva il suo sostegno, il principale divertimento, e cioè l’opera: i contratti con gli impresari prevedevano che il principale teatro romano, l’Apollo, rimanesse aperto per tutto il Carnevale eccetto venerdì e altri giorni stabiliti. 7 L’attenzione del papa verso l’attività teatrale trova una significativa testimonianza nel rescritto del 12 gennaio 1848 con il quale Pio IX, dietro istanza di Vincenzo Jacovacci (allora impresario ai teatri Apollo, Argentina e Valle), che era venuto a trovarsi in una situazione debitoria disastrosa, interveniva per risolvere la crisi: l’amministrazione dei teatri Apollo e Argentina veniva delegata al Consiglio comunale onde risolvere il deficit e garantire così il consueto svolgimento degli spettacoli.8 Quanto fosse importante tenere aperti i teatri e dare l’impressione alla città che nulla intaccasse il normale ordine degli eventi è indirettamente dimostrato dal fatto che nella stagione di carnevale 1868 cominciarono a circolare lettere anonime con minacce e intimidazioni per impedire la presenza del pubblico a teatro: che dipendesse o no da tali azioni, di fatto l’affluenza fu scarsa e fece risonanza.9 A Napoli, una delle piazze teatrali più importanti d’Europa, con la quale in Italia solo La Scala e la Fenice potevano competere, vi erano i “Reali Teatri” di S. Carlo e del Fondo, retti da un’unica impresa e con identica (e doppia) compagnia di canto e di ballo. Il governo assegnava all’impresa una “dote” (questo era il termine corrente col quale nel mondo teatrale si intendeva una sovvenzione) assai consistente che, pur diminuita dal 1835 al 1860 rispetto agli
5 Sulla particolare cura con cui le autorità seguivano il principale teatro milanese, PACHOVSKY, pp. 364-365. 6 Cfr. SAEPEN, p. 610. 7 Cfr. GIGER 1999, pp. 236-237. 8 Cfr. CAMETTI, I, pp. 251-253. 9 Cfr. CAMETTI, II, p. 527.
11
anni precedenti, veniva concessa in cambio di una stagione che si pretendeva sempre di altissimo livello e con cantanti “di cartello” (cioè di chiara fama).10 Nonostante la progressiva diminuzione della dote, per volere del governo rimase inalterato il costo dei biglietti d’ingresso, segno di attenzione verso una classe come l’aristocrazia, che vedeva nel teatro S. Carlo il luogo e il divertimento preferito. I due teatri principali erano manifestazione ed espressione della generosità della corte e della volontà di sancire una unione con le classi dirigenti; un’emozionata testimonianza di Giovanni Pacini, pur risalente al 1824 e cioè a 17 anni prima dell’introduzione a Napoli delle opere di Verdi, dà conto dell’artefatta sintonia che poteva stabilirsi in teatro tra re e sudditi: S.M. il Re [Ferdinando IV di Napoli e I delle due Sicilie] interveniva in quella sera allo spettacolo […] Al Re piace molto la voce; ed il modo col quale la precitata cantante [Tosi] declama il recitativo, per la qual cosa S.M. esclama un sonoro brava! Tutta la sala ripete egualmente brava! […] Segue […] la cabaletta […] alla fine della quale S.M. dà il segno dell’applauso, e tutta quell’affollata udienza emette un grido di vero entusiasmo.11 La preoccupazione di tenere aperti i teatri direttamente controllati dai regnanti o dal governo, che abbiamo già visto a Milano e Roma, si ritrova anche a Napoli: basti ricordare che sei settimane dopo il massacro avvenuto nelle strade di Napoli e la dichiarazione dello stato d’assedio (15 maggio 1848), il Teatro S. Carlo riaprì con Parisina di Donizetti, perché era importante dare un segno di ritorno alla normalità e fare capire che la corte deteneva il pieno controllo della situazione.12 Esemplare sotto quest’ultimo aspetto il caso del Teatro Carolino di Palermo, il principale teatro della Sicilia nel periodo della Restaurazione. La città, che nel 1848 aveva dato avvio alle rivoluzioni in Italia con l’insurrezione del 12 gennaio, riaprì il teatro già dal 6 febbraio, perché «i teatri agiscono indefessamente per far vedere ai nostri nemici che non si paventa di un pugno di realisti, delle insidie, dei tradimenti e delle perverse insinuazioni del Re di Napoli contro l’umiliata e bersagliata città di Palermo e l’intera Sicilia».13 Repressa la rivoluzione (il 15 maggio 1849 le truppe borboniche erano rientrate a Palermo), in un momento di lentissima ripresa della vita sociale, il 16 giugno 1849 il Ministro dell’Interno scriveva da Napoli: «Io reputo indispensabile che questa [della Sicilia] Capitale abbia nel nuovo anno teatrale una buona
10 Per i dati relativi al San Carlo ci si è basati su ROSSELLI 1983. 11 COMMONS 1983, p. 80. 12 L’opera ebbe la prima rappresentazione il 31 luglio e rimase sulla scena per tre sere, cfr. MARINELLI 1987, p. 299. Quanto riferisce DAVIS, p. 589, che cita I due Foscari, è probabilmente inesatto. 13 TIBY, pp. 208-209.
12
compagnia di musica e che sia riaperto a tempo debito il Real Teatro Carolino».14 La presenza del pubblico a teatro, che abbiamo visto essere in qualche modo indispensabile perché indiretto riconoscimento del prestigio e della “generosità” dei regnanti, poteva diventare un’arma a doppio taglio: qualunque rappresentazione, qualunque testo poteva costituire l'occasione per reazioni incontrollate del pubblico, che anche attraverso la sola presenza avrebbe potuto contestare il regime. Gli applausi marcati o addirittura gli schiamazzi in determinati passaggi del dramma o su certe espressioni del testo potevano acquistare il significato di opposizione più o meno esplicita al regime. Anche il silenzio o addirittura la scarsa affluenza di pubblico, come abbiamo già ricordato per Roma e come avverrà frequentemente alla Scala dopo il ‘48,15 poteva diventare una forma di contestazione. Il patriota Antonio Trotta scriveva nel dicembre 1847, riferendosi al primo teatro milanese: «La corte quando arriva a teatro è sempre ricevuta freddissima, ed una sera fu perfino imposto silenzio ad alcuni applausi che si fecero sentire.»16 A oltre 1000 chilometri di distanza venivano impiegati simili modi per protestare: la sera del 10 gennaio 1848, durante la rappresentazione di Maria di Rudenz al Real Teatro Carolino di Palermo, il pubblico protestò contro l’arresto di 11 patrioti avvenuto la notte precedente mantenendo un ostinato silenzio.17 In quanto luogo privilegiato del rapporto tra il sovrano e la città, o tra le autorità di governo e gli strati sociali più alti, i teatri erano dunque sottoposti alle più diverse forme di controllo (su spazi, programmazione, rappresentazioni ecc.). Sarebbe però qui necessario fare una precisazione: essi erano non solo oggetto, ma costituivano anche occasioni di controllo. Massimo D’Azeglio scriveva nei suoi Ricordi che il governo austriaco aveva «governato per tant’anni la Lombardia per mezzo del teatro della Scala. E bisogna dirlo, fino a una certa epoca vi è riescito bene». Questa nota affermazione, fatta da un uomo politico consumato, sebbene sembri riferirsi essenzialmente al fascino esercitato dal teatro e dagli artisti che vi ruotavano attorno,18 può costituire l’occasione per una serie di riflessioni sui vantaggi che esso poteva offrire. Le autorità di governo erano consapevoli che il prestigio di cui godeva la Scala si proiettava indirettamente su chi lo sosteneva e finanziava; sapevano anche però che le attività che vi si svolgevano (spettacoli, relazioni sociali), e che altrimenti si sarebbero tenute in luoghi ignoti o privati, potevano più facilmente essere sottoposte a controlli, facilitati dalla stessa struttura architettonica: la 14 TIBY, p. 212. 15 Nel suo articolo Saepen reca diverse testimonianze sulla crescente disaffezione del pubblico, dopo il ’48, per motivi politici. Cfr. SAEPEN, passim. 16 SAEPEN, p. 614. 17 TIBY, p. 208. 18 L’affermazione si presenta infatti in forma lapidaria, non argomentata. Massimo D’Azeglio, I miei ricordi, Firenze, Barbèra, 1867, vol. II, p. 373.
13
conformazione dei palchi permetteva infatti la visione totale su tutti gli spazi da un centro ideale, e agenti di polizia in borghese potevano mescolarsi tra la folla in platea. Stabilire un rapporto privilegiato tra governanti e sudditi, facilitare il controllo e creare forme di consenso: queste erano alcune delle funzioni che svolgeva il teatro. All’interno di questo meccanismo insieme paternalistico e coercitivo si collocava la censura teatrale, vicina per diversi aspetti (ad esempio per i contenuti da salvaguardare) a quella sulla stampa. Quanto mai attiva nel periodo della Restaurazione (come è noto), certamente non esauritasi con l’avvento del Regno d'Italia (come è meno noto), si esprimeva in Italia in modalità diverse: non solo controllando preventivamente i testi manoscritti che dovevano essere pubblicati o le stampe provenienti dall'estero, ma verificando poi che le risoluzioni dei censori fossero rispettate. Era parte di un sistema organizzato in forme diverse da Stato a Stato, attraverso il quale il regime garantiva la propria esistenza, e che associava controllo e neutralizzazione delle opposizioni, repressione e aiuti ai possibili sostenitori. In Lombardia la censura appariva come parte di un sistema di “politica culturale”, che poteva arrivare a sostenere libri attraverso l’acquisto di copie da parte delle biblioteche pubbliche o attraverso altre forme che potremmo definire “sovvenzioni editoriali”;19 nel Regno di Sardegna la stampa fu fortemente condizionata dai privilegi assegnati alle diverse tipografie.20 Necessari per la creazione del consenso erano i teatri e la loro esistenza così come, per fare alcuni esempi, le tante gazzette ufficiali pubblicate nei singoli stati, alle quali si affiancavano giornali “indipendenti” ma finanziati più o meno nascostamente dal regime. Il governo sabaudo favoriva attraverso il sostegno economico giornali come la «Gazzetta piemontese» (fondata nel 1814 e diretta dal 1834 al 1849 da Felice Romani), la «Gazzetta di Genova» (presente dal 1807), «L’Indicatore sardo» (1832-1852); altri organismi ufficiali o sostenuti dai vari governi erano la «Gazzetta di Milano» (attiva dal 1816), la famosa «Biblioteca italiana» (1816-1841), la «Gazzetta di Venezia», la «Gazzetta di Parma», la «Gazzetta di Firenze», attive per tutto il periodo della Restaurazione; nello Stato Pontificio godeva di ampia libertà un giornale in sintonia col regime come «L’Osservatore romano» (1849-1852); nel Regno delle due Sicilie esisteva un periodico fiancheggiatore sostenuto dalla polizia anche con finanziamenti indiretti, «L’armonia» (dal 1850).21 Tali periodici, solitamente favoriti dalla censura, ne integravano il ruolo di sostegno del regime: a Roma, nel periodo successivo al ritorno di Pio IX, «il
19 ALBERGONI, p. 215. 20 ROMAGNANI, p. 198. 21 I dati sul periodo di attività dei periodici sono stati ricavati da Catalogo italiano dei periodici (http://acnp.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html); DEL CERRO; GALANTE GARRONE – DELLA PERUTA. Agli ultimi due si rimanda per la discussione sui periodici fiancheggiatori dei regimi.
14
Governatore propugnava la necessità di permettere la nascita di giornali moderati, i quali, evitando le posizioni estreme dei liberali e dei reazionari, finissero per divenire interpreti del pensiero del Governo».22 In campo teatrale, una sicura forma di creazione del consenso fu il singolare concorso lanciato nello Stato Pontificio nel 1853 dal Ministro all’Interno Teodolfo Mertel per la creazione di drammi che trasformassero i teatri in «scuole di virtù» e ispirassero sentimenti di simpatia verso il governo: ciò anche allo scopo «di troncare tutte quelle arti inique che cospirano a ridurre i leciti e giovevoli divertimenti e spettacoli teatrali in scuola di ferocia e di libertinaggio, di immoralità e di miscredenza.»23 Espressione della legge e insieme dell’arbitrio, la censura teatrale era fissata da decreti che ne stabilivano i principi generali, e da regolamenti (in parte ancora ignoti agli studiosi) che ne precisavano il funzionamento; i nomi dei censori, che avevano incarichi definiti e retribuiti, erano pubblicati negli Almanacchi, Manuali o elenchi simili dei vari Stati. Non era affatto raro l’intervento al di fuori delle leggi, insomma la manifestazione di potere scoperta e arbitraria, esercitata dai governanti o dai re: la mancata approvazione di Rigoletto fu firmata dal Governatore generale del Veneto, a Roma il direttore generale di polizia mons. Matteucci avocava a sé compiti di pertinenza dei censori ufficiali, Ernani a Napoli e nel Regno delle due Sicilie fu vietata per «sovrana determinazione». Definito il quadro d’insieme in cui va collocato il fenomeno, la presenza di manifestazioni diverse e apparentemente contrastanti del potere allo scopo di proteggersi dovrebbe ora permettere di precisare il significato e il ruolo della censura. Traendo spunto dal classico testo della Otto, che definisce la censura «controllo autoritario delle forme di espressione umane»,24 potremmo intendere quella teatrale come controllo autoritario nei confronti degli aspetti che riguardano lo spettacolo: libretto, musica, disposizioni sceniche, figurini, messinscena ecc. La censura si preoccupa non tanto di giudicare il valore del “testo” in sé (libretto, partitura ecc.), ma di condizionare o annullare l’effetto che tale “testo” potrebbe esercitare su chi lo recepisce. In campo teatrale ciò significa che il revisore immagina l’effetto che talune espressioni possano avere sul pubblico (ciò vale soprattutto per i termini politici, come si vedrà) e tenta pertanto di condizionarne la ricezione. I versi «il mattino di domani grandi cose apprenderà» (Un ballo in maschera) potevano avere significati molto diversi per il revisore nel febbraio del 1859 o in quello del 1860: di qui un atteggiamento mutevole legato all’evolversi dei tempi. La censura è un mezzo attraverso il quale un gruppo di potere (un governo o il regnante e l’establishment che lo circonda) cerca di garantire la
22 SANDRI, p. 16, che però non cita la fonte. 23 RIVELLI , pp. 344-345, 380-381. 24 Cfr. OTTO, p. 3. Tale concetto viene spiegato e definito nel corso del volume.
15
propria esistenza e di compattare attorno a sé la società, riferendosi ad una verità che è quella stabilita da tale gruppo per legittimare se stesso e uniformare attorno a sé l’opinione pubblica (nell’Ottocento: la visione delle classi superiori).25 Nella relazione fra potere e mezzi con cui garantisce se stesso, censura e propaganda sono agli antipodi come mezzi attivati dal regime ma non per lo scopo cui devono tendere, poiché entrambi hanno come obiettivo la manipolazione della comunicazione. E’ facile intuire come i due elementi possano bilanciarsi ma anche sommarsi tra di loro; si potrà anche capire come, essendo più deboli i mezzi di propaganda, il regime debba innalzare il livello della censura. Nella dialettica censura-propaganda rientrano a pieno titolo i fenomeni che abbiamo esaminato: la diffusione dei teatri, il sostegno selettivo a certa stampa o a iniziative in favore del governo. Certo è che la censura non è altro che uno dei (numerosi) mezzi attraverso i quali il potere politico afferma se stesso, tanto più importante quando gli altri sono meno efficaci. Date tali premesse non sarà difficile considerare che se è vero che la censura fu particolarmente acuta nell’epoca della Restaurazione, essa era solo un elemento di un sistema complessivo; non era certo nata nell’Ottocento, non finì con l’Unità d’Italia e sicuramente non morirà mai.26
25 Sulla componente extra legale e arbitraria della censura, sulla verità stabilita dal potere cfr. Alessandro Fontana, Censura, in Enciclopedia Einaudi, Torino, Einaudi, 1977-1984, vol. 2, pp. 868-893, in particolare 872-873. 26 Come unico significativo esempio di una questione marginale rispetto al nostro lavoro, cfr. Antonio Armano, Maledizioni. Processi, sequestri e censure a scrittori e editori in Italia dal dopoguerra a oggi anzi a domani, Torino, Aragno, 2013.
17
2. NORME E LEGISLAZIONE
Benché infatti possa capitare che un censore sia più assennato dell’ordinario – un bel rischio per i suoi successori -, tuttavia l’ufficio stesso e il suo mandato gli impongono di non lasciar passare nulla che non sia già comunemente accettato. John Milton, Areopagitica, 1644
Uno sguardo d’insieme sull’operato delle censure fa emergere con chiarezza un dato comune, e cioè che esse agivano avendo come riferimento tre contenuti principali: religione, morale, politica. L’importanza assegnata ad ognuno di essi, gli aspetti che dovessero comprendere, l’accento posto su ulteriori motivi (ad esempio la necessità di non offendere la “sensibilità comune”, l’attenzione verso il valore artistico e l’originalità dell’oggetto), le modalità con cui dovevano agire i revisori venivano poi definiti nei singoli Stati da leggi e normative. L’esistenza di queste non deve però far dimenticare che nei procedimenti intervenivano elementi soggettivi e, come già sottolineato, arbitrari. Lo studioso che si addentra in questo campo incontra di frequente nei panni dei revisori persone che potevano vantare una discreta o sostenuta attività letteraria (quando non erano addirittura attive in campo teatrale): erano pertanto impegnate nell’esercizio creativo e si trovavano a giudicare loro colleghi, portando nelle scelte anche convinzioni personali.27 Diversi studiosi hanno sottolineato la forte presenza di religiosi tra i revisori: è quanto notano Maria Iolanda Palazzolo (che evidenzia anche il fatto che la formazione di numerosi laici aveva avuto luogo in istituti religiosi), Giampietro Berti e Antonio Trampus per l’area veneta, Jeremy Commons e Raffaele De Cesare per il Regno delle due Sicilie; si aggiunga che nello Stato pontificio le cariche direttive (direttore generale di polizia, ministri, rappresentanti del governo ecc.) erano di norma coperte da religiosi.28 Non possiamo tuttavia dare un valore preciso a tale presenza, non disponendo in maniera sistematica degli organigrammi per un arco di tempo significativo, soprattutto con riferimento alla censura teatrale. L’azione di censura era il risultato del rapporto tra idee personali, influenze dell’ambiente di lavoro, indicazioni dei regolamenti e interventi delle 27 Il fatto che i revisori fossero spesso figure impegnate nell’attività letteraria è stato evidenziato da Jeremy Commons con riferimento alla produzione donizettiana, cfr. COMMONS 1983. 28 PALAZZOLO, p. 25, BERTI, TRAMPUS, COMMONS 1983, DE CESARE, I, p. 143.
18
autorità superiori (direzione di polizia, ministero, lo stesso regnante) che potevano indicare quali aspetti privilegiare oppure, come emergerà chiaramente, assumere iniziative e decisioni scavalcando il revisore. Allo stato attuale degli studi lo scontro tra norma e arbitrio, tra regola e sua elusione non è ancora chiaro in molti procedimenti: conosciamo sempre i risultati finali ma più raramente il percorso attraverso il quale ci si è arrivati. Nell’esaminare l’insieme del fenomeno, con riferimento all’età della Restaurazione, distinguiamo tra «censura preventiva», che prevedeva il preliminare controllo dell’opera e l’autorizzazione perché questa fosse pubblicata, e «censura repressiva», all’epoca identificata con la libertà di stampa, che consentiva l’immediata pubblicazione dell’opera e l’eventuale successivo intervento delle autorità qualora non fossero rispettate le leggi dello Stato. 2.1 Regno Lombardo Veneto La censura nel Lombardo Veneto si caratterizza per un sistema fortemente centralizzato i cui due vertici sono rappresentati dagli uffici di Venezia e Milano, che estendono la loro giurisdizione sulle due aree regionali di riferimento. All’indomani dell’istituzione del Regno Lombardo Veneto (7 aprile 1815), vengono costituiti un Dipartimento di censura per le provincie venete (Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Udine) con sede a Venezia, e un Regio ufficio di censura per le provincie lombarde (Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Sondrio, Pavia, Lodi) con sede a Milano. Il primo viene stabilito con decreto n. 61 del 1 giugno 1815 e diventa attivo dal successivo 15 giugno; il Regio ufficio viene fissato con decreto n. 49 del 22 aprile 1816 e diventa attivo dal primo maggio 1816. 29 I due decreti, simili nel contenuto, fissano anche l’organizzazione dei due uffici principali, posti sotto l’immediata direzione del Governo generale, e stabiliscono tra l’altro che «La censura poi delle rappresentazioni teatrali stampate o manoscritte che si producono non pel permesso della stampa, ma per quello della produzione, è affidata agli uffizj di polizia sotto la direzione della rispettiva superiore autorità.» E’ però con il Piano generale di censura che vengono definiti precisamente i compiti dei censori e i contenuti da salvaguardare: basato sul principio della censura preventiva, viene attivato per le provincie venete con
29 COLLEZIONE LEGGI PROVINCE VENETE, vol. II parte I, 1816, pp. 241-250; RACCOLTA ATTI GOVERNO LOMBARDIA, vol. I, 1816, pp. 353-357. Il testo relativo alla sede di Venezia contiene anche l’estratto del codice penale per coloro che non rispettavano le norme sulla censura.
19
decreto n. 127 del 31 dicembre 1815; per quelle lombarde viene pubblicato nel 1841, ma sicuramente era attivo prima del 1820.30 Il Piano conteneva indicazioni operative e prevedeva un Dipartimento di censura composto da quattro censori col compito di rivedere «tutt'i libri che s'introducono dall'estero, e tutti li manoscritti, che voglionsi dare alla stampa nell'interno delle province soggette a questo Governo Generale». Nel Veneto, ad esempio, a quello di Venezia si affiancavano gli uffici nelle provincie; veniva però stabilito (e chiarito dalle circolari pubblicate successivamente) che a tali uffici spettava il controllo dei cataloghi e dei testi che non superassero i tre fogli, mentre a quello centrale spettava il controllo di tutti gli altri, allo scopo dichiarato di evitare discrepanze tra centro e periferia (art. 90), e anche perché «sarebbe troppo lunga e dispendiosa la trafila per le città provinciali (art. 86)». Questa disposizione e la tendenza al centralismo che la caratterizza avranno conseguenze anche in campo teatrale: nel Lombardo Veneto apparentemente i libretti della stessa opera rappresentata in piazze diverse ma appartenenti allo stesso Governo (Milano o Venezia) sono uguali, diversamente da quanto, come vedremo, poteva verificarsi per lo Stato Pontificio o il Regno delle due Sicilie. Il Piano divideva la materia in “opere stampate ossia libri”, “Gazzette e giornali politici”, “Fogli volanti”, “Stampe figurate”, e quindi “Teatri”, cui veniva dedicata una sezione intera (il Titolo VI). Esso indicava come massima generale (art. 12) «che non devesi ammettere nulla, che sia contro la Religione dominante, gl'interessi del Sovrano e dello Stato, e contro i buoni costumi.» All'art. 19 stabiliva che «Le stesse cautele [nell'art. precedente si erano discusse le opere che trattavano della pubblica amministrazione] dovranno praticarsi a quell'opere che contengono discussioni sugli affari e rapporti politici de' differenti Stati, e che per qualsiasi ragione potessero dispiacere ad una potenza estera o compromettere la politica dell'Austriaco Governo». All'art. 21 leggiamo che «Opere, le quali attaccano il supremo capo dell'Impero, la sua dinastia, od anche governi esteri [...], che hanno per iscopo di seminare il malcontento e di turbare la pubblica tranquillità, di rompere i nodi fra Sovrano e suddito, di sovvertire la religione dello Stato, di corrompere la moralità [...] devono essere trattati [sic] con tutto il rigore della censura [...]».
30 Secondo Angela Pachovsky prima della pubblicazione del 1841 l’azione della censura teatrale a Milano non si espresse secondo un criterio unitario. In realtà doveva circolare uno stampato di riferimento contenente lo stesso testo attivo a Venezia: un esemplare è conservato presso la Biblioteca statale di Cremona. Nello stesso la data da completare negli allegati (181…) fa ritenere che esso sia anteriore al 1820. PACHOVSKY, pp. 367-368. I testi sono del tutto simili fra loro, con i necessari adattamenti di natura geografica: Piano generale di censura per le provincie venete, in COLLEZIONE LEGGI PROVINCE VENETE, [1816]; Piano generale di censura per le Province Lombarde, ante 1820 (cfr. riproduzione parziale in Appendice); Piano generale di censura per le provincie lombarde coll'aggiunta delle principali disposizioni di massima emanate posteriormente alla sua attivazione ch'ebbe luogo col primo maggio 1816, Milano, I.R. Stamperia, 1841.
55
3. VERDI E LA CENSURA
…prima di segnare un contratto vorrei un dramma finito di tutta mia sodisfazione ed approvato dalla Censura perché io non voglio più diventar matto colle Censure. Verdi a Cesare De Sanctis, 10 gennaio 1853123
Come emerge dal capitolo precedente, Verdi visse di fatto tutta la sua esistenza dovendo misurarsi con un sistema politico basato sul controllo preventivo delle creazioni per il teatro. Va da sé che le condizioni variarono nel tempo, e che dopo il 1864 (legge 1630) l’approvazione da parte degli uffici di revisione fu un atto più spesso burocratico; restava però il principio fondamentale del controllo prima della messinscena. Per Verdi, come per un artista o un intellettuale della sua epoca, la censura era una pre-condizione, qualcosa che già esisteva e che veniva accettato come un dato di fatto col quale bisognava misurarsi. Non è esagerato affermare che essa agiva ancora prima che un soggetto drammatico potesse prendere una qualche forma nella fantasia del compositore e, per quanto possa sembrare strano ad una primissima riflessione, continuava ad agire dopo che un’opera era stata approvata; Verdi non approfondì nemmeno alcuni soggetti che lo interessavano perché sapeva già che non sarebbero stati accettati. Solo per citare alcuni esempi ricordiamo che subito prima di dedicarsi a Ernani, Verdi aveva incluso tra le ipotesi di lavoro un Cola da Rienzi che giudicava «magnifico» ma censurabile da parte della Polizia e al quale rinunciava subito.124 Nella fase iniziale di lavorazione del Re Lear, che vedeva la collaborazione di Salvadore Cammarano, il poeta aveva realizzato una sinossi in fondo alla quale aveva riportato, col titolo Ostacoli delle Censure, una serie di azioni che avrebbero potuto essere contestate. Si potrà notare che si tratta nella quasi totalità di azioni che si caratterizzano per la violenza o la sofferenza fisica e che
123 CARTEGGI VERDIANI, I, pp. 17-18. 124 ERNANI EDIZIONE CRITICA, p. 37.
56
potevano suscitare “disgusto” nel pubblico: pur con termini diversi, tutte le norme che abbiamo esaminato pongono l’attenzione su questo aspetto. Ostacoli delle Censure - Duplice azione negli avvenimenti delle famiglie di Lear e Glocester, quantunque infine si annodino insieme. - Molti Personaggi, fra cui undici principali. - 26 cangiamenti di scena, per eseguire i quali abbisognano 18 o 19 Decorazioni. - Il buffone è pazzo, Lear diventa pazzo, Edgardo si finge pazzo. - Edmondo si ferisce Cornovaglia svelle un occhio a Glocester Un servo ferisce Cornovaglia Regana uccide il servo Cornovaglia strappa l’altro occhio a Glocester 2. Edgardo uccide il Maggiordomo 1. Annunzio della morte di Cornovaglia Edgardo ferisce Edmondo Racconto della morte di Glocester Si annunzia l’avvelenamento di Regana Si annunzia che Gonerilla si è trucidata Si portano i loro corpi in iscena Lear porta il cadavere di Cordelia Lear dice aver trucidato l’uccisore della figlia 2. Il buffone fu strozzato 1. Si annuncia la morte di Edmondo Lear muore125 Numerosi sono i casi di soggetti respinti, ancora prima che fosse presentata la «selva» (il riassunto con le azioni principali): la censura veneziana bocciò Catterina Howard «per soverchia atrocità», e I due Foscari «perché involgono riguardi dovuti a famiglie viventi in Venezia» (si aveva timore di offendere i discendenti dei Loredan e Barbarigo). 126 La censura romana rifiutò un progettato Lorenzino de' Medici (1844), poi messo in musica da Pacini per Venezia;127 quella napoletana rifiutò la selva di Maria de' Ricci, ricavata da L’assedio di Firenze di Francesco Domenico Guerrazzi. A proposito di quest’ultimo soggetto, così Salvadore Cammarano scriveva a Verdi il 14 aprile 1849: Con mio sommo rammarico sono costretto ad annunziarvi sinistro avvenimento: l'Autorità che sopraintende a questi teatri ha domandato il nostro programma Maria de' Ricci e lo ha respinto con un ufficio del tenore seguente: ”Per la inopportunità del
125 CARTEGGIO VERDI-CAMMARANO, pp. 371-372. 126 ERNANI EDIZIONE CRITICA, p. 37. 127 GIGER 1999, pp. 243-45.
105
4. CENSURA AL QUADRATO (E AL CUBO): LA DIFFUSIONE DELLE OPERE DI VERDI
Si fà la Traviata a Napoli? ... Povera Traviata! Sarà data come fù dato Rigoletto (la mia migliore opera!). Quando penso a questi massacri mi auguro d'esser messo all'indice come era altra volta a Napoli, così non farebbero più mie opere: cosa che m'auguro di gran cuore piuttosto che di vederle così maltrattate. Verdi a Cesare De Sanctis, 20 gennaio 1855247
Una volta che il libretto veniva approvato dalla censura e l’opera poteva raggiungere il pubblico, alla fine di un percorso che abbiamo visto talora estenuante per il poeta e il compositore, ciò non significava che potesse continuare liberamente il proprio cammino. Nel momento in cui si rappresentava in un altro Stato, doveva essere sottoposta a nuovo esame; era poi del tutto possibile che una nuova messinscena nello Stato in cui era stata approvata, o addirittura nella città in cui era stata già presentata, comportasse una nuova revisione. Era affatto normale che si verificassero, dunque, censure su testi censurati. Non possiamo però considerare fra loro equivalenti i diversi gradi della censura, perché fra quella che portava il dramma per la prima volta sulla scena e le successive esiste una differenza fondamentale: il percorso che portava alla prima approvazione si svolgeva sotto il controllo del poeta e di Verdi; nelle fasi successive invece il libretto era corretto modificato stravolto senza che i due autori potessero intervenire. Tale situazione spinge a chiedersi se non esistessero forme di tutela del prodotto artistico, o in altri termini: se il poeta o il compositore avevano affidato alle stampe o reso pubblica (ad esempio attraverso la rappresentazione) la loro opera, se questa aveva avuto una legittimazione proprio dalla censura, non vi era alcuna garanzia, alcuna protezione paragonabile all’attuale tutela del diritto d’autore? Fin dai primi decenni dell’Ottocento (ci riferiamo all’Italia) alcuni Stati avevano provveduto a fissare, attraverso leggi, regole di protezione di ciò che 247 CARTEGGI VERDIANI, I, pp. 28-29. La Traviata andò in scena al S. Carlo dal 28 gennaio col titolo Violetta, cfr. MAIONE – SELLER, p. 125. Rigoletto era stato rappresentato al Teatro Nuovo nell'ottobre 1853 come Clara di Pertb, cfr. libretto.
106
veniva chiamato proprietà artistica o scientifica o letteraria. Nel Regno delle due Sicilie fin dal 7 novembre 1811 era stato varato un decreto riguardante i teatri, sostituito poi (5 febbraio1828) da uno nuovo riguardante la materia generale del diritto d’autore. Lo stato pontificio aveva emanato fin dal 1826 (23 settembre) un editto che recitava: 1. Chiunque nello Stato pubblicherà per istampa od incisione di qualsivoglia maniera opere di scienze, lettere ed arti qualunque, di cui sia egli autore, avrà quind’innanzi di esse, durante sua vita naturale, il diritto d’assoluta proprietà. […] 12. Nessuno potrà stampare, incidere e pubblicare in qualunque maniera opere manoscritte, né ancora stampate d’autori viventi o d’autori dopo la cui morte non sono ancor passati dodici anni, i quali abbiano trasmesso ai loro eredi il diritto di proprietà, senza permesso in iscritto degli autori od eredi rispettivi. Se questa tutela esisteva all’interno dello Stato, e diversi Stati agirono con norme di protezione della proprietà scientifica, letteraria e artistica, la storia delle leggi sul diritto d’autore insegna però che la pirateria editoriale (e indirettamente, sulle rappresentazioni teatrali) fu assai fiorente fino al 1865 quando (25 giugno) fu pubblicata la nota legge Scialoja: proprio contro i frequenti casi di pirateria editoriale fu spesso interpellata la censura, creando talora una sovrapposizione di attribuzioni, un conflitto di competenze tra uffici di revisione e tribunali. I problemi maggiori potevano però sorgere nel momento in cui l’opera veniva pubblicata in uno Stato diverso da quello nel quale era stata stampata originariamente. A tale garanzia vennero siglate convenzioni fra i diversi Stati e una di queste, firmata dapprima tra la corte d’Austria e quella di Sardegna (22 maggio 1840), vide poi l’adesione nello stesso anno di Granducato di Toscana (31 ottobre), Ducato di Modena (27 ottobre), Ducato di Lucca (6 novembre), Stato pontificio (16 novembre), Ducato di Parma Piacenza e Guastalla (18 dicembre) e finalmente provincie napoletane dal 21 aprile 1862.248 Tale convenzione però stabiliva all’art. 26: Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicheranno per nulla all'esercizio dei rispettivi diritti di censura e di proibizione, il quale continuerà ad avere luogo negli stati rispettivi indipendentemente dalla stipulazione surriferita secondo le regole stabilite e da stabilirsi. 248 Il Regno delle due Sicilie non aveva aderito alla convenzione del 1840, per cui rimaneva in vigore il decreto del 1828. Per le convenzioni firmate nel 1840, si veda il Manifesto senatorio 27 febbraio 1841 n. 320 del Regno di Sardegna; per l’estensione alle provincie napoletane, Regio decreto del Regno d’Italia 21 aprile 1862 n. 560. Un’ottima introduzione all’argomento in Alessandra Bassi, Storia del diritto d’autore nel teatro di Torino, Tesi di laurea in giurisprudenza, Università di Pavia, a.a. 1999/2000. Per gli intrecci tra diritto d’autore e censura, e per la storia della legislazione con particolare riguardo a Verdi, BAIA CURIONI.
107
Dunque lo Stato tutelava i propri interessi attraverso un diritto di censura che veniva prima della salvaguardia del diritto di proprietà. Tale regola avrà enormi conseguenze nella diffusione delle opere verdiane: il godimento del diritto di proprietà del bene artistico all’interno del singolo stato poteva avere luogo solo dopo l’approvazione da parte della censura, che pertanto poteva intervenire e modificare il prodotto artistico “finito”. La strada per la mutilazione delle opere era aperta. 4.1 Rigoletto Per quello che riguarda i controlli e le modifiche imposte dalle censure, nel suo cammino di diffusione Rigoletto costituisce indubbiamente un caso esemplare. Appena giunta sulla scena (Venezia, 11 marzo 1851) e quindi al grande pubblico l’opera si era guadagnata una messe di critiche riguardanti gli aspetti morali e addirittura l’opportunità di trasferire un soggetto del genere nel teatro musicale. Su «Il vaglio» così scriveva l’anonimo articolista: Il sig. Piave volle copiare Le Roi s'amuse di Vittor Hugo, e di più volle regalar all'onorevol casa de’ Duchi di Gonzaga un novello don Giovanni Tenorio per amorosa vita, e accagionare un principe italiano di libertinaggio, di ratti, di stupri e violenze che gli stessi francesi, tanto proclivi ad infamarci, non ardirono fare.249 La direzione della «Gazzetta musicale di Milano», in coda ad una corrispondenza da Padova di Melchiorre Balbi datata 6 agosto 1852, annotava: «Diremo prima di tutto, che a noi sembrano mostruosi gli argomenti nei quali le male passioni sono poste in trionfo, non dove sono mostrate in tutta la loro immondezza e terribilmente punite.»250 E ancora, in una recensione anonima pubblicata sulla «Gazzetta di Genova», possiamo leggere Non abbiamo mestieri di spendere molte parole sul merito della poesia e sulla moralità dell'argomento. Il breve cenno che ne abbiamo fatto basta a darne un'idea. Di una cosa solo ci meravigliamo, che il Sig. Piave siasi formato un criterio così sinistro del pubblico italiano da introdurre simili sozzure sul nostro teatro melodrammatico.251 Infine, un articolo non firmato da «La Gazzetta di Parma»
249 «Il vaglio», a. 15, n. 11, Venezia, 15 marzo 1851, p. 88. Riportato in DELLA CORTE - CONATI, pp. 1700-1701. Conati ipotizza che l’autore anonimo potesse essere Francesco Gamba, che effettivamente ne era il redattore principale. Scheda descrittiva del periodico, anche in relazione alla censura, in BERTI, pp. 63-65. 250 «Gazzetta musicale di Milano», a. 10, n. 35 (15 agosto 1852), p. 147. Articolo riportato in DELLA CORTE - CONATI, pp. 1711-1712. 251 «Gazzetta di Genova», 29 dicembre 1852, in DELLA CORTE - CONATI, pp. 1712-1713.
153
5.2 DOCUMENTI
REGNO LOMBARDO VENETO
5.2.1 Piano generale di censura per le Province Lombarde [1816-1819 circa] Nel Regno Lombardo Veneto furono pubblicati nel 1816 un Piano generale di censura per le provincie venete e, del tutto simile, solo nel 1841 un Piano generale di censura per le Province Lombarde coll'aggiunta delle principali disposizioni di massima emanate posteriormente alla sua attivazione ch'ebbe luogo nel primo maggio 1816. Già nel secondo decennio dell’Ottocento circolava comunque un fascicoletto, comprendente il Piano generale di censura per le Province Lombarde, come si può evincere da un esemplare non datato e conservato presso la Biblioteca statale di Cremona. Tale fascicolo contiene anche un’Appendice di più recenti prescrizioni generali; Istruzioni per la manipolazione degli affari; un Formulario con un Protocollo generale dell’Imperiale Regio ufficio di Censura per l’anno 181[…], organizzato in colonne relative a Numero progressivo, Data della presentazione e della rimessa al Censore, Esibente, Titolo dell’opera, Nome del Censore cui fu rimessa, Giorno in cui fu ritornato dal Censore, Decisione che ottenne; infine un Estratto del Codice penale relativo alle gravi trasgressioni politiche. Da tale fascicolo abbiamo estratto l’intero Titolo VI; nella trascrizione gli accenti e la desinenza maschile plurale “j” sono stati normalizzati secondo l’uso moderno.
Titolo VI. Teatri
64. Se vi è cosa che meriti tutta l'attenzione, si è certamente quelle delle rappresentazioni teatrali. Fanno esse la massima impressione in chi le ascolta, vengono frequentate da ogni sorta di persone, e sono maneggiate da soggetti che, avidissimi come sono d'applauso, cercano adattarsi all'umore ed al genio della moltitudine, senza scrupolizzare sui mezzi. È necessario quindi che siano rivedute le Commedie, i Drammi, le Tragedie, le Opere buffe e serie, i Melodrammi, gli Scheletri delle commedie a soggetto tollerate ancora nelle Marionette e ne' Teatri de' burattini, i Programmi de' balli e gli argomenti delle azioni pantomimiche. 65. Riguardo a que' pezzi teatrali che verranno sottoposti alla Censura per la stampa, o che stampati provengono dall'estero, saranno essi trattati come tutti gli altri libri e manoscritti dalla Regia Censura. 66. Siccome però l'Italia è inondata di una quantità di teatrali rappresentazioni manoscritte e stampate, comparse alla luce sotto il cessato Governo od anche in tempi anteriori, rappresentazioni di cui sono in possesso i negozianti di libri, gl'impresari e capicomici, non potrà quindi da qui innanzi essere prodotta in iscena alcuna di esse senza la preliminare revisione della Polizia, la quale non dovrà attenersi per l'ammissione o rigettazione di esse agli elenchi stampati nel