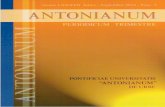La tradition sahidique de philologie gréco-copto-arabe: MSS des XIVe-XVe siècles (2000)
“Gorgia scettico? Una riflessione sulla presenza del sofista nelle opere di Sesto Empirico”,...
Transcript of “Gorgia scettico? Una riflessione sulla presenza del sofista nelle opere di Sesto Empirico”,...
GORGIA SCETTICOUna riflessione sulla presenza del sofista
nelle opere di Sesto Empirico
Sesto Empirico egrave fonte per noi preziosissima per la conoscen-za del pensiero presocratico Nel caso di Gorgia a lui si deve unadelle due testimonianze che ci tramandano per intero il Περ το μντος (drsquoora in avanti PTMO) contenuto in M 765ndash87 Bencheacute laversione dellrsquoAnonimo pseudo-aristotelico (MXG 979a12ndash980b21) sia ormai concordemente ritenuta la piugrave attendibile nella tras -missione del trattato1 Sesto rappresenta una voce essenziale per laricostruzione degli argomenti gorgiani2 soprattutto lagrave dove il testo
) Un grazie particolare va a Lorenzo Perilli per la disponibilitagrave e lrsquointeres-se dimostrati verso il mio lavoro
1) Si vedano in proposito O Apelt Gorgias bei Pseudo-Aristoteles und beiSextus Empiricus RhM 43 1888 202ndash19 G Calogero Studi sullrsquoeleatismo Firen-ze 1932 O Gigon Gorgias lsquoUumlber das Nicht-seinrsquo Hermes 71 1936 186ndash213A Levi Storia della Sofistica Napoli 1966 M Migliori La filosofia di Gorgia Con-tributi per una riscoperta del sofista di Lentini Milano 1973 H-J Newiger Unter-suchungen zu Gorgiasrsquo Schrift lsquoUumlber das Nicht-seiendersquo Berlin 1973 J MansfeldHistorical and Philosophical Aspects of Gorgiasrsquo laquoOn what is notraquo SicGym 381985 243ndash71 T Buchheim (Hrsg) Gorgias von Leontini Reden Fragmente undTestimonien Hamburg 1989 B Cassin LrsquoEffet Sophistique Paris 1995 e R WardyThe Birth of Rhetoric Gorgias Plato and Their Successors London 1996 Poche levoci in favore della superioritagrave di Sesto tra di esse ricordo H Diels W Kranz DieFragmente der Vorsokratiker II Berlin 61952 in cui egrave accolta la sola versione se-stana E Dupreacuteel Les Sophistes Protagoras Gorgias Prodicus Hippias Neuchacirc-tel 1948 J H M M Loenen Parmenides Melissus Gorgias A Reinterpretation ofEleatic Philosophy Assen 1959 J Barnes The Presocratic Philosophers London1979 In favore di unrsquointegrazione tra le due fonti sono G B Kerferd Gorgias onnature or that which is not Phronesis 1 1955ndash6 3ndash25 M Untersteiner (a cura) So-fisti Testimonianze e frammenti II Firenze 21961 C M J Sicking Gorgias und diePhilosophen in C J Classen (ed) Sophistik Darmstadt 1976 384ndash407 G Maz -zara Gorgia ontologo e metafisico Palermo 1982
2) Di questo avviso sono tra gli altri G B Kerferd Meaning and ReferenceGorgias and the Relation between Language and Reality in K Boudouris (ed) TheSophistic Movement Athens 1984 215ndash22 A P D Mourelatos Gorgias on theFunctions of Language Philosophical Topics 15 1987 135ndash70 136 G MazzaraGorgia La retorica del verosimile Sankt Augustin 1999 passim
dellrsquoAnonimo sia lacunoso o oscuro per via della sua concisioneNon egrave mia intenzione offrire qui un quadro dettagliato delle diffe-renze tra le due versioni ma individuare se e dove siano rintrac-ciabili nel testo di Sesto le evidenze in favore di una revisione lsquoscet-ticheggiantersquo del trattato di Gorgia o piuttosto gli interventi mi-ranti ad esaltare lrsquounicitagrave della via scettica oscurando le analogie colpensiero sofistico
1 LrsquoAnonimo pseudo-aristotelico e Sesto Empirico due distinte versioni del PTMO
La versione dellrsquoAnonimo e quella di Sesto sono verosimil-mente due fonti distinte del PTMO derivate con ogni probabilitagravedal medesimo iparchetipo3 ma indipendenti lrsquouna dallrsquoaltra nellatrasmissione del testo Sono infatti numerose le differenze lingui-stiche stilistiche e argomentative ciograve non significa tuttavia che trale due opere non esistano significativi punti di convergenza e anzitalvolta lrsquouna puograve far luce sullrsquoaltra Se Sesto avesse attinto a MXGcome fonte per la trasmissione del PTMO4 ci aspetteremmo trac-ce di tale filiazione viceversa in Sesto troviamo elementi gorgianiassenti nella versione dellrsquoAnonimo e che nel caso di una sua deri-vazione da MXG dovremmo ipotizzare introdotti in maniera con-sapevole da Sesto attraverso una contorta manipolazione e unrsquoim-probabile contaminazione di fonti
Il caso piugrave evidente egrave rappresentato a mio avviso dallrsquoargo-mento su 13διον πειρον tramandatoci in M 769ndash70 e corrispon-dente a MXG 979b22ndash26 Il testo di Sesto presenta unrsquointeressan-te analogia linguistica con un passo del Parmenide platonico (Parm137d7ndash138b6) in cui sono numerosi i riecheggiamenti del trattatodi Gorgia a dimostrare il recupero di suggestioni gorgiane da par-te di Platone un raffronto tra i due testi rivela altresigrave lrsquoindipenden-
332 Rober ta Io l i
3) Anche per Mansfeld (come n 1) 244 le due versioni deriverebbero dallostesso iparchetipo dipendente dal Πρς τ Γοργου aristotelico (cfr D L 525) PerM L Silvestre Una lettura aristotelica di Gorgia le ragioni di un silenzio SicGym38 1985 411ndash27 412 invece il Πρς τ Γοργου sarebbe opera giovanile in cui Ari-stotele avrebbe confutato non il PTMO ma i τποι della retorica gorgiana confu-tazione poi ripresa in etagrave matura in Topici e Retorica
4) Questa egrave la tesi difesa da W Broumlker Gorgias contra Parmenides Hermes86 1958 425ndash40 425 e Newiger (come n 1) 161ndash70
za di Sesto nella trasmissione dellrsquoargomento sulla generazione InGorgia come in Platone la riflessione sullrsquoessere ingenerato si svi-luppa a partire dallrsquoequivalenza melissiana tra lrsquoessere ingeneratocioegrave eterno e lrsquoessere infinito che per sua intrinseca natura nonpuograve essere contenuto in alcun luogo tale argomento che rappre-senta uno dei due corni del dilemma sulla generazione egrave usato daGorgia per dimostrare che niente egrave mentre da Platone egrave impiegatocontro lrsquoesistenza dellrsquouno La conclusione egrave esplicita nel PTMO(ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave) mentre resta implicita ma ine-quivocabile nel Parmenide in cui lrsquoammissione dellrsquoessere unitarioconduce a unrsquoinaccettabile serie di aporie
Premessa comune a Gorgia e a Platone egrave che essendo infini-to lrsquoessere (o lrsquouno) non saragrave in alcun luogo poicheacute non saragrave neacute inaltro da seacute neacute in se stesso in entrambi i casi infatti ci sarebbero dueinfiniti Nella versione MXG esattamente come in Melisso rie-cheggiato dal sofista il paradosso dellrsquoinfinito contenuto in altro daseacute conduce allrsquoaporia dei due infiniti inconciliabile prima ancorache con il presupposto dellrsquoinfinitagrave con quello dellrsquounitagrave
Mel 30B6 DK Se infatti (scil lrsquoessere) fosse infinito sarebbe uno poi-cheacute se fossero due non potrebbero piugrave essere infiniti trovando limitilrsquouno nellrsquoaltro5
MXG 979b23ndash24 (scil Lrsquoinfinito) neacute puograve essere in se stesso neacute in altroin tal caso infatti vi sarebbero due infiniti quello che egrave contenuto equello che contiene6
Come in Melisso (e implicitamente in MXG) la definizione stessadi infinito in quanto privo di confini impone la conferma del pre-supposto unitario7 cosigrave Platone pur sviluppando la propria argo-
333Gorgia Scettico
5) ε γρ ⟨πειρον⟩ εη ν εη ν ε γρ δο εη οκ $ν δναιτο πειρα εampναι13λλ( )χοι $ν περατα πρς λληλα Cfr anche 30B5 DK ε μ ν εη περανε+ πρςλλο
6) ο-τε γρ ν ατ0 ο-τ( $ν ν λλ1 εampναι δο γρ $ν ο2τως 13περω εampναιτ τε νν κα τ ν 4 Seguo in analogia con Melisso la congettura di Bonitz13περω invece del tradito 5 πλεω che risolverebbe tutta lrsquoargomentazione nei ter-mini del regressus ad infinitum zenoniano (cfr 29A24 DK) Si veda in propositoH Bonitz Zu der Schrift uumlber Xenophanes Zenon und Gorgias in AristotelischeStudien Vienne 1862 I 63ndash86
7) Cosigrave suggerisce anche Simpl in Aristot phys 1105 (13π δ6 το 13περουτ ν συνελογσατο) introducendo 30B5 DK E che questo fosse il fine di Melissoegrave confermato dalla controargomentazione di Eudemo (fr 41 Wehrli) che difendecontro Melisso unrsquoidea di infinitezza conciliabile con quella di pluralitagrave
mentazione in senso antieleatico presuppone perograve lrsquounitagrave del -lrsquoessere come premessa implicita e tacitamente operante si dice in-fatti che laquose fosse in altro da seacute sarebbe circondato come in un cer-chio da quello in cui egrave e con esso in molti casi avrebbe molti pun-ti di contattoraquo8 essendo perograve uno intero e privo di parti lrsquoesserenon puograve avere contatti in piugrave punti con altro da seacute
In Sesto invece lrsquoargomentazione da confutare egrave quella checompromette lrsquoidea stessa di infinito qualora lo si ammetta conte-nuto in altro da seacute e per ciograve stesso non piugrave infinito si sostiene chelaquoil contenente egrave infatti sempre maggiore del contenutoraquo (M 769με+ζον γ9ρ στι το μπεριεχομνου τ μπεριχον) secondo unrsquoar-gomentazione a cui lo scettico ricorre sovente nella sua opera ri-proponendo anche il medesimo linguaggio (si veda ad esempioPH 386 με+ζον γρ εampναι δε+ τ περιχον το περιεχομνου)9 Lrsquoelemento di indubbia analogia tra il Parmenide e la versione diSesto egrave rappresentato dallrsquoimpiego del participio περιχον eviden-za linguistica che non va ritenuta casuale10 Possiamo ipotizzareche tale termine fosse presente nellrsquooriginale gorgiano e omessonella versione MXG lrsquoAnonimo infatti nella sua tendenza al-lrsquoesposizione sintetica puograve aver tralasciato di trascrivere per inte-ro la dimostrazione enunciandone solo premesse e conclusioniNei dettagli perograve lrsquoargomentazione di Gorgia doveva seguire unalinea analoga a quella poi tracciata da Platone nel qual caso Sestoavrebbe come si egrave visto leggermente modificato lrsquoargomento11
334 Rober ta Io l i
8) Parm 138a3ndash5 ν λλ1 μ6ν ltν κκλ1 που $ν περιχοιτο π( κενου ν4 νεη κα πολλαχο $ν ατο =πτοιτο πολλο+ς Cfr i περατα di 30B6 DK
9) Ma altre altrove ricorre la medesima strategia argomentativa egrave il caso diM 9301 (13λλ τ μ6ν με+ζον 13π το gtττονος οκ $ν 13φαιρεθεη δε+ γρ τ 13πτινος 13φαιρομενον περιχεσθαι ν κεν1 τ0 ξ οB C 13φαρεσις ν δ6 τ0 gtττονι οπεριχεται τ με+ζον) e di M 9408 (D γρ )σχατον νενοEκασι τF διανοGπεριληπτν στιν D δ6 περιληπτν στι διανοG πεπρασται)
10) M 770 κα μν οδ( ν ατ0 περιχεται (cfr Parm 138a7ndash8 Hλλ μνατ γε ν Iαυτ0 ltν κ$ν Iαυτ0 εη περιχον οκ λλο 5 ατ) A parte questrsquounicaoccorrenza Sesto negli altri casi usa il composto μπεριχεσθαι termine tardo escarsamente attestato ma caro allo scettico che sembra impiegarlo in alternativa aπεριχεσθαι Si vedano in proposito Mansfeld (come n 1) 261ndash2 e C J ClassenLrsquoesposizione dei sofisti e della sofistica in Sesto Empirico Elenchos 13 1992 57ndash79 77
11) Anche Mansfeld (come n 1) 262 ritiene che lrsquoargomento autenticamentegorgiano possa essere stato assimilato da Platone e tramandato diversamente nelledue versioni a riprova della loro reciproca indipendenza Sul legame teoretico tra
giocando su quel binomio contenente-contenuto che egrave spesso dalui adottato nella confutazione di δξαι non condivise
2 Revisioni scettiche nella presentazione del PTMO
21 La prima tesi
Nel PTMO lrsquoenunciazione sintetica delle tre tesi a parte qual-che lieve differenza tra le due versioni cosigrave suona laquoGorgia dice cheniente egrave e se egrave egrave inconoscibile e anche se egrave ed egrave conoscibile tutta-via non si puograve mostrare ad altriraquo12 Le due versioni si differenzia-no in realtagrave giagrave a partire dalla strategia adottata nellrsquoorganizzazio-ne degli argomenti della prima tesi lrsquoAnonimo propone infatti duegrandi blocchi argomentativi
A ΠρJτος λγος ovvero διος 13πδειξις cioegrave la laquodimostra-zione propriaraquo di MXG 979a25ndash33 in cui Gorgia dimostra cheniente egrave servendosi di argomentazioni proprie Tale dimostrazioneegrave strutturata in tre argomenti distinti a partire da tre diverse pre-messe ipotetico-concessive (a) se ciograve che non egrave egrave ciograve che non egrave (b)se ciograve che non egrave egrave (c) se ciograve che non egrave e ciograve che egrave sono identici Qua-lunque delle tre premesse venga accolta Gorgia conclude che nien-te egrave o per la precisione che non egrave possibile neacute essere neacute non esse-re secondo la formulazione sintetica di MXG 979a24
B Δετερος λγος ovvero συνθετικ 13πδειξις cioegrave la laquodi-mostrazione sinteticaraquo di MXG 979b20ndash980a8 derivata dal con-fronto e dalla reciproca confutazione di tesi altrui (soprattutto Me-lisso e Zenone) in base alla quale niente egrave Essa egrave sviluppata in dueargomenti distinti precisamente lrsquoantinomia generato ingeneratoe quella uno molti con lrsquoaggiunta di una riflessione sul movimen-to che costituisce un ampliamento tematico delle due precedentiantinomie
In Sesto manca invece un esplicito riferimento sia alla tesi pro-pria di Gorgia sia alla dimostrazione derivata da tesi altrui alla con-clusione per cui niente egrave si giunge attraverso lrsquoeliminazione di
335Gorgia Scettico
Gorgia e Platone rimando a R Ioli Il silenzio di Platone e Aristotele sul Περ τομ ντος di Gorgia Dianoia 12 2007 7ndash42 spec 12ndash14
12) MXG 979a12ndash13 οκ εampνα φησιν οδν ε δ( )στιν γνωστον εampναι εδ6 κα )στι κα γνωστν 13λλ( ο δηλωτν λλοις
ognuno dei tre corni di un grande trilemma e non attraverso sin-gole dimostrazioni autosufficienti
A Dimostrazione della non esistenza di ciograve che non egrave(M 767) attraverso due argomenti che partono da due distintepremesse ipotetico-concessive e corrispondono rispettivamenteagli argomenti (a) e (b) della διος 13πδειξις
B Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave (M 768ndash74) attraverso argomenti in parte assimilabili a quelli dellaσυνθετικ 13πδειξις di MXG ma senza esplicita attribuzione del-la loro paternitagrave a Melisso e Zenone si tratta del trilemma genera-to ingenerato generato e ingenerato insieme e dellrsquoantinomiauno molti senza alcun riferimento alla riflessione sul movimento
C Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave e ciograve chenon egrave insieme (M 775ndash76) attraverso un argomento che egrave formaestesa ma banalizzata dellrsquoargomento (c) della διος 13πδειξις
La maggiore attendibilitagrave della versione MXG risulta eviden-te non solo nei dettagli argomentativi ma anche nellrsquoarticolazionecomplessiva della prima tesi Sesto infatti ne ingabbia la strutturain un grande trilemma in base al quale laquose qualcosa egrave egrave ciograve che nonegrave o ciograve che egrave o ciograve che egrave e ciograve che non egrave insiemeraquo (M 766) Non sitratta verosimilmente di unrsquoaggiunta arbitraria13 ma di una forza-tura degli argomenti gorgiani entro uno schema caro allo scettico oalla sua fonte Va detto infatti a conferma dellrsquoipotesi di unrsquointer-ferenza scettica sul testo di Gorgia che il trilemma col terzo cornoche unisce due contraddittori o due contrari riproposto da Sestoanche nellrsquoargomento sulla generazione riecheggia una strategia ti-pica di Enesidemo Si confronti per esempio lrsquoenunciazione deltrilemma sulla generazione (M 768) con la trattazione derivata daEnesidemo in cui il vero egrave introdotto come sensibile o intelligibi-le o insieme sensibile e intelligibile14
336 Rober ta Io l i
13) Come opportunamente mi fa notare Walter Leszl le manipolazioni di Sesto sulle fonti comportano piuttosto omissioni di argomenti o revisioni lingui-stiche
14) Tra i numerosi esempi di trilemma cosigrave costruito si possono citareM 852 125 344 M 10209 235ndash7 (cfr anche PH 2178 378 110ndash114 M 7242questrsquoultimo col quadrilemma di origine pirroniana su cui si veda Aristocl ap EusPE 14181ndash4) Broumlker (come n 4) 435 critica lrsquoatteggiamento di Sesto da lui defi-nito travisante nellrsquoimposizione sia di trilemmi sia di quadrilemmi come nellrsquoargo-mento contro lrsquouno (M 773) Alcuni studiosi hanno tentato un parziale recuperodella versione di Sesto ma senza argomenti probanti in favore del terzo corno del
M 768 se infatti ciograve che egrave egrave certamente egrave eterno o generato o insiemeeterno e generato ma non egrave neacute eterno neacute generato neacute entrambi comemostreremo dunque ciograve che egrave non egrave15
M 840ndash41 se infatti vi egrave qualcosa di vero certamente egrave sensibile o in-telligibile o insieme sensibile e intelligibile ma non egrave neacute sensibile neacute in-telligibile neacute entrambi come saragrave stabilito dunque non vi egrave nulla divero16
Per Lloyd il trilemma potrebbe rappresentare una struttura volu-tamente introdotta dal sofista per spezzare lrsquoangustia del dilemmaeleatico che impiega due termini contrari come fossero due contraddittori esaustivi17 tuttavia i confronti col testo di Sestoricchissimo di simmetrie polilemmatiche lrsquoassenza di una talestrut tura nella corrispondente versione MXG e soprattutto nellesuperstiti orazioni di Gorgia pur non essendo in seacute elementi pro-banti ci inducono a dubitare dellrsquoautenticitagrave del trilemma Inoltrelrsquoargomento conclusivo di M 775ndash76 (laquose infatti neacute ciograve che egrave neacuteciograve che non egrave neacute entrambi sono e se oltre a questi niente egrave conce-pito niente egraveraquo) non fa altro che sviluppare lrsquoipotesi dellrsquoidentitagrave traessere e non essere presente anche in MXG 979a31ndash33 ma arti-colata da Sesto in modo prolisso cosigrave da completare lrsquoenumera-zione e la definitiva esclusione di tutte le possibilitagrave logicamenteconcepibili18 Tale esigenza risulta ancora piugrave evidente nel caso del
337Gorgia Scettico
trilemma cosigrave Levi (come n 1) 214 n 39 R Mondolfo Problemi del pensiero anti-co Bologna 1936 180 M Untersteiner I Sofisti Milano 21996 222ndash3 e n 32 Maz-zara (come n 1) 122 n 67
15) ε γρ τ ltν )στιν Lτοι 13διν στιν 5 γενητν 5 13διον =μα κα γενητνο-τε δ6 13διν στιν ο-τε γενητν ο-τε 13μφτερα Mς δεξομεν οκ ρα )στι τ ν
16) ε γρ )στι τι 13ληθς Lτοι ασθητν στιν 5 νοητν στιν 5 κα νοητνστι κα ασθητν στιν [5] ο-τε δ6 ασθητν στιν ο-τε νοητν στιν ο-τε τσυναμφτερον Mς παρασταθEσεται οκ ρα )στι τι 13ληθς
17) Si veda G E R Lloyd Polarity and Analogy Two Types of Argumenta-tion in Early Greek Thought Cambridge 1966 103ndash27 115 ss Lo studioso indivi-dua nellrsquoopposizione antitetica la struttura fondamentale della dialettica eleaticaZenone ad esempio sostiene la tesi dellrsquounitagrave sulla base delle conseguenze antiteti-che a cui la molteplicitagrave dagrave vita ma trattandosi di ipotesi tra loro contrarie (piccolo grande finito infinito) e non contraddittorie esse non sono esaustive pertanto laconfutazione della molteplicitagrave non conduce automaticamente allrsquoaffermazione del-lrsquounitagrave Lo stesso Lloyd rileva che il gusto per le antitesi polari era proprio non solodella filosofia eleatica ma della sofistica in generale (si vedano infatti come tratto ti-pico della dialettica sofistica le antitesi proposte nellrsquoEutidemo platonico)
18) Con la tendenza onnicomprensiva propria del suo argomentare Sestoparte prima dallrsquoidentitagrave di ciograve che non egrave con ciograve che egrave poi viceversa dallrsquoidentitagrave
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
dellrsquoAnonimo sia lacunoso o oscuro per via della sua concisioneNon egrave mia intenzione offrire qui un quadro dettagliato delle diffe-renze tra le due versioni ma individuare se e dove siano rintrac-ciabili nel testo di Sesto le evidenze in favore di una revisione lsquoscet-ticheggiantersquo del trattato di Gorgia o piuttosto gli interventi mi-ranti ad esaltare lrsquounicitagrave della via scettica oscurando le analogie colpensiero sofistico
1 LrsquoAnonimo pseudo-aristotelico e Sesto Empirico due distinte versioni del PTMO
La versione dellrsquoAnonimo e quella di Sesto sono verosimil-mente due fonti distinte del PTMO derivate con ogni probabilitagravedal medesimo iparchetipo3 ma indipendenti lrsquouna dallrsquoaltra nellatrasmissione del testo Sono infatti numerose le differenze lingui-stiche stilistiche e argomentative ciograve non significa tuttavia che trale due opere non esistano significativi punti di convergenza e anzitalvolta lrsquouna puograve far luce sullrsquoaltra Se Sesto avesse attinto a MXGcome fonte per la trasmissione del PTMO4 ci aspetteremmo trac-ce di tale filiazione viceversa in Sesto troviamo elementi gorgianiassenti nella versione dellrsquoAnonimo e che nel caso di una sua deri-vazione da MXG dovremmo ipotizzare introdotti in maniera con-sapevole da Sesto attraverso una contorta manipolazione e unrsquoim-probabile contaminazione di fonti
Il caso piugrave evidente egrave rappresentato a mio avviso dallrsquoargo-mento su 13διον πειρον tramandatoci in M 769ndash70 e corrispon-dente a MXG 979b22ndash26 Il testo di Sesto presenta unrsquointeressan-te analogia linguistica con un passo del Parmenide platonico (Parm137d7ndash138b6) in cui sono numerosi i riecheggiamenti del trattatodi Gorgia a dimostrare il recupero di suggestioni gorgiane da par-te di Platone un raffronto tra i due testi rivela altresigrave lrsquoindipenden-
332 Rober ta Io l i
3) Anche per Mansfeld (come n 1) 244 le due versioni deriverebbero dallostesso iparchetipo dipendente dal Πρς τ Γοργου aristotelico (cfr D L 525) PerM L Silvestre Una lettura aristotelica di Gorgia le ragioni di un silenzio SicGym38 1985 411ndash27 412 invece il Πρς τ Γοργου sarebbe opera giovanile in cui Ari-stotele avrebbe confutato non il PTMO ma i τποι della retorica gorgiana confu-tazione poi ripresa in etagrave matura in Topici e Retorica
4) Questa egrave la tesi difesa da W Broumlker Gorgias contra Parmenides Hermes86 1958 425ndash40 425 e Newiger (come n 1) 161ndash70
za di Sesto nella trasmissione dellrsquoargomento sulla generazione InGorgia come in Platone la riflessione sullrsquoessere ingenerato si svi-luppa a partire dallrsquoequivalenza melissiana tra lrsquoessere ingeneratocioegrave eterno e lrsquoessere infinito che per sua intrinseca natura nonpuograve essere contenuto in alcun luogo tale argomento che rappre-senta uno dei due corni del dilemma sulla generazione egrave usato daGorgia per dimostrare che niente egrave mentre da Platone egrave impiegatocontro lrsquoesistenza dellrsquouno La conclusione egrave esplicita nel PTMO(ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave) mentre resta implicita ma ine-quivocabile nel Parmenide in cui lrsquoammissione dellrsquoessere unitarioconduce a unrsquoinaccettabile serie di aporie
Premessa comune a Gorgia e a Platone egrave che essendo infini-to lrsquoessere (o lrsquouno) non saragrave in alcun luogo poicheacute non saragrave neacute inaltro da seacute neacute in se stesso in entrambi i casi infatti ci sarebbero dueinfiniti Nella versione MXG esattamente come in Melisso rie-cheggiato dal sofista il paradosso dellrsquoinfinito contenuto in altro daseacute conduce allrsquoaporia dei due infiniti inconciliabile prima ancorache con il presupposto dellrsquoinfinitagrave con quello dellrsquounitagrave
Mel 30B6 DK Se infatti (scil lrsquoessere) fosse infinito sarebbe uno poi-cheacute se fossero due non potrebbero piugrave essere infiniti trovando limitilrsquouno nellrsquoaltro5
MXG 979b23ndash24 (scil Lrsquoinfinito) neacute puograve essere in se stesso neacute in altroin tal caso infatti vi sarebbero due infiniti quello che egrave contenuto equello che contiene6
Come in Melisso (e implicitamente in MXG) la definizione stessadi infinito in quanto privo di confini impone la conferma del pre-supposto unitario7 cosigrave Platone pur sviluppando la propria argo-
333Gorgia Scettico
5) ε γρ ⟨πειρον⟩ εη ν εη ν ε γρ δο εη οκ $ν δναιτο πειρα εampναι13λλ( )χοι $ν περατα πρς λληλα Cfr anche 30B5 DK ε μ ν εη περανε+ πρςλλο
6) ο-τε γρ ν ατ0 ο-τ( $ν ν λλ1 εampναι δο γρ $ν ο2τως 13περω εampναιτ τε νν κα τ ν 4 Seguo in analogia con Melisso la congettura di Bonitz13περω invece del tradito 5 πλεω che risolverebbe tutta lrsquoargomentazione nei ter-mini del regressus ad infinitum zenoniano (cfr 29A24 DK) Si veda in propositoH Bonitz Zu der Schrift uumlber Xenophanes Zenon und Gorgias in AristotelischeStudien Vienne 1862 I 63ndash86
7) Cosigrave suggerisce anche Simpl in Aristot phys 1105 (13π δ6 το 13περουτ ν συνελογσατο) introducendo 30B5 DK E che questo fosse il fine di Melissoegrave confermato dalla controargomentazione di Eudemo (fr 41 Wehrli) che difendecontro Melisso unrsquoidea di infinitezza conciliabile con quella di pluralitagrave
mentazione in senso antieleatico presuppone perograve lrsquounitagrave del -lrsquoessere come premessa implicita e tacitamente operante si dice in-fatti che laquose fosse in altro da seacute sarebbe circondato come in un cer-chio da quello in cui egrave e con esso in molti casi avrebbe molti pun-ti di contattoraquo8 essendo perograve uno intero e privo di parti lrsquoesserenon puograve avere contatti in piugrave punti con altro da seacute
In Sesto invece lrsquoargomentazione da confutare egrave quella checompromette lrsquoidea stessa di infinito qualora lo si ammetta conte-nuto in altro da seacute e per ciograve stesso non piugrave infinito si sostiene chelaquoil contenente egrave infatti sempre maggiore del contenutoraquo (M 769με+ζον γ9ρ στι το μπεριεχομνου τ μπεριχον) secondo unrsquoar-gomentazione a cui lo scettico ricorre sovente nella sua opera ri-proponendo anche il medesimo linguaggio (si veda ad esempioPH 386 με+ζον γρ εampναι δε+ τ περιχον το περιεχομνου)9 Lrsquoelemento di indubbia analogia tra il Parmenide e la versione diSesto egrave rappresentato dallrsquoimpiego del participio περιχον eviden-za linguistica che non va ritenuta casuale10 Possiamo ipotizzareche tale termine fosse presente nellrsquooriginale gorgiano e omessonella versione MXG lrsquoAnonimo infatti nella sua tendenza al-lrsquoesposizione sintetica puograve aver tralasciato di trascrivere per inte-ro la dimostrazione enunciandone solo premesse e conclusioniNei dettagli perograve lrsquoargomentazione di Gorgia doveva seguire unalinea analoga a quella poi tracciata da Platone nel qual caso Sestoavrebbe come si egrave visto leggermente modificato lrsquoargomento11
334 Rober ta Io l i
8) Parm 138a3ndash5 ν λλ1 μ6ν ltν κκλ1 που $ν περιχοιτο π( κενου ν4 νεη κα πολλαχο $ν ατο =πτοιτο πολλο+ς Cfr i περατα di 30B6 DK
9) Ma altre altrove ricorre la medesima strategia argomentativa egrave il caso diM 9301 (13λλ τ μ6ν με+ζον 13π το gtττονος οκ $ν 13φαιρεθεη δε+ γρ τ 13πτινος 13φαιρομενον περιχεσθαι ν κεν1 τ0 ξ οB C 13φαρεσις ν δ6 τ0 gtττονι οπεριχεται τ με+ζον) e di M 9408 (D γρ )σχατον νενοEκασι τF διανοGπεριληπτν στιν D δ6 περιληπτν στι διανοG πεπρασται)
10) M 770 κα μν οδ( ν ατ0 περιχεται (cfr Parm 138a7ndash8 Hλλ μνατ γε ν Iαυτ0 ltν κ$ν Iαυτ0 εη περιχον οκ λλο 5 ατ) A parte questrsquounicaoccorrenza Sesto negli altri casi usa il composto μπεριχεσθαι termine tardo escarsamente attestato ma caro allo scettico che sembra impiegarlo in alternativa aπεριχεσθαι Si vedano in proposito Mansfeld (come n 1) 261ndash2 e C J ClassenLrsquoesposizione dei sofisti e della sofistica in Sesto Empirico Elenchos 13 1992 57ndash79 77
11) Anche Mansfeld (come n 1) 262 ritiene che lrsquoargomento autenticamentegorgiano possa essere stato assimilato da Platone e tramandato diversamente nelledue versioni a riprova della loro reciproca indipendenza Sul legame teoretico tra
giocando su quel binomio contenente-contenuto che egrave spesso dalui adottato nella confutazione di δξαι non condivise
2 Revisioni scettiche nella presentazione del PTMO
21 La prima tesi
Nel PTMO lrsquoenunciazione sintetica delle tre tesi a parte qual-che lieve differenza tra le due versioni cosigrave suona laquoGorgia dice cheniente egrave e se egrave egrave inconoscibile e anche se egrave ed egrave conoscibile tutta-via non si puograve mostrare ad altriraquo12 Le due versioni si differenzia-no in realtagrave giagrave a partire dalla strategia adottata nellrsquoorganizzazio-ne degli argomenti della prima tesi lrsquoAnonimo propone infatti duegrandi blocchi argomentativi
A ΠρJτος λγος ovvero διος 13πδειξις cioegrave la laquodimostra-zione propriaraquo di MXG 979a25ndash33 in cui Gorgia dimostra cheniente egrave servendosi di argomentazioni proprie Tale dimostrazioneegrave strutturata in tre argomenti distinti a partire da tre diverse pre-messe ipotetico-concessive (a) se ciograve che non egrave egrave ciograve che non egrave (b)se ciograve che non egrave egrave (c) se ciograve che non egrave e ciograve che egrave sono identici Qua-lunque delle tre premesse venga accolta Gorgia conclude che nien-te egrave o per la precisione che non egrave possibile neacute essere neacute non esse-re secondo la formulazione sintetica di MXG 979a24
B Δετερος λγος ovvero συνθετικ 13πδειξις cioegrave la laquodi-mostrazione sinteticaraquo di MXG 979b20ndash980a8 derivata dal con-fronto e dalla reciproca confutazione di tesi altrui (soprattutto Me-lisso e Zenone) in base alla quale niente egrave Essa egrave sviluppata in dueargomenti distinti precisamente lrsquoantinomia generato ingeneratoe quella uno molti con lrsquoaggiunta di una riflessione sul movimen-to che costituisce un ampliamento tematico delle due precedentiantinomie
In Sesto manca invece un esplicito riferimento sia alla tesi pro-pria di Gorgia sia alla dimostrazione derivata da tesi altrui alla con-clusione per cui niente egrave si giunge attraverso lrsquoeliminazione di
335Gorgia Scettico
Gorgia e Platone rimando a R Ioli Il silenzio di Platone e Aristotele sul Περ τομ ντος di Gorgia Dianoia 12 2007 7ndash42 spec 12ndash14
12) MXG 979a12ndash13 οκ εampνα φησιν οδν ε δ( )στιν γνωστον εampναι εδ6 κα )στι κα γνωστν 13λλ( ο δηλωτν λλοις
ognuno dei tre corni di un grande trilemma e non attraverso sin-gole dimostrazioni autosufficienti
A Dimostrazione della non esistenza di ciograve che non egrave(M 767) attraverso due argomenti che partono da due distintepremesse ipotetico-concessive e corrispondono rispettivamenteagli argomenti (a) e (b) della διος 13πδειξις
B Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave (M 768ndash74) attraverso argomenti in parte assimilabili a quelli dellaσυνθετικ 13πδειξις di MXG ma senza esplicita attribuzione del-la loro paternitagrave a Melisso e Zenone si tratta del trilemma genera-to ingenerato generato e ingenerato insieme e dellrsquoantinomiauno molti senza alcun riferimento alla riflessione sul movimento
C Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave e ciograve chenon egrave insieme (M 775ndash76) attraverso un argomento che egrave formaestesa ma banalizzata dellrsquoargomento (c) della διος 13πδειξις
La maggiore attendibilitagrave della versione MXG risulta eviden-te non solo nei dettagli argomentativi ma anche nellrsquoarticolazionecomplessiva della prima tesi Sesto infatti ne ingabbia la strutturain un grande trilemma in base al quale laquose qualcosa egrave egrave ciograve che nonegrave o ciograve che egrave o ciograve che egrave e ciograve che non egrave insiemeraquo (M 766) Non sitratta verosimilmente di unrsquoaggiunta arbitraria13 ma di una forza-tura degli argomenti gorgiani entro uno schema caro allo scettico oalla sua fonte Va detto infatti a conferma dellrsquoipotesi di unrsquointer-ferenza scettica sul testo di Gorgia che il trilemma col terzo cornoche unisce due contraddittori o due contrari riproposto da Sestoanche nellrsquoargomento sulla generazione riecheggia una strategia ti-pica di Enesidemo Si confronti per esempio lrsquoenunciazione deltrilemma sulla generazione (M 768) con la trattazione derivata daEnesidemo in cui il vero egrave introdotto come sensibile o intelligibi-le o insieme sensibile e intelligibile14
336 Rober ta Io l i
13) Come opportunamente mi fa notare Walter Leszl le manipolazioni di Sesto sulle fonti comportano piuttosto omissioni di argomenti o revisioni lingui-stiche
14) Tra i numerosi esempi di trilemma cosigrave costruito si possono citareM 852 125 344 M 10209 235ndash7 (cfr anche PH 2178 378 110ndash114 M 7242questrsquoultimo col quadrilemma di origine pirroniana su cui si veda Aristocl ap EusPE 14181ndash4) Broumlker (come n 4) 435 critica lrsquoatteggiamento di Sesto da lui defi-nito travisante nellrsquoimposizione sia di trilemmi sia di quadrilemmi come nellrsquoargo-mento contro lrsquouno (M 773) Alcuni studiosi hanno tentato un parziale recuperodella versione di Sesto ma senza argomenti probanti in favore del terzo corno del
M 768 se infatti ciograve che egrave egrave certamente egrave eterno o generato o insiemeeterno e generato ma non egrave neacute eterno neacute generato neacute entrambi comemostreremo dunque ciograve che egrave non egrave15
M 840ndash41 se infatti vi egrave qualcosa di vero certamente egrave sensibile o in-telligibile o insieme sensibile e intelligibile ma non egrave neacute sensibile neacute in-telligibile neacute entrambi come saragrave stabilito dunque non vi egrave nulla divero16
Per Lloyd il trilemma potrebbe rappresentare una struttura volu-tamente introdotta dal sofista per spezzare lrsquoangustia del dilemmaeleatico che impiega due termini contrari come fossero due contraddittori esaustivi17 tuttavia i confronti col testo di Sestoricchissimo di simmetrie polilemmatiche lrsquoassenza di una talestrut tura nella corrispondente versione MXG e soprattutto nellesuperstiti orazioni di Gorgia pur non essendo in seacute elementi pro-banti ci inducono a dubitare dellrsquoautenticitagrave del trilemma Inoltrelrsquoargomento conclusivo di M 775ndash76 (laquose infatti neacute ciograve che egrave neacuteciograve che non egrave neacute entrambi sono e se oltre a questi niente egrave conce-pito niente egraveraquo) non fa altro che sviluppare lrsquoipotesi dellrsquoidentitagrave traessere e non essere presente anche in MXG 979a31ndash33 ma arti-colata da Sesto in modo prolisso cosigrave da completare lrsquoenumera-zione e la definitiva esclusione di tutte le possibilitagrave logicamenteconcepibili18 Tale esigenza risulta ancora piugrave evidente nel caso del
337Gorgia Scettico
trilemma cosigrave Levi (come n 1) 214 n 39 R Mondolfo Problemi del pensiero anti-co Bologna 1936 180 M Untersteiner I Sofisti Milano 21996 222ndash3 e n 32 Maz-zara (come n 1) 122 n 67
15) ε γρ τ ltν )στιν Lτοι 13διν στιν 5 γενητν 5 13διον =μα κα γενητνο-τε δ6 13διν στιν ο-τε γενητν ο-τε 13μφτερα Mς δεξομεν οκ ρα )στι τ ν
16) ε γρ )στι τι 13ληθς Lτοι ασθητν στιν 5 νοητν στιν 5 κα νοητνστι κα ασθητν στιν [5] ο-τε δ6 ασθητν στιν ο-τε νοητν στιν ο-τε τσυναμφτερον Mς παρασταθEσεται οκ ρα )στι τι 13ληθς
17) Si veda G E R Lloyd Polarity and Analogy Two Types of Argumenta-tion in Early Greek Thought Cambridge 1966 103ndash27 115 ss Lo studioso indivi-dua nellrsquoopposizione antitetica la struttura fondamentale della dialettica eleaticaZenone ad esempio sostiene la tesi dellrsquounitagrave sulla base delle conseguenze antiteti-che a cui la molteplicitagrave dagrave vita ma trattandosi di ipotesi tra loro contrarie (piccolo grande finito infinito) e non contraddittorie esse non sono esaustive pertanto laconfutazione della molteplicitagrave non conduce automaticamente allrsquoaffermazione del-lrsquounitagrave Lo stesso Lloyd rileva che il gusto per le antitesi polari era proprio non solodella filosofia eleatica ma della sofistica in generale (si vedano infatti come tratto ti-pico della dialettica sofistica le antitesi proposte nellrsquoEutidemo platonico)
18) Con la tendenza onnicomprensiva propria del suo argomentare Sestoparte prima dallrsquoidentitagrave di ciograve che non egrave con ciograve che egrave poi viceversa dallrsquoidentitagrave
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
za di Sesto nella trasmissione dellrsquoargomento sulla generazione InGorgia come in Platone la riflessione sullrsquoessere ingenerato si svi-luppa a partire dallrsquoequivalenza melissiana tra lrsquoessere ingeneratocioegrave eterno e lrsquoessere infinito che per sua intrinseca natura nonpuograve essere contenuto in alcun luogo tale argomento che rappre-senta uno dei due corni del dilemma sulla generazione egrave usato daGorgia per dimostrare che niente egrave mentre da Platone egrave impiegatocontro lrsquoesistenza dellrsquouno La conclusione egrave esplicita nel PTMO(ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave) mentre resta implicita ma ine-quivocabile nel Parmenide in cui lrsquoammissione dellrsquoessere unitarioconduce a unrsquoinaccettabile serie di aporie
Premessa comune a Gorgia e a Platone egrave che essendo infini-to lrsquoessere (o lrsquouno) non saragrave in alcun luogo poicheacute non saragrave neacute inaltro da seacute neacute in se stesso in entrambi i casi infatti ci sarebbero dueinfiniti Nella versione MXG esattamente come in Melisso rie-cheggiato dal sofista il paradosso dellrsquoinfinito contenuto in altro daseacute conduce allrsquoaporia dei due infiniti inconciliabile prima ancorache con il presupposto dellrsquoinfinitagrave con quello dellrsquounitagrave
Mel 30B6 DK Se infatti (scil lrsquoessere) fosse infinito sarebbe uno poi-cheacute se fossero due non potrebbero piugrave essere infiniti trovando limitilrsquouno nellrsquoaltro5
MXG 979b23ndash24 (scil Lrsquoinfinito) neacute puograve essere in se stesso neacute in altroin tal caso infatti vi sarebbero due infiniti quello che egrave contenuto equello che contiene6
Come in Melisso (e implicitamente in MXG) la definizione stessadi infinito in quanto privo di confini impone la conferma del pre-supposto unitario7 cosigrave Platone pur sviluppando la propria argo-
333Gorgia Scettico
5) ε γρ ⟨πειρον⟩ εη ν εη ν ε γρ δο εη οκ $ν δναιτο πειρα εampναι13λλ( )χοι $ν περατα πρς λληλα Cfr anche 30B5 DK ε μ ν εη περανε+ πρςλλο
6) ο-τε γρ ν ατ0 ο-τ( $ν ν λλ1 εampναι δο γρ $ν ο2τως 13περω εampναιτ τε νν κα τ ν 4 Seguo in analogia con Melisso la congettura di Bonitz13περω invece del tradito 5 πλεω che risolverebbe tutta lrsquoargomentazione nei ter-mini del regressus ad infinitum zenoniano (cfr 29A24 DK) Si veda in propositoH Bonitz Zu der Schrift uumlber Xenophanes Zenon und Gorgias in AristotelischeStudien Vienne 1862 I 63ndash86
7) Cosigrave suggerisce anche Simpl in Aristot phys 1105 (13π δ6 το 13περουτ ν συνελογσατο) introducendo 30B5 DK E che questo fosse il fine di Melissoegrave confermato dalla controargomentazione di Eudemo (fr 41 Wehrli) che difendecontro Melisso unrsquoidea di infinitezza conciliabile con quella di pluralitagrave
mentazione in senso antieleatico presuppone perograve lrsquounitagrave del -lrsquoessere come premessa implicita e tacitamente operante si dice in-fatti che laquose fosse in altro da seacute sarebbe circondato come in un cer-chio da quello in cui egrave e con esso in molti casi avrebbe molti pun-ti di contattoraquo8 essendo perograve uno intero e privo di parti lrsquoesserenon puograve avere contatti in piugrave punti con altro da seacute
In Sesto invece lrsquoargomentazione da confutare egrave quella checompromette lrsquoidea stessa di infinito qualora lo si ammetta conte-nuto in altro da seacute e per ciograve stesso non piugrave infinito si sostiene chelaquoil contenente egrave infatti sempre maggiore del contenutoraquo (M 769με+ζον γ9ρ στι το μπεριεχομνου τ μπεριχον) secondo unrsquoar-gomentazione a cui lo scettico ricorre sovente nella sua opera ri-proponendo anche il medesimo linguaggio (si veda ad esempioPH 386 με+ζον γρ εampναι δε+ τ περιχον το περιεχομνου)9 Lrsquoelemento di indubbia analogia tra il Parmenide e la versione diSesto egrave rappresentato dallrsquoimpiego del participio περιχον eviden-za linguistica che non va ritenuta casuale10 Possiamo ipotizzareche tale termine fosse presente nellrsquooriginale gorgiano e omessonella versione MXG lrsquoAnonimo infatti nella sua tendenza al-lrsquoesposizione sintetica puograve aver tralasciato di trascrivere per inte-ro la dimostrazione enunciandone solo premesse e conclusioniNei dettagli perograve lrsquoargomentazione di Gorgia doveva seguire unalinea analoga a quella poi tracciata da Platone nel qual caso Sestoavrebbe come si egrave visto leggermente modificato lrsquoargomento11
334 Rober ta Io l i
8) Parm 138a3ndash5 ν λλ1 μ6ν ltν κκλ1 που $ν περιχοιτο π( κενου ν4 νεη κα πολλαχο $ν ατο =πτοιτο πολλο+ς Cfr i περατα di 30B6 DK
9) Ma altre altrove ricorre la medesima strategia argomentativa egrave il caso diM 9301 (13λλ τ μ6ν με+ζον 13π το gtττονος οκ $ν 13φαιρεθεη δε+ γρ τ 13πτινος 13φαιρομενον περιχεσθαι ν κεν1 τ0 ξ οB C 13φαρεσις ν δ6 τ0 gtττονι οπεριχεται τ με+ζον) e di M 9408 (D γρ )σχατον νενοEκασι τF διανοGπεριληπτν στιν D δ6 περιληπτν στι διανοG πεπρασται)
10) M 770 κα μν οδ( ν ατ0 περιχεται (cfr Parm 138a7ndash8 Hλλ μνατ γε ν Iαυτ0 ltν κ$ν Iαυτ0 εη περιχον οκ λλο 5 ατ) A parte questrsquounicaoccorrenza Sesto negli altri casi usa il composto μπεριχεσθαι termine tardo escarsamente attestato ma caro allo scettico che sembra impiegarlo in alternativa aπεριχεσθαι Si vedano in proposito Mansfeld (come n 1) 261ndash2 e C J ClassenLrsquoesposizione dei sofisti e della sofistica in Sesto Empirico Elenchos 13 1992 57ndash79 77
11) Anche Mansfeld (come n 1) 262 ritiene che lrsquoargomento autenticamentegorgiano possa essere stato assimilato da Platone e tramandato diversamente nelledue versioni a riprova della loro reciproca indipendenza Sul legame teoretico tra
giocando su quel binomio contenente-contenuto che egrave spesso dalui adottato nella confutazione di δξαι non condivise
2 Revisioni scettiche nella presentazione del PTMO
21 La prima tesi
Nel PTMO lrsquoenunciazione sintetica delle tre tesi a parte qual-che lieve differenza tra le due versioni cosigrave suona laquoGorgia dice cheniente egrave e se egrave egrave inconoscibile e anche se egrave ed egrave conoscibile tutta-via non si puograve mostrare ad altriraquo12 Le due versioni si differenzia-no in realtagrave giagrave a partire dalla strategia adottata nellrsquoorganizzazio-ne degli argomenti della prima tesi lrsquoAnonimo propone infatti duegrandi blocchi argomentativi
A ΠρJτος λγος ovvero διος 13πδειξις cioegrave la laquodimostra-zione propriaraquo di MXG 979a25ndash33 in cui Gorgia dimostra cheniente egrave servendosi di argomentazioni proprie Tale dimostrazioneegrave strutturata in tre argomenti distinti a partire da tre diverse pre-messe ipotetico-concessive (a) se ciograve che non egrave egrave ciograve che non egrave (b)se ciograve che non egrave egrave (c) se ciograve che non egrave e ciograve che egrave sono identici Qua-lunque delle tre premesse venga accolta Gorgia conclude che nien-te egrave o per la precisione che non egrave possibile neacute essere neacute non esse-re secondo la formulazione sintetica di MXG 979a24
B Δετερος λγος ovvero συνθετικ 13πδειξις cioegrave la laquodi-mostrazione sinteticaraquo di MXG 979b20ndash980a8 derivata dal con-fronto e dalla reciproca confutazione di tesi altrui (soprattutto Me-lisso e Zenone) in base alla quale niente egrave Essa egrave sviluppata in dueargomenti distinti precisamente lrsquoantinomia generato ingeneratoe quella uno molti con lrsquoaggiunta di una riflessione sul movimen-to che costituisce un ampliamento tematico delle due precedentiantinomie
In Sesto manca invece un esplicito riferimento sia alla tesi pro-pria di Gorgia sia alla dimostrazione derivata da tesi altrui alla con-clusione per cui niente egrave si giunge attraverso lrsquoeliminazione di
335Gorgia Scettico
Gorgia e Platone rimando a R Ioli Il silenzio di Platone e Aristotele sul Περ τομ ντος di Gorgia Dianoia 12 2007 7ndash42 spec 12ndash14
12) MXG 979a12ndash13 οκ εampνα φησιν οδν ε δ( )στιν γνωστον εampναι εδ6 κα )στι κα γνωστν 13λλ( ο δηλωτν λλοις
ognuno dei tre corni di un grande trilemma e non attraverso sin-gole dimostrazioni autosufficienti
A Dimostrazione della non esistenza di ciograve che non egrave(M 767) attraverso due argomenti che partono da due distintepremesse ipotetico-concessive e corrispondono rispettivamenteagli argomenti (a) e (b) della διος 13πδειξις
B Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave (M 768ndash74) attraverso argomenti in parte assimilabili a quelli dellaσυνθετικ 13πδειξις di MXG ma senza esplicita attribuzione del-la loro paternitagrave a Melisso e Zenone si tratta del trilemma genera-to ingenerato generato e ingenerato insieme e dellrsquoantinomiauno molti senza alcun riferimento alla riflessione sul movimento
C Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave e ciograve chenon egrave insieme (M 775ndash76) attraverso un argomento che egrave formaestesa ma banalizzata dellrsquoargomento (c) della διος 13πδειξις
La maggiore attendibilitagrave della versione MXG risulta eviden-te non solo nei dettagli argomentativi ma anche nellrsquoarticolazionecomplessiva della prima tesi Sesto infatti ne ingabbia la strutturain un grande trilemma in base al quale laquose qualcosa egrave egrave ciograve che nonegrave o ciograve che egrave o ciograve che egrave e ciograve che non egrave insiemeraquo (M 766) Non sitratta verosimilmente di unrsquoaggiunta arbitraria13 ma di una forza-tura degli argomenti gorgiani entro uno schema caro allo scettico oalla sua fonte Va detto infatti a conferma dellrsquoipotesi di unrsquointer-ferenza scettica sul testo di Gorgia che il trilemma col terzo cornoche unisce due contraddittori o due contrari riproposto da Sestoanche nellrsquoargomento sulla generazione riecheggia una strategia ti-pica di Enesidemo Si confronti per esempio lrsquoenunciazione deltrilemma sulla generazione (M 768) con la trattazione derivata daEnesidemo in cui il vero egrave introdotto come sensibile o intelligibi-le o insieme sensibile e intelligibile14
336 Rober ta Io l i
13) Come opportunamente mi fa notare Walter Leszl le manipolazioni di Sesto sulle fonti comportano piuttosto omissioni di argomenti o revisioni lingui-stiche
14) Tra i numerosi esempi di trilemma cosigrave costruito si possono citareM 852 125 344 M 10209 235ndash7 (cfr anche PH 2178 378 110ndash114 M 7242questrsquoultimo col quadrilemma di origine pirroniana su cui si veda Aristocl ap EusPE 14181ndash4) Broumlker (come n 4) 435 critica lrsquoatteggiamento di Sesto da lui defi-nito travisante nellrsquoimposizione sia di trilemmi sia di quadrilemmi come nellrsquoargo-mento contro lrsquouno (M 773) Alcuni studiosi hanno tentato un parziale recuperodella versione di Sesto ma senza argomenti probanti in favore del terzo corno del
M 768 se infatti ciograve che egrave egrave certamente egrave eterno o generato o insiemeeterno e generato ma non egrave neacute eterno neacute generato neacute entrambi comemostreremo dunque ciograve che egrave non egrave15
M 840ndash41 se infatti vi egrave qualcosa di vero certamente egrave sensibile o in-telligibile o insieme sensibile e intelligibile ma non egrave neacute sensibile neacute in-telligibile neacute entrambi come saragrave stabilito dunque non vi egrave nulla divero16
Per Lloyd il trilemma potrebbe rappresentare una struttura volu-tamente introdotta dal sofista per spezzare lrsquoangustia del dilemmaeleatico che impiega due termini contrari come fossero due contraddittori esaustivi17 tuttavia i confronti col testo di Sestoricchissimo di simmetrie polilemmatiche lrsquoassenza di una talestrut tura nella corrispondente versione MXG e soprattutto nellesuperstiti orazioni di Gorgia pur non essendo in seacute elementi pro-banti ci inducono a dubitare dellrsquoautenticitagrave del trilemma Inoltrelrsquoargomento conclusivo di M 775ndash76 (laquose infatti neacute ciograve che egrave neacuteciograve che non egrave neacute entrambi sono e se oltre a questi niente egrave conce-pito niente egraveraquo) non fa altro che sviluppare lrsquoipotesi dellrsquoidentitagrave traessere e non essere presente anche in MXG 979a31ndash33 ma arti-colata da Sesto in modo prolisso cosigrave da completare lrsquoenumera-zione e la definitiva esclusione di tutte le possibilitagrave logicamenteconcepibili18 Tale esigenza risulta ancora piugrave evidente nel caso del
337Gorgia Scettico
trilemma cosigrave Levi (come n 1) 214 n 39 R Mondolfo Problemi del pensiero anti-co Bologna 1936 180 M Untersteiner I Sofisti Milano 21996 222ndash3 e n 32 Maz-zara (come n 1) 122 n 67
15) ε γρ τ ltν )στιν Lτοι 13διν στιν 5 γενητν 5 13διον =μα κα γενητνο-τε δ6 13διν στιν ο-τε γενητν ο-τε 13μφτερα Mς δεξομεν οκ ρα )στι τ ν
16) ε γρ )στι τι 13ληθς Lτοι ασθητν στιν 5 νοητν στιν 5 κα νοητνστι κα ασθητν στιν [5] ο-τε δ6 ασθητν στιν ο-τε νοητν στιν ο-τε τσυναμφτερον Mς παρασταθEσεται οκ ρα )στι τι 13ληθς
17) Si veda G E R Lloyd Polarity and Analogy Two Types of Argumenta-tion in Early Greek Thought Cambridge 1966 103ndash27 115 ss Lo studioso indivi-dua nellrsquoopposizione antitetica la struttura fondamentale della dialettica eleaticaZenone ad esempio sostiene la tesi dellrsquounitagrave sulla base delle conseguenze antiteti-che a cui la molteplicitagrave dagrave vita ma trattandosi di ipotesi tra loro contrarie (piccolo grande finito infinito) e non contraddittorie esse non sono esaustive pertanto laconfutazione della molteplicitagrave non conduce automaticamente allrsquoaffermazione del-lrsquounitagrave Lo stesso Lloyd rileva che il gusto per le antitesi polari era proprio non solodella filosofia eleatica ma della sofistica in generale (si vedano infatti come tratto ti-pico della dialettica sofistica le antitesi proposte nellrsquoEutidemo platonico)
18) Con la tendenza onnicomprensiva propria del suo argomentare Sestoparte prima dallrsquoidentitagrave di ciograve che non egrave con ciograve che egrave poi viceversa dallrsquoidentitagrave
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
mentazione in senso antieleatico presuppone perograve lrsquounitagrave del -lrsquoessere come premessa implicita e tacitamente operante si dice in-fatti che laquose fosse in altro da seacute sarebbe circondato come in un cer-chio da quello in cui egrave e con esso in molti casi avrebbe molti pun-ti di contattoraquo8 essendo perograve uno intero e privo di parti lrsquoesserenon puograve avere contatti in piugrave punti con altro da seacute
In Sesto invece lrsquoargomentazione da confutare egrave quella checompromette lrsquoidea stessa di infinito qualora lo si ammetta conte-nuto in altro da seacute e per ciograve stesso non piugrave infinito si sostiene chelaquoil contenente egrave infatti sempre maggiore del contenutoraquo (M 769με+ζον γ9ρ στι το μπεριεχομνου τ μπεριχον) secondo unrsquoar-gomentazione a cui lo scettico ricorre sovente nella sua opera ri-proponendo anche il medesimo linguaggio (si veda ad esempioPH 386 με+ζον γρ εampναι δε+ τ περιχον το περιεχομνου)9 Lrsquoelemento di indubbia analogia tra il Parmenide e la versione diSesto egrave rappresentato dallrsquoimpiego del participio περιχον eviden-za linguistica che non va ritenuta casuale10 Possiamo ipotizzareche tale termine fosse presente nellrsquooriginale gorgiano e omessonella versione MXG lrsquoAnonimo infatti nella sua tendenza al-lrsquoesposizione sintetica puograve aver tralasciato di trascrivere per inte-ro la dimostrazione enunciandone solo premesse e conclusioniNei dettagli perograve lrsquoargomentazione di Gorgia doveva seguire unalinea analoga a quella poi tracciata da Platone nel qual caso Sestoavrebbe come si egrave visto leggermente modificato lrsquoargomento11
334 Rober ta Io l i
8) Parm 138a3ndash5 ν λλ1 μ6ν ltν κκλ1 που $ν περιχοιτο π( κενου ν4 νεη κα πολλαχο $ν ατο =πτοιτο πολλο+ς Cfr i περατα di 30B6 DK
9) Ma altre altrove ricorre la medesima strategia argomentativa egrave il caso diM 9301 (13λλ τ μ6ν με+ζον 13π το gtττονος οκ $ν 13φαιρεθεη δε+ γρ τ 13πτινος 13φαιρομενον περιχεσθαι ν κεν1 τ0 ξ οB C 13φαρεσις ν δ6 τ0 gtττονι οπεριχεται τ με+ζον) e di M 9408 (D γρ )σχατον νενοEκασι τF διανοGπεριληπτν στιν D δ6 περιληπτν στι διανοG πεπρασται)
10) M 770 κα μν οδ( ν ατ0 περιχεται (cfr Parm 138a7ndash8 Hλλ μνατ γε ν Iαυτ0 ltν κ$ν Iαυτ0 εη περιχον οκ λλο 5 ατ) A parte questrsquounicaoccorrenza Sesto negli altri casi usa il composto μπεριχεσθαι termine tardo escarsamente attestato ma caro allo scettico che sembra impiegarlo in alternativa aπεριχεσθαι Si vedano in proposito Mansfeld (come n 1) 261ndash2 e C J ClassenLrsquoesposizione dei sofisti e della sofistica in Sesto Empirico Elenchos 13 1992 57ndash79 77
11) Anche Mansfeld (come n 1) 262 ritiene che lrsquoargomento autenticamentegorgiano possa essere stato assimilato da Platone e tramandato diversamente nelledue versioni a riprova della loro reciproca indipendenza Sul legame teoretico tra
giocando su quel binomio contenente-contenuto che egrave spesso dalui adottato nella confutazione di δξαι non condivise
2 Revisioni scettiche nella presentazione del PTMO
21 La prima tesi
Nel PTMO lrsquoenunciazione sintetica delle tre tesi a parte qual-che lieve differenza tra le due versioni cosigrave suona laquoGorgia dice cheniente egrave e se egrave egrave inconoscibile e anche se egrave ed egrave conoscibile tutta-via non si puograve mostrare ad altriraquo12 Le due versioni si differenzia-no in realtagrave giagrave a partire dalla strategia adottata nellrsquoorganizzazio-ne degli argomenti della prima tesi lrsquoAnonimo propone infatti duegrandi blocchi argomentativi
A ΠρJτος λγος ovvero διος 13πδειξις cioegrave la laquodimostra-zione propriaraquo di MXG 979a25ndash33 in cui Gorgia dimostra cheniente egrave servendosi di argomentazioni proprie Tale dimostrazioneegrave strutturata in tre argomenti distinti a partire da tre diverse pre-messe ipotetico-concessive (a) se ciograve che non egrave egrave ciograve che non egrave (b)se ciograve che non egrave egrave (c) se ciograve che non egrave e ciograve che egrave sono identici Qua-lunque delle tre premesse venga accolta Gorgia conclude che nien-te egrave o per la precisione che non egrave possibile neacute essere neacute non esse-re secondo la formulazione sintetica di MXG 979a24
B Δετερος λγος ovvero συνθετικ 13πδειξις cioegrave la laquodi-mostrazione sinteticaraquo di MXG 979b20ndash980a8 derivata dal con-fronto e dalla reciproca confutazione di tesi altrui (soprattutto Me-lisso e Zenone) in base alla quale niente egrave Essa egrave sviluppata in dueargomenti distinti precisamente lrsquoantinomia generato ingeneratoe quella uno molti con lrsquoaggiunta di una riflessione sul movimen-to che costituisce un ampliamento tematico delle due precedentiantinomie
In Sesto manca invece un esplicito riferimento sia alla tesi pro-pria di Gorgia sia alla dimostrazione derivata da tesi altrui alla con-clusione per cui niente egrave si giunge attraverso lrsquoeliminazione di
335Gorgia Scettico
Gorgia e Platone rimando a R Ioli Il silenzio di Platone e Aristotele sul Περ τομ ντος di Gorgia Dianoia 12 2007 7ndash42 spec 12ndash14
12) MXG 979a12ndash13 οκ εampνα φησιν οδν ε δ( )στιν γνωστον εampναι εδ6 κα )στι κα γνωστν 13λλ( ο δηλωτν λλοις
ognuno dei tre corni di un grande trilemma e non attraverso sin-gole dimostrazioni autosufficienti
A Dimostrazione della non esistenza di ciograve che non egrave(M 767) attraverso due argomenti che partono da due distintepremesse ipotetico-concessive e corrispondono rispettivamenteagli argomenti (a) e (b) della διος 13πδειξις
B Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave (M 768ndash74) attraverso argomenti in parte assimilabili a quelli dellaσυνθετικ 13πδειξις di MXG ma senza esplicita attribuzione del-la loro paternitagrave a Melisso e Zenone si tratta del trilemma genera-to ingenerato generato e ingenerato insieme e dellrsquoantinomiauno molti senza alcun riferimento alla riflessione sul movimento
C Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave e ciograve chenon egrave insieme (M 775ndash76) attraverso un argomento che egrave formaestesa ma banalizzata dellrsquoargomento (c) della διος 13πδειξις
La maggiore attendibilitagrave della versione MXG risulta eviden-te non solo nei dettagli argomentativi ma anche nellrsquoarticolazionecomplessiva della prima tesi Sesto infatti ne ingabbia la strutturain un grande trilemma in base al quale laquose qualcosa egrave egrave ciograve che nonegrave o ciograve che egrave o ciograve che egrave e ciograve che non egrave insiemeraquo (M 766) Non sitratta verosimilmente di unrsquoaggiunta arbitraria13 ma di una forza-tura degli argomenti gorgiani entro uno schema caro allo scettico oalla sua fonte Va detto infatti a conferma dellrsquoipotesi di unrsquointer-ferenza scettica sul testo di Gorgia che il trilemma col terzo cornoche unisce due contraddittori o due contrari riproposto da Sestoanche nellrsquoargomento sulla generazione riecheggia una strategia ti-pica di Enesidemo Si confronti per esempio lrsquoenunciazione deltrilemma sulla generazione (M 768) con la trattazione derivata daEnesidemo in cui il vero egrave introdotto come sensibile o intelligibi-le o insieme sensibile e intelligibile14
336 Rober ta Io l i
13) Come opportunamente mi fa notare Walter Leszl le manipolazioni di Sesto sulle fonti comportano piuttosto omissioni di argomenti o revisioni lingui-stiche
14) Tra i numerosi esempi di trilemma cosigrave costruito si possono citareM 852 125 344 M 10209 235ndash7 (cfr anche PH 2178 378 110ndash114 M 7242questrsquoultimo col quadrilemma di origine pirroniana su cui si veda Aristocl ap EusPE 14181ndash4) Broumlker (come n 4) 435 critica lrsquoatteggiamento di Sesto da lui defi-nito travisante nellrsquoimposizione sia di trilemmi sia di quadrilemmi come nellrsquoargo-mento contro lrsquouno (M 773) Alcuni studiosi hanno tentato un parziale recuperodella versione di Sesto ma senza argomenti probanti in favore del terzo corno del
M 768 se infatti ciograve che egrave egrave certamente egrave eterno o generato o insiemeeterno e generato ma non egrave neacute eterno neacute generato neacute entrambi comemostreremo dunque ciograve che egrave non egrave15
M 840ndash41 se infatti vi egrave qualcosa di vero certamente egrave sensibile o in-telligibile o insieme sensibile e intelligibile ma non egrave neacute sensibile neacute in-telligibile neacute entrambi come saragrave stabilito dunque non vi egrave nulla divero16
Per Lloyd il trilemma potrebbe rappresentare una struttura volu-tamente introdotta dal sofista per spezzare lrsquoangustia del dilemmaeleatico che impiega due termini contrari come fossero due contraddittori esaustivi17 tuttavia i confronti col testo di Sestoricchissimo di simmetrie polilemmatiche lrsquoassenza di una talestrut tura nella corrispondente versione MXG e soprattutto nellesuperstiti orazioni di Gorgia pur non essendo in seacute elementi pro-banti ci inducono a dubitare dellrsquoautenticitagrave del trilemma Inoltrelrsquoargomento conclusivo di M 775ndash76 (laquose infatti neacute ciograve che egrave neacuteciograve che non egrave neacute entrambi sono e se oltre a questi niente egrave conce-pito niente egraveraquo) non fa altro che sviluppare lrsquoipotesi dellrsquoidentitagrave traessere e non essere presente anche in MXG 979a31ndash33 ma arti-colata da Sesto in modo prolisso cosigrave da completare lrsquoenumera-zione e la definitiva esclusione di tutte le possibilitagrave logicamenteconcepibili18 Tale esigenza risulta ancora piugrave evidente nel caso del
337Gorgia Scettico
trilemma cosigrave Levi (come n 1) 214 n 39 R Mondolfo Problemi del pensiero anti-co Bologna 1936 180 M Untersteiner I Sofisti Milano 21996 222ndash3 e n 32 Maz-zara (come n 1) 122 n 67
15) ε γρ τ ltν )στιν Lτοι 13διν στιν 5 γενητν 5 13διον =μα κα γενητνο-τε δ6 13διν στιν ο-τε γενητν ο-τε 13μφτερα Mς δεξομεν οκ ρα )στι τ ν
16) ε γρ )στι τι 13ληθς Lτοι ασθητν στιν 5 νοητν στιν 5 κα νοητνστι κα ασθητν στιν [5] ο-τε δ6 ασθητν στιν ο-τε νοητν στιν ο-τε τσυναμφτερον Mς παρασταθEσεται οκ ρα )στι τι 13ληθς
17) Si veda G E R Lloyd Polarity and Analogy Two Types of Argumenta-tion in Early Greek Thought Cambridge 1966 103ndash27 115 ss Lo studioso indivi-dua nellrsquoopposizione antitetica la struttura fondamentale della dialettica eleaticaZenone ad esempio sostiene la tesi dellrsquounitagrave sulla base delle conseguenze antiteti-che a cui la molteplicitagrave dagrave vita ma trattandosi di ipotesi tra loro contrarie (piccolo grande finito infinito) e non contraddittorie esse non sono esaustive pertanto laconfutazione della molteplicitagrave non conduce automaticamente allrsquoaffermazione del-lrsquounitagrave Lo stesso Lloyd rileva che il gusto per le antitesi polari era proprio non solodella filosofia eleatica ma della sofistica in generale (si vedano infatti come tratto ti-pico della dialettica sofistica le antitesi proposte nellrsquoEutidemo platonico)
18) Con la tendenza onnicomprensiva propria del suo argomentare Sestoparte prima dallrsquoidentitagrave di ciograve che non egrave con ciograve che egrave poi viceversa dallrsquoidentitagrave
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
giocando su quel binomio contenente-contenuto che egrave spesso dalui adottato nella confutazione di δξαι non condivise
2 Revisioni scettiche nella presentazione del PTMO
21 La prima tesi
Nel PTMO lrsquoenunciazione sintetica delle tre tesi a parte qual-che lieve differenza tra le due versioni cosigrave suona laquoGorgia dice cheniente egrave e se egrave egrave inconoscibile e anche se egrave ed egrave conoscibile tutta-via non si puograve mostrare ad altriraquo12 Le due versioni si differenzia-no in realtagrave giagrave a partire dalla strategia adottata nellrsquoorganizzazio-ne degli argomenti della prima tesi lrsquoAnonimo propone infatti duegrandi blocchi argomentativi
A ΠρJτος λγος ovvero διος 13πδειξις cioegrave la laquodimostra-zione propriaraquo di MXG 979a25ndash33 in cui Gorgia dimostra cheniente egrave servendosi di argomentazioni proprie Tale dimostrazioneegrave strutturata in tre argomenti distinti a partire da tre diverse pre-messe ipotetico-concessive (a) se ciograve che non egrave egrave ciograve che non egrave (b)se ciograve che non egrave egrave (c) se ciograve che non egrave e ciograve che egrave sono identici Qua-lunque delle tre premesse venga accolta Gorgia conclude che nien-te egrave o per la precisione che non egrave possibile neacute essere neacute non esse-re secondo la formulazione sintetica di MXG 979a24
B Δετερος λγος ovvero συνθετικ 13πδειξις cioegrave la laquodi-mostrazione sinteticaraquo di MXG 979b20ndash980a8 derivata dal con-fronto e dalla reciproca confutazione di tesi altrui (soprattutto Me-lisso e Zenone) in base alla quale niente egrave Essa egrave sviluppata in dueargomenti distinti precisamente lrsquoantinomia generato ingeneratoe quella uno molti con lrsquoaggiunta di una riflessione sul movimen-to che costituisce un ampliamento tematico delle due precedentiantinomie
In Sesto manca invece un esplicito riferimento sia alla tesi pro-pria di Gorgia sia alla dimostrazione derivata da tesi altrui alla con-clusione per cui niente egrave si giunge attraverso lrsquoeliminazione di
335Gorgia Scettico
Gorgia e Platone rimando a R Ioli Il silenzio di Platone e Aristotele sul Περ τομ ντος di Gorgia Dianoia 12 2007 7ndash42 spec 12ndash14
12) MXG 979a12ndash13 οκ εampνα φησιν οδν ε δ( )στιν γνωστον εampναι εδ6 κα )στι κα γνωστν 13λλ( ο δηλωτν λλοις
ognuno dei tre corni di un grande trilemma e non attraverso sin-gole dimostrazioni autosufficienti
A Dimostrazione della non esistenza di ciograve che non egrave(M 767) attraverso due argomenti che partono da due distintepremesse ipotetico-concessive e corrispondono rispettivamenteagli argomenti (a) e (b) della διος 13πδειξις
B Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave (M 768ndash74) attraverso argomenti in parte assimilabili a quelli dellaσυνθετικ 13πδειξις di MXG ma senza esplicita attribuzione del-la loro paternitagrave a Melisso e Zenone si tratta del trilemma genera-to ingenerato generato e ingenerato insieme e dellrsquoantinomiauno molti senza alcun riferimento alla riflessione sul movimento
C Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave e ciograve chenon egrave insieme (M 775ndash76) attraverso un argomento che egrave formaestesa ma banalizzata dellrsquoargomento (c) della διος 13πδειξις
La maggiore attendibilitagrave della versione MXG risulta eviden-te non solo nei dettagli argomentativi ma anche nellrsquoarticolazionecomplessiva della prima tesi Sesto infatti ne ingabbia la strutturain un grande trilemma in base al quale laquose qualcosa egrave egrave ciograve che nonegrave o ciograve che egrave o ciograve che egrave e ciograve che non egrave insiemeraquo (M 766) Non sitratta verosimilmente di unrsquoaggiunta arbitraria13 ma di una forza-tura degli argomenti gorgiani entro uno schema caro allo scettico oalla sua fonte Va detto infatti a conferma dellrsquoipotesi di unrsquointer-ferenza scettica sul testo di Gorgia che il trilemma col terzo cornoche unisce due contraddittori o due contrari riproposto da Sestoanche nellrsquoargomento sulla generazione riecheggia una strategia ti-pica di Enesidemo Si confronti per esempio lrsquoenunciazione deltrilemma sulla generazione (M 768) con la trattazione derivata daEnesidemo in cui il vero egrave introdotto come sensibile o intelligibi-le o insieme sensibile e intelligibile14
336 Rober ta Io l i
13) Come opportunamente mi fa notare Walter Leszl le manipolazioni di Sesto sulle fonti comportano piuttosto omissioni di argomenti o revisioni lingui-stiche
14) Tra i numerosi esempi di trilemma cosigrave costruito si possono citareM 852 125 344 M 10209 235ndash7 (cfr anche PH 2178 378 110ndash114 M 7242questrsquoultimo col quadrilemma di origine pirroniana su cui si veda Aristocl ap EusPE 14181ndash4) Broumlker (come n 4) 435 critica lrsquoatteggiamento di Sesto da lui defi-nito travisante nellrsquoimposizione sia di trilemmi sia di quadrilemmi come nellrsquoargo-mento contro lrsquouno (M 773) Alcuni studiosi hanno tentato un parziale recuperodella versione di Sesto ma senza argomenti probanti in favore del terzo corno del
M 768 se infatti ciograve che egrave egrave certamente egrave eterno o generato o insiemeeterno e generato ma non egrave neacute eterno neacute generato neacute entrambi comemostreremo dunque ciograve che egrave non egrave15
M 840ndash41 se infatti vi egrave qualcosa di vero certamente egrave sensibile o in-telligibile o insieme sensibile e intelligibile ma non egrave neacute sensibile neacute in-telligibile neacute entrambi come saragrave stabilito dunque non vi egrave nulla divero16
Per Lloyd il trilemma potrebbe rappresentare una struttura volu-tamente introdotta dal sofista per spezzare lrsquoangustia del dilemmaeleatico che impiega due termini contrari come fossero due contraddittori esaustivi17 tuttavia i confronti col testo di Sestoricchissimo di simmetrie polilemmatiche lrsquoassenza di una talestrut tura nella corrispondente versione MXG e soprattutto nellesuperstiti orazioni di Gorgia pur non essendo in seacute elementi pro-banti ci inducono a dubitare dellrsquoautenticitagrave del trilemma Inoltrelrsquoargomento conclusivo di M 775ndash76 (laquose infatti neacute ciograve che egrave neacuteciograve che non egrave neacute entrambi sono e se oltre a questi niente egrave conce-pito niente egraveraquo) non fa altro che sviluppare lrsquoipotesi dellrsquoidentitagrave traessere e non essere presente anche in MXG 979a31ndash33 ma arti-colata da Sesto in modo prolisso cosigrave da completare lrsquoenumera-zione e la definitiva esclusione di tutte le possibilitagrave logicamenteconcepibili18 Tale esigenza risulta ancora piugrave evidente nel caso del
337Gorgia Scettico
trilemma cosigrave Levi (come n 1) 214 n 39 R Mondolfo Problemi del pensiero anti-co Bologna 1936 180 M Untersteiner I Sofisti Milano 21996 222ndash3 e n 32 Maz-zara (come n 1) 122 n 67
15) ε γρ τ ltν )στιν Lτοι 13διν στιν 5 γενητν 5 13διον =μα κα γενητνο-τε δ6 13διν στιν ο-τε γενητν ο-τε 13μφτερα Mς δεξομεν οκ ρα )στι τ ν
16) ε γρ )στι τι 13ληθς Lτοι ασθητν στιν 5 νοητν στιν 5 κα νοητνστι κα ασθητν στιν [5] ο-τε δ6 ασθητν στιν ο-τε νοητν στιν ο-τε τσυναμφτερον Mς παρασταθEσεται οκ ρα )στι τι 13ληθς
17) Si veda G E R Lloyd Polarity and Analogy Two Types of Argumenta-tion in Early Greek Thought Cambridge 1966 103ndash27 115 ss Lo studioso indivi-dua nellrsquoopposizione antitetica la struttura fondamentale della dialettica eleaticaZenone ad esempio sostiene la tesi dellrsquounitagrave sulla base delle conseguenze antiteti-che a cui la molteplicitagrave dagrave vita ma trattandosi di ipotesi tra loro contrarie (piccolo grande finito infinito) e non contraddittorie esse non sono esaustive pertanto laconfutazione della molteplicitagrave non conduce automaticamente allrsquoaffermazione del-lrsquounitagrave Lo stesso Lloyd rileva che il gusto per le antitesi polari era proprio non solodella filosofia eleatica ma della sofistica in generale (si vedano infatti come tratto ti-pico della dialettica sofistica le antitesi proposte nellrsquoEutidemo platonico)
18) Con la tendenza onnicomprensiva propria del suo argomentare Sestoparte prima dallrsquoidentitagrave di ciograve che non egrave con ciograve che egrave poi viceversa dallrsquoidentitagrave
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
ognuno dei tre corni di un grande trilemma e non attraverso sin-gole dimostrazioni autosufficienti
A Dimostrazione della non esistenza di ciograve che non egrave(M 767) attraverso due argomenti che partono da due distintepremesse ipotetico-concessive e corrispondono rispettivamenteagli argomenti (a) e (b) della διος 13πδειξις
B Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave (M 768ndash74) attraverso argomenti in parte assimilabili a quelli dellaσυνθετικ 13πδειξις di MXG ma senza esplicita attribuzione del-la loro paternitagrave a Melisso e Zenone si tratta del trilemma genera-to ingenerato generato e ingenerato insieme e dellrsquoantinomiauno molti senza alcun riferimento alla riflessione sul movimento
C Dimostrazione della non esistenza di ciograve che egrave e ciograve chenon egrave insieme (M 775ndash76) attraverso un argomento che egrave formaestesa ma banalizzata dellrsquoargomento (c) della διος 13πδειξις
La maggiore attendibilitagrave della versione MXG risulta eviden-te non solo nei dettagli argomentativi ma anche nellrsquoarticolazionecomplessiva della prima tesi Sesto infatti ne ingabbia la strutturain un grande trilemma in base al quale laquose qualcosa egrave egrave ciograve che nonegrave o ciograve che egrave o ciograve che egrave e ciograve che non egrave insiemeraquo (M 766) Non sitratta verosimilmente di unrsquoaggiunta arbitraria13 ma di una forza-tura degli argomenti gorgiani entro uno schema caro allo scettico oalla sua fonte Va detto infatti a conferma dellrsquoipotesi di unrsquointer-ferenza scettica sul testo di Gorgia che il trilemma col terzo cornoche unisce due contraddittori o due contrari riproposto da Sestoanche nellrsquoargomento sulla generazione riecheggia una strategia ti-pica di Enesidemo Si confronti per esempio lrsquoenunciazione deltrilemma sulla generazione (M 768) con la trattazione derivata daEnesidemo in cui il vero egrave introdotto come sensibile o intelligibi-le o insieme sensibile e intelligibile14
336 Rober ta Io l i
13) Come opportunamente mi fa notare Walter Leszl le manipolazioni di Sesto sulle fonti comportano piuttosto omissioni di argomenti o revisioni lingui-stiche
14) Tra i numerosi esempi di trilemma cosigrave costruito si possono citareM 852 125 344 M 10209 235ndash7 (cfr anche PH 2178 378 110ndash114 M 7242questrsquoultimo col quadrilemma di origine pirroniana su cui si veda Aristocl ap EusPE 14181ndash4) Broumlker (come n 4) 435 critica lrsquoatteggiamento di Sesto da lui defi-nito travisante nellrsquoimposizione sia di trilemmi sia di quadrilemmi come nellrsquoargo-mento contro lrsquouno (M 773) Alcuni studiosi hanno tentato un parziale recuperodella versione di Sesto ma senza argomenti probanti in favore del terzo corno del
M 768 se infatti ciograve che egrave egrave certamente egrave eterno o generato o insiemeeterno e generato ma non egrave neacute eterno neacute generato neacute entrambi comemostreremo dunque ciograve che egrave non egrave15
M 840ndash41 se infatti vi egrave qualcosa di vero certamente egrave sensibile o in-telligibile o insieme sensibile e intelligibile ma non egrave neacute sensibile neacute in-telligibile neacute entrambi come saragrave stabilito dunque non vi egrave nulla divero16
Per Lloyd il trilemma potrebbe rappresentare una struttura volu-tamente introdotta dal sofista per spezzare lrsquoangustia del dilemmaeleatico che impiega due termini contrari come fossero due contraddittori esaustivi17 tuttavia i confronti col testo di Sestoricchissimo di simmetrie polilemmatiche lrsquoassenza di una talestrut tura nella corrispondente versione MXG e soprattutto nellesuperstiti orazioni di Gorgia pur non essendo in seacute elementi pro-banti ci inducono a dubitare dellrsquoautenticitagrave del trilemma Inoltrelrsquoargomento conclusivo di M 775ndash76 (laquose infatti neacute ciograve che egrave neacuteciograve che non egrave neacute entrambi sono e se oltre a questi niente egrave conce-pito niente egraveraquo) non fa altro che sviluppare lrsquoipotesi dellrsquoidentitagrave traessere e non essere presente anche in MXG 979a31ndash33 ma arti-colata da Sesto in modo prolisso cosigrave da completare lrsquoenumera-zione e la definitiva esclusione di tutte le possibilitagrave logicamenteconcepibili18 Tale esigenza risulta ancora piugrave evidente nel caso del
337Gorgia Scettico
trilemma cosigrave Levi (come n 1) 214 n 39 R Mondolfo Problemi del pensiero anti-co Bologna 1936 180 M Untersteiner I Sofisti Milano 21996 222ndash3 e n 32 Maz-zara (come n 1) 122 n 67
15) ε γρ τ ltν )στιν Lτοι 13διν στιν 5 γενητν 5 13διον =μα κα γενητνο-τε δ6 13διν στιν ο-τε γενητν ο-τε 13μφτερα Mς δεξομεν οκ ρα )στι τ ν
16) ε γρ )στι τι 13ληθς Lτοι ασθητν στιν 5 νοητν στιν 5 κα νοητνστι κα ασθητν στιν [5] ο-τε δ6 ασθητν στιν ο-τε νοητν στιν ο-τε τσυναμφτερον Mς παρασταθEσεται οκ ρα )στι τι 13ληθς
17) Si veda G E R Lloyd Polarity and Analogy Two Types of Argumenta-tion in Early Greek Thought Cambridge 1966 103ndash27 115 ss Lo studioso indivi-dua nellrsquoopposizione antitetica la struttura fondamentale della dialettica eleaticaZenone ad esempio sostiene la tesi dellrsquounitagrave sulla base delle conseguenze antiteti-che a cui la molteplicitagrave dagrave vita ma trattandosi di ipotesi tra loro contrarie (piccolo grande finito infinito) e non contraddittorie esse non sono esaustive pertanto laconfutazione della molteplicitagrave non conduce automaticamente allrsquoaffermazione del-lrsquounitagrave Lo stesso Lloyd rileva che il gusto per le antitesi polari era proprio non solodella filosofia eleatica ma della sofistica in generale (si vedano infatti come tratto ti-pico della dialettica sofistica le antitesi proposte nellrsquoEutidemo platonico)
18) Con la tendenza onnicomprensiva propria del suo argomentare Sestoparte prima dallrsquoidentitagrave di ciograve che non egrave con ciograve che egrave poi viceversa dallrsquoidentitagrave
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
M 768 se infatti ciograve che egrave egrave certamente egrave eterno o generato o insiemeeterno e generato ma non egrave neacute eterno neacute generato neacute entrambi comemostreremo dunque ciograve che egrave non egrave15
M 840ndash41 se infatti vi egrave qualcosa di vero certamente egrave sensibile o in-telligibile o insieme sensibile e intelligibile ma non egrave neacute sensibile neacute in-telligibile neacute entrambi come saragrave stabilito dunque non vi egrave nulla divero16
Per Lloyd il trilemma potrebbe rappresentare una struttura volu-tamente introdotta dal sofista per spezzare lrsquoangustia del dilemmaeleatico che impiega due termini contrari come fossero due contraddittori esaustivi17 tuttavia i confronti col testo di Sestoricchissimo di simmetrie polilemmatiche lrsquoassenza di una talestrut tura nella corrispondente versione MXG e soprattutto nellesuperstiti orazioni di Gorgia pur non essendo in seacute elementi pro-banti ci inducono a dubitare dellrsquoautenticitagrave del trilemma Inoltrelrsquoargomento conclusivo di M 775ndash76 (laquose infatti neacute ciograve che egrave neacuteciograve che non egrave neacute entrambi sono e se oltre a questi niente egrave conce-pito niente egraveraquo) non fa altro che sviluppare lrsquoipotesi dellrsquoidentitagrave traessere e non essere presente anche in MXG 979a31ndash33 ma arti-colata da Sesto in modo prolisso cosigrave da completare lrsquoenumera-zione e la definitiva esclusione di tutte le possibilitagrave logicamenteconcepibili18 Tale esigenza risulta ancora piugrave evidente nel caso del
337Gorgia Scettico
trilemma cosigrave Levi (come n 1) 214 n 39 R Mondolfo Problemi del pensiero anti-co Bologna 1936 180 M Untersteiner I Sofisti Milano 21996 222ndash3 e n 32 Maz-zara (come n 1) 122 n 67
15) ε γρ τ ltν )στιν Lτοι 13διν στιν 5 γενητν 5 13διον =μα κα γενητνο-τε δ6 13διν στιν ο-τε γενητν ο-τε 13μφτερα Mς δεξομεν οκ ρα )στι τ ν
16) ε γρ )στι τι 13ληθς Lτοι ασθητν στιν 5 νοητν στιν 5 κα νοητνστι κα ασθητν στιν [5] ο-τε δ6 ασθητν στιν ο-τε νοητν στιν ο-τε τσυναμφτερον Mς παρασταθEσεται οκ ρα )στι τι 13ληθς
17) Si veda G E R Lloyd Polarity and Analogy Two Types of Argumenta-tion in Early Greek Thought Cambridge 1966 103ndash27 115 ss Lo studioso indivi-dua nellrsquoopposizione antitetica la struttura fondamentale della dialettica eleaticaZenone ad esempio sostiene la tesi dellrsquounitagrave sulla base delle conseguenze antiteti-che a cui la molteplicitagrave dagrave vita ma trattandosi di ipotesi tra loro contrarie (piccolo grande finito infinito) e non contraddittorie esse non sono esaustive pertanto laconfutazione della molteplicitagrave non conduce automaticamente allrsquoaffermazione del-lrsquounitagrave Lo stesso Lloyd rileva che il gusto per le antitesi polari era proprio non solodella filosofia eleatica ma della sofistica in generale (si vedano infatti come tratto ti-pico della dialettica sofistica le antitesi proposte nellrsquoEutidemo platonico)
18) Con la tendenza onnicomprensiva propria del suo argomentare Sestoparte prima dallrsquoidentitagrave di ciograve che non egrave con ciograve che egrave poi viceversa dallrsquoidentitagrave
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
trilemma sulla generazione qui il terzo corno (generato e ingene-rato insieme) subito liquidato come autocontraddittorio assolvesemplicemente a una funzione di esaustivitagrave logica infine se si fos-se trattato di una struttura scelta da Gorgia per rompere lo sche-ma dilemmatico non si comprenderebbe lrsquoassenza del terzo cornoa conclusione dellrsquoargomento su unitagrave molteplicitagrave dove si sup-pone semplicemente che laquose egrave di certo egrave uno o moltiraquo (M 773)Sesto o la sua fonte uniscono dunque gli argomenti della cosiddet-ta laquodimostrazione propriaraquo a quelli della laquosinteticaraquo per costruirecon essi un trilemma ontologico secondo la struttura tipica del-lrsquoargomentare pirroniano19
Perfino il commento dellrsquoAnonimo al termine della διος13πδειξις pur nellrsquoincertezza di alcuni passi lacunosi ci restituiscecon precisione lrsquoobiettivo proprio di Gorgia dimostrare che nien-te egrave e non semplicemente che il non essere non egrave come nella cor-rispondente versione sestana20 Questrsquoultima conclusione infattirenderebbe incomprensibile la natura della confutazione dellrsquoAno-nimo per il quale in base alle premesse della dimostrazione pro-pria e con deduzione rigorosa si sarebbe dovuto concludere con-
338 Rober ta Io l i
di ciograve che egrave con ciograve che non egrave Nel primo caso perograve passa indebitamente dallrsquoiden-titagrave di essere e non essere Oσον π τ0 εampναι alla supposta e ingiustificata identitagrave sot-to il segno del non essere concludendo in maniera non consequenziale rispetto allepremesse che niente egrave nel secondo caso invece lrsquoargomentazione si fonda sullrsquoin-conciliabilitagrave tra lrsquoidea di identitagrave e quella di coesistenza Infine Sesto si appella a unprincipio quello per cui il non essere non egrave accettato al di fuori del contesto argo-mentativo e considerato nello specifico giagrave concordato (Pμλογον) ma tale princi-pio di per seacute basterebbe a liquidare lrsquoargomento dellrsquoidentitagrave senza bisogno di svi-lupparlo in modo cosigrave pedante
19) Nonostante accordi la sua preferenza alla versione dellrsquoAnonimoK Reinhardt Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie Bonn1916 36ndash9 e 262 considera plausibile la tripartizione di Sesto sulla base della pro-pria interpretazione delle tre vie di Parmenide Per Reinhardt infatti la prima viasarebbe quella tautologica dellrsquoessere che egrave la seconda quella contraddittoria delnon essere che egrave (o dellrsquoessere che non egrave) la terza quella del contemporaneo esseree non essere Le tre vie sarebbero state sistematicamente confutate da Gorgia masolo nella versione di Sesto a sostegno di tale interpretazione perograve Reinhardt egrave co-stretto a intervenire pesantemente sul testo tradito di entrambe le versioni
20) Come sottolinea Calogero (come n 1) 194ndash6 nella versione dellrsquoAnoni-mo Gorgia vuole dimostrare che non egrave possibile neacute essere neacute non essere confutan-do in tal modo la κρσις parmenidea tra εampναι e μ εampναι mentre in Sesto proprio laδιος 13πδειξις finirebbe per recuperare paradossalmente un argomento difeso econsacrato dallrsquoontologia di Parmenide cioegrave la non esistenza di ciograve che non egrave
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
trariamente a Gorgia che tutto egrave e non solo il non essere LrsquoAno-nimo utilizza laquoGorgia contro Gorgiaraquo21 si serve cioegrave delle sue stes-se premesse per giungere a conclusioni opposte cosigrave come Gorgiaaveva fatto con Parmenide Melisso Zenone Pertanto data la pri-ma premessa della διος 13πδειξις secondo cui ciograve che non egrave egrave ciograveche non egrave e sfruttando la confusione tra uso copulativo ed esisten-ziale di εampναι viene legittimata per lrsquoAnonimo una conclusione an-titetica a quella di Gorgia22 se a ciograve che non egrave va attribuito lrsquoesseredi una proposizione di identitagrave e a ciograve che egrave va aggiunto anche lrsquoes-sere in accezione esistenziale ne deriva che tutto egrave (MXG 979b4ndash6)
Nel complesso il metodo argomentativo di Gorgia deriva ve-rosimilmente da Zenone e dalla sua dialettica antinomica tuttaviail sofista non si limita a liquidare una tesi assunta in ipotesi sullabase delle conseguenze contrarie o contraddittorie a cui essa dagravevita ma la inserisce in un processo piugrave articolato23 in cui conflui-scono ndash e questa saragrave la forza corrosiva della sua dialettica ndash ele-menti dimostrativi in origine utilizzati per uno scopo opposto adesempio gli argomenti di Zenone contro la molteplicitagrave finisconoper essere impiegati contro lrsquounitagrave Lrsquoassenza dei nomi di Melisso eZenone nella versione di Sesto puograve farci pensare che mancasse neltrattato originale un esplicito riferimento a tali autori ma che essirisultassero facilmente riconoscibili per il lettore accorto Certo egraveche lrsquoAnonimo anche nel caso abbia aggiunto di propria volontagrave ilriferimento ai due eleati non opera forzature esegetiche ma si li-mita ad esplicitare la paternitagrave filosofica degli argomenti impiegatidal sofista Nellrsquoantinomia generato ingenerato per esempio egrave in-dubbia lrsquoinfluenza di argomenti tratti da Melisso travolti perograve sot-to lrsquourto di δξαι zenoniane per dimostrare infatti che lrsquoessere nonegrave ingenerato Gorgia parte come si egrave visto dal presupposto melis-
339Gorgia Scettico
21) Cosigrave J Mansfeld De Melisso Xenophane Gorgia Pyrrhonizing Aristote-lianism RhM 131 1988 239ndash76 260
22) Lungi dallrsquoessere unrsquointerferenza dellrsquoAnonimo come invece suggerisceJ Cook Wilson Notice of Apeltrsquos Pseudo-Aristotelian Treatises The ClassicalReview 6 1892 441ndash6 442 lrsquoalternativa tra accezione esistenziale e copulativa restituita in MXG 979a35ndash36 rispecchia perfettamente le premesse dei primi due argomenti della διος 13πδειξις
23) Sulle diverse modalitagrave argomentative adottate dal sofista e soprattuttosulla laquolsquoRussian dollrsquo argumentationraquo si veda D G Spatharas Patterns of argumen-tation in Gorgias Mnemosyne 54 2001 393ndash408 in particolare 405ndash8
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
siano per cui ciograve che egrave eterno egrave infinito e ciograve che egrave infinito non puograveessere racchiuso in alcun luogo confuta poi la tesi iniziale del-lrsquoeternitagrave impiegando gli argomenti di Zenone sullo spazio secon-do cui ciograve che non egrave in alcun luogo non egrave nulla (MXG 979b21ndash25)24 Quanto al dilemma contro lrsquoessere generato in MXG Gor-gia esclude che lrsquoessere possa nascere dallrsquoessere sulla base dellrsquoi-dentitagrave melissiana tra nascita e cambiamento laquose infatti ciograve che egrave simodificasse non sarebbe piugrave ciograve che egrave proprio come se anche ciograveche non egrave nascesse non sarebbe piugrave ciograve che non egraveraquo (MXG 979b28ndash29) tale argomento che in Sesto egrave taciuto riecheggia evidente-mente il frammento 8 di Melisso come dimostra anche la presenzadel termine μεταππτειν di per seacute raro ma conservato proprio nel-la versione dellrsquoAnonimo
A proposito dellrsquoantinomia uno molti va detto che sia nel te-sto dellrsquoAnonimo sia in quello di Sesto Gorgia liquida in poche ri-ghe lrsquoargomento contro la pluralitagrave forse percheacute poco interessatoa esso una volta esclusa lrsquounitagrave infatti va da seacute lrsquoesclusione dellapluralitagrave che di unitagrave egrave composta In entrambe le versioni invecepur nella forma contratta e gravemente lacunosa di MXG e nellaparziale diversitagrave della dimostrazione in Sesto Gorgia si concentraestesamente sullrsquoargomento contro lrsquounitagrave in difesa della quale sierano pronunciati tutti gli eleati in particolare Zenone Due ordi-ni di riflessioni mi fanno propendere per la versione dellrsquoAnonimoe cioegrave la valutazione della terminologia che in Sesto risente com-plessivamente della lettura aristotelica dei Presocratici e lrsquoanalisidella struttura argomentativa Sesto infatti procede secondo lastruttura polilemmatica e disgiuntiva a lui cara per via del lsaquomodustollendo tollensrsaquo se lrsquouno esiste egrave (a) o (b) o (c) o (d) ma neacute (a) neacute(b) neacute (c) neacute (d) dunque lrsquouno non esiste Nellrsquoargomentazionequadrilemmatica di M 773 viene dunque negata lrsquounitagrave dellrsquoessereescludendo uno dopo lrsquoaltro quei concetti definitori (ποσνσυνεχς μγεθος σJμα) che vorrebbero via via esaurire lrsquoidea stes-sa di unitagrave e che in parte come nel caso di laquocontinuitagraveraquo (συνεχς)e laquoquantitagraveraquo (ποσν) sono proposti attraverso il filtro aristotelicoDal punto di vista linguistico infatti solo laquograndezzaraquo (μγεθος) elaquocorporaquo (σJμα) sembrano appartenere allrsquoargomentazione origi-
340 Rober ta Io l i
24) In questa direzione si veda anche lrsquointerpretazione di T Gomperz Pen-satori greci Storia della filosofia antica Firenze 31950 II 319ndash20
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
naria25 μγεθος egrave esplicitamente attestato sia in Zenone (29B1 e 2DK) sia in Melisso (30B3 e 10 DK) e σJμα presente in Melisso(30B4 DK) egrave evocato da Zenone attraverso il sostantivo π9χος im-piegato spesso come suo sinonimo (29B1 e 2 DK) Viceversa lrsquoele-mento della laquocontinuitagraveraquo e quello della laquoquantitagraveraquo questrsquoultimomai attestato nelle dottrine eleatiche come attributo dellrsquoesserenon sembrano aggiungere nulla al discorso quasi fossero usati daSesto per esaurire tutte le possibilitagrave logiche dellrsquoargomentazionesecondo una pratica a lui congeniale lrsquoaccostamento dei quattrotermini alimenta il sospetto che lo scettico stia riecheggiando comealtrove argomenti e terminologia aristotelici26
Infine in Sesto egrave del tutto assente la riflessione sul movimen-to sviluppata invece in MXG 980a1ndash8 a completamento dei pre-cedenti argomenti su generazione e numero intendendo infatti ilmoto come alterazione esso verragrave confutato con unrsquoargomenta-zione analoga a quella sulla nascita mentre concependolo comemovimento nello spazio lrsquoidea di divisibilitagrave da esso implicata por-teragrave ad escludere lrsquounitagrave dellrsquoessere Ben pochi interpreti conside-rano la riflessione sul movimento unrsquointerpolazione dellrsquoAnoni-mo mentre i piugrave la riconoscono come autentica e in quanto taleulteriore prova della superioritagrave di MXG tra questi ultimi perogravemolti suggeriscono lrsquoesistenza di una lacuna in corrispondenza di un presunto argomento sulla quiete27 A favore di tale ipotesicrsquoegrave senzrsquoaltro la simmetria con le coppie antitetiche precedenti se-condo una strategia argomentativa cara a Gorgia ampiamente at-testata nella dossografia filosofica tesa a risolvere tutta la realtagrave incoppie di opposti si puograve infatti menzionare allrsquointerno di tale tra-dizione il confronto con quelle voci in cui compare tra le altre
341Gorgia Scettico
25) Si veda Newiger (come n 1) 83 versus Classen (come n 10) 76ndash726) In Phys Z 9 239b9 ss commentando la prima aporia zenoniana sul mo-
vimento e considerando ciograve che egrave continuo e infinito sia esso lunghezza o tempoAristotele polemizza con Zenone e introduce la distinzione tra infinito secondoquantitagrave (κατ ποσν) e infinito secondo divisibilitagrave (κατ διαρεσιν) Inoltre lrsquou-so della categoria della quantitagrave egrave sistematico nella riflessione aristotelica sui Preso-cratici come dimostrano per esempio la testimonianza su Democrito (GC A 2316a13 ss = 68A48 DK) e quella su Melisso (Phys A 2 185a32 ss = 30A11 DK)
27) Si vedano H Gomperz Sophistik und Rhetorik Leipzig 1914 20W Nestle Die Schrift des Gorgias lsquoUumlber die Natur oder uumlber das NichtseiendersquoHermes 57 1922 551ndash62 556 Levi (come n 1) 173 Sicking (come n 1) 390 Newi-ger (come n 1) 75ndash107 e Mansfeld (come n 1) 245
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
coppie antinomiche anche quella quiete moto28 Eppure a sfavo-re dellrsquoipotesi di una lacuna vi sono varie considerazioni di cui egravenecessario tener conto per quanto non siano in seacute risolutive dellaquestione in primo luogo dellrsquoipotetica coppia di termini quiete moto non si parla nellrsquoincipit della trattazione lagrave dove lrsquoAnonimoillustrando la dimostrazione sintetica di Gorgia introduce gli ar-gomenti antinomici ingenerato generato uno molti e non nemenziona altri In secondo luogo bisognerebbe ipotizzare due la-cune una iniziale in corrispondenza dellrsquoenunciazione del dilem-ma e dellrsquoeventuale trattazione sulla quiete e una finale con la ri-capitolazione e negazione di entrambi i corni del dilemma secon-do il tipico procedimento adottato da Gorgia Come perograve sugge-risce Calogero laquolrsquoammissione di lacune egrave rimedio estremoraquo(p 225) e dello stesso avviso furono certo Apelt e Diels che si li-mitarono a correggere il testo tradito senza ipotizzare lacune29Neppure lrsquoοδ iniziale con cui si apre la riflessione sul movi-mento autorizza a pensare che manchi una parte relativa alla quie-te poicheacute la congiunzione funge da semplice collegamento tra dueargomentazioni tradizionalmente connesse quella su unitagrave mol-teplicitagrave e quella sul movimento In terzo luogo lrsquoargomento sulmoto veniva considerato in ambito eleatico e poi atomistico noncome elemento autonomo ma come parte e sviluppo della rifles-sione su generazione mutamento e su molteplicitagrave divisibilitagrave30Infine egrave assai probabile che se Sesto avesse avuto di fronte a seacute undilemma quiete moto considerata la sua propensione per le sim-metrie e gli schematismi non se lo sarebbe lasciato sfuggire Egrave al-lora verosimile che di fronte alla riflessione sul moto piugrave com-plessa degli argomenti precedenti nella sua ironia antieleatica emeno facilmente circoscrivibile Sesto abbia deciso di omettere
342 Rober ta Io l i
28) Cosigrave Xenoph Mem 1114ndash15 In proposito Mansfeld (come n 1) 246analizzando lrsquoargomento tripartito (uno molti immobile in movimento genera-to ingenerato) ritiene verosimile che la fonte del passo senofaneo sia proprio Gor-gia Analogamente per H Maier Socrate la sua opera e il suo posto nella storia Fi-renze 1943 182 n 2 lrsquoargomento egrave di origine gorgiana anche se forse mutuato daAntistene Si veda anche J Mansfeld Aristotle Plato and the Preplatonic Doxo-graphy and Chronography in Id Studies in the Historiography of Greek Philo-sophy Assen Maastricht 1990 22ndash83 spec 59 ss
29) Cfr anche Gigon (come n 1) 200ndash2 e V Di Benedetto Il Περ το μντος di Gorgia e la polemica con Protagora RAL 10 1955 287ndash307 292ndash3
30) In proposito rimando a Parmenide 28B8 DK e Melisso 30B7 8 10 DK
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
lrsquoargomento percheacute nella generale prospettiva scettica non avreb-be aggiunto nulla a quanto giagrave delineato31
22 La seconda tesi
Anche nella seconda tesi cosiddetta lsquognoseologicarsquo lrsquointegra-zione tra le due fonti e la loro lettura comparata con accentuazio-ne delle analogie piugrave che delle differenze consente di ricostruirelrsquooriginale pensiero di Gorgia32 In MXG Gorgia sostiene che nien-te egrave conoscibile attraverso una duplice argomentazione dalla coin-cidenza eleatica tra essere e pensabilitagrave discende in primo luogo ilparadosso per cui non esiste il falso in quanto tutte le cose anchele piugrave incredibili e fantastiche avrebbero nellrsquoessere pensate la lorogaranzia di veritagrave (MXG 980a9ndash12) Forzando e radicalizzando ipresupposti parmenidei Gorgia aggiunge che anche le cose perce-pite sono solo in quanto oggetto di pensiero (MXG 980a13ndash14)eleaticamente considerato superiore criterio di veritagrave rispetto aisensi ingannevoli33 A questo argomento dalla finalitagrave antiparme-nidea il sofista ne fa seguire un secondo (contrassegnato dallrsquousodi )τι) il cui obiettivo polemico doveva essere facilmente identifi-cabile per i lettori del tempo in Protagora (MXG 980a14ndash19) In
343Gorgia Scettico
31) Meno probabile mi sembra la lettura di Sicking (come n 1) 390 ss e diUntersteiner (come n 14) 154 n 90 secondo i quali considerando il silenzio di Se-sto e lrsquoargomento cosigrave come tramandato in MXG si ricaverebbe che le due versio-ni del PTMO derivino da una medesima fonte giagrave in seacute lacunosa
32) Eccessivamente riduttivo egrave in proposito il giudizio di Calogero (comen 1) 245 che liquida parte dellrsquoargomentazione sestana come laquoun crogiolo di con-traddizioni ed incoerenzeraquo
33) Mansfeld (come n 1) 250ndash1 vede in questo argomento di Gorgia un rie-cheggiamento dellrsquohomo mensura protagoreo per cui si puograve solo fare appello a unaconoscenza relativa e personale se qualcuno dice di vedere carri sul mare ciograve cor-risponde alla sua personale percezione e non gli si puograve contrapporre alcuna veritagraveassoluta A mio avviso lrsquoargomento si direbbe piuttosto una risposta allrsquoassurdoeleatico per cui unrsquoasserzione o un pensiero evidentemente falsi debbano essereconsiderati veri solo percheacute concepiti dal νος la riduzione del mondo sensibile asemplice funzione del pensiero appare infatti conseguenza di una radicalizzazionedi premesse parmenidee Per Di Benedetto (come n 29) 299ndash302 invece tutta la se-conda tesi sarebbe antiprotagorea percheacute contemplando pensieri e percezioni ab-braccia una concezione del piano intellettivo piugrave ampia di quella parmenidea chedelegittima solo i sensi ma sul Protagora laquotroppo platonicoraquo di Di Benedetto si vedaancora Mansfeld 249ndash58
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
questo caso infatti lrsquoessere risulta inconoscibile a causa della paridignitagrave e affidabilitagrave di ogni pensiero in quanto pensato e di ognipercezione in quanto percepita non crsquoegrave piugrave un appiattimento diogni nostra attivitagrave percettiva o immaginativa sul pensiero intesoquale univoco criterio di veritagrave ma un riconoscimento di ambitiepistemici diversi e insieme lsquoisostenicirsquo percheacute tutti dotati di unproprio interno criterio Se il pensiero non egrave piugrave superiore criteriodellrsquoessere come nel primo argomento esso diviene semplice mez-zo di apprensione al pari degli altri34 Il consenso o συμφωνα nu-merica non egrave sufficiente per dirimere il contrasto tra le diverse rappresentazioni prodotte dal pensiero o dai sensi poicheacute a una comunitagrave di senzienti puograve sempre opporsi una comunitagrave di pen-santi in direzione antitetica35 Cosigrave se per Protagora tutte le perce-zioni pur nella loro diversitagrave sono indistinguibilmente vere inGorgia allrsquoopposto la loro equipollenza testimonia non la loro fal-sitagrave ma la loro oscuritagrave poicheacute egrave indecidibile quale di esse sia veracioegrave corrispondente al reale stato delle cose
Anche in Sesto la tesi gnoseologica egrave sviluppata in due argo-menti principali in parte assimilabili ai due argomenti di MXGma diversamente trattati in particolare lrsquoargomento antiparmeni-deo viene imbrigliato da Sesto entro un rigido schematismo frut-to della tipica tendenza sestana a voler esaurire ogni possibilitagrave ar-gomentativa a costo di creare percorsi dialettici capziosi e fittizi(M 777ndash9) Ciograve che soprattutto colpisce egrave lrsquoassenza in Sesto diun riferimento al tema della 13δηλτης intorno al quale ruota inMXG la conclusione della seconda tesi infatti mentre nella versione di Sesto si sostiene che lrsquoessere egrave inconoscibile o meglioancora impensabile in quella dellrsquoAnonimo la realtagrave risulta inco-noscibile non in quanto intrinsecamente oscura ma in quanto egraveoscuro quale tra le nostre molteplici rappresentazioni sia vera inassenza di un criterio sia interno cioegrave non valutabile da altro senon da se stesso sia esterno (argomento del consenso verosimil-mente non amato da Sesto per via delle sue implicazioni relativi-stiche) Va perograve rilevato che anche nel corpus sestano dove il ter-mine δηλον egrave frequentissimo la realtagrave egrave ritenuta oscura non in seacute
344 Rober ta Io l i
34) In proposito rimando anche a B Cassin Si Parmeacutenide Le traiteacute an onymeDe Melisso Xenophane Gorgia Lille 1980 525
35) Sulla centralitagrave in Protagora della nozione di consenso stando soprat-tutto alla testimonianza platonica segnalo M Narcy in Platon Theacuteeacutetegravete Paris2
1995 115 n 4
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
ma in relazione alle molteplici e differenziate esperienze dellrsquouomo in tal modo Sesto astenendosi dal dogmatismo negativo dichi come gli accademici asserisce lrsquoinconoscibilitagrave del vero pro-pone la sospensione dellrsquoassenso come garanzia di onestagrave intellet-tuale e cura di seacute di fronte allrsquoinfinita διαφωνα dogmatica Analo-gamente Gorgia registra il caos dissonante delle umane esperien-ze percettive lagrave dove gli eventi siano noti e incontestabili per tut-ti lui stesso ne rivendica lrsquoevidenza come in Hel 3 a propositodei natali di Elena o in Pal 19 dove riconosce come cosa ovvia lrsquoi-dentificazione del tradimento della patria con il tradimento di sestessi Tuttavia ben diversamente da Sesto di fronte allrsquoassenza diun univoco criterio epistemico Gorgia non sostiene la sospensio-ne dellrsquoassenso ma lrsquoinconoscibilitagrave del vero Si potrebbe dunquepensare che il termine δηλον cruciale nel percorso di giustifica-zione della ποχE pirroniana venga omesso nella versione scetticadel PTMO per evitare indesiderate commistioni tra lrsquoorizzonte so-fistico e quello propriamente efettico Lrsquoipotesi di un interventoscettico su questa parte del testo gorgiano sembra confermata an-che dalla veste linguistica tarda (γνωστος 13νεπινητος M 777) esoprattutto dal richiamo a Scilla e alla Chimera come esempi dinon esistenti a differenza dellrsquoimmagine dei carri in corsa sul mareattestata in entrambe le versioni e unicum nella letteratura grecaScilla e la Chimera sono figure evocate solo nella versione di Sestoe combinate in un immaginario di probabile origine scettica36
Altro elemento di sorprendente difformitagrave tra le due versioniegrave costituito dalla presenza in MXG 979a27 e 980a17 della clauso-la οδ6ν μQλλον espressione lsquotecnicarsquo in Sesto di cui perograve nel-lrsquointera sezione da lui dedicata a Gorgia non vi egrave traccia Lrsquoeven-tuale presenza del sintagma ο οδ6ν μQλλον nel PTMO nondeve stupire in quanto tipico della riflessione sofistica37 e perfet-tamente coerente con lrsquoorizzonte speculativo in cui opera Gor-gia38 Nella prima tesi infatti lrsquoespressione egrave adottata verosimil-
345Gorgia Scettico
36) Si veda anche la testimonianza di D L 975 (= Suidas μ 1156 ο 80210)In proposito rimando a Calogero (come n 1) 250ndash1 e Newiger (come n 1) 142ndash9
37) Per S Makin Indifference Arguments Oxford 1993 ο οδ6ν μQλλον ca-ratterizza il pensiero presocratico come espressione di quellrsquolaquoindifference argumentraquoche giagrave in Zenone trova compiutamente voce negli argomenti contro la pluralitagrave
38) Si veda in proposito P De Lacy Ο μQλλον and the Antecedents of An-cient Scepticism in G P Anton G L Kustas (edd) Essays in Ancient Greek Phil -osophy Albany 1972 I 593ndash606 595
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
mente nella sua valenza ontologica (laquole cose sono non piugrave diquanto non sonoraquo MXG 979a27) e impiegata non solo in funzio-ne antieleatica ma anche antiatomistica essere e non essere scom-paiono infatti nella vacuitagrave di ogni tentativo definitorio e discri-minante39 Nella seconda tesi in cui lrsquoavversario principale egrave il relativismo di Protagora lrsquoespressione assume invece un valoreepi stemico e lrsquoapplicazione di essa allrsquoambito percettivo e intellet-tivo (laquociograve che vediamo egrave non piugrave di ciograve che pensiamoraquo MXG979b15) potrebbe essere mutuata proprio dal sofista di Abdera40In analogia con Democrito Gorgia svilupperebbe allora una pole-mica contro la δξα di Protagora che difende lrsquoindifferenza in po-sitivo di ogni percezione come infatti testimoniano Platone(Theaet 166c3 ss) Aristotele (Metaph Γ 5 1009b7ndash10) e SestoEmpirico (M 7389) i presupposti dellrsquohomo mensura autorizza-no Protagora a sostenere che nessuno puograve cogliere la veritagrave megliodegli altri Sulla base delle medesime premesse Democrito ricono-sce che nellrsquoimpossibilitagrave di dirimere il conflitto tra percezioni di-verse egrave impossibile innalzare allo statuto di conoscenza sensibileuna qualsiasi di esse cosigrave se in Protagora la 13διαφορα conduce adasserire la veritagrave di tutte le percezioni in Democrito al contrarioessa porta a riconoscerne la falsitagrave o per lo meno lrsquooscuritagrave (Me-taph Γ 5 1009b11ndash12 cfr Democr 68B9 10 117 DK)41 Come
346 Rober ta Io l i
39) A conferma di ciograve si possono citare alcune testimonianze sullrsquoimpiegodemocriteo dellrsquoespressione usata per asserire provocatoriamente lrsquoequivalenza traessere (atomi) e non essere (vuoto) come in Leucippo anche in Democrito infattiο μQλλον ha per fine il riconoscimento dellrsquoesistenza di entrambi i termini dellacorrelazione nel polemico superamento della κρσις parmenidea (si veda 68B156DK μ μQλλον τ δ6ν 5 τ μηδ6ν εampναι)
40) De Lacy (come n 38) restio a interpretare lrsquoespressione in termini episte-mici evita di applicarla alla riflessione sulla relativitagrave percettiva lo studioso dagrave cre-dito alla testimonianza plutarchea secondo cui Democrito non utilizzograve mai ομQλλον in connessione al problema della conoscenza (adv Col 1109a) diversa-mente da quanto fece Protagora (cfr ad esempio Plat Theaet 182e) Makin (comen 37) attribuisce invece maggiore credibilitagrave a quelle fonti (Theoph De sens 69 eSext PH 1213) dalle quali possiamo desumere che in ambito epistemologico De-mocrito abbia recuperato provocatoriamente la formula da Protagora accentuan-done perograve lrsquoindifferenza in negativo
41) Che la posizione di Democrito sia una risposta a Protagora egrave conferma-to anche da Plut adv Col 1108F (= 68B156 DK) Si puograve allora pensare che Gorgiae Democrito sviluppassero contemporaneamente (o lrsquouno in dipendenza dallrsquoaltro)argomenti polemici nei confronti del sofista di Abdera inserendosi in un vasto pa-norama antiprotagoreo dellrsquoAtene del V secolo a C
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
nello scacco ontologico della prima tesi Gorgia colpiva congiunta-mente eleatismo e atomismo cosigrave nella presunta equipollenza diogni percezione egli respinge non solo lrsquolsaquoottimismorsaquo protagoreoma anche il pessimismo atomistico e la svalutazione dei sensi ri-spetto al νος affermando la σοσθνεια di sensi e pensiero e riconoscendo nellrsquooscuritagrave del vero lrsquounica residua certezza epi-stemica Ancora una volta dunque come nel caso di δηλον lrsquoas-senza di ο μQλλον nella versione di M 7 piugrave che autorizzarci adipotizzare unrsquoaggiunta arbitraria da parte dellrsquoAnonimo42 potreb-be corrispondere allrsquoesigenza sestana di marcare una differenza sa-rebbe cioegrave stata omessa anche in questo caso unrsquoespressione chepur nellrsquouso specifico e distinto fattone da Gorgia rischiava diconfondersi ingiustificatamente con una φωνE scettica Per ammis-sione dello stesso Sesto infatti il sintagma ο μQλλον egrave impiegatodai pirroniani non laquoin modo distruttivoraquo (13ναρετικJς) come in-vece nel PTMO bensigrave laquoindifferentementeraquo (13διαφρως) cioegrave sen-za alcuna valenza ontologica o epistemica (PH 1191)43
23 La terza tesi
Sesto puograve essere considerato una fonte importante per la ri-costruzione e comprensione degli argomenti gorgiani nella terzatesi del PTMO ma solo limitatamente alla prima parte Se infattieliminiamo le incrostazioni linguistiche tarde (καταλαμβ9νω
347Gorgia Scettico
42) Viceversa per Mansfeld (come n 21) 258 lrsquoimpiego di ο οδ6ν μQλλονcostituirebbe una prova della natura scettica dellrsquoargomentare dellrsquoAnonimo siapercheacute lrsquoespressione vi egrave usata laquoin modo distruttivoraquo (e questo coinciderebbe perMansfeld con lrsquouso che ne fanno i pirroniani sulla base della testimonianza di D L975) sia percheacute non egrave attestata nella corrispondente versione di Sesto Pertanto lrsquoA-nonimo avrebbe interpolato una formula pirronizzante oppure riformulato la tesidi Gorgia laquoin a Pyrrhonist wayraquo Ma sullrsquouso pirroniano della formula in Sestotuttrsquoaltro che distruttivo si veda supra e n 43
43) Tale accezione lsquosospensivarsquo piugrave che distruttiva per quanto in una formasorprendentemente vicina a Gorgia egrave confermata anche dallrsquouso di ο μQλλον daparte di Enesidemo ap Phot Bibl 212170a8ndash11 (13λλ τ ατ Mς επε+ν ομQλλον 13ληθ6ς 5 ψεδος 5 πιθανν 5 13πθανον 5 ltν 5 οκ ν 5 ττε μ6ν το+ονττε δ6 το+ον 5 4 μ6ν τοιονδ 4 δ6 κα ο τοιονδ) Sullrsquouso pirroniano della clau-sola segnalo il fr 54 in F Decleva Caizzi (a cura di) Pirrone Testimonianze Napo-li 1981 234ndash6 sullrsquointerpretazione laquounassertiveraquo di essa da parte dei pirroniani in-siste M L McPherran Skeptical Homeopathy and Self-Refutation Phronesis 321987 290ndash328 287
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
διαδηλω μενω κτς ποκεμενα ecc) e una certa nota tenden-za alla prolissitagrave Sesto ci offre una testimonianza convergente conquella di MXG solo a proposito dellrsquoargomento cosiddetto lsquocate-gorialersquo (MXG 980a20ndashb8) quello cioegrave che tratta dellrsquoeterogeneitagravedel λγος rispetto ai πρ9γματα (M 783ndash4) e della distinzione tra idiversi ambiti percettivi (M 786) Assenti nella versione di Sestosono le argomentazioni intersoggettiva (MXG 980b8ndash14) e intra-soggettiva (MXG 980b14ndash19) in esse si sostiene che egrave impossibileche due persone distinte comunichino tra loro poicheacute non poten-do sperimentare la medesima esperienza percettiva non potrannoconcepire lo stesso riconoscibile pensiero44 inoltre egrave impossibilepersino che il singolo individuo abbia in se stesso le medesime per-cezioni dal momento che esse si modificano in rapporto alle di-verse fasi temporali e ai diversi sensi in lui operanti
Il silenzio di Sesto potrebbe a prima vista sembrare funzio-nale alla volontagrave di presentare solo un Gorgia scettico45 che nel re-lativismo estremo degli argomenti intersoggettivi si distaccher-ebbe troppo dalla riflessione dei pirroniani Ma egrave lettura che nontrovo persuasiva tanto piugrave che se il fine fosse davvero quello diammantare Gorgia di unrsquoaura scettica Sesto non avrebbe certoomesso una sezione in cui a ben guardare risultano piugrave accentua-te le analogie con i tropi di Enesidemo46 A preoccupare Sesto nondoveva essere neppure il rischio di un possibile appiattimento del
348 Rober ta Io l i
44) Questo argomento egrave articolato a sua volta in due sotto-argomenti se-condo cui due individui non potranno mai vivere la medesima esperienza poicheacute ilpensiero che ne deriva se presente in due soggetti fisicamente distinti risulterebbesdoppiato (MXG 980b8ndash11) inoltre se fosse possibile al medesimo e unico pensie-ro essere presente in due soggetti distinti nella loro assoluta identitagrave percettiva taliindividui non sarebbero piugrave due ma uno solo (MXG 980b11ndash14)
45) Sul ruolo e la mediazione di Sesto nella trasmissione di unrsquoimmagine scet-tica dei sofisti insistono F Adorno Protagora nel IV sec d C da Platone a DidimoCieco in AA VV Protagora Antifonte Posidonio Aristotele Saggi su frammen-ti inediti e nuove testimonianze da papiri Firenze 1986 9ndash60 e S Hays On theskeptical influence of Gorgiasrsquo lsquoOn Non-Beingrsquo JHPh 28 1990 327ndash38 Sulla con-tiguitagrave tra sofisti e pirroniani si veda J P Dumont Le Scepticisme et le pheacutenomegraveneEssai sur la signification et les origines du pyrrhonisme Paris 21986 218 mentre perClassen (come n 10) 74 n 42 Sesto avrebbe scelto appositamente quei pensatori equelle dottrine piugrave facilmente distinguibili dalle scettiche per ovviare a laquoconfusio-ni o indebite equiparazioniraquo (p 79)
46) La stranezza di questo silenzio egrave rilevata anche da Mondolfo (come n 14)181 n 1 che si concentra sulle analogie tra la sezione finale di MXG e il secondo ilquarto e lrsquoottavo tropo di Enesidemo
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
pensiero gorgiano su quello di Protagora47 quanto piuttosto laperdita di una supremazia teoretica dei pirroniani nellrsquoelaborazio-ne di alcuni temi La ricerca di antesignani della scepsi da parte diSesto va dunque in ben altra direzione tanto che Gorgia non egrave nep-pure menzionato nella sezione relativa alle παρακεμεναιφιλοσοφαι (PH 1210ndash35) Sesto potrebbe aver eliminato gli ele-menti di piugrave accentuata analogia tra sofistica e scetticismo48 perevitare di attribuire una paternitagrave gorgiana a temi di cui rivendicala nascita in ambito pirroniano considerate le corrispondenze spe-culative tra lrsquoargomento intersoggettivo di Gorgia e il terzo tropoagrippeo (quello della relazione in PH 1167)49 si puograve allora ipo-tizzare che Sesto abbia omesso lrsquoargomentazione del sofista pernon oscurare il presunto primato dei pirroniani per lo stesso mo-tivo sarebbe stata eliminata nella conclusione dellrsquoδιος 13πδειξιςlrsquoespressione ο μQλλον cosigrave cara agli scettici o sarebbe stato evi-tato il riferimento alla 13δηλτης al termine della seconda tesi tuttielementi che come si egrave visto avrebbero inevitabilmente accostatola riflessione di Sesto a quella di Gorgia Egrave verosimile che la lungasezione di M 7 dedicata al sofista derivi da Enesidemo filosofo chedovette nutrire un atteggiamento lsquosimpateticorsquo verso Gorgia50 mase Enesidemo si mostra incline a ricercare antesignani del pirroni-
349Gorgia Scettico
47) Cosigrave suggerisce invece Mazzara (come n 2) 7948) Anche nel caso di Protagora gli studiosi riconoscono la notevole analo-
gia tra la sua riflessione e quella di Sesto (basti ricordare il tema della διαφωνα lrsquoas-senza di un criterio veritativo la formulazione del quarto tropo di Enesidemo cheper J Annas J Barnes The Modes of Scepticism Ancient Texts and Modern Inter-pretations Cambridge 1985 97 sarebbe ascrivibile a Protagora) Nonostante que-sto o forse proprio per questo Sesto preferisce relegare Protagora tra i dogmaticievitando di attribuirgli un ruolo di spicco tra i possibili predecessori della scepsi pir-roniana In proposito segnalo L Rossetti Sulla differenza tra il fenomenismo diProtagora e il fenomenismo scettico in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antiquePerspectives historiques et systeacutematiques Geneacuteve Lausanne Neuchacirctel 1990 55ndash68
49) Si veda anche lrsquoanalogia con i tropi enesidemei che sviluppano sotto di-versi aspetti il tema della relativitagrave percettiva e cognitiva In proposito G StrikerThe Ten Tropes of Aenesidemus in M Burnyeat (ed) The Skeptical TraditionBerkeley Los Angeles London 1983 95ndash115
50) Sullrsquoatteggiamento di Enesidemo nei confronti della filosofia presocrati-ca e nello specifico di Eraclito si veda R Polito The Sceptical Road Aeneside musrsquoappropriation of Heraclitus Leiden 2004 per il quale Enesidemo pur non aderen-do alle δξαι eraclitee simpatizza con alcune di esse ma sempre con un approcciofenomenista
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
smo in ambito presocratico Sesto preferisce accentuare i punti didistacco grazie ai quali far emergere la natura efettica della scepsi(PH 1209) rivendicando lrsquoassoluta originalitagrave dei padri del pirro-nismo secondo una linea purista che va da Pirrone a Timone daEnesidemo ad Agrippa51
3 La presenza di Gorgia nel corpus sestano
Allrsquointerno di Adversus Mathematicos oltre che nella lungasezione dedicata al PTMO Gorgia egrave ricordato unrsquounica volta pre-cisamente in M 748 in un passo che rientra nella trattazione delproblema della veritagrave e nellrsquoenunciazione generale dellrsquoessenza delcriterio52 Il sofista vi compare tra i soppressori del criterio a que-sto gruppo appartengono Senofane e Seniade Protagora AnacarsiDionisodoro (gli ultimi due citati solo in M 7) a cui vengono ag-giunti in una sorta di calcolato distacco rispetto al gruppo inizialeGorgia Metrodoro di Chio Anassarco di Abdera e Monimo il Ci-nico Possiamo supporre che questo secondo accorpamento sepa-rato dal primo derivi dalla presenza di un qualche elemento co-mune che rende tra loro assimilabili tali pensatori anche inM 787ndash8 infatti alla lunga trattazione su Gorgia segue la presen-tazione dei tre filosofi Metrodoro Anassarco e Monimo ricordatiinsieme come negatori del criterio secondo la testimonianza forni-ta da laquonon pochiraquo testimoni53 Chi sono dunque gli οκ Vλγοι aiquali egrave verosimile Sesto si sia ispirato come fonte per questa sezio-ne di Adversus Mathematicos David Sedley riconosce in Eneside-mo il probabile autore almeno della prima parte della trattazionesul criterio quella cioegrave relativa ai negatori della sua esistenza
350 Rober ta Io l i
51) Sulla tendenza di Sesto a tutelare lrsquooriginalitagrave della propria 13γωγE si ve-dano R Ioli (ΑγωγE and related concepts in Sextus Empiricus SicGym 56 2003401ndash28 422ndash3 E Spinelli Scetticismi antichi a confronto Paradigmi 62 2003 313ndash41 335ndash6 e Id Lrsquoantico intrecciarsi degli scetticismi in M De Caro E SpinelliScetticismo Una vicenda filosofica Roma 2007 17ndash38 33ndash4 Polito (come n 50)36ndash7
52) Nellrsquoampia sezione dedicata al criterio (M 738ndash262) Sesto si occupa pri-ma dei suoi negatori (M 48ndash88) poi dei suoi assertori (M 89ndash262) Segue inM 7263ndash439 la trattazione relativa al criterio particolarissimo o logico
53) Egrave degno di nota il fatto che oltre al passo in questione e a M 787ndash8 incui compaiono tutti e tre i filosofi Anassarco non egrave citato altrove Monimo egrave ricor-dato solo in M 85 e Metrodoro in M 161 e 258
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
(M 748ndash88) alla quale il nostro testo appartiene54 Vari e signifi-cativi sono gli elementi addotti in favore di tale derivazione in primo luogo vanno ricordate la presenza di un diffuso relativismoassimilabile al quarto tropo di Enesidemo55 e la scelta tra i nomicitati da Sesto di Senofane Metrodoro di Chio e Anassarco tradi-zionalmente riconosciuti da Enesidemo quali antesignani del pir-ronismo56 Inoltre la paternitagrave enesidemea di questa sezione potrebbe trovare conferma come osserva ancora Sedley nella pre-senza di numerosi riferimenti a fonti del I secolo a C (ad esempiola testimonianza su Metrodoro corrisponderebbe opportunamen-te rivista a Cic Ac 273) e infine nellrsquoampio spazio concesso aGorgia rispetto ad altri autori piugrave prossimi ai pirroniani
A giustificare la particolare attenzione riservata al sofista po-trebbe essere il legame dottrinario tra Gorgia ed Enesidemo que-strsquoultimo infatti mostrograve interesse sia per lrsquoargomentare gorgianoche sembra contravvenire provocatoriamente al principio di noncontraddizione57 sia per lrsquoapproccio empirico al problema della
351Gorgia Scettico
54) Si veda D Sedley Sextus Empiricus and the atomist criteria of truthElenchos 13 1992 19ndash56 25ndash7 Per lo studioso inoltre Posidonio sarebbe la fon-te diretta della seconda parte della sezione dossografica (M 789ndash140) di cui Enesi-demo egrave probabilmente solo fonte intermedia Per Polito (come n 50) 164ndash5 infineanche la sezione su Eraclito (M 7126ndash134) deriverebbe ad eccezione del paragrafo126 direttamente da Enesidemo tutta questa sezione infatti fa parte della lungatrattazione sul criterio problema al quale sappiamo che Enesidemo era particolar-mente sensibile (si vedano in proposito D L 9106 e Sext M 84ndash10)
55) Concordo con Sedley (come n 54) 26 n 9 sullrsquoimplausibilitagrave che questomateriale di impostazione relativistica sia tratto direttamente da Protagora comevorrebbero invece Annas Barnes (come n 48) 85
56) Su Senofane si vedano M 8325ndash6 e D L 972 per Metrodoro e Anas-sarco rimando a Pirrone frr 1A 1B 25AndashB (e relativo commento) in DeclevaCaizzi (come n 43) ad loc A proposito dellrsquointerpretazione scettica di Senofane se-gnalo lrsquoampia discussione in J H Lesher Xenophanesrsquo scepticism Phronesis 231978 1ndash21 Barnes (come n 1) I 138ndash51 E Spinelli Il problema dellrsquoagire nel pir-ronismo antico Problemata 2 2002 29ndash59 41ndash4 W Lapini Un recente studio sul-lo scetticismo di Senofane e alcune precisazioni di filologia filosofica in Id Studidi filologia filosofica greca Firenze 2003 59ndash72 R Ioli Senofane B 34 DK e il co-noscere GIF 55 2003 199ndash219
57) Gorgia fonda sia la tesi ontologica sia quella gnoseologica sullrsquoimpossi-bilitagrave di discernere essere e non essere vero e falso Si veda analogamente seppurecon esiti aporetici la posizione di Enesidemo in Fozio supra n 43 Anche nel casodi Eraclito in PH 1210ndash212 Sesto ci suggerisce che la negazione del principio dinon contraddizione nella coincidentia oppositorum fu uno degli elementi maggior-mente cari alla scepsi enesidemea
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
conoscenza58 sia infine per la dottrina dei pori di derivazioneempedoclea probabile antecedente della teoria enesidemea deiπροι ασθητικο59 Analoga egrave anche la modalitagrave argomentativaadottata da entrambi sappiamo infatti dalle due versioni delPTMO e dalle orazioni epidittiche che Gorgia ricorse ampiamen-te a quella struttura concessiva (ε κα κτλ) che sarebbe poi stataereditata e usata in maniera sistematica da Enesidemo non va di-menticato che ad eccezione del suo uso in Platone60 non vi sonoinfatti prima di Enesidemo testimonianze che comprovino lrsquoim-piego filosofico dellrsquoargomentazione concessiva cosigrave come svilup-pata nel sofista
Anche nelle Ipotiposi Pirroniane Gorgia viene ricordato al-lrsquointerno della lunga trattazione relativa al criterio di veritagrave(PH 257ndash64) Introducendo il tema in PH 218 Sesto distingue ifilosofi per i quali esiste un criterio di veritagrave da quelli per i qualinon esiste alcun criterio in questrsquoultima categoria colloca Seniadedi Corinto e Senofane di Colofone61 gli unici citati anche inM 748 ma sorprendentemente non vi include Gorgia che com-pare invece tra i sostenitori dellrsquointelletto Il suo nome era forse ne-
352 Rober ta Io l i
58) La concezione empirica della conoscenza cosigrave come emerge nel PTMOrisulta perfettamente conciliabile col presupposto enesidemeo per cui non vi egrave co-noscenza al di fuori delle apparenze sensibili Per Gorgia si veda MXG 980b3ndash6 laquodiciograve di cui dunque non si ha concetto come ci si potrebbe formare un concetto [ ]se non vedendolo nel caso sia un colore e ascoltandolo nel caso sia un suonoraquo
59) Per quanto riguarda Gorgia rimando alla testimonianza di Teoph Ign 73(= 82B5 DK) e Plat Men 76a8ndashe4 (= 82B4 DK) Quanto invece allrsquoespressioneπροι ασθητικο essa come suggerisce Polito 2004 pp 119ndash29 egrave rara nella lette-ratura scettica dove ricorre due sole volte in passi di derivazione enesidemea(M 7130 e D L 981)
60) Sedley (come n 54) 25ndash6 n 8 segnala lrsquouso di argomentazioni concessi-ve nel Carmide ma va ricordato che anche nel Parmenide Platone ne fa un impie-go sistematico M M Sassi Platone Fedone 108 D Glauco Protagora il mito PP42 1987 27ndash34 33 sottolinea la presenza sia in Men 80d sia in Phaed 108d diquella strategia concessiva tipicamente gorgiana che recupera in ipotesi una tesi perpoi dimostrarla insostenibile
61) Nelle Ipotiposi Seniade compare solo qui e in PH 276 quale assertoredella tesi secondo cui tutte le φαντασαι sono indegne di fede In Adversus Mathe-maticos egrave citato ora in veste di negatore dellrsquointelletto come criterio laquoper mezzo delqualeraquo (M 748 e 53) ora come sostenitore della tesi per cui ogni φαντασα intesacome criterio laquosecondo il qualeraquo egrave falsa (M 7388 e 399) infine come negatore delvero insieme a Monimo il Cinico (M 85) Anche Senofane egrave introdotto da un latocome negatore del criterio di veritagrave (qui e in M 714 48 49 53) dallrsquoaltro come suosostenitore sotto forma di ragione opinativa (ad esempio in M 7110)
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
cessario in PH per completare lo schema dossografico relativo aidifensori dellrsquointelletto in virtugrave del quale alcuni sostengono lrsquoesi-stenza delle cose altri invece la loro non esistenza nello schemapolare proposto da Sesto solo Gorgia poteva rispondere a que-strsquoultimo requisito Seguendo il suo amore per le simmetrie e glischemi enumerativi Sesto distingue poi il criterio di veritagrave in laquoco-muneraquo laquoparticolareraquo e laquoparticolarissimoraquo o logico Questrsquoultimoinclude ogni criterio di apprensione di ciograve che egrave non evidente eviene ulteriormente distinto in criterio laquodal qualeraquo laquoper mezzo delqualeraquo e laquosecondo il qualeraquo si apprende il vero La sezione per noiinteressante egrave quella che tratta del criterio laquoper mezzo del qualeraquosi accede alla veritagrave (PH 248ndash69) sulla natura di esso esiste un in-finito disaccordo tra i dogmatici che lo identificano ora con i sen-si ora con lrsquointelletto ora con entrambi secondo lo schema tri-lemmatico spesso adottato da Sesto
Tra i sostenitori dei sensi non egrave citato esplicitamente alcun fi-losofo ma vi si distinguono coloro per i quali tutte le percezionisensibili sono vere (ad esempio Protagora ed Epicuro) e coloroper i quali solo alcune sono vere ed altre false (e qui si allude sul-la base del confronto con M 7369 e 388 a peripatetici stoici e ac-cademici) Tra i fautori dellrsquoesistenza di sensi e intelletto congiun-tamente considerati criteri di conoscenza della realtagrave sono citatiDemocrito ed Eraclito che sulla base del medesimo criterio per-vengono perograve a conclusioni opposte Infine tra i sostenitori del-lrsquointelletto sono menzionati Gorgia per il quale niente esiste e glianonimi difensori dellrsquoesistenza della realtagrave che esso giudica Tut-tavia mentre a proposito dei sensi Sesto si interrogava esclusiva-mente sulla loro affidabilitagrave cioegrave non si chiedeva se essi esistesse-ro ma solo se esistessero le cose cosigrave come essi le percepiscono nelcaso dellrsquointelletto si interroga prima di tutto sulla sua esistenzapoi sulla sua affidabilitagrave Sesto elimina infatti lrsquointelletto come cri-terio attraverso una duplice argomentazione in primo luogo selrsquointelletto egrave il criterio di conoscenza di cui dobbiamo verificareesistenza e validitagrave non puograve essere assunto come criterio per ri-solvere la διαφωνα quanto alla sua stessa esistenza pena la cadu-ta nella petitio principii di qui la delegittimazione della posizionedi Gorgia (PH 257) In secondo luogo anche ammettendone lrsquoesistenza come criterio epistemico secondo quellrsquoargomentareconcessivo cosigrave caro a Gorgia ben prima che a Sesto risulta im-possibile dirimere lo scontro tra i diversi intelletti difesi dai diver-
353Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
si pensatori (PH 259) Riproponendo lo schema trilemmaticoSesto individua infatti tre possibili δξαι giustificate dallrsquointellettoquella di Gorgia per il quale niente esiste quella di Eraclito per ilquale tutto esiste e quella di quanti sostengono lrsquoesistenza di al-cune cose e non di altre
Drsquoaltra parte in PH 264 Gorgia compare come sostenitoredella tesi per cui non bisogna seguire neacute sensi neacute intelletto asser-zione che egrave apertamente in contrasto con quanto detto in prece-denza (lrsquointelletto egrave per il sofista criterio di veritagrave) ma che in seacutesembra riecheggiare lrsquoatteggiamento aporetico della tesi gnoseolo-gica del PTMO Gorgia infatti deve presupporre lrsquointelletto qua-le criterio logico per fondare la veritagrave della propria asserzione se-condo cui niente esiste dunque neppure sensi e intelletto A Sestonon interessa la coerenza del resoconto dossografico consideran-do nellrsquoinsieme la sua testimonianza sul sofista in PH 2 si po-trebbe pensare piugrave che a un collage di tradizioni divergenti e inverosimilmente compresse nello spazio di poche righe a unrsquooriginale elaborazione dello scettico secondo il quale partendodallrsquoargomento gorgiano per cui niente egrave va da seacute che neppure isensi e lrsquointelletto sono ancor meglio si puograve ipotizzare unrsquoassimi-lazione operata da Sesto tra le due prime tesi del PTMO quellaper cui niente egrave e quella per cui nulla egrave conoscibile proprio in virtugravedellrsquoassenza di un criterio veritativo
Lrsquoaspetto piugrave rilevante egrave lrsquoinserimento di Gorgia nellrsquoambitodi un confronto con altri pensatori dogmatici ognuno dei qualiportavoce di una propria δξα inconciliabile con quelle altrui nel-lo scontro lsquodiafonicorsquo che ne consegue lo scettico giunge alla so-spensione dellrsquoassenso Assentire a un certo tipo di intelletto in tesocome strumento attraverso il quale giudicare della veritagrave o falsitagraveequivarrebbe infatti ad accettare lrsquoesistenza di ciograve che egrave invece og-getto di indagine mentre chiamare in causa un criterio esterno perdirimere la controversia significherebbe falsificare lrsquoasserzione ini-ziale secondo cui lrsquointelletto egrave lrsquounico criterio Sesto non mira asmascherare le incongruenze dellrsquoargomentare di Gorgia bensigrave ainserirlo in un orizzonte di confronto-scontro con altri filosofi incui il sofista sembra dar voce a una forma di dogmatismo negativo
354 Rober ta Io l i
62) Sullrsquoimpiego scettico dellrsquoargomento della διαφωνα si veda J Barnes Laδιαφωνα pyrrhonienne in A J Voelke (ed) Le Scepticisme antique Perspectiveshistoriques et systematiques Genegraveve Lausanne Neuchacirctel 1990 97ndash106
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
comunque pericoloso per la 13ταραξα del pirroniano62 Spessonella presentazione realizzata da Sesto i medesimi filosofi sono in-trodotti diversamente in rapporto alle diverse esigenze dimostrati-ve e nella cornice scettica delle Ipotiposi Gorgia egrave una voce tra lealtre inserita nel contesto del pensiero dogmatico con le sue anti-nomie irrisolvibili A lui possiamo attribuire con sicurezza la tesiontologica per cui niente egrave enunciata sinteticamente in PH 257 e59 e possiamo anche rintracciare unrsquoeco della sua seconda tesi inPH 26463 dove lrsquoesclusione di sensi e intelletto quali criteri di ve-ritagrave trova parziale corrispondenza in M 781 e in MXG 980a18ndash19A Sesto si deve invece la selezione argomentativa operata sul testogorgiano con accentuazione ora del tratto dogmatico ora di quel-lo autoconfutante la sua elaborazione dossografica mira a colloca-re ogni dottrina in uno schema perfettamente equilibrato ed esau-stivo da lui costruito per legittimare solo la disposizione efetticadel pirroniano
Conclusioni
Diversamente da quanti vedono in Sesto un semplice copistao nel migliore dei casi un laquocreative copyistraquo64 e considerano le di-versitagrave nella trattazione degli autori come un mero effetto della di-versitagrave delle fonti utilizzate ritengo che egli intervenga in modoconsapevole sui testi da cui attinge riformulandone talvolta le tesia seconda delle proprie finalitagrave dimostrative e polemiche65 cosigravenel caso di Gorgia e di altri pensatori che dovevano essere ben pre-senti a Enesidemo Sesto avrebbe privilegiato un atteggiamento purista e selettivo rifiutando di riconoscere quali antesignani delpirronismo filosofi accolti invece dal suo predecessore A tal finerisponderebbero alcune scelte di Sesto nella trattazione del pensie-ro di Gorgia lagrave dove come in PH 2 ne accentua la posizione au-tocontraddittoria in riferimento alla δι9νοια o dove come in M 7
355Gorgia Scettico
63) Cosigrave egrave anche per Calogero (come n 1) 251 n 5764) J Barnes Diogenes Laertius IX 61ndash116 ANRW II 366 1990 4241ndash301
4260 n 13165) In proposito rimando a Classen (come n 10) 71 e E Spinelli Sextus Em-
piricus the Neighbouring Philosophies and the Sceptical Tradition (again on PH I220ndash225) in J Sihvola (ed) Ancient Scepticism and the Sceptical Tradition Hel-sinki 2000 35ndash61 35ndash6
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico
omette argomenti e tecnicismi in cui la prossimitagrave tra il sofista e lascepsi potesse compromettere la supremazia teoretica di questrsquoultima
Nella sua strategia generale il PTMO appare come un eserci-zio del λγος confutatorio che negando le pretese assolutistichedelle ontologie precedenti ma anche le forzature epistemiche delrelativismo protagoreo lascia intravedere la possibilitagrave che di filo-sofia si possa parlare solo nel processo dialettico del pensiero66tale esito aporetico dovette aver colpito in modo profondo gli scet-tici cosigrave da indurre Sesto e prima verosimilmente Enesidemo adedicare a Gorgia una lunghissima trattazione pur senza fare delsofista un pirroniano ante temporem Anche nello scetticismo siassiste allrsquoapparente paradosso di un discorso filosofico (dunqueper sua natura espressione di δξαι) che si esprime nellrsquoastensio-ne da qualsiasi asserzione dogmatica Tuttavia Gorgia non egrave unoscettico che confuti in assenza di credenze neacute si preoccupa di evi-tare un atteggiamento dogmatico evidente anzi nel proprio ri-vendicare una precisa posizione teoretica Semmai il λγος del so-fista sembra imporsi nella laquovertiginosa incertezza di seacuteraquo67 Gorgianon ci offre una scala da gettare una volta utilizzata (secondo la fa-mosa metafora pirroniana) ma recuperando la provocatoria im-magine di Wardy ci induce forse a camminare sospesi in aria Nonsaragrave casuale neppure il ruolo cruciale rappresentato dalla metaforaλγοι-φ9ρμακα in Sesto lo scettico se ne serve infatti in PH 3280ndash1 per evocare il potere terapeutico del λγος pirroniano in gradodi curare lrsquoanima dallrsquoavventatezza e dalla precipitazione dei dog-matici Ben diversamente da Sesto Gorgia a nostra conoscenzaprimo formulatore di questo nesso metaforico (Hel 14) offre conla sua orazione lrsquoesempio di un λγος non terapeutico ma am-morbante come quello che incantograve la bella Elena con la sua peri-colosa malia o quello che lo stesso retore Gorgia pronuncia difronte a un uditorio paralizzato dal potere persuasivo della paro-la La forza autoespungente del λγος pirroniano graduato in basealla gradualitagrave del male e che non lascia traccia se non nel benesse-re della liberazione da false credenze (PH 2188) rappresenta al-
356 Rober ta Io l i
66) Per una lettura lsquodialetticarsquo del PTMO si vedano anche G StrikerMethods of sophistry in Ead Essays in Hellenistic Epistemology and EthicsCambridge 1996 3ndash21 e S Consigny Gorgias Sophist and Artist Carolina 2001
67) Wardy (come n 1) 24
lora un rovesciamento antifrastico della parola di Gorgia che allastregua di un φ9ρμακον resistente si insinua nellrsquoanima e la mo-della come tavoletta di cera
Cesena Rober ta Io l i
357Gorgia Scettico