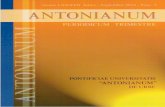Interpretacion articulo 296 Constitucion periodo de los rectores CNE
296.La presenza imperiale nelle città del Picenum tra l’epoca augustea e il regno dei Severi: un...
Transcript of 296.La presenza imperiale nelle città del Picenum tra l’epoca augustea e il regno dei Severi: un...
MARC MAYER
LA PRESENZA IMPÉRTALE NELLE CITTA
DEL PICENUM TRA L'EPOCA AUGUSTEA
E IL REGNO DEI SEVERI:
UN PRIMO APPROCCIO
Estratto da:
ATTI DEL XLI CONVEGNODI STUDI MACERATESI
Abbadia di Fiastra (Tolentino) 26-27 novembre 2005
tipografía san giuseppe - pollenza (me) - 2007
MARC MAYER
LA PRESENZA IMPERIALE
NELLE CITTÁ DEL PICENUM
TRA L'EPOCA AUGUSTEA E IL REGNO DEI SEVERI:
UN PRIMO APPROCCIO
In questo colloquio tratteremo solo sintéticamente untema che merita di certo un maggiore approfondimento eun'indagine in un contesto geográfico piü ampio di quellopreso in considerazione che comprenda, come minimo, anchele regioni limítrofe. In questa sede, per attenerci al tema delconvegno, ci limitiamo ai dati la regio V della divisione augu-stea e ad un'analisi degli ambiti urbani. Lasciamo per un'altraoccasione la presentazione del piú ampio studio preliminaredal quale sonó tratti i dati che qui presentiamo. Per completa-re il panorama é comunque necessario, almeno in taluni casi,fare riferimento ad alcuni di questi nuclei limitrofi.
Ad introduzione del lavoro va detto che la documenta-zione del Picenum non é distinta né risulta incoerente rispettoa quella che conosciamo per le altre regioni d'Italia e perbuona parte delle province piü antiche dell'impero.
Va sottolineato, inoltre, che il nostro lavoro non vuole inalcun modo essere uno studio del culto imperiale o della reli-giositá nella quale questo si iscrive (1), e tantomeno vuole
(1) In genérale vedi D. FISHWICK, The Imperial Cult in the Latín West, I-II,Leiden 1987-1992 (= «EPRO», 108), e, a complemento, dello stesso autore:The Development of the Provincial Ruler Worship in the Western Román Empire, in
28 MARC MAYER
riflettere il complesso processo di interventi del potete impe-tiale e delle iniziative degli stessi impetatoti nelle vane cittá;afftontiamo, invece, una questione moho piü sfaccettata petla quale é necessatio ptendete in considetazione i documentiatcheologici, soptattutto quelli telativi agli aspetti utbanisti-ci e all'edilizia pubblica e la loto cronología. E cetto chiato atutti che ci tifetiamo ad un petiodo che va dal I secólo d.C.sino all'epoca dei Seveti con patticolate attenzione all'etá giu-lio-claudia (2) e a quella ttaianea ed antonina. Non ttattete-mo neanche dell'epigtafia viatia, in patticolate dei miliati,che sottendono altti parametti di compottamento e interven-ti di tipo diverso (3).
Elemento essenziale del nostto studio é l'epigrafia anche se,owiamente, é necessatio tenere contó della scultura, ad esempiodei titratti imperiali; in questi casi l'iconogtafia ptesupponequasi sicutamente l'esistenza di epigrafía e viceversa (4).
ANRW II, 16. 2, pp. 1201-1253. É un classico limitato ad una zona dell'im-peto: R. ETIENNE, Le cuite imperial dans la péninsule ibérique d'Auguste aDiodétien, Patis 19742, (1a ed. Paris 1958). Un stato della questione é presen-tato nel lavoro di sintesi di H. HÁNLEIN-SCHÁFER, Veneratio Augusti. EineStudie zu den Tempeln der ersten romischen Kaiser, München 1985. Pet l'Oriente éutile: S.R.F. PRICE, Rituals and Power. The Román imperial cult in Asia Minar,Cambtidge 1984. Piü di recente sul culto provinciale D. FISHWICK, TheImperial Cult in Latín West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of theRomán Empire, III, 1: Institution andEvolution, Leiden, Boston, Koln 2002; Part2: The Provincial Priesthood, Leiden, Boston, Koln 2002; E HURLET, Les colle-gues du prime au temps d'Auguste et de Tibére: de la regalité républicaine a la légiti-mité dynastique, Roma 1996 («CEFR», 227), pp. 415-538, spec. 486-497,511-531, con un importante inventario delle iscrizioni e statue conosciute intutto l'impero pp. 573-600 e 601-612. Una bibliografía piü completa in M.MAYER, Las dedicatorias a miembros de la domus Augusta julio-daudia y su soporte:una primera aproximación, in XIII Rencontre sur l'épigraphie du monde romain.Contributi all'epigrafía d'eta augustea. Macérala 9-11 setiembre 2005, Tivoli2007, pp. 171-199, con esempi dal Picenum.
(2) Cfr. ad esempio la sintesi di I. COGITORE, Series de dédicaces italiennes a ladinastie julio-claudienne, in «MEFR Ant.» 104 (1992), pp. 817-867; o ilsostanziale aumento di esempi che rappresenta per una sola cittá S. CONTI,Dinastía giulio-claudia a Reselle: una serie di dediche imperiali in Etruria, in«Ann. Pac. Lett. e Filos. Univ. Siena» 18 (1997), pp. 101-127.
(3) A. DONATI, / miliari delle regioni IV e V dell'ltalia, in «Epigraphica»XXXVI (1974), pp. 65-222.
(4) Cf. per i gruppi scultorici: D. BOSCHUNG, Gens Augusta. Untersuchungen
LA PRESENZA IMPERIALE NELLE CITTÁ DEL PICENUM 29
II nostro procedimento, come risulta sempre in questicasi, é relativamente arbitrario. Di fronte alia possibilitá dianalizzare i dati delle cittá per ordine alfabético o per situa-zione geográfica abbiamo optato per quest'ultima soluzione.Di conseguenza abbiamo analizzato il materiale procedendoda sud a nord e per frange che vanno da est ad ovest, nei casiin cui in questo ámbito territoriale vi sia piú di un sito.
II primo núcleo che ci restituisce delle infórmazioni éHadria. Da questa cittá provengono solo due dediche, una aMarco Aurelio e una, come purtroppo accade frequentementein questa zona, non piü attribuibile (5).
Interamnia Praetuttiorum, l'attuale Teramo, ci offre unatestimonianza indiretta della presenza imperiale attraverso lamenzione di una sacerdos Augustarum (6). Da Campli, forseVolanum, proviene una importante testimonianza che atiestail culto del Divus lulius iniziato per disposizione del PopulusRomanus in virtü della Lex Rufrena (7).
II caso di Ascoli, Asculum Picenum, é singolare poichépresenta alcune rilevanti particolaritá come la presenza diAugusta/es VI viri Tiberiales o a volte, piü semplicemente, VIviri Tiberiales, oltre ad alcune iscrizioni di non facile attribu-zione dedicare ad imperatori (8). Al contrario non vi é dub-
zu Aufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch-claudiscbenKaiserhauses, Mainz a. R. 2002, («Monumenta Artis Romanae», XXXII).Inoltre C.B. ROSE, Dynastic Commemoration and Imperial Portraiture in thejulio-Claudian period, Cambridge 1997; D. BOSCHUNG, Die Bildungstypen der iuliscb-claudischen Kaiserfamilie: ein kritischer Forschungsbericht, in «Journ. Rom. Arch.»6 (1993), pp. 59-00; Z. Kiss, L'iconographie des princes julio-claudiens au tempsd'Auguste et de Tibere, Varsovia 1975; limitatamente al fondatore dell'impero:D. BOSCHUNG, Die Bildnisse des Augustus, Berlin 1993, e per il caso di Liviacfr. E. BARTMAN, Portraits of Livia. Imaging the Imperial Woman in AugustanRome, Cambridge 1999 e A. ALEXANDRIDIS, Die Fraven des romischen Kaiser-hauses. Eine Untersucbung ihrer bildlichen Darstellung von Livia bis Julia Domna,Mainz 2004. Inoltre: P. ZANKER - H. VON HESBERG, Archaologische Denkmálerzum romischen Kaiserkult, in ANRW, II, 16. 2, Berlin, New York 1978, pp.911-995.
(5) C.I.L. IX 5013 e 5014 rispettivamente.(6) C.I.L. IX 5068 = 6147.(7) C.I.L. IX 5136, nella chiesa di S. Pietro a Campovalano.(8) Su Asculum Picenum: Asculum I., Pisa 1975 con gli studi di U. LAFFI,
30 MARC MAYER
bio sulla dedica a Domitia Lucillo. (9), che deve essere collega-ta agli onori collettivi caratteristici degli ultimi antonini.
II légame di Cupra Marítima con la gens giulio-claudiatrova un elemento marginale ma importante nella dedicafatta nel 9 a.C. da Tiberio Claudio Nerone, padre di Tiberio eprimo marito di Livia (10). I materiali conservad (11) dellacittá rivelano una serie di dati importanti, anche se nonesclusivi né eccezionali; dobbiamo ricordare, ád esempio, lapresenza di Fasti consulares, come nel caso di Vrbs Salvia, e diun Kalendarium (12). Un fattore distintivo é costituito dall'e-sistenza di un tempio dedicato alia Dea Cupra e restaúrate daAdriano (13). Le iscrizioni dedícate alia domus imperiale sem-
Storia di Asco/i Piceno nell'etá antica, e di M. PASQUINUCCI, Studio sull'urbanística diAscoli Piceno romana. Atlante dei beni culturali di Ascoli Piceno e i Fermo. Beni archeo-logici, a cura di G. DE MARINIS - G. PACÍ, Cinisello Balsamo 2000. Per l'epigra-fia: P. BONVICINI, Iscrizioni latine della quinta regio Italiae, in «Rend. Accad.Naz. Lincei» ser. VIII, XXVII (1973), pp. 195-205; su una iscrizione della cat-tedrale di Ascoli relativa ad uno dei primi imperaron G. PACÍ, Note di epigrafíaascolana, II: iscrizioni di nuova e vecchia acquisizione, in «Picus» XX (2000), pp. 7-49. Sui seviri Tiberiales, cfr. G. PACÍ, La dedica incompiuta al Genius di Tiberio daTuficum, in «Picus» XXIII, 2003, pp. 139-151, spec. p. 149 e Note di epigrafíaascolana: i sacerdoti del culto imperiale, in «Picus» XIX (1999), pp. 7-27, la formaé: Aug(ustalis) VI vir Tibe{er(ialis)} o semplicemente VI vir Tiberíalis. Cfr. per leiscrizioni imperiali: C.l.L. IX 5181, di imperatore incerto; C.l.L. IX 5183, dialtro imperatore incerto e C.l.L. IX 5184: AVG. ET CONST[—].
(9) C.l.L. 1X5182.(10) C.l.L. IX 5308.(11) In genérale cfr. A. MASTINO, La lavóla di patronato di Cupra Marítima
(Piceno) e le relazioní con Basa (Sardegna), in «Picus» XII-XIII (1992-1993),pp. 109-125; B.F. MOSTARDI, Cupra, Ascoli Piceno 1977, per l'epoca romanapp. 105-176; P. FORTINI, Cupra Marítima: origini, storia, urbanística, AscoliPiceno 1981; G. PACÍ (cur.), Cupra Marittima e il suo territorio in eta antica.Atti del Convegno di Studi. Cupra Marittima 3 maggio 1992, Tivoli 1993(«Picus», Suppl. II).
(12) C.l.L. IX 5286 - 5293 e add. ad 5287, p. 687; l.lt. XIII 1, Roma1947, n. 7, pp. 243-248 e add. p. 572; G. PACÍ, Fasti cuprensi ed origine dellaciña romana di Cupra Marittima, in PACÍ (cur.), Cupra Marittima..., pp. 71-82;MOSTARDI, Cupra..., p. 128, per un frammento nel Museo di CupraMarittima. Per il Kalendarium cfr. l.lt. XIII 2, Roma 1963, n. 9, p. 69; G.PACÍ, A proposito di un nuovo frammento del calendario romano di Cupra Marítima,in «Annali Pac. Lett. e Filos. Univ. Macerara» XIII (1980), pp. 281-295.
(13) C.l.L. IX 5294 si trova a Grottamare nella chiesa di San Martino cfr.MOSTARDI, Cupra..., pp. 129-130, Atlante..., p.108, con fotografía.
LA PRESENZA IMPÉRTALE NELLE CITTÁ DEL PICENUM 31
bra abbiáno inizio in época giulio-claudia e continuano inquella antonina con una dedica a Marco Aurelio e successiva-mente a un imperatore della dinastía dei Severi (14); nonmanca in época tarda una dedica a Valeria, figlia diDiocleziano e moglie di Massimino a riprova di un'abbon-danza e continuitá della tradizione di onori imperiali dellaquale abbiamo solo poche attestazioni (15).
Falerio Picenus, Falerone, ha una notevole serié di dedicheimperiali vincolate con ogni verosimiglianza ad importantiedifici conservad che denotano l'importanza della cittá (16).Un rescritto di Domiziano, inciso in una tabula asma, oggiperduta, dava informazioni circa un processo tra i Firmani e iFalerienses (17). Si tratta di una delle poche testimonianze nelterritorio preso in esame dei frequenti interventi amministra-tivi degli imperatori nei litigi tra le diverse comunitá.D'altro canto nella cittá Adriano porta a termine un'impor-tante opera viaria, vía nova per médium forum pecuarium fatta exconlatione manipretii dai collegia locali (18). Gli onori tributatiai membri della casa regnate iniziano, secondo la documenta-zione conservara, con Gaio Cesare nel teatro (19) e continua-no con Claudio (20), Nerva e Antonino Pió. In quest'ultimo
(14) C.I.L. IX 5297, 5298 e 5299 rispettivamente.(15)C./.L. 1X5324.(16) In linea genérale vedi L. PUPILLI, // territorio del Piceno céntrale dal tar-
doantico al medioevo. Dall'otium al negotium, Ripatransone 1996; G. PACÍ, Su unadedica falerionense a M. Claudio Marcello Esernino, in Ottava Miscellanea Greca eRomana, Roma 1982, pp. 267-283 (= G. PACÍ (cur.) Scritti su Falerone romana,Tivoli 1995, pp. 315-330), con un buon stato della questione.
(17) C.I.L. IX 5420; cfr. Firmum Picenum I, a cura di L. POLVERINI-N.F.PARISE-S. AGOSTINI-M. PASQUINUCCI, Pisa 1987, in particolare lo studio di L.POLVERINI, Fermo in eta romana, pp.19-75, spec. pp. 41-43; PUPILLI, //territorio..., pp. 54-55 e p. 122 nota 305; CH. DELPLACE, La romanisation duPicenum. L'exemple d'Urbs Salvia, Roma 1993, p. 67.
(18) C.I.L. IX 5438, l.L.S. 5368, cfr. Atlante..., p. 112, fotografía trattadal Giornale degli Scavi del 1836 contenuta in un contributo del De Minicis;DELPLACE, La romanisation..., pp. 80-81.
(19) C.I.L. 1X5425.(20) C.I.L. IX 5426, cfr. L. GASPERINI, L'Augusteo di Fermo Piceno in un'epi-
grafe da rileggere, in «Annali Pac. Lett. Filos. Univ. Macerara» 10 (1977), pp.57-87, spec. p. 61, nota 6.
32 MARC MAYER
caso si tratta di una sacerdos di Faustina Maior che erige statuenel teatro (21). Sulla base di questa donazione di statue sipotrebbe supporre l'uso del teatro o delle aree annesse comeAugusteum ma soprattutto l'esistenza di un collegio sacerdota-le femminile destinato al culto di Faustina che senza dubbio,data la forte presenza degli Antonini nelle cittá della zona,non doveva costituire un'eccezione. Un'altra iscrizione, di cuiresta solamente la formula finale, ma tanto simile a quellaprecedentemente menzionata che si era supposto fosse partedella stessa, sembra proponesse una serie di onori simili resi,forse, alio stesso imperatore o a qualche membro della fami-glia imperiale nello stesso periodo (22). I Severi sonó attestatida una menzione di Commodo, onorato come princeps iuventu-tis (23). Di recente é stata anche rinvenuta una nuova dedicaalio stesso imperatore (24). La serie trova continuitá in épocapiü tarda con una notevole presenza di Volusiano (25).
Per il tema preso in esame Fermo, Firmum Picenum, ésenza dubbio uno dei centri piü importanti (26). Come a suotempo ha constátate L. Gasperini, Y Augusteum di FirmumPicenum (27) costituisce uno degli elementi piü rilevanti perquanto riguarda gli onori ricevuti in questa regio dai membridella casa imperiale, anche se il documento non permette disupporre la ricchezza di quello di Ferentis o Ferentum (28).con
(21) C.I.L. IX 5427, 5430 e 5428 dedicata ad Antonino Pió da AntoniaPicentina sacerdos, cfr. PUPILLI, // territorio..., p. 122, nota 304.
(22) C.I.L. IX 5429; PUPILLI, // territorio..., p. 59, fig. 71, e p.124 nota 327.(23) C.I.L. IX 5430; cfr. G. CERULLI IRELLI-?. MORENO, Alome iscrizioni di
Falerone, in «Arch. Class.» XIII (1961), pp. 159-167 (= PACÍ (cur.) Scritti suFalerone..., pp. 289-303, spec. pp .291-294).
(24) P. BONVICINI, Falertme. Iscrizioni romane inedite, in «Not. Scavi» 1958, pp.73-76, spec. p. 75, nr. 7 e PUPILLI, // territorio..., p. 59, fig. 72, e p. 124, nota 328.
(25) C.I.L. IX 5431 e 5432 in onore di Licinio Valeriano figlio diGallieno, PUPILLI, 11 territorio..., p. 59, fig. 73.
(26) C. COSTANZI-L. PUPILLI, Fermo. Antiquarium. Pinacoteca cívica, Bologna1990, (= «Musei d'Italia - Meraviglie d'Italia» 23), in particolare per il mate-riale iscritto PUPILLI, Fermo. Antiquarium..., pp. 94-113; POLVERINI-PARISE-AGOSTANI-PASQUINUCCI, Firmum Picenum /..., e per l'epigrafia e i sacerdoziPOLVERINI, Fermo in eta romana..., pp.19-75 e pp.50-64.
(27) Cfr. GASPERINI, L'Augusteo..., pp. 57-87.• (28)A.Ep. 1911, 184, cfr. GASPERINI, L'Augusteo..., p. 67.
LA PRESENZA IMPERIALE NELLE CITTÁ DEL PICENUM 3 3
la menzione di un foro e di un Augusteum con 69 statue, unaporttcus e un lacus realizzato da un accemus di Germánico. Eevidente che Firmum non va considerata come una particola-ritá per la zona anche se la precarietá della documentazioneconservata potrebbe suggerire questa interpretazione.
Tolentinum conserva un frammento di iscrizione dedicaraa Vespasiano; si tratta di uno dei pochi esempi della presen-zia dei Flavi nella zona (29). Un'iscrizione sembra esserededicara a Commodo, cui forse si puó attribuire un altropezzo epigráfico che contiene una damnatio (30).
II caso di Vrbs Salvia non presenta un panorama moltopiü ricco rispetto al tema trattato, anche se di recente éauméntate notevolmente grazie ai rinvenimenti sporadici eagli scavi archeologici. Da tempo é conosciuta un'iscrizionededicata a Claudio e conservata nell'Abbadia di Piastra (31).Piü recentemente si é potuto integrare un frammento iscrittorinvenuto negli scavi del santuario della Salus nel quale si éproposto di leggere maf\ri Nerones I publice, uno dei rarissimiesempi di epigrafía imperiale di época neroniana (32).Recentemente un rinvenimento sporadico e fuori contesto,ma sempre nelle vicinanze del tempio della Salus, ha permes-so di restituiré una dedica a un principe della famiglia giu-lio-claudia, forse Gaio Cesare, e almeno un altro frammentodi un'iscrizione imperiale inteterminata (33). La presenza diFasti triumphales mette in evidenza il ruólo fondamentale
(29) C.I.L. IX 6369, Suppl. It., n. s. 11, 2, p. 69, A. MASSI SECONDARI,Novita sulla topografía di Tolentino romana, in «Picus» VIII (1988), pp. 169-197,spec. p. 184, fig. 11.
(30) Suppl. It., n. s. 11, 4, p. 71, forse Commodo, e C.I.L. IX 6371, cfr.MASSI SECONDARI, Novita..., p. 183, fig. 12.
(31) C.I.L IX 5332. Cfr. G. PACÍ in G. FABRINI - G. PACÍ, La raccoltaarcbeologicapresso l'Abbazia di Piastra, Urbisaglia 1991, pp. 23-26.
(32) G. PACÍ, Fasti consolari ed altri frammenti epigrafía dagli scavi del cripto-portico di Urbisaglia (terza campagna, 1978), in «Not Scavi» 1981, pp. 59 —76,in CH. DELPLACE, Urbisaglia (Macérala) — Rapporto preliminare sulla terza campa-gna di scavo (1978) condolía a Urbs Salvia, in «Not. Scavi» 1981, pp. 37-76,spec. pp. 63-69, nr. 1 e nr. 2 e pp. 72-74, fig. 27, 4.
(33) M. MAYER, Frustula epigrapbica in Vrbe Salvia nuperrime reperta, in«Picus» XXVI (2006), pp. 377-386.
34 MARC MAYER
della cittá nel quadro dell'epigrafia della zona (34). É impor-tante sottolineare l'esistenza di ritratti notevoli imperialicome é il caso di quello di Augusto e di quello di Dmsusmaior entrambi conservad a Piastra (35).
Pausulae, presso l'odierna S. Claudio al Chienti, ha restitui-to un'iscrizione dedicata probabilmente ad Augusto, cui si ag-giunge una di recente acquisizione in onore di Commodo (36).
(34) Tra i molti lavori vedi in genérale. G. PACÍ, Vent'anni di studi urbisal-viensi (1970-1990), in «Picus» X (1990), pp. 71-97; S.M. MARENGO-G. PACÍ,Recenti acquisizioni storico epigrafiche nel Maceratese, in Atti del XXXVIIIConvegno di Studi Maceratesi, Abbadia di Piastra (Tolentino) 23 -24 Novembre2002, Pollenza 2004, pp. 297-319, spec. pp. 306-311 con bibliografíaaggiornata; E SARACENI, / Salvii e Urbs Salvia, Urbania 1958; G. PIERGIACOMI,Pneuentia — Urbs Salvia — Urbisaglia, Macerata 1964; G. PACÍ, Le prime testimo-nianze paleocristiane da Urbs Salvia, in «Picus» XXII (2002), pp. 282-288; E.CATANI, Monumenti funerari nell'agro urbisalviense, in Atti del XIII convegno diStudi Maceratesi (Abbadia di Piastra — Tolentino, 14-15 Novembre 1987) =«Studi Maceratesi» 23, 1990, pp. 121-162; U. MOSCATELLI, Urbs Salvia: lettu-ra preliminare di un territorio, ibidem, pp. 79-86; CH. DELPLACE, Evergétisme etconstruction publique dans la "regio V (Picenum)". A propos du théatre í/'Urbs Salvia,in «Picus» 10 (1990), pp. 101-106; G. PACÍ, Omphaloi da Urbs Salvia, in«Picus» XII-XIII (1992-1993), pp. 226-230; CH. DELPLACE, La romanisationdu Picenum. L'exemple d'Urbs Salvia, Roma 1993; L. BACCHiELLi-CH. DELPLACE-W. ECK-L. GASPERINI-G. PACÍ, Studi su Urbisaglia romana, Tivoli 1995; CH.DELPLACE, Rapporto preliminare sulle due prime campagne di scavo (1976-1977)condone ad Urbs Salvia - Urbisaglia (MC), in «Atti e Mem. Dep. Stor. patr.Marche» 85 (1980), pp. 7-35; G.M. FABRINI, L'area del Tempio- Criptoportico adUrbs Salvia, in «Picus» XX (2000), pp. 103-158; EAD. Nuovi contñbuti storico-archeologici dall'area del Tempio-Criptoportico e del Foro di Urbs Salvia, in «Picus»XXI (2001), pp. 9-35; EAD., Le origini di Urbs Salvia; /'/ contributo delle piürecenti indagini archeologiche, in «Picus» XXIII (2003), pp. 109-137; EAD.,Nuove evidenze monumentali nell'area forense di Urbs Salvia (Campagne di scavo2001-2004), in «Picus» XXV (2005), pp. 65-118; R. PERNA, Note di urbaní-stica urbisalviense, in «Picus» XVII (1998), pp. 193-207; M. LUNI (ed.),Archeologia nelle Marche. Dalla Preistoria all'Etá tardoantica, Firenze 2003, spec.pp. 148-153, con bibliografía; G.M. FABRiNi-G. PACI-R. PERNA (cur.), Beniarcheologici della provincia di Macerata, Pescara 2004, pp. 177-181 (ad opera diS.M. Marengo); E. CATANI, Scavi pontifici del 1777 nella Marca anconetana.Maraño, Reciña, Palerone, Urbisaglia, in L'antichitá classica nelle Marche traSeicento e Settecento. Atti del convegno (Ancana — Pesara 15-17 ottobre 1987),Ancona 1989, pp. 191-274.
(35) FABRINI, in FABRINI-PACI, La raccolta..., rispettivamente pp. 60-62 e63-67 e infra nota 63.
(36) C.l.L. IX 5792, A.Ep. 1981, 308, cfr. G. GIAMBUZZI, Iscrizioni latine
LA PRESENZA IMPERIALE NELLE CITTÁ DEL PICENUM 3 5
Trea offre un patrimonio epigráfico piü in accordo conquello che conosciamo nell'ambito territoriale preso inesame: una serie di frammenti attribuibili probabilmente aliadinastia giulio-claudia (37), una dedica ad Antonino Pió euna all!'Aeternitas della iuventus Vlpiana augusta, che senzadubbio é costituita dai giovani beneficiad dagli alimenta isti-tuiti da Traiano (38).
Ricina, Villa Potenza, la colonia Helvia Ricina Pertinax (39),vincolata al nome di un imperatore tanto importante quantoeffimero come é stato Elvio Pertinace, merita certamente unaparticolare attenzione. Augusto é noto grazie ad un rinveni-mento antico (40); il divus Traianus risulta legato al rifaci-mento delle terme (41) e Settimio Severo é onorato come con-ditor della colonia, che pero continua a portare il nome dicolui che é stato il benefattore anteriore, per un processo difedeltá alia memoria di Pertinace, del quale, come con gran-de sagacitá ha dimostrato S. Marengo (42), sembra non man-
dí San Claudio al Chienti (Macérala), in L. GASPERINI (ed.), Scritti starico epigra-fici in memoria di M. Zambelti, Roma 1978, pp. 167-174, spec. pp. 168-169,fig. XX, propone l'ipotesi che si tratti di Augusto divinizzato dopo il 14 d.C.Per Commodo: L. GASPERINI, Dedica dei Pausulani a Commodo mreggente dell'im-pero, in Studi sul mondo antico in memoria di Fulvio Grosso, Roma 1981, pp. 179-187;A.Ep. 1981,311.
(37) S.M. MARENGO, Trea, in Suppl. It., n.s. 18, Roma 2000, pp. 155-188.La numero 4 puó essere imperiale di época giulio-claudia; una datazione aná-loga puó essere proposta per i numeri 20, 22 e 23.
(38) C.I.L. IX 5644; MARENGO, Trea..., pp. 173-174 é dedicata aliaAeternitas iuventutis Vlpianae Augustae, la gioventü che ha beneficiato degli ali-menta di Traiano, cfr. P. VEYNE, Les aliments de Trujan, in Les empereurs romainsd'Espagne, París 1965, pp. 163-179.
(39)C./.L. 1X5755.(40) C.I.L. 1X5745.(41) C.I.L. IX 5746.(42) C.I.L. IX 5740, dove é cancellato il nome della cobors Vil praetoria,
che si era ribellata ed aveva partecipato all'assassinio di Pertinace nel 193 d.C.Forse si tratta della damnatio memoriae della coorte disciolta da Settimio Severodi cui non sappiamo se esistono altri casi. Cfr. S.M. MARENGO, Interpunzione ecancellature. Note a C.I.L. IX 5454, 5570, 5740, in «Picus» XX (2000), pp.223-243, spec. pp. 237-243, per questa ipotesi che ben si accorda con la rela-zione esistente tra Pertinace e la cittá C.I.L. IX 5755 i 5747. Sul tema delladoppia colonizzazione di Ricina si rimanda a C. Di GlACOMO, Iscrizioni latine
36 MARC MAYER
chino anche altre attestazioni nella stessa colonia. Anche ilrinnovamento del foedus dei Camertes (43) potrebbe celare daparte di Settimio Severo un'attitudine conservatrice dellostesso tipo.
Potentia, l'attuale Porto Recanati, presenta, per quantoriguarda i dati epigrafici e certe particolaritá istituzionali,tratti comuni con Vrbs Salvia (44). Le iscrizioni menzionanoprincipi della domus giulio-claudia, come é il caso di GaioCesare e forse di Lucio Cesare. Una tabula aenea, inoltre, ri-corda verosímilmente gli onori funebri resi a Druso il Gio-vane, figlio di Tiberio (45). Un sevir augustalis ha eretto unaltare con la rappresentazione del clupeus virtutis augusteo,recentemente ristudiato (46), che indica l'importanza delladevozione alia casa imperiale di Augusto nella zona. Infine,
del Museo cívico di Macerata, in L. GASPERINI (ed.), Scritti..., pp. 102-122,spec. pp. 113-114 e fig VIII, 1; cfr. D. CECHI - C. MOZZICAFREDDO, HelviaRicina e il Piceno nell'eta romana, in «Studi Maceratesi» IV (1968), pp. 126-214, spec. 199-
(43) C.l.L. IX 5631, l.L.S. 432, S.M. MARENGO, Camerinum, in Suppl. It.,n. s. 6, Roma 1990, p. 64; cfr. P. VEYNE, Foederati: Tarquinies, Camerinum,Capéne, in «Latomus» XIX (1960), pp. 429-436, spec. pp. 432-435, S.PANCIERA, Ficolenses foederati, in «Riv. Stor. dell'Antichitá» 6-7 (1976-1977) =Scritti in memoria di Gianfranco Tibiletti, pp. 195-213, spec. pp. 210-212.
(44) Cfr. W. EcK-G. PACI-E. PERCOSSI, Per una nuova edizione dei FastiPotentini, in «Picus» XXIII (2003), pp. 51-108; FABRINI-PACI-PERNA (cur.),Beni..., p. 51, fig.51, fotografía; p. 53, fig. 53, fac-simile dei Fasti. C.l.L. IX5808. G. PACÍ, Potentia (Porto Recanati): l'iscrizione dei praetores, in «Picus»XXI (2001), pp. 191-197; DELPLACE, La romanisation..., pp. 236-238. Uncalendario molto importante é in C.l.L. IX 5808.
(45) G. PACÍ, Ñuove iscrizioni romane da Potentia (Porto Recanati), in«Picus» XXII (2002), pp. 169-231, spec. pp. 171-176, nr. 1, onori funebri diDruso il giovane figlio di Tiberio in una tabula bronzea; pp. 184-185, nr. 4,Gaio Cesare; pp. 186-187, nr. 5 forse frammento di un'epigrafe dedicata aLucio Cesare. Una mostra curata da E. PERCOSSI SERENELLI, Potentia. Quandopoi scese il silenzio. ..Rito e societa in una colonia romana, Milano 2001, ha datoorigine a nuovi studi come quello di G. PACÍ, Iscrizioni romane di Potentia, pp.88-105.
(46) C.l.L. IX 5811: Primus Marc[—]/ Vivir au(g) I S.P.Q.R. /Augusto deditIdupeum virtutis lclementiae{ius}t{itiae I \_-~\pietatis cama}; cfr. S. ANTOLINI,L'altare con il clupeus virtutis da Potentia, in «Picus» XXIV (2004), pp. 9-28,con nuovo testo definitivo: [pietatis erga déos} I patr\iamq(ue)~\, il testo era dedi-cato dai seviri augúrales; DELPLACE, La romanisation..., pp. 236-238.
LA PRESENZA IMPERIALE NELLE CITTÁ DEL PICENUM 3 7
un frammento rinvenuto in occasione degli ultimi scavi,potrebbe essere pertinente ad un'iscrizione imperiale (47).
Cingulum, offre poche attestazioni per il periodo preso inesame (48). Infatti sonó noti solo un prowedimento ex iussu,ordinato da Augusto (49), e un'iscrizione dedicata adAdriano (50).
Da Planina, oggi identificata con S. Vittore di Cingoli, énota solo un'iscrizione imperiale incerta, datata alI-II secólod.C., attribuibile, pero, per le sue caratteristiche formali piúprobabilmente ad época giulio-claudia (51).
Auximum, che possiede un importante corredo epigráfico,si limita, per quanto concerne il nostro tema, a documentarela serie di imperatori del II secólo d.C. a partiré da Traianosino a Marco Aurelio e Lucio Vero (52).
La documentazione di Cupra Montana corrisponde aquanto ci si aspetta: Gaio Cesare (53) e Antonino Pió, proba-bilmente in due iscrizioni, ammesso che nella seconda non sitratti di un altro imperatore antonino (54), oltre ad un prince-ps iuventutis dello stesso periodo, forse Commodo, come nelcaso di Falerio Picenus (55).
(47) PACÍ, Nuove..., nr. 14, pp. 194-196.(48) G. PACÍ, Cingulum, in Suppl. It., n. s. 6, Roma 1990, pp. 37-53; G.
PACÍ, S. Vittore di Cingoli, in Suppl. It., n. s. 22, Roma 2004, pp.147-151.(49) Paci, Cingulum, cit., p. 44, un iussus d'Augusto.(50) C.I.L. IX 5681, PACÍ, Cingulum..., p. 44; S. M. MARENGO-F.
CANCRINI - CH. DELPLACE, L'energetismo nella regio V (Picenum), Tivoli 2000 (=«Picus» Suppl. VIII), pp. 142-144.
(51) G. PACÍ, Iscrizioni romane da S. Vittore in Cingoli, in «Picus» VI (1986),pp. 99-126, spec. nr. 4, p. 112: pont}if'ma{x trib}unicpo{t, lastra persa. G. PACÍ,S. Vittore di Cingoli, in Suppl. It., n. s. 22, pp. 153-159; G. PACÍ, Un municipioromano a S. Vittore di Cingoli, in «Picus»VIII (1988), pp. 51-69; G. PACÍ, S.Vittore di Cingoli, in Suppl. It., n. s. 8, Roma 1991, pp. 73-88, in particolare lanr. 6 a p. 82, iscrizione imperiale incerta di I-II sec. d.C. ma probabilmenteattribuibile ad época giulio-claudia per lo spessore e le dimensioni della lastra.
(52) C.I.L. IX 5825, 5826, e 5827. Su Auximum cfr. G.V. GENTILI, Auximum(Osimo) Regio V - Picenum, Roma 1955, pp. 148-151; ID., Osimo nell'Antichita. /cimeli archeologici nella cívica raccolta d'arte e il Lapidario del Comune. Catalogo-Guida, Casalecchio di Reno 1990, pp. 32-36, 73-74, tav. 19-20.
(53)C./.L. 1X5703.(54)C./.L. IX 5700 e 5701.(55)C7.L. 1X5702.
38 . MARC MAYER
Rimane, infine, Ancona, dove si trova lo spettacolarearco che testimonia gli onori resi a Traiano, a sua moglie Plo-tina e a sua sorella Marciana (56). La cittá offre anche te-stimonianze di onori attribuiti ai giulio-claudi (57), adAntonino Pió o Adriano (58), a Lucio Vero (59) e, in épocaseveriana, a Geta (60). Di nuovo un orizzonte coerente con ladocumentazione della maggior parte delle cittá della regione,senza pero che si distacchino singolaritá in una cittá tantocosmopolita e rivolta verso Oriente a tal punto da meritareun nuovo porto traianeo.
Per concludere possiamo presentare delle considerazionigenerali alia luce del materiale epigráfico preso in esame.Innanzitutto il fenómeno degli Augustea (61) si configurasempre piü come elemento comune a buona parte delle cittáa misura che si avanzi sia nell'indagine archeologica dellestesse che nello studio del materiale epigráfico, specialmentequello frammentario, presente in esse. L'attestazione di onoritributati ai principi giulio-claudi costituisce un buon indizioe le iscrizioni dedicare a Gaio e Lucio Cesare sonó un indica-tore di primo ordine. Le consegne di onori funebri si sonófatte pubbliche (62) e sonó state seguite nella maggior parte
(56) C.I.L. IX 5894, cfr. LUNI, Anheologia..., pp. 268-270 figg. 107,110 i 112(57) C.I.L. IX 5896.(58) G. PACÍ, Frammento di iscrizione monumentale da Ancona, in «Picus»
XVI-XVII (1996-1997), pp.249-253.(59) L. GASPERINI, Spigolature epigraficbe marchigiam (I-III), in «Picus» I
(1981), pp. 41-64, spec. pp. 44-4, fig. 2 con l'immagine del manoscritto diAnnibaldi.
(60) C.I.L. 1X5695.(61) I.G. XII 58, un decreto di Mitilene datato generalmente tra 27 e il 18/17
a.C. costituisce il documento piü antico e menziona, tra gli altri, anche monu-menti e templi nella stessa Mitilene, a Pergamo e a Actium, Brundisium, Tarraco,Massilia e Antiocbia adDapbnem, cfr. GASPERINI, L'Augusteo..., pp. 68-69.
(62) Si veda ad esempio il decreto dei decurioni di Pisae del 2 d.C. suglionori da rendere a Lucio Cesare, C.I.L. XI 1420, I.L.S. 139, e il decreto del 4d.C. relativo a Gaio Cesare, C.I.L. XI 1421, I.L.S. 140. In genérale J.-C.RICHARD, Recherches sur certains aspects du cuite imperial: Leí funerailles des empe-reurs Romains aux deux premien siecles de notre ere, in ANRW II, 16, 2, Berlin,New York 1978, pp. 1121-1134.
LA PRESENZA IMPERIALE NELLE CITTA DEL PICENUM 39
delle cittá, come d'altra parte dimostra la circolazione delsenatoconsulto che stabilisce gli onori che devono essere resia Germánico. In questo caso é evidente quanto sia importan-te focalizzare l'attenzione sugli elementi scultorei; la galleríadi ritratti della vicina Aesis, Jesi, da cui provengono altreiscrizioni giulio-claudie (63) non si deve assolutamente con-siderare un caso isolato. Non si osserva nessun elemento vin-colato alia rifbrma neroniana nella forma di presentazionedella domus Augusta come peraltro accade anche nelle zonelimítrofe a quella presa in esame. Va sottolineato, inoltre, chequesto momento é sicuramente un chiaro antecedente diquello che accadrá piú tardi in época flavia.
Risulta evidente l'assenza quasi totale di dati relativiall'epoca flavia, fatto che pero non va soprawalutato; infatti idati dipendono sempre dalla casualitá dei rinvenimenti epi-grafici. É chiaro che i Flavi devono essere stati moho presentinella zona e per questo non é possibile interpretare in sensonegativo il silenzio delle fonti epigrafiche.
Al contrario nelle cittá del Piceno balza all'occhio l'ab-bondanza delle testimonianze relative a Traiano e alia dina-stia antonina ed é importante segnalare che esistono fortiindizi della presenza di gruppi di iscrizioni in onore dellafamiglia di Marco Aurelio simili a quelli noti da zone vicinee da molti altri punti dell'impero.
Una menzione speciale merita il probabile intervento diPertinace nella zona, sicuramente a Ricina, che non deve dicerto essere stato un fatto isolato ma che deve avere i suoiparalleli in altre zone.
Settimio Severo sembra aver seguito in questa regio unapolitica particolare, forse in continuitá delle iniziative di
(63) C.I.L. XI 6199-6202, Aesis, Jesi. Per le statue di Aesis cfr. L. SENSI, IIciclo di ritratti imperiali giulio-daudi di Jesi, in «Nuovi Quad. Ist. d'ArcheologiaUniv. Perugia» 1 (1979), pp. 229-239; BOSCHUNG, Gens Augusta..., pp.136-137. Per i ritratti imperiali della zona presa in esame si veda il recente volumea cura di G. DE MARINIS, Arte romana nei Musei delle Marche, Roma 2005,Augusto e Drusus maior a Urbisaglia, pp. 75-78 e 86-87 (R. Perna); Augustocapite velato di Ancona pp.78-79 (S. De María); Tiberio e Caligola di Jesi, pp.84-85 e 90-91 (L. Sensi); Traiano di Asculum pp. 106-107(8. Rinaldi Tufi).
40 MARC MAYER
Pertinace, del quale ha preso uno dei cognomina honoris. In que-sto contesto si possono iscrivere i casi di Ritina e di Camerinum.
Rispettando gli obbiettivi del nostro lavoro non ci occu-piamo degli imperatori posteriori ai Severi rispetto ai quali siosserva, comunque, una sempre minore presenza di datiiscritti, dovuta forse al tipo di supporto utilizzato per la loroepigrafía onorifica o per quella utilizzata per lasciare unamemoria scritta dei loro interventi (64). Come sempre sitratta del discusso problema dell'epigrafia tarda che ha fattopensare ad un cambiamento in quello che siamo abituati achiamare "abito epigráfico" e che sicuramente, da una parte,come abbiamo detto, corrisponde a cambiamenti nel modo diperpetuare la memoria degli imperatori, attraverso espedientidi maggiore fragilitá, e, dall'altra, risponde soprattutto acause archeologiche: le realtá e gli strati piü recenti sonóquelli che si alterano con maggiore facilita, mentre buonaparte delle realtá anteriori, ammortizzate o riutilizzate,hanno giá sofferto le perdite proprie di un giacimentoarcheologico, e, coperte e sigillate almeno in parte, sonórimaste protette dal riutilizzo immediato sempre piü fre-quente a partiré dal IV secólo d.C.
(64) G. PACÍ, Documentazione epigráfica e trasformazione tardoantica in áreamarchigiana, in Atti del XXXIII Convegno di Studi Maceratesi (Potenza Picena,22-23 Novembre 1997), Macerata 1999, pp- 1-23, e Le Marche in eta tardoanti-ca: alome considerazioni, in E. MENESTÓ (cur.), Ascoli e le Marche tra tardoantico ealtomedioevo, Spoleto 2003, pp.1-24. Per il culto imperiale cfr. R. TURCAN, Lecuite imperialau III' siecle, in ANRW II, 16,2, pp. 996-1084.