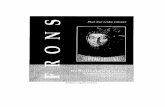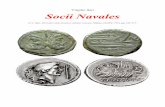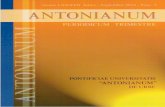Materiali arcaici e classici (Seconda metà VII-V secolo a.C.) da Marina di Caronia (ME). Nuovi dati...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Materiali arcaici e classici (Seconda metà VII-V secolo a.C.) da Marina di Caronia (ME). Nuovi dati...
1
Francesco Collura
MATERIALI ARCAICI E CLASSICI (SECONDA METÀ VII-V SECOLO A.C.) DA
MARINA DI CARONIA (ME). NUOVI DATI SULLA PRESENZA GRECA LUNGO
LA COSTA TIRRENICA IN ETÀ COLONIALE. L’EMPORION DI KALÈ AKTÉ
ARCHAIC AND CLASSICAL MATERIALS (VI-V CENTURY BC) FROM MARINA DI CARONIA (ME). NEW DATA ON
GREEK PRESENCE ALONG THE TYRRHENIAN COAST IN COLONIAL AGE. THE “EMPORION” OF KALE AKTE
Preprint. 4.2015
2
MATERIALI ARCAICI E CLASSICI (SECONDA METÀ
VII-V SECOLO A.C.) DA MARINA DI CARONIA
(ME). NUOVI DATI SULLA PRESENZA GRECA
LUNGO LA COSTA TIRRENICA IN ETÀ COLONIALE.
L’EMPORION DI KALÈ AKTÉ
Francesco Collura Preprint. 4.2015
i dà notizia del recente casuale rinvenimento da
parte di chi scrive di materiali di epoca arcaica e
classica in terreno di risulta, proveniente da vecchi
scavi edilizi eseguiti a Marina di Caronia, probabilmente
negli anni ‘80 del secolo scorso e contenuti in una
discarica scoperta davanti alla spiaggia in contrada
Pantano.1 Sebbene le modalità della scoperta siano
estremamente fortuite e al di fuori di qualsiasi criterio
scientifico di ricerca, i materiali presenti risultano di
grandissima importanza per elaborare nuove ipotesi e
gettare luce sulla presenza coloniale greca lungo la fascia
settentrionale della Sicilia, che fin qui ha rivelato
principalmente evidenze di epoca ellenistica e romana e,
per l’epoca antecedente, è stata tradizionalmente
considerata esclusiva pertinenza di popolazioni indigene,
eventualmente entrate in contatto con la cultura greca,
senza tuttavia una presenza stabile di tipo greco al di là
della lontanissima colonia di Himera. Il presente preprint
costituisce un’anteprima di nuove ipotesi di lavoro,
supportate da dati concreti quali possono essere le
ceramiche di determinate fasi storiche, che saranno
trattati in maniera più completa in un volume di prossima
pubblicazione a cura dell’autore2.
La discarica da cui provengono i materiali in argomento
era formata da sette cumuli di terra, larghi ciascuno circa
4 metri per un’altezza di circa un metro, depositati sulla
spiaggia sassosa a poca distanza da numerose altre
discariche di terreno, alcune delle quali contenenti
materiali antichi, principalmente di età romana
imperiale.3 Prevalevano i materiali edilizi, costituiti
soprattutto da grandi ciottoli non lavorati, spezzoni di
calcare bianco e di conglomerato di origine alluvionale,
1 I materiali, parzialmente recuperati per forza di cose al di fuori di precise regolamentazioni in materia, con il preciso scopo di evitarne la
scomparsa, trattandosi di terreno depositato davanti al mare e soggetto
quindi a erosione e disfacimento, si presentano in questa sede in maniera molto preliminare, in attesa di un esame più approfondito che
riguardi le diverse tipologie ceramiche attestate 2 F. Collura, Studia Calactina I. Studi e ricerche su una città greco-romana di Sicilia. In c.d.p. 2015 3 La periferia occidentale del moderno abitato di Marina di Caronia
(contrada Pantano) è stata da sempre luogo di discariche da scavi edilizi. Molte di queste non sono più esaminabili perché erose dal mare, quando
depositate davanti alla spiaggia, o perché inglobate all’interno di una
fittissima vegetazione spontanea. Quelle presenti ai margini di un viottolo che parte dal “campo sportivo”, contengono in molti casi
materiale archeologico, in particolare mattonacci ellenistico-romani,
tegolame e ceramiche principalmente di età romana imperiale. Altri siti di discariche da scavi in area urbana, che sarebbe stato interessante
esaminare all’epoca della loro creazione per la presenza di materiale
archeologico di varie epoche, si trovano presso la contrada Chiappe (occultata da infrastrutture pubbliche moderne), presso la contrada
Fiumara (margine ovest del torrente Caronia) e nell’area del Ponte
Vecchio, sempre ai margini del torrente.
tutti elementi abbondantemente presenti sia a Marina di
Caronia (ciottoloni di spiaggia) sia lungo i pendii
collinari retrostanti. A questi si associavano numerosi
frammenti di solenes a pasta chiara, di probabile
produzione locrese,4 e qualche rado frammento di tegola
curva con le medesime caratteristiche nelle argille
impiegate. Pochi spezzoni di mattonacci di tipo
ellenistico-romano e di tegole curve a bordo ispessito
attestavano che i livelli asportati nello scavo avevano
interessato anche fasi di frequentazione di età imperiale.
Una grande quantità di frammenti ceramici era contenuta
in alcuni dei cumuli di terra e, tra questi, uno
comprendeva principalmente ceramiche arcaiche e
classiche, individuandosi in questo terrapieno
probabilmente lo strato più profondo intercettato, sebbene
materiali di identica cronologia fossero presenti in altri
cumuli, mischiati ad altri di età ellenistica e romana.
Il rinvenimento, di per sé, non porta novità assolute
quanto alla cronologia della prima frequentazione del sito
di Marina di Caronia, poiché materiali arcaici e classici
erano già stati presentati da A. Lindhagen5 e C. Bonanno6
in occasione degli scavi eseguiti tra il 1999 e il 2005 in
contrada Pantano, ad est del presunto bacino portuale
interno trasformatosi nei secoli in palude e bonificato agli
inizi del ‘900. Tuttavia le notizie contenute nelle
pubblicazioni dei due autori presentano un esiguo numero
di reperti di quell’epoca, peraltro non tutti di
rinvenimento in contesto, a fronte della quasi esclusiva
descrizione di materiali ellenistici e romani. Lindhagen
soprattutto presentava in appendice alcuni frammenti in
possesso di un privato che li recuperò da una discarica
oggi scomparsa, comprendente, tra gli altri, un
frammento di coppa Iato K480, uno di probabile cratere
attico a figure nere ed un frammento di skyphos di tipo
corinzio con decorazione a filettature verticali, databili tra
gli ultimi decenni del VI e i primi decenni del V secolo
a.C. A questi si aggiungeva una porzione di anfora
corinzia A e uno di anfora samia rinvenuti in corso di
scavo dai livelli più profondi raggiunti nel 1999-2001,
datati agli inizi del V secolo a.C. Bonanno, invece,
presentava unicamente un’applique molto consunta
configurata a testina in stile dedalico, datata alla fine del
VII secolo a.C., recuperata da terreno rimescolato
all’interno dell’area di scavo, dando notizia di altri
materiali di epoca sicuramente anteriore all’età
ellenistica.7
4 Le tegole, caratterizzate da alette con profilo a quarto di cerchio, sono
realizzate generalmente con argille di colore beige chiaro, internamente rosate, contenenti numerosissimi inclusi sabbiosi di colore bianco e
nero-grigio. Simili manufatti sono stati rinvenuti, sempre a Caronia
Marina, in un crollo affiorato nell’area della Stazione Ferroviaria, nonché, in area nebroidea, nell’insediamento indigeno di Monte Scurzi
e in quello di Gioiosa Guardia. La loro cronologia sembra spaziare, in
base ai contesti di rinvenimento, tra la fine del VI o inizi V secolo a.C. e i primi decenni del IV secolo a.C. 5 Lindhagen 2006 6 Bonanno 2008 7 Da comunicazione personale di A. Lindhagen, che ha avuto modo di
visionare velocemente i materiali dello scavo 2003-2005, e di F.
Sudano, che partecipò a quello scavo, si conosce il rinvenimento di frammenti di ceramiche probabilmente databili a partire dalla seconda
metà del VI secolo a.C., tra cui esemplari di coppe ioniche e coppe tipo
Iato K480
S
3
In questa sede si presentano alcuni esemplari, tra i
numerosi presenti, di ceramiche rinvenuti nella discarica,
pertinenti sia a vasellame che ad anfore, la cui cronologia
spazia almeno dalla prima metà del VI secolo a.C. alla
fine del secolo successivo. Una particolare
concentrazione riguarda il V secolo ed è probabilmente a
questa fase che si daterebbero le strutture intercettate e
distrutte dallo scavo, a cui si riferisce il tegolame prima
descritto. Va detto preliminarmente che la discarica non
conteneva solo materiali arcaici e classici ma, in
concentrazioni diverse, anche di età ellenistica e, assai
meno, di età imperiale. L’esemplare più tardo è costituito
da una porzione di anfora tipo Termini Imerese 151/354
di produzione locale, mentre alla prima età imperiale si
riferiscono pochi frammenti di sigillata italica, tra cui uno
con bollo rettangolare L. TI. TI. riferibile alla produzione
del ceramista aretino L. Titius8 Ad età ellenistica si
riferiscono numerosi esemplari di anfore greco-italiche,
databili tra la fine del IV e tutto il III secolo a.C. e oltre,
nonché uno di Lamboglia 2, assieme a frammenti di
vasellame a vernice nera e acroma (assente la Campana
C). Tuttavia oltre i due terzi dei materiali contenuti nel
terreno si datano fino al IV secolo a.C., presumibilmente
perché la discarica in questione conteneva gli strati di
terreno più profondi, dopo che quelli più superficiali
erano stati smaltiti altrove.9
I materiali più antichi sono costituiti da alcune lame
frammentarie e scarti di lavorazione in ossidiana. Non
sappiamo se lo scavo abbia intercettato livelli preistorici,
non attestati comunque da ceramiche, o se piuttosto
questi utensili siano stati già in antico rimescolati nel
terreno in occasione dell’occupazione del sito in fase
storica. In ogni caso, la presenza di ossidiana è attestata
in diversi punti a Marina di Caronia, ad esempio nell’ex
proprietà Naselli10 e sporadicamente nella stessa area di
contrada Pantano in cui sono stati eseguiti gli ultimi
scavi. L’assenza di ceramiche pre e protostoriche nella
discarica in argomento, assieme alle notizie di altri
rinvenimenti di ossidiana, fa pensare all’esistenza di un
insediamento probabilmente dell’Età del Bronzo, come
altri ne sono stati individuati nell’area di Caronia,11 che
forse venne abbandonato prima dell’Età del Ferro in
seguito allo spostamento della popolazione in siti
d’altura. In effetti, sia dai dati di scavo che dai
rinvenimenti sporadici di materiali, compresi quelli della
discarica in argomento, si osserva uno iatus di diversi
secoli nella frequentazione del sito, almeno dalla fine
dell’Età del Bronzo fino al VII secolo a.C., che potremmo
estendere anche alla retrostante collina di Caronia.
Oltre i due terzi dei frammenti presenti nel terreno è
costituito da porzioni di anfore commerciali. L’esemplare
più antico sembra essere costituito da alcuni bordi di
anfore fenicio-puniche del tipo Ramòn 10.1.2.1, la cui
cronologia spazia tra la metà del VII e la metà del VI
8 Comunicazione S. Cascella 9 I materiali di rinvenimento sporadico presentati in Lindhagen 2006 proverrebbero, infatti, dalla stessa area di scavo, come pare suggerire la
contemporanea presenza, in due distinte discariche, di due frammenti
della stessa coppa (?) a vernice nera, decorata con un raro motivo a fila di civette stampigliate, di probabile produzione ateniese. 10 Bonanno 1993-1994 11 Rinvenimento personale di un insediamento in c.da Fiumara, inedito
secolo a.C., sebbene la frammentarietà degli esemplari
non consentana una datazione certa e assoluta. Alla
seconda metà del VI secolo si datano alcuni esemplari di
anfore con bordo bombato e listello sottostante,
inquadrabili nella diversificata categoria dei contenitori
da trasporto indicati di volta in volta come “greco-
occidentali” arcaiche, “massaliote”, “ionio-massaliote” o
“corinzie B” arcaiche, che a tutt’oggi non riescono ad
essere riunite entro un tipo univoco. La loro
caratterizzazione dipende dalla forma del bordo, del collo
e del corpo piuttosto panciuto. Gli esemplari di cui
parliamo si conservano solo nella parte corrispondente al
bordo, fino all’attacco dell’ansa e parte del collo
cilindrico, per cui non si può determinare l’esatta forma
dell’intero contenitore. Inoltre sono diverse le argille
impiegate, il cui colore varia dal rosa-arancio al rosato
con sbiancatura superficiale. Tuttavia, il profilo
conservato dei bordi, con evidente listello sottostante, e
talvolta la forma dell’ansa ricurva verso l’alto prima di
scendere verticalmente, li pongono in una fase molto
antica, che per alcuni potremmo genericamente
assegniaro al 540-500 a.C. Tra la fine del VI e gli inizi
del V secolo a.C. si data un bordo di anfora corinzia A
con profilo superiormente piano e argilla di colore
arancio-rossastro con numerosi inclusi grigiastri. Intorno
alla metà del V secolo si datano invece un bordo di anfora
corinzia A’ e un puntale di corinzia B, la cui tonalità
dell’argilla, di colore giallino o beige pallido richiama le
produzioni dell’area di Corinto. Un cospicuo gruppo di
bordi e anse si riferisce alla categoria delle “greco-
occidentali” classiche o “pseudo-chiote”, caratterizzati da
profilo a cuscinetto, talvolta con incavo di produzione
interno, sottolineato inferiormente da una gola più o
meno profonda. Parti del collo conservate ne fanno
ipotizzare un profilo leggermente rigonfio, tipico, per
l’appunto, delle “pseudo-chiote”. Questo tipo di anfora si
daterebbe dalla metà del V alla metà circa del IV secolo
a.C.: quasi tutti gli esemplari sembrano di produzione
locrese, con argille di colore beige pallido-crema e
minuscoli inclusi sabbiosi bianchi e grigiastri, oltre a
tracce più o meno evidenti di mica. Un unico esemplare,
conservato nel bordo e in parte del collo in
corrispondenza dell’attaccatura dell’ansa, presenta
tuttavia caratteristiche materiali diverse, mostrando
numerosi inclusi di quarzite bianca nell’argilla di colore
camoscio, simile per certi versi a produzioni locali
osservate, ad esempio, nell’insediamento indigeno di
Pizzo Cilona nell’entroterra e nella stessa Caronia per
l’epoca ellenistica e romana. Al V-IV secolo a.C.
appartengono alcuni bordi molto frammentari di anfore
puniche di vario tipo: la più che discreta presenza di
contenitori da trasporto di produzione fenicio-punica di
varie epoche suggerisce contatti non solo con la colonia
di Himera, individuabile come mercato mediatore dei
materiali di produzione occidentale, ma probabilmente
l’arrivo su questo tratto di costa di mercanti provenienti
da Solunto o Panormos. Infine ad epoca tardoclassica
(fine V – seconda metà IV secolo a.C.) si datano alcuni
bordi parzialmente conservati di anfore con bordo a
echino (MGS III).
Per ciò che riguarda il vasellame, gli esemplari più
antichi, databili almeno negli ultimi decenni del VI secolo
4
a.C., sono costituiti da ceramiche a bande nere o rosse di
tradizione ionica, pertinenti a coppe skyphoidi, lekanai,
pissidi e amphoryskoi, la cui area di produzione potrebbe
essere Zancle o propriamente il versante egeo. Ad area
greco orientale si riferiscono alcuni frammenti decorati
con strette fasce di colore rosso-arancio o bruno. Stessa
cronologia dovrebbero avere alcuni piccoli frammenti di
coppe tipo Iato K480 di produzione imerese ed un
frammento di kylix di produzione attica, nonché alcuni
frammenti di ceramiche corinzie, di cui uno con
decorazione non decifrabile resa con sovradipintura di
colore paonazzo e sottili motivi incisi. Sempre agli ultimi
decenni del VI secolo a.C. si datano una coppetta a
vernice nera con bordo bombato di produzione coloniale,
alcune coppette apodi con doppia ansa di tipo ionico e un
piede di probabile coppa calcidese. Tra la fine dello
stesso secolo e i primi decenni del successivo si datano
alcuni piedi svasati di skyphoi attici di tipo corinzio e
alcuni esemplari frammentari di lucerne.
Figg. 1-2. Materiali in recupero dalla discarica: in alto,
frammenti di solenes a pasta chiara assieme a elementi edilizi
(pietrame) e contenitori frammentari; in basso, ceramiche fini e
frammenti di anfore e pithoi
Un cospicuo gruppo di frammenti si riferisce a
produzioni attiche. Si tratta principalmente di skyphoi a
vernice nera, caratterizzati da vernice molto compatta con
riflessi iridescenti e piede torico. Due frammenti a figure
rosse si riferiscono ad un medesimo cratere attico a
colonnette inquadrabile nel secondo terzo del V secolo
a.C., mentre ad un secondo cratere attico databile nella
prima metà del V secolo dovrebbe riferirsi un bordo
decorato nella faccia superiore con un motivo a boccioli
di loto intersecati. Alla stessa produzione si assegnano
altri piccoli frammenti decorati non riconducibili a
precise forme. Dall’esame delle decorazioni, quando
presenti, e del profilo dei vasi frammentari, questi
esemplari attici coprono un periodo compreso tra l’inizio
del V secolo a.C. e la seconda metà dello stesso secolo.
L’abbondante presenza di ceramica attica e in particolare
la presenza di vasi decorati di un certo pregio pongono
quesiti circa lo status delle genti che vivevano in questo
avamposto nel corso del V secolo a.C.
Assieme ai prodotti d’importazione si annoverano
numerosi frammenti di ceramiche a vernice nera o
acrome con decorazioni a fasce che andrebbero riferite a
produzioni coloniali, probabilmente dell’area dello
Stretto. Le forme maggiormente attestate sono costituite
da skyphoi, coppette e lekythoi globulari, ma in gran parte
i frammenti, poco diagnostici, non consentono di
ricostruire il profilo del vaso a cui appartengono. Molto
abbondante è la ceramica da cucina (lopadia e chytrai), la
cui cronologia è incerta ma che, per similare contesto,
possiamo datare tra gli ultimi decenni del VI e tutto il IV
secolo a.C. Non sono stati rinvenuti pesi da telaio né
coroplastica di alcun tipo. Di incerta cronologia sono
alcuni strumenti in bronzo e in piombo verosimilmente
utilizzati nell’ambito di attività pescherecce (ami e
utensili per la riparazioni delle reti). Infine si segnala la
presenza di molte ossa animali, a volte semicombuste, e
di diverse vertebre di tonno. Unico al momento il
rinvenimento di un tetras in bronzo di Gela databile al
420-405 a.C. della serie con testa del dio fluviale Gelas e
toro stante a destra.12
I frammenti ceramici sono estremamente lacunosi ma
talvolta parzialmente ricomponibili. Il loro stato, con
superfici perfettamente integre e linee di frattura nette,
induce a ritenere che al momento dello sbancamento i
manufatti si trovassero in giacitura primaria e in molti
casi interamente conservati. Una tale circostanza fa
ritenere che i livelli arcaici e classici non siano mai stati
sconvolti dalle successive sovrapposizioni e che uno
scavo sistematico avrebbe permesso il recupero dei
reperti in condizioni ottimali. Piuttosto, le tracce di
affumicatura in alcune pareti di anfore e diversi brandelli
di carbonella frammisti nel terreno potrebbero suggerire il
verificarsi di un incendio, non sappiamo se esteso su
vasta area o localizzato nelle strutture intercettate.
Pur tenendo conto che non tutti i cumuli di terreno della
discarica sono stati sistematicamente controllati,
essendosi concentrato il recupero su tre di essi dei sette
complessivi, ovvero quelli che a prima vista contenevano
principalmente materiali di epoca greca, possiamo fare
un’osservazione preliminare sotto l’aspetto quantitativo
dei frammenti per cronologia. La maggiore percentuale si
concentra tra l’inizio del V e i primi decenni del IV
12 Sono stati esaminati solo i materiali di alcuni dei cumuli di terreno e non si esclude che altre monete e ceramiche significative ai fini della
ricostruzione delle prime fasi di vita dell’insediamento siano contenute
negli altri cumuli, mischiati a materiali ellenistici e romani
5
secolo a.C., con una fase molto rappresentata
corrispondente al periodo 500-420 a.C. In discreto
numero sono i frammenti databili tra il 530 e il 500 a.C.
La seconda metà del IV secolo è meno rappresentata e
mancano alcune tipiche forme di questo periodo, tra cui
gli skyphoi di tipo attico con profilo del corpo meno
concavo internamente e bordo distinto. La fase compresa
tra III e I secolo a.C., in rapporto a quella di V-IV secolo,
è testimoniata da molti meno frammenti di vasellame
fine, tra cui alcuni piattini, anche in Campana A, mentre,
al contrario, sempre il periodo che va dalla fine del IV al
II secolo a.C. è ben descritto da numerosi esemplari di
anfore greco-italiche, circostanza che potrebbe suggerire
un cambiamento nella destinazione d’uso degli ambienti
intercettati dallo scavo.
La cospicua presenza di anfore commerciali, di cui si
sono identificati, come accennato, alcuni tipi principali e
ricorrenti, ma per le quali non si esclude la presenza di
produzioni diverse, forse anche da area egea, per la
presenza di numerosi frammenti non diagnostici ma con
caratteristiche dell’argilla e delle superfici non
assimilabili alle tipologie riconosciute, induce a ritenere
che alcuni degli ambienti intercettati dallo scavo fossero
dei magazzini. D’altra parte, la presenza di diversi tipi di
vasellame con funzioni diversificate (da mensa, da
dispensa, da cucina, lucerne, ecc.) non esclude che ad essi
fossero associati ambienti di tipo domestico, oltre a
luoghi di rivendita di merci. La presenza di almeno due
crateri attici figurati e di numerosi skyphoi richiama
inoltre la pratica del simposio, tanto cara ai Greci e
praticata in qualsiasi sede abitativa, a meno di pensare
che anche queste preziose suppellettili si trovassero
immagazzinate per un’eventuale rivendita. In ogni caso,
lo scavo edilizio a cui si riferisce la discarica non dovette
essere molto esteso, poiché la quantità di terreno
asportata e depositata sulla spiaggia, in considerazione
della profondità a cui si trovano normalmente i livelli più
antichi sepolti, induce a ritenere che le strutture andate
distrutte dovevano comprendere pochi ambienti.
I materiali sinteticamente descritti, asportati da un unico
contesto probabilmente riferibile ad un luogo di rivendita
o a magazzini per via della preponderante presenza di
anfore frammentarie, non solo confermano
un’occupazione del sito di molto precedente la nascita di
Kalè Akté come polis di metà V secolo a.C., ma
accendono tutta una serie di ipotesi sulla natura di questo
insediamento arcaico-classico sulla costa tirrenica, posto
a metà strada tra le subcolonie zanclee di Mylai e Himera.
Fig. 3. Bordo di cratere attico a colonnette con decorazione a
boccioli di loto intersecanti. Prima metà V secolo a.C.
Fig. 4. Insediamenti greci (colonie, subcolonie, phrouria ed emporia) della Sicilia settentrionale nel VI-V secolo a.C. (rielaborazione
da Google Maps)
6
Come è noto (Diodoro Siculo 12.8.2), Kalè Akté venne
fondata da Ducezio con la collaborazione di alcuni siculi,
tra cui Archonidas di Herbita, e di un gruppo di coloni
Corinzi nel 446 a.C. Trattandosi di una fondazione
propriamente sicula, nonostante la presenza di Greci e gli
affermati influssi ellenici in materia di organizzazione
urbana e tipologia di sito da scegliere per la fondazione di
colonie, la nuova città doveva rispondere piuttosto ai
consolidati criteri topografici di ascendenza protostorica,
che suggerivano la creazione di abitati su alture
naturalmente difese. La Kalè Akté di Ducezio venne
quindi fondata sulla collina di Caronia, a poca distanza
dalla costa, in un sito sufficientemente sicuro ma con
agevole accesso ai traffici commerciali che si svolgevano
via mare. La scelta del sito da parte di Ducezio, senza in
questa sede volere tenere conto di possibili prescrizioni
da parte delle potenze dell’epoca, di cui comunque non
abbiamo notizia, tenne probabilmente conto
dell’esistenza di un insediamento in vita da tempo sulla
costa, che doveva svolgere un ruolo non secondario da un
punto di vista commerciale. Tale circostanza avrebbe
permesso alla sua città, che ne prese lo stesso nome, di
svilupparsi rapidamente.
I materiali più antichi finora rinvenuti a Caronia13
confermano in buona sostanza la datazione tramandata da
Diodoro. Tuttavia una presenza greca sulla spiaggia di
Caronia, ben prima della fondazione di Ducezio, era
ipotizzabile per due ordini di motivi. Il primo è la stessa
posizione del sito, praticamente al centro della costa
tirrenica settentrionale, che dovette essere precocemente
esplorato dalle genti di Zancle nell’avanzata verso ovest,
dove nel 648 a.C. verrà fondata Himera. Potremmo
immaginare che viaggiatori zanclei si siano spinti in
queste contrade già nei primi decenni del VII secolo a.C.,
dopo la fondazione di Mylai intorno al 715 a.C. e la presa
di controllo della piana di Milazzo-Barcellona entro la
fine dell’VIII secolo a.C. Prima della fondazione di
Himera è ipotizzabile che siano stati esplorati vari siti
lungo la costa, alla ricerca del luogo più adatto per
fondare una subcolonia e che in alcuni di essi siano stati
creati piccoli insediamenti o meglio, postazioni
intermedie dove ricoverare le navi lungo un tratto di costa
molto ampio. A tal fine, tre sono quelli che
morfologicamente si prestavano ad essere utilizzati come
approdi: la baia protetta dal promontorio di Capo
d’Orlando, il basso promontorio di Caronia e quello di
Cefalù. Tra questi, quello di Caronia dovette attirare fin
da subito l’attenzione dei colonizzatori zanclei,
trattandosi di una larga piana proiettata sul mare estesa
per circa 70 ettari, che formava ad est un’insenatura
adatta all’attracco delle navi. La morfologia del sito era
idonea all’impianto di un esteso abitato, potendosi
sfruttare sia la piana costiera, molto ampia, sia il
retrostante altipiano (odierne contrade S. Anna-S.
Todaro) che si innalza verso sud in una naturale acropoli
(la collina di Caronia). Sotto certi aspetti, la morfologia di
quest’area richiama da vicino quella del sito di Himera,
13 Si tratta di frammenti di ceramiche indigene a decorazione geometrica e di alcuni frammenti di ceramiche attiche e di produzione coloniale
databili negli ultimi decenni del V secolo a.C. rinvenuti da chi scrive sul
pendio orientale della collina
che infatti si articolò in una città bassa nella piana
costiera e in una città alta nel retrostante pianoro elevato
(Piano di Imera-Piano del Tamburino). La scelta di
fondare la colonia nella piana di Buonfornello, a così
grande distanza, piuttosto che a Caronia, fu dettata da
migliori condizioni ambientali, in particolare la più
agevole possibilità di entrare in contatto con l’entroterra
sicano attraverso la vallata naturale del fiume Imera ed un
più vasto comprensorio adatto all’impianto di colture, con
bassi rilievi e ampie vallate fluviali.
Il secondo motivo è di interpretazione letteraria ed è
costituito dal cenno di Erodoto 6.22, che descrive il fallito
tentativo di fondare una colonia Samia, su invito di
Zancle, nel sito di Kalè Akté agli inizi del V secolo a.C.
Nel testo di Erodoto14 il toponimo parrebbe ben noto agli
Zanclei a quell’epoca e fa presumere che il luogo
nominato fosse già da tempo sotto il diretto controllo
della città dello Stretto. In quell’occasione, essi dovettero
chiamare gli Ioni a popolare un sito dove esisteva già un
abitato perché questo si trasformasse in polis. In questo
modo, Zancle avrebbe assunto il totale e definitivo
controllo di un’area molto vasta, sottomettendo l’intera
comunità indigena della Sicilia settentrionale e
impedendo l’avanzata verso nord di potenze greche come
Siracusa, Gela e Akragas. E’ da ricordare, in ultimo, che
il nome di Kalè Akté riferito da Erodoto – sia esso un
semplice toponimo a indicare un preciso punto della costa
o quello di un vero e proprio abitato - è l’unico noto per
la Sicilia settentrionale, a parte i toponimi di Mylai e
Himera, fino ad età ellenistica, ad avvalorare
l’importanza che esso ebbe in qualche modo in una fase
piuttosto oscura, l’epoca arcaica e altoclassica, fino
proprio alla fondazione di Ducezio, lungo la fascia di
alture nebroidee, tradizionalmente ritenuta esclusivo
controllo dei Siculi e per questo trascurata nel racconto
degli eventi che interessarono la Sicilia fino a tarda età.
Contatti tra mondo greco e mondo indigeno in questo
settore della Sicilia sono attestati da materiali databili già
a partire dalla fine del VII o inizi VI secolo a.C. A questa
fase, ad esempio, si datano le ceramiche greche più
antiche rinvenute nel sito indigeno-ellenizzato di Gioiosa
Guardia (Gioiosa Marea)15, mentre intorno alla metà del
VI secolo si datano le prime ceramiche greche presenti
nel sito indigeno di Monte Scurzi (Militello
Rosmarino)16. Infine, all’inizio – primi decenni del V
secolo a.C. si collocano i materiali greci presenti in
contrada Arìa17 e Pizzo Cilona18 in territorio di Caronia.
In tutti questi siti indigeni, che appaiono ellenizzarsi (mai
completamente) via via da est verso ovest a partire dalla
fine del VII secolo a.C., ceramiche greche, talvolta di
pregio, convivono con ceramiche di produzione locale,
talvolta fabbricate con metodi arcaici che richiamano
14 “Ζαγκλαῖοι γὰρ οἱ ἀπὸ Σικελίηςτὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον πέμποντες ἐς
τὴν Ἰωνίην ἀγγέλους ἐπεκαλέοντο τοὺς Ἴωνας ἐς Καλὴν ἀκτήν,
βουλόμενοι αὐτόθιπόλιν κτίσαι Ἰώνων. ἡ δὲ Καλὴ αὕτη ἀκτὴ καλεομένη
ἔστι μὲν Σικελῶν, πρὸς δὲ Τυρσηνίην τετραμμένη τῆς Σικελίης.
τούτωνὦν ἐπικαλεομένων οἱ Σάμιοι μοῦνοι Ἰώνων ἐστάλησαν, σὺν δέ
σφι Μιλησίων οἱ ἐκπεφευγότες: ἐν ᾧ τοιόνδε δή τι συνήνεικεγενέσθαι” 15 Tigano 2008 16 Bianco 1988 e ricognizioni di chi scrive 17 Collura - Alfieri 2012; Collura 2015 18 Collura 2015
7
tradizioni artigiane di fase protostorica. Inoltre si osserva,
considerando le caratteristiche materiali del vasellame
importato, che nell’area occidentale dei Nebrodi sono
presenti manufatti di produzione imerese ed anfore
puniche, quest’ultime commerciate da mercanti di
Solunto-Palermo o piuttosto provenienti dalla stessa
Himera, importante polo commerciale dove giungevano
merci sia dall’area greca che da quella punica, magno-
greca ed etrusca.
Lo studio della colonizzazione greca in Sicilia e, in
generale, in Occidente, è stato intrapreso molti decenni fa
e le linee principali sono state fissate sulla base del
resoconto delle fonti storiche e di scavi sistematici in situ.
Tuttavia riferirsi pedissequamente ai dati letterari può
essere in alcuni casi fuorviante e si deve pur sempre
tenere conto della loro parzialità e sinteticità. Il fenomeno
della prima colonizzazione a partire dall’ultimo terzo
dell’VIII secolo a.C. dovette essere preceduto da una fase
di ripetuti contatti tra la Grecia continentale e le coste
siciliane, con reiterate esplorazioni finalizzate alla ricerca
del sito più adatto alla creazione di una città, tenendo
conto sia delle preesistenze che della morfologia dei
luoghi. Anche la seconda generazione di colonie dovette
rispondere agli stessi criteri, nel tentativo di espansione,
da parte di centri già insediati, verso territori ancora
sconosciuti nei quali individuare siti adatti alla creazione
di subcolonie. Pensare che, dopo la precoce fondazione di
Mylai, Zancle si sia diretta nel sito in cui fonderà Himera
senza avere prima frequentato altri siti intermedi, pare
fuori di logica. Nei circa 70 anni che intercorrono tra
l’insediamento della postazione di Mylai e la nascita di
Himera dovette essere esplorata l’intera costa tirrenica e
il numero di anni in questione dovette essere sufficiente
alla frequentazione o occupazione di alcuni luoghi
ritenuti adatti, quantomeno ad accogliere le imbarcazioni
su cui si muovevano i coloni. Possiamo pensare alla
creazione di accampamenti davanti alla spiaggia da parte
di spedizioni isolate di coloni, che permettessero di
esplorare sufficientemente il territorio circostante ed
entrare in contatto con le popolazioni locali, il che
richiedeva anche molte settimane. Alcuni di questi
diedero forse vita a piccoli insediamenti stabili,
ripetutamente frequentati dalle navi che si spingevano
verso ovest, diversi dei quali tuttavia si esaurirono nel
giro di qualche decennio una volta che si decise a quali di
essi dare ulteriore sviluppo come città vera e propria,
come emporion o come semplice phrourion. Dopo la
fondazione di Himera, qualcuna di queste postazioni
temporanee probabilmente continuò ad essere frequentata
o trasformata in un vero e propria stazione permanente:
per l’appunto un emporion o, come viene chiamato nella
letteratura anglosassone, un trading post, espressione che
definisce per l’appunto un insediamento, di dimensioni e
struttura diversificata, creato quale polo commerciale,
piuttosto che una apoikia che dava luogo alla creazione di
una vera e propria polis politicamente e urbanisticamente
organizzata.19
19 Hansen 1997
Figg. 5-6. Modello digitale del territorio di Kalè Akté (in alto) e
Himera (in basso). Come si può notare, la seconda fu insediata
su un’area di bassi rilievi con ampie vallate fluviali che
mettevano la città in rapido collegamento con l’entroterra. Il
complesso di alture delle Madonie, a sud-est, impediva
un’espansione verso il centro della Sicilia. Kalè Akté, invece,
seppure esistente in un sito molto favorevole all’impianto di una
città, era tuttavia relativamente isolata rispetto all’entroterra
da una fitta serie di rilievi alti oltre 1000 metri e con poche vie
naturali di penetrazione, che tuttavia permettevano contatti con
le città indigene poste a sud delle alture nebroidee
(rielaborazione da DTM Sitr Sicilia)
Figg. 7-8. Panoramica virtuale del tratto di costa di Kalè Akté e
Himera così come doveva apparire ai naviganti provenienti da
est, che evidenzia la diversa morfologia del territorio alle spalle
e intorno al sito individuato come possibile sede di un
insediamento coloniale. Appare evidente la natura
notevolmente più accidentata dell’area in cui insisteva la piana
di Kalè Akté, sebbene essa si prestasse favorevolmente
all’insediamento di una città dotata di un approdo naturale
(rielaborazione da Google Earth 2014)
8
A Caronia non sono ancora stati rinvenuti materiali
sicuramente antecedenti la fine del VII secolo a.C.20 A
questo periodo, in attesa di possibili future scoperte,
dovrebbe quindi risalire la creazione dell’ipotizzato
emporion, la cui esistenza, in base ai materiali di cui
parliamo, è confermata senz’altro per la seconda metà del
VI secolo a.C. A questo punto, trovano un precedente sia
la mancata colonizzazione dei Samii per l’inizio del V
secolo a.C. riportata da Erodoto, che la stessa fondazione
di Ducezio un cinquantennio dopo.
Se infatti gli Zanclei avrebbero voluto dare impulso
demografico ad un abitato già esistente, facendone una
vera e propria polis, Ducezio si sarebbe diretto a Kalè
Akté, probabilmente con la compiacenza di Siracusa21,
più che con quella di Zancle-Messene che in quella fase
viveva un momento convulso della propria vita dopo la
caduta della tirannide di Anassila e l’instaurarsi di nuovi
rapporti con la stessa Siracusa, secondo un preciso
obiettivo. La scelta del sito, cioè, non sarebbe stata
casuale ma probabilmente indotta dal ruolo che già quel
luogo rivestiva nel panorama dei commerci e degli
equilibri politici di quella precisa fase storica. Riteniamo
comunque che la fondazione siculo-greca di metà V
secolo a.C. non abbia interrotto o modificato la vita
dell’emporion sulla costa che, a giudicare dalla continuità
cronologica dei materiali sinora noti, in particolare delle
anfore da trasporto, continuò ad esercitare la propria
attività prettamente mercantile, non sappiamo bene in
quali rapporti con il nuovo abitato sulla collina. A questo
proposito, rileva la presenza di frammenti di ceramiche
indigene databili alla seconda metà del V secolo a.C. (o
agli inizi del successivo) nel sito collinare e la quasi
totale assenza di materiali similari sulla costa22, come se
per un certo lasso di tempo i due centri, in verità
vicinissimi, facessero parte ancora di due entità distinte
anche sotto l’aspetto culturale.23 Bisognerebbe infine
verificare se i coloni Corinzi che seguirono Ducezio
nell’impresa si siano effettivamente insediati nella nuova
città o si siano sparsi tra collina e costa.
L’ipotesi di una pre-colonizzazione della costa tirrenica
da parte dei Calcidesi di Zancle nel corso del VII secolo
a.C., prima della fondazione di Himera, era stata già
avanzata da alcuni studiosi, pur in mancanza di riscontri
materiali. In particolare, Dominguez24 osserva che
l’interesse di Zancle nei confronti di quell’area è
testimoniato dalla precoce fondazione di Mylai,
ipotizzando che già intorno alla metà del VII secolo a.C.
la città dello stretto cercò di fondare una colonia a Kalè
20 Potrebbero datarsi a partire dalla metà dello stesso secolo alcuni esemplari frammentari di anfore fenicio-puniche tipo Ramòn T-10.1.2.1
rinvenute nella discarica 21 Prestianni Giallombardo 2006 22 Si menzionano solo alcuni frammenti di grandi contenitori a bordo
svasato, simili a dei pithoi, nei quali erano probabilmente state
commerciate derrate alimentari, ma non frammenti di vasellame fine o decorato 23 Occorre rilevare che probabilmente sino alla fine metà del IV secolo
a.C. l’abitato collinare non ebbe grandi dimensioni, rimanendo concentrato nella parte più alta ed avanzata della collina. Il basso peso
demografico del centro si rispecchia nella quantità di ceramiche presenti
in situ, che appaiono in percentuali crescenti a partire dagli ultimi decenni del IV secolo a.C. per raggiungere l’apice in corrispondenza del
II-I secolo a.C. 24 Dominguez 2006, pp. 294-295
Akté, spinta dall’intenzione sia di dare un luogo da
abitare ad un’eterogenea popolazione concentrata in città
e nella vicina Mylai, sia di creare un mercato per
esercitare i commerci con i centri che si affacciavano sul
Tirreno (in primis gli Etruschi) e con le popolazioni
fenicie del Mediterraneo occidentale. L’esigenza di
disporre di un ampio territorio adatto allo sfruttamento
agricolo e la maggiore vicinanza ai centri fenici della
Sicilia occidentale fece scegliere il sito di Himera per
l’insediamento di una colonia. Questo scenario sembra
trovare oggi riscontro nei ritrovamenti di cui discutiamo,
che finora confermano la frequentazione del sito di
Caronia negli ultimi decenni del VII secolo a.C.
I materiali recuperati dalla discarica, che abbiamo prima
descritto, parlano di un insediamento propriamente greco
e non di un possibile emporion indigeno, di cui peraltro
non si conoscono precedenti, almeno lungo la costa
tirrenica. La varietà dei manufatti, molti dei quali
provenienti dall’Attica, da Corinto e da area greco-
orientale, assieme a produzioni coloniali di Zancle-Mylai
e Himera e ad anfore puniche, oltre ai contenitori da
trasporto di Corinto, Locri (o Sibari) e forse anche
Marsiglia, fanno pensare ad un centro magari di piccole
dimensioni ma molto vitale, dove è possibile che
rimanesse parte del carico di navi in transito da est verso
ovest e viceversa, per un immagazzinamento temporaneo
e per un’eventuale commercio con i centri indigeni. E’
probabile che in epoca arcaica e classica Kalè Akté abbia
esercitato, in piccolo per ovvie ragioni, un ruolo
commerciale analogo a quello svolto su vasta scala da
Himera: il basso Tirreno era intensamente percorso da
rotte mercantili che collegavano la Sicilia greca con la
penisola (Calabria, Campania, Etruria), con la Francia
meridionale e, ovviamente, con i mercati fenicio-punici
sia siciliani che del nord-Africa e del Mediterraneo
occidentale. E’ impensabile che i soli centri (fin qui
tradizionalmente noti) di Mylai e Himera abbiano
sostenuto da soli i flussi commerciali provenienti dal
medio e alto Tirreno e dall’area fenicio-punica,
indirizzandoli parzialmente verso l’entroterra indigeno.
E’ più logico pensare all’esistenza di una serie di stazioni
commerciali intermedie, in particolare lungo la parte
centrale della costa tirrenica, da dove una serie di vallate
fluviali e passaggi tra le montagne metteva in
comunicazione la costa con un entroterra disseminato di
centri siculi molto floridi, come Centuripe, Agyrion,
Assoros, Henna o Morgantina.
Sarebbe interessante eseguire ricerche sistematiche nei
numerosi siti indigeni sparsi lungo le dorsali nebroidea e
madonita e a sud di queste per accertare la presenza di
determinati prodotti d’importazione, in particolare di
contenitori da trasporto e di certi tipi di vasellame, per
appurare quale merce vi giungesse e attraverso quali
canali25. La costa tirrenica era altamente strategica per le
25 Possediamo alcuni dati per tre di questi insediamenti, due dei quali
ricadenti proprio nel territorio dell’odierna Caronia. A Pizzo Cilona, a circa 6 km dalla costa, sono presenti anfore greco-occidentali di V -
prima metà IV secolo a.C. (“pseudo-chiote” di probabile produzione
locrese) e corinzie B, mentre riguardo al vasellame si sono osservate produzioni coloniali (in particolare di Himera) ed alcune importazioni
attiche. In contrada Arìa, alcuni km a sud della frazione di Canneto di
Caronia, i materiali dalla necropoli appaiono essere in gran parte di
9
colonie greche ma la risalita verso nord delle principali
tra esse in una certa fase storica, come Siracusa, Gela e
Akragas dovette senz’altro essere ostacolata dalla
resistenza delle popolazioni autoctone che abitavano
l’aspro settore centro-settentrionale dell’isola. Fu invece
più agevole per Zancle, forse anche per Naxos, aggirare
l’ostacolo occupando la costa, verso la quale sembra
fosse meno pressante l’esigenza di un controllo assoluto
da parte dei Siculi, proiettati soprattutto verso i siti
d’altura e l’entroterra. Non dobbiamo necessariamente,
pertanto, pensare ad un rapporto conflittuale tra Greci e
popolazioni autoctone, che vivevano in piccoli centri su
rilievi (“kata komas” secondo la definizione di Tucidide),
apparentemente autonomi e con un’area geografica di
pertinenza non molto estesa. Non si conoscono
insediamenti indigeni costieri su tutta la fascia tirrenica.
L’evidenza non esclude una presenza greca stabile e non
invasiva in alcuni siti costieri, ai quali potevano avere
accesso gli stessi indigeni per scambiare i loro prodotti,
con proficuo vantaggio per entrambi. L’esistenza di
emporia, piuttosto che di poleis con necessità di un vasto
retroterra (che avrebbe condotto a conflittualità con le
popolazioni locali), potrebbe avere dato vita non ad una
vera e propria colonizzazione ma ad una graduale
ellenizzazione di questa parte di Sicilia, basata su una
tranquilla coesistenza di culture fino a tarda età (prima
metà IV secolo a.C.), attraverso la creazione di postazioni
commerciali costiere, senza necessità di controllo politico
di un vasto territorio.
Fig. 9 Ipotesi di localizzazione dell’emporion nell’area degli
attuali quartiere Nunziatella – contrada Pantano a Marina di
Caronia e probabile andamento dell’antica linea di costa
L’emporion arcaico di Kalè Akté è finora attestato dai
materiali mobili cui si è accennato e da un’interpretazione
più pratica e adattata alla realtà dei luoghi di quanto
riferiscono sinteticamente le fonti letterarie. Occorrerebbe
adesso eseguire scavi sistematici sotto i livelli ellenistici e
romani fin qui indagati ed effettuare saggi nell’area di
Marina di Caronia non ancora urbanizzata allo scopo di
accertarne le dimensioni e la struttura. Diversi indizi ne
produzione coloniale. A Monte Scurzi, in territorio di Militello
Rosmarino, si sono osservati pochi frammenti di anfore da trasporto, tra
le quali rilevano almeno due esemplari di anfore puniche di V secolo a.C., mentre relativamente al vasellame si osservano produzioni
coloniali, presumibilmente dall’area nord-orientale della Sicilia, vasi
calcidesi e alcuni esemplari di materiali attici
suggeriscono la localizzazione alle spalle dell’insenatura,
a partire dal corso del torrente S. Anna verso est nella
parte più ampia della piana costiera, anche laddove,
probabilmente in età romana, venne aperto un bacino
portuale interno (il “pantano” attuale). Essendo a così
grande distanza dalle poleis di riferimento, ovvero Zancle
e Himera, riteniamo che dovette dotarsi sin dalle prime
fasi di vita di una struttura urbana organizzata, dotata di
tutti gli apprestamenti necessari ad una permanenza
prolungata.26
Pensiamo ad un gruppo di abitazioni e strutture di
accoglienza, nonché ad attività artigianali, a ridosso di
magazzini, luoghi di rivendita e attrezzature portuali, con
l’immancabile presenza di piccoli santuari e naturalmente
di un’area cimiteriale, da ricercarsi forse verso est, oltre il
corso del torrente.27 Dovette passare da qui, tra VI e V
secolo a.C., buona parte del carico commerciale diretto
verso i centri indigeni dell’entroterra e dei rilievi
nebroidei. E’ logico pensare che qui fossero
immagazzinati i prodotti acquistati dalle popolazioni
locali (legname, pelli, minerali, ecc.) per rifornire le
colonie. La totale assenza di notizie circa eventi bellici
che possano essersi verificati in queste contrade tra VI e
V secolo a.C. induce a ritenere che i rapporti tra Greci e
indigeni si siano basati su una pacifica convivenza e che
l’area sia fondamentalmente rimasta estranea a lungo da
concreti tentativi di penetrazione da parte delle principali
potenze dell’epoca.
Naturalmente le ipotesi avanzate nel presente contributo
preliminare necessitano di verifiche e approfondimenti
futuri. L’esistenza di un insediamento con funzioni
prettamente commerciali è comunque suggerito dalla
tipologia stessa dei materiali descritti, comprendenti
soprattutto anfore da trasporto. Lo studio degli emporia
greci di Sicilia in realtà non è mai stato intrapreso
concretamente, mentre l’attenzione degli studiosi si è
sempre focalizzata sugli aspetti urbanistici delle poleis e
sulla loro proiezione nel territorio circostante in chiave di
chora agricola. Emporia andrebbero cercati per l’epoca
26 L’organizzazione urbana di un emporion di epoca arcaica e classica poteva variare da un’area geografica all’altra e dipendere da molti
fattori. Quelli più noti fino ad oggi si trovano ai margini opposti del Mediterraneo: Emporion nella penisola iberica e Naukratis nel delta del
Nilo in Egitto. Il primo fu creato poco dopo la fondazione di Massalia
(sud della Francia, nei primi decenni del VI secolo a.C., e dovette convivere con le popolazioni indigene degli insediamenti circostanti,
basando la propria esistenza su rapporti di reciproco scambio e
favorendo l’ellenizzazione di parte dell’attuale Spagna. Le sue dimensioni non furono mai estese: era difesa da una cinta muraria ed
esistevano dei templi. Naukratis fu invece un vitale centro commerciale
greco in territorio egiziano, creato su un ramo del Nilo dove si trovava il porto e dotato di una nutrita serie di santuari dedicati a varie divinità.
L’area occupata, che comprendeva comunque una vera e propria città
egiziana, era piuttosto vasta e a settori fittamente occupati da case e magazzini si alternavano aree dove si svolgevano attività pubbliche e
artigianali. Naturalmente, i contesti in cui sorsero Emporion e Naukratis
appaiono assai diversi da quello che doveva contraddistinguere la stazione commerciale di Kalè Akté, sia da un punto di vista morfologico
e ambientale che sotto l’aspetto della densità abitativa delle popolazioni
locali e dei rapporti con queste. 27 La localizzazione di una necropoli arcaica-classica in questo settore è
suggerita al momento dalla scoperta di tombe ellenistiche nell’area
dell’ex Rifornimento Agip (Scibona 1987) e di materiali della stessa epoca di rinvenimento sporadico presso lo sbocco del torrente Nivale-
Cinquegrana, probabile espansione verso est in fasi successive del
cimitero impiantato all’epoca dell’emporion
10
arcaica sulle lunghe distanze, ad esempio lungo la costa
meridionale tra Gela e Selinunte, oltre che nella stessa
fascia tirrenica, dove non è da escludere esistessero altri
piccoli insediamenti dotati di approdo. Soprattutto la
costa tirrenica si prestava alla creazione di postazioni
commerciali verso cui convogliare i traffici intercorrenti
con mercati eterogenei e molto attivi quali erano quelli
etruschi e quelli fenici, senza trascurare i rapporti con i
diversi centri greci che tra la metà dell’VIII e il VI secolo
a.C. vennero fondati nell’Italia meridionale, nel sud della
Francia e nella penisola iberica.
Materiali28
A. Ceramiche
1. Porzione di coppa skyphoide di tradizione ionica.
Decorazione a bande orizzontali a vernice nera lucente.
Superficie interna a vernice nera con riflessi iridescenti. Argilla
di colore rosa-arancio (Munsell 2.5YR6/12). Seconda metà VI
secolo a.C.29
2. Frammento di vaso (hydria?) con decorazione a linee
incrociate di colore rosso-arancio. Parte interna acroma. Argilla
di colore rosa-beige (Munsell 2.5YR6/10). Probabile
produzione greco-orientale. Seconda metà VI secolo a.C.
3. Piccolo frammento di coppa (?) corinzia con decorazione
graffita e fascia di vernice color paonazzo. Superficie interna a
vernice nera. Argilla di colore beige pallido (Munsell 5YR7/10).
Seconda metà VI secolo a.C.
4. Frammento di parete di coppa tipo Iato K480 di produzione
imerese. Si conserva la fascia a risparmio decorata a tratti
verticali. Superficie interna a vernice nera. Argilla beige scuro
(Munsell 2.5YR5/8). Ultimi decenni VI secolo a.C.30
5. Frammento di vaso di forma aperta di produzione corinzia.
Parte esterna a vernice di colore marrone con decorazione a
linee graffite orizzontali. Superficie interna a vernice bruna.
Argilla di colore beige pallido (Munsell 5YR7/10). Metà VI
secolo a.C.
6. Coppetta a bordo ispessito di produzione coloniale. Vernice
nera interna ed esterna tranne che nel piede e nella parte esterna
del fondo. Bordo ingrossato esternamente. Argilla di colore
28 A causa dell’estrema frammentarietà dei materiali non è stato
possibile, in molti casi, né stabilire la forma dell’oggetto cui si
riferiscono, né attribuire precise cronologie. E’ il caso, ad esempio, di alcuni bordi di anfore puniche, per le quali occorrerebbe conoscere la
forma dell’intero contenitore, o anche di frammenti ceramici la cui
cronologia può essere dedotta solo dalla tipologia decorativa e, talvolta, dal trattamento delle superfici. Solo in alcuni casi è stato possibile
trovare precisi confronti in letteratura. In questa sede si presentano solo
a titolo esemplificativo e in via del tutto preliminare alcuni frammenti, tra i tanti presenti nel terreno di discarica. La frammentarietà e
dispersione all’interno dei cumuli di terra, che necessiterebbero di una
sistematica indagine al fine di recuperare interamente i reperti, non consentono che in pochi casi di ricomporre almeno parzialmente gli
oggetti e suggeriscono che nell’area intaccata dallo scavo ne giacessero
in gran numero e concentrazione 29 Dovrebbe trattarsi di uno skyphos o coppa skyphoide forma Athenian
Agora XII fig. 4 n. 332 30 Cfr. Vassallo 1996, fig. 2 n. 9
beige-arancio (Munsell 2.5YR7/10). Fine VI - inizi V secolo
a.C.31
7. Coppetta apode di produzione ionica. Acroma con parziale
sbiancatura superficiale esterna. Doppia ansa con parte
sporgente a vernice nera. Argilla di colore rosato (Munsell
2.5YR7/8). Fine VI secolo a.C.32
8. Frammento di vaso di forma chiusa (hydria?) con fascia
esterna di colore rosso di tradizione ionica. Superficie interna
acroma. Argilla di colore rosa-beige (Munsell 2.5YR7/10). Fine
VI – inizi V secolo a.C.33
9. Frammento di vaso di forma chiusa (olpe?) con decorazione a
fasce di colore marrone. Superficie interna acroma. Argilla ben
depurata di colore beige (Munsell 5YR6/8). Fine VI – inizi V
secolo a.C.
10. Piede di coppa di produzione calcidese a vernice nera.
Profilo del piede di forma tronconica con base a risparmio.
Argilla di colore beige grigiastro (Munsell 7.5YR6/8). Seconda
metà VI secolo a.C.
11. Frammento di vaso di forma chiusa (brocca?) con
decorazione a fasce di colore rosso e bruno. Argilla ben
depurata, esternamente lucente. Superficie interna acroma.
Argilla di colore rosa-beige (Munsell 10R6/14). Probabile
produzione ionica. Fine VI – primi decenni V secolo a.C.
12. Ansa di boccaletto di produzione attica. Vernice rossa
lucente sull’ansa, nera lucente nella parte conservata della parte
interna dell’attacco. Argilla di colore beige chiaro (Munsell
5YR6/8). Prima metà V secolo a.C.34
13. Frammento di parete di vaso di forma non definibile con
decorazione esterna a bande di colore marrone e nero separate
da fascia a risparmio. Superficie interna a vernice bruna diluita.
Argilla di colore beige pallido (Munsell 5YR7/8). Produzione
corinzia? Prima metà V secolo a.C.
14. Porzione di lucerna a vasca aperta. Vernice nera interna e
sulla spalla. Base d’appoggio piana. Argilla di colore rosa-beige
(Munsell 2.5YR7/10). Simile a Athenian Agora IV tipo 22A (n.
195). Fine VI – primi decenni V secolo a.C.
15. Becco di lucerna a vasca aperta. Vernice nere esterna.
Argilla di colore brunastro tendente al grigio per ipercottura
(Munsell 7.5YR5/6). Prima metà V secolo a.C.
16. Piede a profilo svasato di skyphos di tipo corinzio. Vernice
nera lucida all’esterno, tranne nel fondo esterno acromo, dove è
dipinto un ampio cerchio a vernice nera. Superficie interna a
vernice marrone lucida. Argilla di colore beige (Munsell
2.5YR5/12). Fine VI – primi decenni V secolo a.C.
17. Porzione di grande skyphos attico, conservato nel bordo,
parte superiore della parete e attacco dell’ansa (orizzontale
appena sotto il bordo. Orlo verticale indistinto. Vernice nera
interna ed esterna molto compatta e con riflessi iridescenti.
Argilla di colore beige (Munsell 2.5YR5/10). Prima metà V
secolo a.C.
31 Cfr. Bacci, Tigano 2002, pag. 135, fig. 7 n. 17 32 Cfr. Meligunis LIpàra IX, tav. XCIV nn. 1161, 162, 166. Il tipo
appare abbastanza attestato nel contesto d’origine per la presenza di
numerosi frammenti, comprese diverse anse 33 Dello stesso vaso, decorato con fasce di colore rosso, sono presenti
nella discarica diversi frammenti non ricomponibili 34 Cfr. Athenian Agora XII pp. 70-76
11
18. Parte inferiore di vaso apode (olpe?). Base piana. Acromo
internamente ed esternamente tranne nella parte inferiore a
vernice brunastra diluita. Graffito sul fondo esterno (N?).
Argilla di colore beige scuro (Munsell 2.5YR3/6). V secolo a.C.
19. Frammento di grande vaso (hydria?)35. Superficie esterna di
colore grigiastro con bande orizzontali schiarite e decorazione
incisa a fitti tratti obliqui affiancati entro fascia orizzontale.
Argilla di colore grigiastro (Munsell 5YR3/2) in superficie,
rossastra internamente (Munsell 10R4/10). Fine VI-V secolo
a.C.36
20. Ansa e bordo di skyphos a vernice nera. Orlo verticale
indistinto, ansa orizzontale. Vernice lucida e compatta. Argilla
di colore rosa-arancio (Munsell 10R5/12). V secolo a.C.
21. Frammento (bordo?) di vaso attico a figure rosse.
Decorazione non interpretabile. Superficie interna acroma.
Argilla di colore rosa-beige (Munsell 2.5YR5/10). V secolo a.C.
22. Frammenti di cratere attico a colonnette. Si conserva parte
della decorazione accessoria a fascia verticale con puntinature
all’interno e della decorazione principale non interpretabile.
Vernice compatta e brillante. Superficie interna a vernice nera
stesa a pennellate orizzontali. Argilla di colore rosa-arancio
(Munsell 2.5YR5/10). Secondo terzo del V secolo a.C.
23. Fondo di lucerna a vernice nera. Base piana leggermente
rientrante. Ombelicatura centrale nella parte interna del fondo.
Vernice nera interna ed esterna lucente e parzialmente evanida.
Argilla di colore rosa-beige (Munsell 2.5YR5/12) Forma simile
a Athenian Agora IV tipo 12 var. (n. 80) per la presenza
all’interno di protuberanza conica. Ultimi decenni VI – inizi V
secolo a.C.
24. Frammento di coppa/kylix a vernice nera con cerchio interno
a decorazione graffita (onde continue). Argilla di colore cipria
(Munsell 2.5YR6/12). Seconda metà V secolo a.C.?
25. Parte inferiore di vasetto di forma chiusa apode (lekythos
globulare o piccola olpe). Fondo piano. Esternamente a vernice
nera, internamente acromo. Argilla di colore beige (Munsell
2.5YR6/12). Seconda metà V – prima metà IV secolo a.C.
26. Bordo e parte della vasca di lekane a vernice nera.
Decorazione lungo il bordo a minute puntinature su fondo
acromo. Vernine nera interna ed esterna brillante. Argilla di
colore beige (Munsell 2.5YR6/12). Seconda metà V – inizi IV
secolo a.C.
B. Anfore da trasporto
1. Bordo di anfora Corinzia A. Superficie piana con parte
esterna leggermente concava. Argilla compatta di colore arancio
(Munsell 10R5/14) con numerosi inclusi di pietrisco grigio,
nero e biancastro. Corpo ceramico interno tendente al grigio.
Ultimi decenni VI secolo a.C.
2. Bordo di anfora punica arcaica tipo Ramòn 10.1.2.1.37 Profilo
internamente convesso, esternamente contraddistinto da
35 Sono stati recuperati numerosi frammenti di questo vaso, molti dei
quali ricomponibili 36 I numerosi frammenti riconducibili a questa produzione potrebbero riferirsi a più vasi. Si segnala la presenza costante di incrostazioni e
tracce di affumicatura nelle pareti interne 37 Ramòn 1995, p. 461, fig. 108, n. 17
ripiegatura in corrispondenza della spalla. Argilla compatta di
colore rosa-bruno (Munsell 2.5YR4/8) esternamente grigiastra
(M. 10YR5/4). Minuscoli inclusi biancastri. Seconda metà VII -
prima metà VI secolo a.C.
3. Bordo di anfora punica simile a Ramòn 10.1.2.1.38 Argilla
molto depurata di colore arancio (Munsell 10R5/12) con stretto
corpo interno grigiastro. Seconda metà VII – metà VI secolo
a.C.
4. Bordo di anfora punica tipo Ramòn 10.1.2.1.39 Profilo
internamente convesso, esternamente contraddistinto da
ripiegatura in corrispondenza della spalla. Argilla di colore
arancio simile all’es. n. 3 con radi minuscoli frammenti micacei.
Seconda metà VII – metà VI secolo a.C.
5. Bordo di anfora greco-occidentale arcaica. Si conserva, oltre
all’orlo, l’attacco dell’ansa e parte del collo cilindrico. Bordo
bombato con listello inferiore. Profilo interno verticale. Argilla
compatta di color cipria (Munsell 2.5R5/10) con schiaritura (M.
2.5YR7/10) nella parte interna del bordo. Minuscoli inclusi
grigiastri e micacei. Ultimi decenni VI – inizi V secolo a.C.
6. Bordo di anfora greco-occidentale arcaica. Bordo bombato
con listello inferiore. Profilo interno lievemente concavo in
corrispondenza dello spigolo superiore. Argilla compatta di
colore rosato (Munsell 2.5YR6/8) con schiaritura superficiale
interna ed esterna (M. 7.5YR7/6). Piccoli inclusi biancastri,
nerastri e micacei. Ultimi decenni VI – inizi V secolo a.C.
7. Bordo di anfora greco-occidentale (“pseudo-chiota”). Orlo a
cuscinetto, inferiormente terminante in una netta gola in
corrispondenza dell’attacco dell’ansa. Profilo interno verticale
con estremità superiore tendenzialmente appuntita. Vacuolo di
produzione interno. Argilla di colore beige pallido (Munsell
5YR7/8), più chiara in superficie. Minuscoli inclusi grigiastri e
micacei, probabile produzione locrese.40 Fine V – prima metà
IV secolo a.C.
8. Bordo di anfora Corinzia A’.41 Si conserva il bordo,
caratterizzato da profilo declinante verso il basso con netta
ripiegatura verso l’estremità inferiore, a contatto con l’ansa, di
cui è conservata l’attaccatura. Produzione di Corinto. Argilla di
colore beige pallido (Munsell 10YR6/6), esternamente tendente
all’avorio (M. 7.5YR8/6). Innumerevoli inclusi di pietrisco di
colore grigiastro/marrone con numerosi vacuoli. Metà V secolo
a.C.
9. Puntale di anfora Corinzia B.42 Parte inferiore del contenitore
concavo ed espanso con breve puntale di forma tronco-
cilindrica con cavità interna. Probabile produzione corcirese.
Argilla di colore beige pallido (Munsell 5YR7/8) molto
depurata, liscia in superficie. Seconda metà V secolo a.C.
38 Ramòn 1995, p. 461, fig. 108, n. 6 (?) 39 Ramòn 1995, p. 461, fig. 108, n. 10 40 Barra Bagnasco 2001 41 Koehler 1981, pl. 99 lett. g 42 Koehler 1981, pl. 99 lett. c
14
Bibliografia
Alaimo et alii 1999 = R. Alaimo - R. Giarrusso - Y.
Iliopoulos - G. Montana, Coppe tipo Iato K480: indagini
archeometriche finalizzate alla individuazione del centro
di produzione. I Congresso Nazionale dell’Associazione
Italiana di Archeometria 1999, pp. 413-426.
Albanese Procelli 1996 = R.M. Albanese Procelli,
Appunti sulla distribuzione delle anfore commerciali
nella Sicilia arcaica. Kokalos XLII 1996, pp. 91-137
Athenian Agora IV = R.H. Howland, Athenian Agora IV.
Greek Lamps and Their Survivals. Princeton 1958
Athenian Agora XII = B.A. Sparkes, L. Talcott, Athenian
Agora XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th, and
4th Centuries B.C. Princeton 1970
Athenian Agora XXIII = M.B. Moore, M.Z. Pease
Philippides, Attic black-figured pottery. Princeton 1986
Bacci, Tigano 2002 = G.M. Bacci - G. Tigano, Da Zancle
a Messina I-III. Messina 2002
Barone et alii 2006 = G. Barone, M. Belfiore, A. Lo
Giudice, P. Mazzoleni, A. Pezzino, G. Spagnolo, C.
Ingoglia, G. Tigano, R.M. Albanese, Localizzazione dei
centri di produzione anforica nell’occidente greco: dati
archeometrici su anfore “Corinzie B”, “Ionico-
massaliote”, “Pseudo-chiote” e “Greco-italiche”
rinvenute in Sicilia. Atti del Workshop: L’approccio
multidisciplinare allo studio e alla valorizzazione dei beni
culturali (Siracusa 8-29 ottobre 2005), 2006 pp. 83-92
Barra Bagnasco 1989 = M. Barra Bagnasco M., Lo scavo.
In Locri Epizeferi Vol. II. Gli isolati I2 e I3 dell’Area di
Centocamere. Firenze 1989
Barra Bagnasco 1995 = M. Barra Bagnasco, Anfore
locresi: documenti a favore di una produzione locale tra
VI e IV sec. a.C. M. Vendrell-Saz et alii, Estudios sobre
Ceràmica Antica. Barcelona 1995, pp. 77-81
Barra Bagnasco 2001 = M. Barra Bagnasco et alii,
Mineralogical and Chemical Composition of Transport
Amphorae Excavated at Locri Epizephiri (Southern
Italy). Journal of Cultural Heritage 2.3 2001, pp. 229-239
Barra Bagnasco 2006 = M. Barra Bagnasco, Da
Terravecchia di Grammichele a Occhiolà. Archeologia di
un insediamento della Sicilia centro orientale: campagne
di scavo 2000-2001. Alessandria 2006
Bats 1990 = M. Bats, Les amphores del Marseille
grecque. Chronologie et diffusion (Vie-Ier s. av. J.C.).
Actes de la table-ronde (Lattes 11 mars 1989). Etudes
Massalietes 2. Aix-en-Province 1990
Bechtold 2013 = B. Bechtold, Le anfore da trasporto da
Cossyra: un’analisi diacronica (VIII sec. a.C. – VI sec.
d.C.) attraverso lo studio del materiale dalla
ricognizione. Cossyra II. Ricognizione topografica. Storia
di un paesaggio mediterraneo, 2013. pp. 409-517 + tavv.
25-43
Bernabò Brea 1958 = L. Bernabò Brea, La Sicilia prima
dei Greci. Milano 1958
Bernabò Brea 1975 = L. Bernabò Brea, Che cosa
conosciamo dei centri indigeni della Sicilia che hanno
coniato moneta prima dell’età di Timoleonte. Atti del IV
Convegno del Centro di Studi Numismatici, Napoli 1973.
Roma 1975, pp. 3-52
Bernabò Brea 2000 = Longane, (con appendice di
G.F.Carrettoni), in Quaderni di Archeologia, Università
di Messina I,1 2000, pp. 7-57
Bonanno 1993-1994 = C. Bonanno, Scavi e ricerche a
Caronia e a S. Marco d’Alunzio. Kokalos 39-40, II 1,
1993-1994, pp. 953-985
Bonanno 1997-1998 = C. Bonanno, Scavi e indagini nel
territorio di Caronia e San Marco d’Alunzio. Kokalos
43-44, II 1, 1997-1998, pp. 423-451
Bonanno 2000 = C. Bonanno, Nuovi ritrovamenti di età
preistorica in alcuni siti della costa settentrionale della
provincia di Messina. Sicilia Archeologica 98 2000, pp.
75-86
Bonanno 2008 = C. Bonanno, Scavi in contrada Pantano
di Caronia Marina 2003-2005. Roma 2008
Bonanno, Sudano 2006 = C. Bonanno, F. Sudano, Kale
Akte. L’insediamento in contrada Pantano a Caronia
Marina. Old Pottery in a New Century. Innovating
perspectives on Roman Pottery Studies. 2006, pp. 435-
449
Brea 1967 = L. Bernabò Brea, La necropoli di Longane,
in Bullettino di Paletnologia Italiana, N.S. XVIII, vol.76,
1967, pp.181-254
Brea, Cavalier 1959 = L. Bernabò Brea - M. Cavalier,
Mylai Novara 1959
Burgio 2012 = A. Burgio, La Sicilia centro-settentrionale
tra Himera e Mylae: ipotesi di lettura sulle dinamiche
storico-topografiche del territorio. In R. Panvini, L. Sole,
La Sicilia arcaica. Dalle apoikiai al 480 a.C. Caltanissetta
2012, pp. 223-233
Cavalier 1985 = M. Cavalier, Les amphores du VIe au
IVe siècle dans les fouilles de Lipari. Napoli 1985
Cohen 2006 = B. Cohen, The Colors of Clay: Special
Techniques in Athenian Vases. Malibu 2006
Collura 2011 = F. Collura, L'area dei Nebrodi dall'età
arcaica all'età classica: frequentazione umana, notizie
storiche ed evidenze archeologiche. Preprint 2011
15
Collura 2012 = F. Collura, Kalé Akté – Calacte. Una città
greco-romana della Sicilia settentrionale (VI secolo a.C.
– V secolo d.C.). Lo stato delle conoscenze ed alcune note
inedite. Preprint 2012
Collura, Alfieri 2012 = F, Collura, V. Alfieri, L’area
archeologica di contrada Aria, Quaderni di Archeologia
Nebroidea. Vol. I, Santo Stefano di Camastra. 2012, pp.
31-34, 67-71
Corbett 1949 = P.E. Corbett, Attic pottery of the later fifth
century from the Athenian Agora. Hesperia XVIII, 1949,
pp. 298-351
Corinth VII = D.A. Amyx, P. Lawrence, Corinth VII.2,
Archaic Corinthian Pottery and the Anaploga Well.
Princeton 1975
Cronache di Archeologia 17 = Insediamenti coloniali
greci in Sicilia nell'VIII e VII secolo a.C. Atti della 2a
Riunione scientifica della Scuola di perfezionamento in
archeologia classica dell'Università di Catania
(Siracusa, 24-26 novembre 1977). Cronache di
Archeologia 17. Università di Catania, Istituto di
Archeologia. Catania 1980
Di Stefano 1998 = C.A. Di Stefano, Palermo punica.
Palermo 1998
Di Stefano 2009 = C.A. Di Stefano, La necropoli punica
di Palermo: dieci anni di scavi nell'area della caserma
Tuköry. Pisa-Roma 2009
Dominguez 2006 = A.J. Dominguez, Greeks in Sicily. In
Greek Colonisation. An Acount of Greek Colonies and
other settlements overseas. Leiden-Boston 2006, pp. 253-
357
Farnswoth 1970 = M. Farnsworth, Corinthian Pottery:
Technical Studies. American Journal of Archaeology Vol.
74.1 1970, pp. 9-22
Fortunelli 2007 = S. Fortunelli, Gravisca. Scavi nel
santuario greco. Il deposito votivo del santuario
settentrionale. Bari 2007
Gabba, Vallet 1980 = E. Gabba, G. Vallet, La Sicilia
Antica. Napoli 1980
Greco 1994 = E. Greco, Pithekoussai: empòrion o
apoikìa? Annali di Archeologia e Storia Antica 1994, pp.
11-18
Hansen 1997 = M.H. Hansen, Emporion. A study of the
use and meaning of the term in the archaic and classical
periods. Yet More Studies in the Ancient Greek Polis,
Volume 2. 1997, pp. 83-107;
Himera I = A. Adriani et alii, Himera I. Campagne di
scavo 1963-1965. Roma 1970
Himera II = N. Allegro et alii, Himera II. Campagne di
scavo 1966-1973. Roma 1976
Himera V = N. Allegro (a cura), Himera V.1. Isolato II. I
blocchi 1-4 della zona 1. Palermo 2008
Ingoglia 2009 = C. Ingoglia, Archeologia urbana a
Messina: lo scavo dell'isolato"P" in Via La Farina-Via
Oddo delle Colonne (rapporto preliminare). Quaderni di
Archeologia 4, 2003. 2009, pp. 83-96
Iozzo 1994, M. Iozzo, Ceramica "calcidese". Nuovi
documenti e problemi riproposti, Atti e Memorie della
Società Magna Grecia, Serie III, n. 2. Roma 1994
Koehler 1979, = C.G. Koehler, Corinthian A and B
transport amphoras. Princeton 1979
Koehler 1981 = C.G. Koehler, Corinthian Developments
in the Study of Trade in the Fifth Century. Hesperia 50.4,
1981, pp. 449-458
Kustermann Graf 2002 = A. Kustermann Graf, Selinunte.
Necropoli di Manicalunga. Le tombe di contrada
Gaggera. Catanzaro 2002
Lentini, Goransson, Lindhagen 2002 = M.C. Lentini K.
Göransson, A. Lindhagen, Excavations at Sicilian
Caronia, ancient Kale Akte, 1999 - 2001. Opuscula
Romana 27, 2002, pp. 79-108.
Lepore 1988 = E. Lepore, L’emporion: alcuni problemi
storiografici e metodologici. Flotte e commercio greco,
cartaginese ed etrusco nel Mar Tirreno. PACT 20 1988,
pp. 47-55
Lindhagen 2006 = A. Lindhagen, Caleacte. Production
and exchange in a north Sicilian town c. 500 BC-AD 500.
Lund 2006
Lindhagen 2015 = A. Lindhagen, Kale Akte and ‘The
Fair Shore’. Settlement, trade and production in North
Sicily c. 500 BC – 500 AD. Forthcoming 2015
Meligunìs Lipàra IX = L. Bernabò Brea, M. Cavalier,
Meligunìs Lipàra IX. Topografia di Lipari in età greca e
romana. Palermo 1998
Meola 1998 = E. Meola, Necropoli di Selinunte. I –
Buffa. Palermo 1998
Mertens 2006 = D. Mertens, Città e monumenti dei Greci
d’Occidente: dalla colonizzazione alla crisi di fine V
secolo a.C. Roma 2006
Möller, 2000 = A. Möller, Naukratis. Trade in Archaic
Greece. Oxford, 2000
Oakley 1988 = J.H. Oakley, Attic red-figured skyphoi of
Corinthian shape. Hesperia 57, 1988, pp. 165-191
Olcese 2010 = G. Olcese, Le anfore greco italiche di
Ischia: archeologia e archeometria: artigianato ed
16
economia nel Golfo di Napoli. Roma 2010
Panvini, Sole 2009 = R. Panvini, L. Sole, La Sicilia in età
arcaica dalle apoikiai al 480 a.C. Contributi dalle recenti
indagini archeologiche. Palermo 2009
Pugliese Carratelli 1996 = G. Pugliese Carratelli, I Greci
in Occidente. Milano 1996
Ramòn 1995 = J. Ramòn Torres, Las ánforas fenicio-
púnicas del Mediterráneo central y occidental. Barcelona
1995
Schreiber 1999 = T. Schreiber, Athenian Vase
Construction: A Potter’s Analysis. Malibu 1999
Scibona 1987 = G. Scibona, s.v. “Caronia”, BTCGI.
Roma-Pisa 1987, pp. 8-15
Sourisseau 1998 = J.C. Sourisseau, Marseille et la
production d’amphores “ionio-massaliètes” en Occident:
les problemes de fabrication. M.C. Amoretti, G. Gomet,
Artisanat et Matériaux. La place des matériaux dans
l’histoire des tecniques. 1998, pp. 127-152
Souriessau 2011 = J.C. Sourisseau, La diffusion des vins
grecs d’Occident du VIIIe au IVe s. av. J.-C., sources
écrites et documents archéologiques. La vigna di
Dioniso: vite, vino e culti in Magna Grecia, atti del
quarantanovesimo Convegno di studi sulla Magna Grecia
(Taranto, 24-28 settembre 2009). 2011, pp. 145-252
Spatafora, Vassallo 2002 = F. Spatafora, S. Vassallo,
Sicani, Elimi e Greci. Storie di contatti e terre di
frontiera. Palermo 2002
Spigo 2004 = U. Spigo, Archeologia a Capo d'Orlando:
studi per l'Antiquarium. Capo d’Orlando 2004
Talcott 1935 = L. Talcott, Attic Black-Glazed Stamped
Ware and Other Pottery from a Fifth Century Well.
Hesperia 4.3, 1935, pp. 477-523
Tigano 2002 = G. Tigano, Le necropoli di Mylai: VIII-I
sec. a.C. Catalogo. Milazzo 2002
Tigano 2009 = G. Tigano, Mylai II. Scavi e ricerche
nell’area urbana 1996-2005. Messina 2009
Tigano 2011 = G. Tigano, L' Antiquarium archeologico
di Milazzo Messina 2011
Tigano et alii 2008 = G. Tigano – P. Coppolino – M.C.
Martinelli, Gioiosa Guardia. L'Antiquarium e il sito
archeologico. Catanzaro 2008
Tullio 1993 = A. Tullio, Cefalù. AA.VV., Di terra in
terra, 1993, pp. 240-250
Vanedermersch 1994 = C. Vandermersch, Vins et
amphores de Grande Grèce et de Sicile. IVe-IIIe s. av.
J.C. Centre J. Berard, Etudes I. Napoli 1994
Vassallo 1996 = S. Vassallo, Coppe tipo "Iato K480".
Tipologia e diffusione. Quaderni del Museo Archeologico
Regionale “Antonino Salinas”. 1996, pp. 91-113
Vassallo 2001 = S. Vassallo, Dati preliminari sulle
importazioni attiche nella necropoli orientale di Himera.
In F. Giudice, R. Panvini, Il Greco, il Barbaro e la
Ceramica Attica. Roma 2001, pp. 89-93 + tavv. I-II
Vassallo 2003 = S. Vassallo, Himera, necropoli di
Pestavecchia. Un primo bilancio sulle anfore da
trasporto. Kokalos XLV 2003, pp. 329-379
Vassallo 2005 = S. Vassallo, Himera città greca. Guida
alla storia e ai monumenti. Palermo 2005
Vassallo 2009, S. Vassallo, La colonia di Himera lungo
le rotte dei commerci mediterranei. Il contributo delle
anfore da trasporto. R. Panvini et alii, Traffici, commerci
e vie di distribuzione nel Mediterraneo tra Protostoria e V
secolo a.C. 2009, pp. 149-157
Vassallo 2012 = S. Vassallo, La colonia dorico-calcidese
di Himera. Dai dati storici di Tucidide e di Diodoro
Siculo all’archeologia. Atti del VII Convegno di Studi -
Sicilia Antica, Caltanissetta 21-22 maggio 2011. 2012,
pp. 149-158
Vassallo 2013 = S. Vassallo, Considerazioni sul sito di
Himera: gli spazi dell'abitato, l'acqua, l'argilla.
L’Occident grec de Marseille à Mégara Hyblaea.
Hommages à Henry Trézny. 2013, pp. 265-276
Williams, Bookidis 2003 = C. Williams, N. Bookkidis,
Corinth, the Centenary, 1896-1996. Princeton 2003