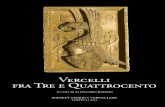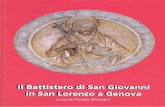I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione all'alienazione (1183-1254)
S. Minelli, Chiesa e bottega: spunti di oreficeria sacra a Vercelli, in Vercelli fra Tre e...
Transcript of S. Minelli, Chiesa e bottega: spunti di oreficeria sacra a Vercelli, in Vercelli fra Tre e...
SOCIETà STORICA VERCELLESE
Vercellifra Tre e Quattrocento
Atti del Sesto Congresso Storico Vercellese
Vercelli, Aula Magna dell’Università A. Avogadro,“Cripta dell’Abbazia di S. Andrea”
22 - 23 - 24 Novembre 2013
A cura diAlessandro Barbero
vercelli2014
9
aBBreViazioni
Archivi:AAVc = Archivio Arcivescovile di VercelliACVc = Archivio Capitolare di VercelliAFMT = Archivio della Fondazione Museo del Tesoro del DuomoAOM = Archivio Storico dell’Ordine Mauriziano di TorinoASAP = Archivio della Soprintendenza per i Beni archeologici del PiemonteASAVc = Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Vercelli ASB = Archivio di Stato di BiellaASCB = Archivio Storico Città di Biella ASCVc = Archivio Storico del Comune di VercelliASCVc, seguito da nome (es. G. Scutari) = Archivio Storico del Comune di Vercelli, Fondo Notarile, notaio G. ScutariASDM = Archivio storico della Diocesi di Milano ASTo = Archivio di Stato di Torino, CorteASTo, Riunite = Archivio di Stato di Torino, Sezioni RiuniteASVc = Archivio di Stato di Vercelli BCVc = Biblioteca Capitolare di Vercelli
Fondi:Acap = Atti capitolariAp = Atti privatiAP = Atti pubbliciFN = fondo notarileOSA = Archivio dell’Ospedale di Sant’Andrea OSA, P = Archivio dell’Ospedale di Sant’Andrea, fondo Pergamene
PC = Protocolli dei notai cameraliPD = Protocolli dei notai ducali
Pubblicazioni:DBI = Dizionario biografico degli Italiani MHP = Monumenta Historiae Patriae
501
Sara Minelli (Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare di Vercelli)
chiesa e botteGa: spunti di oreFiceria sacra a Vercelli
I documenti e i contributi pubblicati fino ad oggi hanno efficacemente dimostrato che la Cattedrale di S. Eusebio di Vercelli, tra la metà del XIV secolo e quella del XV, era dotata di preziose oreficerie, molte delle quali non più esistenti1. Altre sono sopravvissute, nonostante le numerose inte-grazioni, i rifacimenti e le modifiche subite nel corso dei secoli, secondo l’usuale precarietà alla quale sono sottoposti i manufatti metallici.
Oggi, a memoria di una stagione artistica e devozionale apparentemente ricca, il Capitolo della Cattedrale eusebiana può ancora vantare un piccolo insieme di oggetti di gran valore e, in alcuni casi, unici nel loro genere, ascrivibili al periodo compreso tra la seconda metà del XIV secolo e la prima metà del successivo. Questo gruppo comprende una statuetta raffi-gurante S. Eusebio, i reliquiari a braccio contenenti i resti di S. Giacomo Minore e S. Giuliano, il reliquiario architettonico della Beata Vergine, di S. Caterina e di S. Barnaba, il reliquiario delle braccia di S. Giacomo, S. Demetrio e S. Teodoro e il reliquiario a busto di S. Pantaleone2.
1 Il contributo più recente su questo argomento si trova in G. Ferraris, Ornamenta Ecclesie. Paramenti, oggetti e libri liturgici nel medioevo vercellese (secc. XII-XV), in «Bollettino Storico Vercellese», 78 (2012), pp. 5-42. Si veda inoltre quanto accennato da L. Marino, Grandi mecenati e piccole botteghe: le arti preziose al servizio della fede, in Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il Duecento e il Trecento, a cura di V. Natale e A. Quazza, Biella 2007, pp. 105-110, p. 110. Dal regesto dei documenti notarili dell’Archivio Storico della Città di Vercelli, effettuato da E. Canobbio in occasione del VI Congresso Storico Vercellese Vercelli fra Tre e Quattrocento (e si rimanda al suo intervento in questo volume), emergono suppellettili nate dalla committenza privata, come il calice d’argento lasciato nel 1382 da Emma, figlia del fu Giovanni da Revello de Ast, per l’eventuale ordinazione sacerdotale del figlio o, in alternativa, alla cappellania di S. Giovanni Evangelista nella Cattedrale di S. Eusebio (ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, cc. 127r-131v, 1382). 2 Ad esclusione del busto reliquiario di S. Pantaleone che è inglobato in una nicchia a lato dell’altare di S. Giovanni Nepomuceno nella Cattedrale di S. Eusebio, le altre opere citate sono conservate presso il Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli. La prima schedatura critica di questi oggetti si trova in A. M. Brizio, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia. Vercelli, Roma 1935, pp. 81-85, seguita dall’esame più approfondito di Vittorio Viale, in particolare in Id., Il Duomo di Vercelli. Il nuovo Duomo opere d’arte dal XIII al XVIII secolo, Vercelli 1973, pp. 33-35. Il lavoro del Viale è stato poi il punto di riferimento per le successive pubblicazioni fino alle prime revisioni critiche di: Marino, Grandi mecenati
502
Sara Minelli
La datazione di queste opere si inserisce in una linea temporale scandita da quattro date precise: il 1350, anno al quale si data una scritta apposta al codice V3 della Biblioteca Capitolare di Vercelli, il 1362, anno del testa-mento dell’arcidiacono Martino de Bulgaro4, il 1368, momento in cui viene registrato il suo Necrologio5, e il 1426, cioè l’anno in cui è stato stilato l’In-ventarium scripturarum existentium in Archivio Sancti Eusebii Vercellensis dal canonico tesoriere Giovanni de Guidalardis6.
I riferimenti cronologici, in aggiunta alle disamine storico-artistiche e ad altre testimonianze documentarie più specifiche per alcuni oggetti, permet-tono di visualizzare un’attività orafa vercellese che tra XIV e XV secolo è vivace e aperta agli scambi verso manifatture extralocali. All’assoluta man-canza di staticità dell’artigianato vercellese, testimoniata dalle peculiarità degli oggetti, si aggiungono le scelte curiose della committenza, che trova nell’interessante figura di Martino de Bulgaro il riflesso più immediato7. All’arcidiacono, oltre alla donazione di manoscritti e beni di varia natura, riconduciamo con certezza la statuetta di S. Eusebio, il reliquiario a braccio di S. Giacomo minore e l’alberello di corallo inglobato nel reliquiario archi-tettonico della Beata Vergine8.
Sono note le vicissitudini della statuetta argentea posta all’apice della cosiddetta Urna di S. Eusebio conservata al Museo del Tesoro del Duomo (Fig. 1): la cassa è stata eseguita nel 1618-1619 per volere di Carlo Ema-
e piccole botteghe cit., pp. 105-110; L. Marino e C. Piglione, Oreficeria: produzione locale e concorrenza lombarda, in Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il Quattrocento, a cura di V. Natale, Biella 2005, pp. 145-154; si rimanda a questi due saggi per ulteriore bibliografia in merito. 3 BCVc, Codice V, Liber Decretalium. La scritta apposta al codice è trascritta in G. Ferraris, Le chiese “stazionali” nelle rogazioni minori a Vercelli dal sec. X al sec. XIV, a cura di G. Tibaldeschi, Vercelli 1995, p. 221, nota 338. 4 ACVc, Testamenti e codicilli 1202-1598. 5 Ferraris, Le chiese “stazionali” cit., p. 221, nota 338, con riferimento ai documenti. 6 ACVc, Inventario 25, Inventarium scripturarum existentium in Archivio Sancti Eusebii Vercellensis confectum de anno 1426.7 Su Martino de Bulgaro si vedano: Ferraris, Le chiese“stazionali” cit., pp. 221-222, nota 338; G. Ferraris, I canonici della Cattedrale di Vercelli nel secolo XIV. Linee di ricerca, in Vercelli nel secolo XIV. Atti del V Congresso Storico Vercellese, a cura di A. Barbero e R. Comba, Vercelli 2010, pp. 245-292; P. Rosso, Università e sapientes iuris a Vercelli nel Trecento, in ivi, pp. 169-244, alle 212-213; Ferraris, Ornamenta cit., pp. 26-30.8 Ferraris, Le chiese “stazionali” cit., pp. 221-223, nota 338.
503
Chiesa e bottega
nuele I per contenere le spoglie del Beato Amedeo IX di Savoia9. Il 13 ago-sto 1733 i libri dei conti del Capitolo registrano il pagamento all’argentiere Rossetti per la fattura della sedia d’argento e, quindi, per l’adattamento della statuetta alla cassa e, nello stesso giorno viene pagato anche il «...le-gnamaro Feraris per la machina fatta dietro l’altare per espor detto santo»10.
L’Urna di S. Eusebio, così come la vediamo oggi, è nata quindi dal riuso di due oggetti che, nel 1733, sono stati uniti per adempiere alla rinnova-ta sacralizzazione delle spoglie del patrono. La statuetta tuttavia ha una storia più lunga e travagliata: il canonico Gaspardo de Rodobio, entro il 1368, ne affidò l’esecuzione ad artigiani milanesi pagando una commis-sione di 100 fiorini ma in realtà l’opera fu eseguita solo intorno al 1350, momento in cui Martino de Bulgaro intervenne nella questione sospesa e portò a termine il progetto11. Comprensivo del trono, Eusebio è segnalato nell’Inventarium del 1426, senza indicazione sulla destinazione d’uso che, al momento, rimane ancora ignota fino al rimaneggiamento del 173312. Per quanto riguarda il luogo di produzione dell’opera, conclusa la disputa con gli orafi lombardi, non è da escludere che il nuovo committente si sia rivolto ad una bottega locale.
9 Sulla statuetta di S. Eusebio si veda: Marino e Piglione, Oreficeria cit., p. 152 e Marino, Grandi mecenati e piccole botteghe cit., pp. 108-109. Per la cassa seicentesca: G. Romano, Artisti alla corte di Carlo Emanuele I: la costruzione di una nuova tradizione figurativa, in Le collezioni di Carlo Emanuele I, a cura di G. Romano, Torino 1995, pp. 13-52, pp. 34-36. 10 Sulla vicenda si veda A. Brunetto e C. Gilardi, Giacomo Goria vescovo di Vercelli. Eredità astigiana e modello borromaico 1571-1648, Asti – Vercelli 1998, pp. 348-349, nota 19. Nel maggio del 1732 Rosetti viene pagato anche «per aver racomodata et imbiancata tutta l’argentaria della chiesa incluse le lampade e casse con suo argento rimesso in diversi luoghi ove mancava». Forse l’argentiere si lega all’orafo vercellese Antonio Rosetti, menzionato nei libri dei conti fin dal 1674. Antonio si occupava della manutenzione dei reliquiari della Cattedrale ed è a lui che forse è da attribuire il reliquiario ad ostensorio dell’anello di S. Carlo poiché nel 1678 riceve il saldo di quanto dovuto per il «reliquiario novo, come pure per haver accomodato et legato in argento l’anello usato di S. Carlo» entrato l’anno precedente nel patrimonio del Capitolo tramite donazione (ACVc, Contabilità 1667-1689, p. 26; per il reliquiario V. Ibertis e S. Minelli, Reliquiario con anello di san Carlo Borromeo, scheda di catalogo in Divo Carolo. Carlo Borromeo pellegrino e santo tra Ticino e Sesia, a cura di F. Gonzales e C. Lacchia, Novara 2010, pp. 119-122). 11 Ferraris, Le chiese “stazionali” cit., p. 222, nota 338, con riferimento ai documenti, compreso il necrologio del canonico Gaspardo di Robbio. 12 Non è nota la sorte della statuetta del Beato Amedeo sostituita nel 1733 da quella di S. Eusebio, per la descrizione tuttavia si veda Brunetto e Gilardi, Giacomo Goria vescovo di Vercelli cit., p. 348, nota 19.
504
Sara Minelli
Del resto la presenza, anzi l’incremento, di maestranze dedite alla lavo-razione dei metalli nella Vercelli di XIV secolo è stata ampiamente dimo-strata dai documenti dove gli orafi sono presenti in compravendite, come testimoni negli atti notarili piuttosto che come proprietari di terre e piccoli patrimoni immobiliari13.
Nei notarili dell’Archivio Storico del Comune di Vercelli relativi alla seconda metà del XIV secolo sono infatti segnalati alcuni doreri che lavo-ravano in città. Possiamo quindi fare qualche nome prendendo ad esempio gli atti rogati dal notaio Faciolo da Biandrate tra il 1377 e il 1389. In questo breve giro di anni troviamo i de Gaya, Eusebio dorerius e habitator vercel-lensis, figlio del fu Simone, segnalato nel 138414 e 138515, e Bertolino, figlio del fu Antonio16, entrambi doreri, il primo segnalato tra 137817 e 138718. Tra il 1382 e il 1387 si segnalano i Carengo: Giovanni dorerius, figlio del fu Giorgio, è tenuto a versare un fitto in perpetuo per una casa nella vicinia di S. Giuliano19. I documenti permettono di ricostruire anche parte delle vicis-situdini famigliari di questi personaggi: Giovanni Carengo, nel 1382, versa ad Antonio Casalino la dote della moglie Antonia Carengo, figlia del fu Filippone dorerius vercellensis, ma di cui era tutore20. Il padre di Giovanni, l’orafo Giorgio, era sicuramente già morto nel 1384 visto il testamento di
13 B. Del Bo, Mercanti e artigiani a Vercelli nel Trecento: prime indagini, in Vercelli nel secolo XIV cit., pp. 527-552, in particolare alle pp. 548-550. Si rimanda nuovamente all’intervento di E. Canobbio in questo volume. 14 ASCVc, F. da Biandrate, 970/809, c. 8rv, 25 gennaio 1384.15 ASCVc, F. da Biandrate, 971/810, cc. 155r-156v, 5 dicembre 1385.16 ASCVc, F. da Biandrate, 967/806, c. 159rv, 20 ottobre 1379, allorché vengono citati gli eredi fissando così la morte dell’orafo ad un momento precedente. 17 ASCVc, F. da Biandrate, 966/805, cc. 224v-225r e 225v-226r, 12 dicembre 1378; ASCVc, F. da Biandrate, 968/807, cc. 10r-11r e cc. 98r-99r, 18 gennaio e 8 ottobre 1381; ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, c. 142rv, 12 ottobre 1382. 18 ASCVc, F. da Biandrate, 972/811, c. 44r, 24 marzo 1387.19 ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, cc. 208r-211v, 14 dicembre 1382, in ASCVc, F. da Biandrate, 970/809, cc. 34v-35v e c89rv, 24 maggio e 13 ottobre 1384, e in ASCVc, F. da Biandrate, 972/811, c. 100rv, 17 dicembre 1387. Giovanni è menzionato, per il fitto di un terreno, anche nel 1378 (ASCVc, F. da Biandrate, 966/805, c. 221rv, 12 dicembre 1378) e nel 1381 (ASCVc, F. da Biandrate, 968/807, cc. 122r-123r, 1 dicembre 1381; l’atto è del 1 dicembre e nello stesso giorno Giovanni è chiamato come testimone di un altro fitto, ivi, c. 123v).20 ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, cc. 7r-10v, 17 gennaio 1382.
505
Chiesa e bottega
Antonia de Arro21 dove la donna è citata come sua vedova però sappiamo che era già attivo nel 1354, poiché in un notarile del 1382 si annota una sua investitura risalente a quell’anno22. Oltre ai documenti direttamente legati a debiti, crediti, fitti e possedimenti degli orafi, vi sono gli atti rogati alla presenza degli stessi in qualità di testimoni. Sempre Giovanni Carengo è testimone del testamento della vedova di un becarius il 22 ottobre 1382, insieme al dorerius Antonio da Arborio23. Alla famiglia degli Arborio ap-partenevano anche Eusebio24, figlio del fu Giovanni, e Caterina, figlia del fu Ruggero oltre che vedova di Giovanni Carengo, dorerius vercellensis che lascia un testamento datato al 24 marzo 138725. Questo documento in-dica non solo che Giovanni Carengo in quel momento era già defunto, ma suggerisce che tra le famiglie degli orafi vi fossero contatti instaurati anche tramite vincoli matrimoniali.
I de Gaya, i Carengo, gli Arborio non sono gli unici professionisti dei metalli citati dai documenti, troviamo infatti altri orafi: Nicolello de Lena26, Niger de Marchorengo27, Pietro de Lucha28; Antonio de Confienza29, figlio del fu Nicolone, Antonio e il padre Giovanni de Raymondo30 e Nicolello
21 ASCVc, F. da Biandrate, 970/809, cc. 76r-77v, 14 settembre 1384.22 ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, c. 15v, 5 dicembre 1354 (nei documenti relativi al 1382). Alcuni documenti potrebbero testimoniare la rogazione di alcuni atti presso l’abitazione del Carengo nella vicinia di S. Michele (ASCVc, F. da Biandrate, 966/805, c. 79r, 7 marzo 1378; ASCVc, F. da Biandrate, 967/806, c. 178r, 27 novembre 1379; ASCVc, F. da Biandrate, 968/807, c. 3r, 22 dicembre 1380). 23 ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, cc. 151r-152v, 22 ottobre 1382. Antonio compare come testimone anche in ASCVc, F. da Biandrate, 971/810, c. 82rv, 3 agosto 1385.24 ASCVc, F. da Biandrate, 968/807, c. 69rv, 17 giugno 1381.25 ASCVc, F. da Biandrate, 972/811, cc. 41r-43v e c73v, 24 marzo e 15 settembre 1387.26 ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, c. 24r, 9 febbraio 1382.27 ASCVc, F. da Biandrate, 968/807, cc. 45r-46v, 29 gennaio 1381; ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, c.145rv e 148r-149v, 17 e 19 ottobre 1382; in entrambi si tratta del luogo dove sono stipulati gli accordi e non di affari in cui era coinvolto l’orafo. Caterina, moglie di Niger de Marchorengo, è infatti citata come vedova già nel 1379 (ASCVc, F. da Biandrate, 967/806, cc. 178v-179r, 29 novembre 1379). 28 ASCVc, F. da Biandrate, 969/808, c. 195rv, 8 dicembre 1382.29 ASCVc, F. da Biandrate, 970/809, c. 103v, 20 novembre 1384.30 In ASCVc, F. da Biandrate, 970/809, cc. 78r-79r, cc. 101v-102v, cc. 106r-107r e cc. 122r-123v, 17 settembre, 19 e 22 novembre e 12 dicembre 1384 sono citati entrambi ma la qualifica di dorerius è attribuita solo al padre già defunto.
506
Sara Minelli
e Giovanni da Benna, il primo nominato fino al 138731. Nello stesso anno Uberto de Alario32, dorerius, è citato nel testamento della moglie e trovia-mo inoltre Eusebius de Lancea, dorerius e civis vercellensis33. Quello che manca nelle fonti archivistiche sono le esatte mansioni degli artigiani che, sembrano avere competenze flessibili, come ad esempio la manutenzione dell’orologio pubblico di Vercelli, nell’antica sede del Comune, affidata al già citato Simone de Gaya, padre di Eusebio, nel 137734.
L’approvvigionamento metallifero della città inoltre non era un proble-ma di difficile risoluzione alla luce delle tracce documentarie e geologiche che indicano la presenza di una serie di giacimenti argentiferi sul territorio, oggetto di scambi, affitti e concessioni di sfruttamento, anche a minatori stranieri35. L’accesso alle miniere aurifere e argentifere appare abbastan-za limitato per il commercio vercellese, soprattutto rispetto ad altre aree piemontesi ma, verosimilmente, poteva alimentare le manifatture locali affiancandosi alle esportazioni da altri territori36. Seppur i giacimenti non fossero ubicati nelle immediate vicinanze della città, è verso di essi che si assiste, a partire dal XIII secolo, a politiche di espansione che tendono ad accaparrarsi territori caratterizzati da attività minerarie e metallurgiche37. Basti pensare alle coltivazioni di ferro e argento documentate in Val Sesse-
31 In ASCVc, F. da Biandrate, 967/806, c. 155rv, 5 agosto 1379, si trovano entrambi; ASCVc, F. da Biandrate, 968/807, cc. 84r-85v, 14 settembre 1381; ASCVc, F. da Biandrate, 971/810, c. 72r, 18 giugno 1385. Nicolello compare poi nel 1381 (ASCVc, F. da Biandrate, 968/807, cc. 84r-85v, 14 settembre 1381), nel 1384 (ASCVc, F. da Biandrate, 970/809, cc. 116r-117v, 4 dicembre 1384), nel 1385 (ASCVc, F. da Biandrate, 971/810, cc. 72r, 18 giugno 1385), e nel 1387 (ASCVc, F. da Biandrate, 972/811, c. 14r, 26 gennaio 1387). 32 ASCVc, F. da Biandrate, 972/811, cc. 31r-33v, 26 febbraio 1387.33 ASCVc, F. da Biandrate, 972/811, c. 34r, 3 marzo 1387.34 V. Mandelli, Il comune di Vercelli nel Medioevo, III, Vercelli 1858, p. 76. V. Bussi, Scritti vercellesi, a cura di R. Ordano, Vercelli 2003, p. 159. L’autore localizza anche una zona della città destinata alle botteghe dei dorerii che corrisponde all’attuale via Foà. 35 R. Ordano, Appunti di storia vercellese, Vercelli 1959, pp. 73-74. 36 A. M. Nada Patrone, Il Medioevo in Piemonte. Potere, società e cultura materiale, Torino 1986, pp. 189-190 e B. O. Gabrieli, L’inventario della spezieria di Pietro Fasolis e il commercio dei materiali per la pittura nei documenti piemontesi (1332-1453), prima parte, in «Bollettino della Società Storica Pinerolese», 29 (2012), pp. 7-43, alle pp. 15-16. 37 G. Di Gangi, L’attività estrattiva e metallurgica nel Piemonte medievale: spostamenti di maestranze e trasmissione di tecnologie, «imprenditori minerari» ed insediamenti specializzati, in La sidérurgie alpine en Italie (XII-XVII siècle), a cura di P. Braunstein, Roma 2001, pp. 327-392, pp. 339-340.
507
Chiesa e bottega
ra, e nell’area mineraria di Postua-Ailoche-Crevacuore e che quest’ultima, aveva le risorse necessarie per formare minatori specializzati emigranti nel XIV secolo verso la Valle di Lanzo38.
A fronte della presenza di orafi e materie prime, ma anche dell’assenza di documenti di commissione puntuali, risulta impossibile ricondurre con certezza ad una figura locale specifica la realizzazione delle suppellettili della Cattedrale di S. Eusebio.
Parte dell’argento utilizzato per il reliquiario a braccio di S. Giacomo minore, era stato donato direttamente da Martino de Bulgaro (Fig. 2). Il reliquiario è segnalato nel Necrologio del canonico pertanto è databile entro il 136839. La prima scheda di catalogo del manufatto stabiliva un rapporto copia-modello con il braccio di S. Giuliano (Fig. 4), considerando questo un prodotto di bottega oltralpina, giunto a Vercelli nella metà del XIV seco-lo e poi copiato da una bottega locale nel braccio di S. Giacomo minore40. Questa tesi è stata rivista in un secondo tempo attribuendo il reliquiario ad una bottega lombarda ma, secondo il parere di chi scrive, non è da esclu-dere che l’apporto lombardo sia da considerarsi solo come un’influenza e che gran parte dell’oggetto, esclusi forse gli smalti, sia stata creata da una bottega vercellese41.
Per ciò che concerne il rapporto tra i due reliquiari vedremo in seguito che vi è motivo di ritenere il braccio di S. Giuliano come opera molto più tarda. Il confronto tra l’impostazione gestuale dei due manufatti è inevita-
38 R. Ordano, Bocchetta d’Isola. Documenti sulla toponimia della zona, in «Rivista Biellese», 2 (1951), pp. 10-12; Ordano, Appunti cit., pp. 74-78; Di Gangi, L’attività estrattiva cit., pp. 339-340. Per un riferimento specifico alla zona Postua-Ailoche-Crevacuore e al dominio sull’area tra XII e XIV secolo si veda G. Di Gangi, L’attività mineraria e metallurgica nelle Alpi occidentali italiane nel Medioevo. Piemonte e Valle d’Aosta: fonti scritte e materiali, Oxford 2001, p. 174 e pp. 183-184. 39 Ferraris, Le chiese “stazionali” cit., p. 222, nota 338. 40 Viale, Il Duomo di Vercelli cit., p. 34. Qualche decennio prima anche la Brizio schedò i due oggetti attribuendo il braccio di S. Giacomo alla prima metà del Quattrocento (A. M. Brizio, Catalogo delle cose d’Arte e Antichità in Italia. Vercelli, Roma 1935, p. 83) e quello di S. Giuliano alla seconda metà del Trecento, in ambito di produzione non italiano basandosi sugli smalti che lo adornano (ivi, p. 84).41 La revisione giunge in occasione di un’importante mostra di oreficeria gotica con la scheda n. 148 di C. Piglione, in Il Gotico nelle Alpi. 1350-1450, catalogo della mostra a cura di E. Castelnuovo e F. De Gramatica, Trento 2002, pp. 774-775, poi riproposta in L. Marino e C. Piglione, Oreficeria: produzione locale e concorrenza lombarda, in Arti figurative a Biella e Vercelli. il Quattrocento, a cura di V. Natale, Candelo 2005, pp. 145-154, p. 153.
508
Sara Minelli
bile, considerando inoltre la volontà comune di richiamare le preziose vesti trecentesche, ma questi punti di contatto sono insufficienti per indicare l’in-terdipendenza tra gli oggetti42. Oltre ciò, i due reliquiari sono frutto di due diverse lavorazioni, anche a livello decorativo, evidenti nella scelta degli smalti usati: se nel braccio di Martino de Bulgaro si fa ampio uso di smalti traslucidi, in quello di S. Giuliano è lo smalto in filigrana a imporsi sulla decorazione.
Gli smalti traslucidi di S. Giacomo minore, rappresentanti gli apostoli a corredo del messaggio evangelico richiamato dalla reliquia principale, sono la parte più interessante dell’opera, nonostante l’incoerenza dell’as-semblaggio. La fascia verticale presenta nella parte sinistra due losanghe che si prestano ad una lettura orizzontale e non verticale, al contrario di ciò che avviene con le losanghe della parte opposta della fascia. Questo dato potrebbe rimandare ad un errore dell’orafo, qualora egli sia stato colui che ha preparato gli smalti e poi montato la fascia, oppure ad un’incomprensio-ne tra orafo e smaltatore ove si sia trattato di professionalità distinte, magari operanti in botteghe diverse poiché non se ne può escludere l’importazione. Altra ipotesi, per cui mancano fonti documentarie certe, è quella di un re-stauro storico che abbia invalidato l’alloggiamento originale degli elementi, forse sottraendo dalle fasce orizzontali le losanghe per completare la deco-razione verticale.
Gli smalti trovano confronto sia con le produzioni senesi sia con quelle lombarde. Per la prima ipotesi è possibile citare ad esempio con il calice di Giacomo di Guerrino, del 1375, attualmente parte della collezione della Loyola University di Chicago, e gli smalti del nodo del calice di Goro ser Neroccio del 1415, conservato in collezione privata43. Tra le più vicine ope-
42 Tra gli esempi più celebri di rappresentazione degli indumenti dell’epoca si vedano ad esempio la Pietà di Giottino eseguita tra 1360 e 1365 per la chiesa di S. Remigio a Firenze e oggi agli Uffizi (G. Fossi, Romanico e Gotico, Prato 2005, p. 166) e la serena Madonna con Bambino affrescata da Giacomo da Riva nella chiesa trentina di S. Apollinare a Prabi di Arco, databile all’ultimo quarto del XIV secolo (E. Chini, Il Gotico in Trentino. La pittura di tema religioso dal primo Trecento al Tardo Quattrocento, in Il Gotico nelle Alpi. 1350-1450, Catalogo della mostra a cura di E. Castelnuovo e F. de Gramatica, Trento 2002, pp. 78-115). 43 E. Cioni, Un calice indeito firmato da Goro di ser Neroccio per la chiesa di San Francesco a Borgo Sansepolcro, in «Opera Nomina Historiae. Giornale di cultura artistica», 1 (2009), pp. 173-212. Marino, Grandi mecenati e piccole botteghe cit., p. 109, propone un confronto con il reliquiario a busto di S. Donato di Cividale del Friuli del 1374 (si veda la bibliografia a corredo di D. Magrin, Busto reliquiario di San Donato, in Il Gotico nelle Alpi. 1350-1450,
509
Chiesa e bottega
re lombarde, favorite come confronto dal rapporto tra la diocesi vercellese e la realtà milanese, troviamo smalti similari in opere tarde, come il calice di Gian Galeazzo Visconti di Monza posto a cavallo tra XIV e XV secolo e il quattrocentesco reliquiario della Sacra Spina racchiuso nell’ostensorio del Duomo di S. Lorenzo a Voghera44.
Un dato molto interessante legato alle oreficerie vercellesi tra Trecento e Quattrocento si rileva nella tendenza della Cattedrale di S. Eusebio di dotarsi di reliquiari antropomorfi funzionali alle celebrazioni. Suppellettili di questo tipo sono utili alla manifestazione tangibile dei santi durante la liturgia, in modo non dissimile da quanto accadeva in altri contesti trecen-teschi45. La tipologia che più rispecchia la compartecipazione salvifica degli eroi cristiani è quella dei reliquiari a busto ed ecco che, intorno al 1387, la chiesa di S. Eusebio si arricchisce con il busto di S. Pantaleone (Fig. 3), nuovamente di produzione locale46. La testa è databile grazie al lascito te-stamentario di una donna vercellese che contribuì alla sua realizzazione, il che si accorda con la comparsa dell’agiografia e della messa per il santo nel
Catalogo della mostra, a cura di E. Castelnuovo e F. De Gramatica, Trento 2002, pp. 746-747). 44 P. Venturelli, Reliquiario della Sacra Spina, in Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano, Catalogo della mostra, a cura di P. Venturelli, Milano 2012, pp. 156-157. La Venturelli data il reliquiario al 1400 circa, mentre il tabernacolo in cui è inglobato è settecentesco. 45 Mi riferisco al fatto che i cosiddetti “reliquiari parlanti” permettono ai sacri resti di passare dell’essere oggetto di venerazione passiva allo status di strumento attivo durante le celebrazioni. Per un primo orientamento si vedano: H. Keller, Zur Entstehung der sakralen Vollskulptur in der Ottonischen Zeit, in Festschrift für Hans Jantzen, Berlino 1951, pp. 71-90; B. Abou-El-Hai, The audience for the Medieval Cult of Saints, in «Gesta», 30 (1991), pp. 3-15; C. Walker Bynum, P. Gerson, Body-part reliquaries and body-parts in Middle Age, in «Gesta», 36 (1997), pp. 3-7; B. Drake Boehm, Body-Part reliquaries: the state of research, in ivi, pp. 8-19; C. Hahn, The voices of Saints: speaking reliquaries, in ivi, pp. 20-31; C. Hahn, Metaphor and meaning in early medieval reliquaries, in Seeing the invisible in late antiquity and the early middle ages, ed. by G. De Nie, K. F. Morrison e M. Mostert, Turnout 2005, pp. 239-263; C. Hahn, The spectacle of the charismatic body. Patrons, artists, and body-part reliquaries, in Treasures of Heaven. Saints, relics, and devotion in medieval Europe, Catalogo della mostra, ed. by M. Bagnoli, H. A. Klein, C. Griffith Mann, J. Robinson, Baltimora 2010, pp. 163-172, L. Canetti, Impronte di gloria. Effigie e ornamento nell’Europa cristiana, Roma 2012, pp. 203-243. 46 S. Minelli, Un reliquiario parlante: San Pantaleone nel Tesoro del Duomo di Vercelli. Riflessioni e Revisioni, in «Bollettino Storico Vercellese», 2 (2012), pp. 85-106.
510
Sara Minelli
patrimonio codicologico della Biblioteca Capitolare47. Il reliquiario è inoltre citato nel 1426 con una corona di cui si è persa
traccia, e questa non è l’unica alterazione dell’aspetto originale vista l’as-senza del colletto che arricchiva la veste testimoniato dalla presenza dei fori di aggancio. Inoltre, le pupille degli occhi del santo in origine erano smaltate e la base del reliquiario non è originale ma è stata aggiunta nella prima metà del XV secolo48.
Durante un recente restauro il reliquiario è stato smontato e ciò ha per-messo di vedere alcuni segni non decifrati nel verso delle colonnine e degli archetti, incisi, forse, da colui che ha realizzato gli elementi per mantenere traccia della sequenza di montaggio. Questo sistema di bottega è stato rile-vato anche per il già citato calice di Gian Galeazzo Visconti di Monza che, con il nostro busto, è affine per il richiamo alle soluzioni architettoniche del gotico lombardo, senza però che tale somiglianza intacchi l’ipotesi di una provenienza locale del busto49.
La differenza tra la parte anatomica del busto e il suo alloggiamento sta-tico è evidente, inoltre, se si considera l’attenzione dell’orafo nella resa dei piccoli dettagli come i minuti segmenti incisi per dare movimento alla bar-ba, particolari volti ad una rappresentazione realistica forse non raggiunta del tutto poiché legata a modelli ancora duecenteschi50. Pantaleone, risulta-
47 ASCVc, F. da Biandrate, 972/811, cc. 25r-30v, 22 febbraio 1387; si tratta del testamento di Agnesina de Scutariis, figlia del fu Pietro e vedova di Ambrogio de Sylvestro, sepolta nella chiesa di S. Francesco di Vercelli. Segnalato in G. Tibaldeschi, I “misteriosi quaderni”, in Mons. Ferraris...a 10 anni dalla morte. Un sacerdote vercellese tra storia e pastorale, a cura di T. Leonardi, Vercelli 2010, pp. 57-88, a p. 62. 48 Le pupille sono state ricreate con l’inserimento di due chiodini rimossi in occasione del restauro precedente alla mostra Il Gotico nelle Alpi. 1350-1450 svoltasi tra il 30 giugno e il 19 ottobre 2002 al Castello del Buonconsiglio di Trento. Si rimanda alla scheda di catalogo di C. Piglione, Busto reliquiario, in Il Gotico nelle Alpi cit., p. 750. 49 L. Dolcini, Il calice in argento e smalti di Gian Galeazzo Visconti nel Duomo di Monza, in «OPD Restauro. Quaderni dell’Opificio delle Pietre Dure», 4 (1992), pp. 51-61. 50 Tale ipotesi trova forse conferma anche nelle analisi scientifiche patrocinate nel 2011 dalla Fondazione Museo del Tesoro del Duomo, che hanno svelato la composizione metallica del manufatto, per parte dei risultati si veda Minelli 2012, pp. 88-96. Un esempio più riuscito, in tal senso, si può trovare nel busto di S. Bernardo di Aosta, opera del 1424 circa, conservato nella Cattedrale di S. Maria Assunta di Novara. Si vedano: G. Andenna, Documenti intorno al culto di san Bernardo di Aosta nel Novarese (secoli XII-XVI) con alcune riflessioni dell’uso etico e politico di una agiografia, in «Novarien», 10 (1980), pp. 86-108; C. Piglione, Il busto reliquiario di San Bernardo di Aosta e l’oreficeria del primo quattrocento, in Le storie di
511
Chiesa e bottega
va tuttavia presente alle celebrazioni con la sua effige, fissata in giovane età, cioè nel momento in cui, secondo l’agiografia, aveva accettato il martirio. Il tramandarsi della sua agiografia, la messa a lui dedicata, la titolazione di un altare in Cattedrale, sono tutti segni di un fervore devozionale assodato an-che grazie alla scelta di commissionare un reliquiario a busto. Del resto, sia dalle opere tuttora esistenti sia dalle fonti, soprattutto al di fuori del terri-torio vercellese, si evince che tra reliquiari antropomorfi e liturgia esistono interdipendenze che sfociano sul piano teologico, su quello funzionale alla celebrazione e su quello strutturale dell’edificio dove il manufatto è conser-vato. Questo rapporto, che sembra palesarsi con forza nel Trecento, spinge i reliquiari da un ruolo di venerazione passiva a quello di compartecipazione attiva all’interno delle celebrazioni e sono noti molti esempi relativi a bene-dizioni impartite con i reliquiari a braccio51.
Un utilizzo simile, per la Cattedrale vercellese, è ipotizzabile per il brac-cio reliquiario di S. Giacomo minore, mentre è più difficile attribuire lo stesso ruolo al braccio di S. Giuliano, caratterizzato da un’elaborata base architettonica che ne sancisce la staticità (Fig. 4). Il reliquiario di S. Giulia-no è opera di una bottega pienamente lombarda da datare al primo quarto del XV secolo, sicuramente entro il 1426, momento in cui è citato nell’In-ventarium.
Si tratta di un braccio in lamina d’argento che si diparte da una base a dodici lati, ognuno dei quali presenta una piccola finestra contenente una reliquia52. La base è la parte più indicativa di un possibile confronto di nuo-
Salomone e altre opere d’arte nel novarese, Novara 1992, pp. 35-41, p. 66.51 Si veda ad esempio il saggio di G. Freni, Spazio liturgico e luoghi sacri nella cattedrale e nella pieve, in Arte in terra d’Arezzo, il Trecento, a cura di A. Galli e P. Refice, Firenze 2005, pp. 209-228, in particolare p. 225. Per la funzionalità liturgica dei reliquiari a braccio cito ad esempio un braccio di S. Basilio di Essen, dell’XI secolo, che veniva preso dall’altare maggiore e utilizzato per la benedizione finale dei fedeli (Hahn, The voices of Saints cit., p. 27), e lo stesso uso era destinato al braccio di S. Firmino da parte del vescovo di Amiens nelle occasioni importanti (W. Sauerländer, Cathedrals and sculptures. II, Londra 2000, pp. 130-131). La particolare forma del braccio di S. Pietro, S. Lorenzo e S. Andrea del Tesoro della Cattedrale di Ragusa di Dalmazia, della metà del XIV secolo, basta di per sé per comprenderne l’uso visto che è un braccio completo, leggermente piegato, con la mano socchiusa in segno di protezione (Scheda 32, in «Et ils s’émerveillèrent». L’art médiéval en Croatie, Catalogo della mostra, éd. par N. Jaksic, Paris 2012, p. 78).52 Le finestrelle della base contengono le reliquie di: S. Maurizio, S. Nicola, S. Leone, S. Giacomo, S. Emerita, S. Secondo, S. Sebastiano, S. Clemente, S. Vittore, S. Anastasia, S. Giorgio e S. Abbondio.
512
Sara Minelli
vo con il calice di Gian Galeazzo Visconti prodotto tra il 1396 e il 1402 e oggi conservato al Museo del Tesoro del Duomo di Monza53. Questo ca-polavoro è legato all’influenza di Giovannino De Grassi che fu miniatore, pittore e scultore documentato a Milano tra il 1389 e il 1398. Egli fu uno dei personaggi più recepiti del panorama gotico milanese. La sua influenza, e la sua mano, si trova, insieme a quella di Hans Fernach ed altri, anche nella sovrapporta della sagrestia meridionale del Duomo di Milano ed è a questi modelli e allo splendore architettonico delle oreficerie lombarde che biso-gna volgere lo sguardo nel tentativo di confronto con il reliquiario a brac-cio di S. Giuliano. Si prendano ad esempio i tempietti del reliquiario della chiesa del Carmine di Bergamo del XV, la complessità dell’ostensorio della Collegiata di S. Lorenzo a Voghera54 e del tardo calice di Giovanni Maria Parravicini conservati entrambi nelle Civiche Raccolte d’Arte Applicata del Castello Sforzesco a Milano55.
Una nota a parte meritano gli smalti in filigrana del braccio di S. Giu-liano: se ne trovano di molto simili nella base del reliquiario a braccio del Tesoro di S. Orso ad Aosta e nella cassa di S. Grato della Cattedrale della stessa città56. Entrambi gli esempi si legano alla figura di Jean De Malines, documentato ad Aosta tra 1421 e 1459, che riutilizza delle placche non co-eve, realizzate con un grado di raffinatezza e precisione più elevato rispetto alle fasce del braccio di S. Giuliano57.
Il motivo a fiorellini bianchi, che vediamo in veste antica ad Aosta e poi riproposto nel braccio di S. Giuliano, si ritrova in molte altre opere eseguite
53 O. Zastrow, Oreficeria in Lombardia, Milano 1978, pp. 139-140.54 O. Zastrow, Museo d’Arti Applicate. Oreficerie, Milano 1993, pp. 97-92. Nel tardo ostensorio di bottega lombarda prodotto per la collegiata di S. Lorenzo di Voghera si nota la stessa volontà di privilegiare l’aspetto scenografico più che la cura dei singoli dettagli. 55 Zastrow, Oreficeria in Lombardia cit., pp. 153-173.56 C. Piglione, Le oreficerie medievali del Tesoro, in Sant’Orso di Aosta. Il complesso monumentale, I, Saggi, a cura di C. Piglione e E. Rossetti Brezzi, Aosta 2001, pp. 263-280, pp. 263-265. 57 Sono molti gli esempi di riuso in oreficeria come in molte altre tecniche artistiche, anche laddove non mancava la possibilità di creare nuovi elementi. Si veda ad esempio il reimpiego dei cinque trilobi in èmail de plique nella cuspide posteriore della mitra del busto di S. Ignazio di Antiochia del XV secolo conservato a S. Maria Novella a Firenze (M. Collareta e A. Capitanio, Oreficeria sacra italiana, Firenze 1990, p. 195). Per gli ultimi aggiornamenti sul patrimonio aostano si rimanda al catalogo più recente Cattedrale di Aosta. Museo del Tesoro, a cura di E. Castelnuovo, F. Crivello, V. Vallet, Aosta 2013.
513
Chiesa e bottega
tra Trecento e Quattrocento, anche in forma molto diversa. Si vedano ad esempio i fiori di fragaria vesca a tutto tondo nel busto di S. Bernardo a Novara del 1424, materialmente distanti da quelli del braccio vercellese ma sintomo di una moda che si ripropone per molto tempo nell’Italia Setten-trionale58. Sulla stessa scia troviamo altre affinità decorative nelle due ope-re, come il disegno punzonato delle finestre nella base del reliquiario ver-cellese simile a quello della dalmatica di S. Bernardo, i castoni troncoconici delle pietre dure e la volontà di monumentalizzare l’opera ispirandosi alle grandi cattedrali. Le impostazioni, le minuterie e i dettagli indicano sem-plicemente che alcuni elementi stilistici erano comunemente scelti dalle botteghe orafe operanti a cavallo tra XIV e XV secolo, sia fossero esse lom-barde sia sottoposte a tale influenza. La moda del tempo sembra riflettersi in tutta la zona piemontese se si considerano altri esempi come il braccio reliquiario di S. Basilissa della Collegiata di S. Maria della Scala di Chieri, opera di Nicholao de Subrinis del 1388-1389, dove troviamo assonanze con l’arcata goticheggiante che presenta la reliquia del braccio di S. Giuliano e le sferette a grani poste a decorazione delle fasce di Vercelli59.
Di piena produzione locale della seconda metà o ultimo quarto del XIV secolo sono invece il reliquiario architettonico della Beata Vergine e quello zoomorfo delle braccia di S. Giacomo, S. Demetrio e S. Teodoro (Figg. 5-6). I due oggetti non trovano confronto con altre produzioni coeve e sono di difficile lettura poiché formati dall’unione di più parti di reimpiego e da rifacimenti moderni. Nel caso del reliquiario architettonico spicca l’albe-rello di corallo impiegato come sfondo alle spalle dei due angeli. Questo elemento è ricordato nella scritta del codice V, nel Necrologio di Martino de Bulgaro e nell’inventario del 1426, come un suo lascito con piede ar-genteo e pietre pendenti60. L’oggetto è da considerarsi un dono di grande
58 Cfr. nota 50. 59 G. Romano, Nicholao de Subrinis, 1388 o 1389. Braccio reliquiario di santa Basilissa, in Giacomo Jaquerio e il gotico internazionale, Catalogo della mostra, a cura di E. Castelnuovo e G. Romano, Torino 1979, pp. 271-272. 60 Il corallo fu usato tanto in ambito religioso quanto in quello profano come evidenzia Marino, Mecenati e piccole botteghe cit., a p. 109 puntando l’attenzione sul fatto che oggetti di tipologia simile sono i Natternzungenbäum o Languier, come l’esemplare conservato al Museum und Schatzkammer des Deuthschen Ordens di Vienna citato in E. Wetter, Il mondo di Giorgio di Liechtenstein. L’internazionalità come programma, in Il Gotico nelle Alpi cit., pp. 330-331. Si vedano inoltre: C. Arnaldi di Balme e S. Castronovo, I coralli
514
Sara Minelli
valore per essenza materica e difficoltà di approvvigionamento e, secondo le prescrizioni dell’arcidiacono, andava esposto sull’altare di S. Eusebio durante le festività maggiori. Ciò dimostra che l’inglobamento del corallo nel reliquiario, è da datare ad un momento successivo al 1426, posto che sia il corallo, sia il reliquiario sono citati nell’Inventarium.
Alcune considerazioni sulla provenienza del corallo potrebbero partire da quella donazione delle spine della corona di Cristo da parte dell’abate di S. Benigno di Capodifaro a Martino nel 134461. La provenienza ligure, è verosimile, a prescindere da una possibile donazione, poiché il corallo era coltivato nei centri costieri compresi tra Chiavari e il promontorio di Portofino sin dal Medioevo. Il vivace mercato di Vercelli, da parte sua, era collegato ai porti liguri e sono note le importazioni di metalli preziosi62. Non si esclude, tuttavia, una provenienza siciliana o francese, passando per il capoluogo ligure, come ipotizzato non solo per gli alberelli di corallo, ma anche per altri oggetti fin dal XIII secolo63.
Coevo al reliquiario della Vergine è quello zoomorfo delle braccia di S. Giacomo, S. Demetrio e S. Teodoro composto da vari elementi tra cui una cassetta con coperchio dove si innestano tre tubi cavi decorati dalla testa e dagli artigli di un animale fantastico, elementi forse di reimpiego64. Ad ognuno dei tre tubi del reliquiario sono tuttavia fissati tre angeli che se-gnalano l’opera di una stessa bottega, nella fase originaria o in un restauro successivo, per questo reliquiario e per quello della Beata Vergine.
All’interno della cassetta alla base del reliquiario sono contenute le reli-quie dei SS. Innocenti, per i quali il codice LIII della Biblioteca Capitolare, datato al 1372, ricorda la commemorazione presso l’altare di S. Teonesto che conservava i resti di tre corpi65. Durante le processioni delle domeniche
nelle collezioni sabaude: una ricognizione delle fonti inventariali e delle raccolte museali piemontesi, in Rosso corallo. Arti preziose della Sicilia barocca, Milano 2008, pp. 35-53, in particolare la citazione del reliquiario della Beata Vergine, di S. Caterina e di S. Barnaba a p. 39; L. Hansmann e L. Kriss-Rettenbeck, Amulett Magie Talisman. Das Standardwerk mit fast 1000 Abbildungen, Amburgo 1999, pp. 34-35.61 Ferraris, Le chiese “stazionali” cit., p. 222, nota 338.62 Del Bo, Mercanti e artigiani cit., pp. 527-528. 63 Arnaldi di Balme e Castronovo, I coralli nelle collezioni sabaude cit., pp. 39-40. 64 Sulla diffusione delle rappresentazioni animali composite a partire dal XIII secolo si veda J. Baltrušaitis, Il Medioevo fantastico. Antichità ed esotismi nell’arte gotica, Milano 1993. 65 Ferraris, Le chiese “stazionali” cit., p. 215, nota 322.
515
Chiesa e bottega
di Avvento, Settuagesima, Sessagesima, Quinquagesima e di Quaresima che si svolgevano nella Cattedrale di S. Eusebio, era prevista anche l’anti-fona Innocentes pro Christo, al cospetto dei sacri resti66. Oltre ai tre corpi conservati nell’altare, in Cattedrale si conservavano forse altre reliquie, un capo ed alcune ossa, da attribuire ai SS. Innocenti, ritrovate nella cappella di S. Maria e S. Onorato nel 157767. L’attribuzione di questi resti è dub-bia, ma si segnala inoltre che il canonico Marco Aurelio Cusano, nel suo elenco di reliquie seicentesco segnala i tre corpi, un capo, un femore, un omero, una parte di carne, una tibia, una reliquia del sepolcro et alia plu-res reliquia68. Si evince quindi che la presenza di parte delle reliquie degli Innocenti presso l’altare di S. Teonesto, non implichi l’assenza delle stesse anche all’interno del reliquiario delle braccia di S. Giacomo, S. Demetrio e S. Teodoro, che forse corredava l’altare dove si conservavano i tre corpi durante le celebrazioni a loro dedicate.
Dalle opere presentate si evince che a Vercelli, tra Trecento e Quattro-cento, erano presenti orafi capaci di produrre oggetti di buon livello artistico ed aggiornati a quanto era prodotto fuori dalla città, in linea con quanto accadeva in altre realtà italiane all’incirca nello stesso periodo. La situa-zione vercellese, seppur depauperata dalle molte oreficerie andate perse, mostra infatti i segni di quello che è stato definito «un vero e proprio boom» nelle richieste legate all’ammodernamento strutturale e pittorico degli edi-fici religiosi del Trecento che si estese anche a tutto il corollario delle arti minori69. La tendenza si manifesta in un momento preciso della storia delle reliquie cristiane, cioè quando la devozione popolare spinge verso il revival del culto dei santi, intervenendo direttamente in qualità di committente. Questo a Vercelli è ben visibile da una parte nel momento in cui la Catte-drale annovera tra i suoi strumenti liturgici i reliquiari parlanti, dall’altra
66 Per l’edizione critica del codice LIII si rimanda a G. Brusa, Usus psallendi ecclesiae vercellensis (Vercelli, Biblioteca Capitolare, cod. LIII), Roma 2009, in particolare pp. 31-32. 67 Ferraris, Le chiese “stazionali” cit., p. 218, nota 328, segnala la notizia in AAVc, Visite Pastorali, Giovanni Stefano Ferrero, f. 14r, 6 dicembre 1599. 68 M. A. Cusano, Discorsi Historiali concernenti la vita, et attioni de’ Vescovi di Vercelli, Vercelli 1676, p. 348. 69 Cit. R. A. Goldthwaite, Ricchezza e domanda del mercato dell’arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e le origini del consumismo, Abbiategrasso 1995, p. 87.
516
Sara Minelli
nell’unione di un gran numero di reliquie di santi primari all’interno di uno stesso oggetto. Parallelamente, dal punto di vista materico, le aperture delle maestranze locali, dalle scelte che oggi possono sembrare curiose, testimo-niano la versatilità che contraddistinse gli artigiani vercellesi, nonché la committenza ecclesiastica.
518
Sara Minelli
Figura 2 - Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, Reliquiario a braccio di S. Giacomo minore
519
Chiesa e bottega
Figura 3 - Cattedrale di S. Eusebio di Vercelli, Reliquiario a busto di S. Pantaleone
520
Sara Minelli
Figura 4 - Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, Reliquiario a braccio di S. Giuliano
521
Chiesa e bottega
Figura 5 - Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, Reliquiario architettonico della Beata Vergine di S. Caterina e di S. Barnaba
522
Sara Minelli
Figura 6 - Museo del Tesoro del Duomo di Vercelli, Reliquiario zoomorfo delle braccia di S. Giacomo, S. Demetrio e S. Teodoro