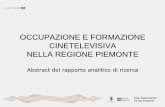Vercelli, Museo Leone. Buccheri a cilindretto orvietani, in Quaderni della Soprintendenza...
-
Upload
beniculturali -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Vercelli, Museo Leone. Buccheri a cilindretto orvietani, in Quaderni della Soprintendenza...
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Direzione e Redazione
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità EgiziePiazza S. Giovanni 2 - 10122 TorinoTel. 011-195244Fax 011-5213145E-mail [email protected]
Direttore della Collana
Egle Micheletto - Soprintendente per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Comitato Scientifico
Marica Venturino Gambari Giuseppina Spagnolo GarzoliSofia UggéMatilde Borla
Coordinamento
Marica Venturino Gambari
Comitato di Redazione
Paola AurinoValentina FaudinoAmanda Zanone
Segreteria di Redazione
Maurizia Lucchino
Editing ed elaborazione immagini
Susanna Salines
Progetto grafico e impaginazione
LineLab.edizioni - Alessandria
Stampa
Filograf Litografia - Forlì
La redazione di questo volume è stata curata da Paola Aurino, Valentina Faudino e Amanda Zanone con la collaborazione di Maurizia Lucchino
Quando non diversamente indicato, i disegni dei reperti sono in scala 1:3 (ceramica, vetri), in scala 1:2 (industria litica levigata, metalli), in scala 1:1 (industria litica scheggiata)
Il volume è stato pubblicato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e con la collaborazione degli Amici del Museo di Antichità di Torino
È possibile consultare gli articoli pubblicati in questo volume nel sito istituzionale della Soprintendenza:http://archeo.piemonte.beniculturali.it
© 2014 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del TurismoDirezione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del PiemonteSoprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Piazza S. Giovanni 2 - 10122 Torino
ISSN 0394-0160
Contributi
11. Analisi archeopalinologiche nel sito romano di PollentiaRosanna Caramiello - Valeria Fossa - Daniele Arobba
19. Un insediamento rustico di età romana a San Giorgio CanaveseStefania Ratto - Alessandro Crivello
27. L’indagine archeologica di piazza della Repubblica 14 a Torino. Un nuovo insediamento suburbano di età romanaStefania Ratto - Francesca Bosman
35. Q. Glitius Atilius Agricola: l’iscrizione greca da Augusta TaurinorumEnrica Culasso Gastaldi
43. Sui “rilievi di Avigliana” al Museo di Antichità di TorinoAnna Maria Riccomini
51. Antica diocesi di Vercelli. Nuovi frammenti scultorei ed epigrafici altomedievali da Villamiroglio e SanthiàAlberto Crosetto
61. Indagini di archeologia dell’architettura. La Rocca di Vogogna (VB) Michela Babbini
81. Archeologia rupestre nelle Alpi Cozie: sondaggi geoarcheologici a Roccho Vélho (Pramollo, Torino). Nuovi approfondimenti analitici Anna Gattiglia - Piergiorgio Rossetti - Maurizio Rossi - Gloria Vaggelli
Notiziario
Provincia di Alessandria
93. Acqui Terme, piazza Maggiorino Ferraris. Quartiere abitativo di età romana e fasi di abbandonoMarica Venturino Gambari - Alberto Crosetto - Emilio Riccino
96. Acqui Terme, via Biorci. Fasi romane e medievali e resti della cinta murariaMarica Venturino Gambari - Alberto Crosetto - Mario Cavaletto - Margherita Roncaglio
99. Acqui Terme, via Monteverde. Rinvenimenti di età romana e tardomedievale con sovrapposizioni moderneMarica Venturino Gambari - Alberto Crosetto - Roberto Codovilla - Silvia Gatti
102. Acqui Terme, via Nizza angolo via V. Scati. Limite urbano settentrionale di Aquae StatiellaeMarica Venturino Gambari - Alessandro Quercia - Valentina Barberis
104. Acqui Terme, via Scatilazzi. Teatro romano e fasi di frequentazione medievaleMarica Venturino Gambari - Alberto Crosetto - Emilio Riccino - Fulvia Sciamanna - Piera Terenzi
108. Alessandria, piazza della Libertà 28. Complesso medievale del Broletto e di Palatium VetusMarica Venturino Gambari - Alberto Crosetto - Margherita Roncaglio
110. Pontecurone, località Cascina Torre. Tracce di frequentazione dalla preistoria al Medioevo Marica Venturino Gambari - Margherita Roncaglio - Melania Cazzulo - Francesco Scarrone
115. Strevi, località Cascina Braida. Insediamento rurale di età romanaMarica Venturino Gambari - Alessandro Quercia - Laura Maffeis - Melania Semeraro
Sommario
120. Tortona. Brocca fittile della seconda età del Ferro e corredi funerari di epoca longobardaMarica Venturino Gambari - Alberto Crosetto - Giuseppe Elegir
124. Tortona. Palazzo Guidobono. Mostra “Marziano e Innocenzo. Tortona paleocristiana tra storia e tradizione”Alberto Crosetto
125. Tortona, corso Repubblica. Necropoli di età romanaMarica Venturino Gambari - Alberto Crosetto - Valentina Barberis - Alessandro Quercia
Provincia di Asti
129. Asti. Giornata di studi “Al tempo dei Longobardi in Piemonte. Nuove scoperte archeologiche”Alberto Crosetto
130. Buttigliera d’ Asti. Ascia in pietra levigataPaola Aurino
131. Valfenera, rio Riccarello. Gruzzolo monetale di età romana Alberto Crosetto
Provincia di Biella
134. Biella. Palazzo Gromo Losa. Intervento archeologico nel giardino orientale Antonella Gabutti - Francesca Garanzini
137. Bioglio, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Pettinengo. Alta Valsessera e valle Dolca. Frequentazione preistorica di alta quota: risultati della campagna di ricognizioneFrancesco Rubat Borel - Gabriele Luigi Francesco Berruti - Davide Berté - Sara Daffara - Luca Scoz
142. Sordevolo, strada Prera-Monti. Indagini sulla struttura della mulattieraFrancesco Rubat Borel - Antonella Gabutti
Provincia di Cuneo
144. Borgo San Dalmazzo. Chiesa di S. AnnaSofia Uggé
146. Castelletto Stura, località Revellino. Luogo di culto di età romana presso risorgiva naturaleValentina Barberis - Luisa Ferrero
147. Cherasco, frazione Roreto. Rinvenimento di fornace postmedievaleFrancesca Restano - Deborah Rocchietti
150. Cuneo. Ex chiesa di S. Francesco. Apparato didattico lungo il percorso archeologicoSofia Uggé
150. Cuneo, località Cascina Bombonina e strada Bombonina. Necropoli di età romana e insediamento di età romana e tardoanticaValentina Barberis
154. Dogliani. Asce in pietra verde levigataLuisa Ferrero - Stefania Padovan
156. Montanera. Necropoli di età romanaValentina Barberis
158. Nucetto, Bagnasco, Priola, Garessio, Ormea. Alta val Tanaro. Indagini preliminari paesaggistico-archeologichePaolo Demeglio
160. Roccaforte Mondovì, località Rastello. Indagine ricognitiva sulla villa di SubtenianumCecilia Galleano
163. Villanova Mondovì. Ex parrocchiale di S. Caterina. Indagini archeologicheSofia Uggé - Paola Comba
Provincia di Novara
166. Castelletto Ticino, località Cicognola, S.S. 33 del Sempione. Contesto tardiglaciale di spondaFrancesco Rubat Borel - Lanfredo Castelletti - Sila Motella De Carlo - Paolo Lampugnani - Nicoletta Martinelli - Olivia Pignatelli - Cristiano Nericcio - Elisa Martinelli
Provincia di Torino
168 Almese, località Grange di Milanere. Villa romana. Restauri, completamento del percorso di visita e restituzione dell’ edificioFederico Barello - Filippo Masino
171. Chieri, via Vittorio Emanuele II - piazza S. Domenico. Controllo archeologico per il teleriscaldamentoGabriella Pantò
171. Chieri, vicolo della Madonnetta. Indagini di archeologia urbanaGabriella Pantò - Marco Subbrizio
176. Favria. Cappella della Madonna della Neve. Assistenza archeologica ai lavori di ripavimentazioneFrancesca Garanzini
177. Grugliasco. Cappella di S. Vito. Indagini archeologicheLuisella Pejrani Baricco - Paolo Demeglio
179. Moncalieri, frazione Testona, strada S. Michele. Parco di Villa Lancia. Resti dell’abitato altomedievale e medievaleGabriella Pantò
181. Torino. Palazzo Chiablese. Testimonianze archeologiche sulle trasformazioni in età modernaLuisella Pejrani Baricco - Frida Occelli - Marco Subbrizio
183. Torino. Vaso carenato dell’età del RameFilippo Maria Gambari - Luisa Ferrero - Paola Aurino
185. Torino, via Garibaldi 13. Chiesa dei SS. Simone e GiudaLuisella Pejrani Baricco - Stefania Ratto - Francesca Bosman
188. Usseglio, località I Seti. Pugnale dell’età del BronzoFrancesco Rubat Borel
191. Valperga, strada Borelli. Tombe di età romanaStefania Ratto
Provincia del Verbano Cusio Ossola
198. Cannobio. Palazzo della Ragione o Parasio. Indagine archeologica nella manica di collegamento con il campanile di S. VittoreFrancesca Garanzini
202. Gravellona Toce. Chiesa parrocchiale di S. Pietro. Indagine archeologicaFrancesca Garanzini
Provincia di Vercelli
204. Borgosesia, Monte Fenera. Grotta della Ciota Ciara. Nuovi dati sull’occupazione musterianaJulie Arnaud - Marta Arzarello - Gabriele Luigi Francesco Berruti - Giulia Berruto - Davide Berté - Claudio Berto - Fabio Buccheri - Anna Iliana Casini - Sara Daffara - Elisa Luzi - Juan Manuel Lopez Garcia - Carlo Peretto
207. Buronzo. Ritrovamenti dal territorio Elisa Panero - Francesca D’Andrea
209. Lenta. Necropoli romana Elisa Panero
213. Vercelli. Museo Leone. Buccheri a cilindretto orvietaniAndrea Martelli
217. Vercelli, corso Libertà. Palazzo Centoris. Ulteriori dati sulle fasi tardoantiche e altomedievaliElisa Panero - Fabio Pistan
221. Vercelli, via Giovenone 4-6. Casa Centoris. Nuovi dati sulle fasi insediative tardoantiche e altomedievaliElisa Panero
Notiziario del Museo di Antichità di Torino
227. Allestimento del Tesoro di MarengoGabriella Pantò
228. “Museo in passerella”: il nuovo spazio per esposizioni temporaneeGabriella Pantò
228. Il Museo di Antichità e i Social Network: #noicisiamoFederica Pepi
230. Il Museo di Antichità per gli abbonatiDaniela Speranza
231. Notti al Museo: aperture serali straordinarie nell’anno 2013Gian Battista Garbarino
232. Signori e signore, benvenuti! “Museum $eatre” al Museo di Antichità di TorinoPatrizia Petitti
234. Medagliere. Acquisto coattivo di uno statere della zecca di CrotoneFederico Barello
235. Medagliere. Monetazione preromana dell’Italia settentrionale: primi risultati di analisi per diffrazione neutronicaFederico Barello - Jacopo Corsi - Alessandro Lo Giudice - Alessandro Re
Notiziario del Museo Antichità Egizie
241. Progetto di studio e analisi per l’individuazione della provenienza del lapislazzuli dell’antico Egitto attraverso tecniche analitiche non invasive: notizia preliminare Matilde Borla
244. Reperti in osso e avorio di epoca romana, bizantina e araba conservati nei depositi del Museo Antichità Egizie di Torino Marcella Trapani - Cristina Ghiringhello
247. Segnalazioni bibliogra!che di archeologia piemontese (2012-2013)
Paola Aurino, Valentina Barberis, Federico Barello, Alberto Crosetto, Luisa Ferrero, Francesca Garanzini, Filippo Masino, Elisa Panero, Gabriella Pantò, Luisella Pejrani Baricco, Alessandro Quercia, Stefania Ratto, Francesca Restano, Deborah Rocchietti, Francesco Rubat Borel, Sofia Uggé, Marica Venturino Gambari Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte
e del Museo Antichità Egizie
Filippo Maria Gambari Soprintendente per i Beni Archeologici della Lombardia
Elisa Martinelli Università degli Studi dell’Insubria - Como
Julie Arnaud, Marta Arzarello, Claudio Berto, Fabio Buccheri, Anna Iliana Casini, Sara Daffara, Juan Manuel Lopez Garcia, Elisa Luzi, Carlo Peretto Dipartimento di Studi Umanistici - Laboratorio TekneHub -
Università degli Studi di Ferrara
Francesca D’Andrea Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - Università
degli Studi di Milano
Andrea Martelli Dipartimento di Scienze dell’Antichità - Sapienza Università
di Roma
Davide Berté Dipartimento di Scienze della Terra - Sapienza Università di Roma
Paolo Demeglio Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici
e del Paesaggio - Politecnico di Torino
Gabriele Luigi Francesco Berruti Department of Geology - Universidade de Tras-os-Montes
e Alto Douro & Instituto Politecnico de Tomar
Lanfredo Castelletti, Sila Motella De Carlo Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como
Luca Scoz Muse - Museo delle Scienze - Trento
Giulia Berruto Associazione Culturale 3P (Progetto Preistoria Piemonte) -
San Mauro Torinese
Cristiano Nericcio Gruppo Storico Archeologico Castellettese - Castelletto Sopra Ticino
Emilio Riccino, Fulvia Sciamanna, Piera Terenzi Arkaia s.r.l. - Genova
Mario Cavaletto, Roberto Codovilla Co.r.a. soc. cooperativa - Torino
Laura Maffeis, Melania Semeraro Cristellotti & Maffeis s.n.c. - Costigliole Saluzzo
Nicoletta Martinelli, Olivia Pignatelli Dendrodata s.a.s. - Verona
Giuseppe Elegir Docilia s.n.c. - Savona
Francesca Bosman GEA S.A.R.T. s.a.s. - Torino
Melania Cazzulo, Silvia Gatti, Margherita Roncaglio, Francesco Scarrone Lo Studio s.r.l. - Alessandria
Paolo Lampugnani Pandora Archeologia s.r.l. - Veruno
Marco Subbrizio Studio Marco Subbrizio - Torino
Frida Occelli Studium s.n.c. - Torino
Paola Comba, Antonella Gabutti, Cecilia Galleano, Stefania Padovan, Fabio Pistan Collaboratori della Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Piemonte e del Museo Antichità Egizie
Schede di:
NOTIZIARIO 213
Vale comunque la pena di sottolineare che il pic-colo sondaggio di Lenta permette di definire ulte-riormente l’organizzazione del territorio in questa porzione di Vercellese, connotata da una serie di piccoli nuclei insediativi disposti probabilmente ‘a pettine’ lungo l’arteria principale, un percorso che da Vercellae si dipartiva verso nord in direzione dei valichi alpini a ovest del fiume Sesia (almeno fino a
Gattinara, ma più probabilmente fino a Serravalle Sesia, dove i rinvenimenti, fra cui quello, recentis-simo, di un frammento di statuetta femminile mar-morea panneggiata, confermano la presenza di un popolamento sparso in età romana), creando un pendant con il percorso orientale in territorio no-varese e un’alternativa terrestre alla via d’acqua rap-presentata dal fiume stesso.
A C. 2002. Gattinara, via P. Micca 36. Nucleo di tom-be a incinerazione di età romana, in Quaderni della Soprinten-denza archeologica del Piemonte, 19, pp. 179-181.
A C. 2007. Nuovi dati sul popolamento di età romana nel Vercellese, in Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Ci-salpina: II secolo a.C. - I secolo d.C. Atti delle giornate di studio, Torino 4-6 maggio 2006, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Bor-go S. Lorenzo, pp. 327-329.
A C. - R M. 2007. Greggio, località Cascina Nuo-va. Insediamento rustico e necropoli di età romana, in Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 22, pp. 282-285.
B T L. 2000. Alle origini di Biella. La ne-cropoli romana, Torino.
Paesaggi fluviali della Sesia in stampa. Paesaggi fluviali della Sesia. Storia, archeologia e valorizzazione. Atti del convegno, Vercelli 12 aprile 2014.
P E. in stampa. Il territorio di Vercellae in età romana, in Paesaggi fluviali della Sesia. Storia, archeologia e valorizzazio-ne. Atti del convegno, Vercelli 12 aprile 2014.
S M.T. 1988. Lenta. Area limitrofa alla Pieve di S. Stefano. Insediamento tardo-antico, in Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte, 7, pp. 107-108.
Area limitrofa alla pieve di S. Stefano 1981-1991. Archivio del-la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, sezione territorio, Lenta (VC), fald. 20\III, fasc. 2, Area limitrofa alla pieve di S. Stefano.
Pieve di S. Stefano 1981-1990. Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, sezione territorio, Lenta (VC), fald. 20\I, fasc. 1, Pieve di S. Stefano.
Bibliogra�a
Fonti storiche e archivistiche
Vercelli. Museo Leone Buccheri a cilindretto orvietani
Andrea Martelli
Nelle collezioni del Museo Camillo Leone di Ver-celli sono conservati due calici in bucchero che, pur essendo in parte editi, risultano ancora poco noti e necessitano di un inquadramento più speci-fico (Museo Leone 2008, p. 22, fig. 32; M 2009, p. 114, fig. 44d). I due esemplari non presen-tano alcun dato di provenienza, ma le loro carat-teristiche decorative, con fregi realizzati a cilin-dretto, permettono di attribuirli con certezza alla produzione orvietana. Come è noto questa produ-zione, analizzata all’inizio degli anni Settanta da G. Camporeale (C 1972), caratterizza il periodo compreso fra la fine del VII secolo e gli anni centrali del VI secolo a.C. e conta un cospicuo numero di esemplari, distribuiti in diverse famiglie morfologiche.
I due calici furono acquistati da Camillo Leone sul mercato antiquario per la propria eclettica collezio-ne (Museo Leone 2008), unitamente ad altri prodotti etruschi, fra cui alcuni buccheri (M 2009, pp. 114-115).
Sono note le vicende che portarono fra gli anni Set-tanta e Ottanta del diciannovesimo secolo allo scavo delle necropoli suburbane di Orvieto: Crocefisso del Tufo e Cannicella. In mancanza di una legislazione del neonato Stato italiano in difesa del proprio pa-trimonio culturale e nonostante l’opera meritoria di personaggi di primo piano come Gian Francesco Ga-murrini, Adolfo Cozza ed Eugenio Faina, che a vario titolo si impegnarono, e con notevoli successi, nella salvaguardia delle testimonianze archeologiche orvie-tane, non fu possibile la conservazione in loco di gran parte dei materiali rinvenuti in quelle convulse fasi di scavo (Storia di Orvieto 2003, pp. 30-33). Soprattutto i reperti venuti in luce nelle fortunate indagini con-dotte da Riccardo Mancini entrarono ben presto a far parte del vasto mercato antiquario di quegli anni. Non sorprende dunque che attualmente la maggior parte dei buccheri a cilindretto sia conservata in collezioni, italiane o estere, in cui al massimo si ha memoria del-la provenienza da Orvieto, mentre solo in pochi casi conosciamo il contesto originario. Tale situazione si è
214 NOTIZIARIO
in parte modificata solo negli anni Novanta del secolo scorso con la pubblicazione delle indagini sistemati-che nella necropoli della Cannicella e in particolare del corredo della t. 4 che conservava vari buccheri a cilindretto (P et al. 1993, figg. 105-109).
I due calici del Museo Leone sono pertinenti a fregi già distinti e si aggiungono dunque agli altri esemplari già inseriti nel catalogo di Camporeale; la loro analisi comunque ci consentirà di aggiornare il numero degli esemplari noti e di proporre alcune ri-flessioni su questa produzione.
Il primo calice (inv. n. 555; h. 14,5 cm; d. orlo 15 cm; d. piede 9,7 cm; integro; bucchero nero) presenta un alto labbro svasato che si innesta su una breve vasca con carena a spigolo decorata da punte di diamante, piede a tromba di media altezza con anello plastico alla sommità del fusto e ampia base di appoggio con margine inciso da una solcatura orizzontale. Il labbro è decorato a metà altezza con un fregio realizzato a cilindretto (fig. 119). L’esemplare rientra nella varietà 1 del tipo 7a della rassegna tipologica del bucchero di area orvietana di P. Tamburini, caratterizzata da un solo anello sul fusto del piede a tromba (T 2004, p. 206, forma XV, tav. 9). Il calice deriva dal tipo Rasmussen 2e, attestato nell’Etruria meridionale (R- 1979, p. 99, tav. 28), e trova confronto anche in area chiusina con il tipo 140.A.70 (M 2009, p. 117). Il motivo a cilindretto appartiene invece al fre-gio III della classificazione di Camporeale ed è com-posto da una teoria di animali gradienti verso sinistra
(C 1972, pp. 26-28). Ai quattro kantharoi censiti da Camporeale, di cui tre provenienti da Or-vieto e uno in particolare dal corredo della t. 2 della Cannicella conservato nel Museo Archeologico Na-zionale di Firenze, si è aggiunto successivamente un quinto kantharos frammentario conservato nel Royal Ontario Museum di Toronto e anch’esso con prove-nienza orvietana (H 1985, p. 103, C78). Più re-centemente dagli scavi tedeschi della necropoli della Cannicella è stato edito un calice con lo stesso motivo, rinvenuto nel ricco corredo della t. 4 (P et al. 1993, p. 79, figg. 105.1, 106.2, 107, 109). Quest’ultimo esemplare presenta le stesse caratteristiche morfolo-giche del calice di Vercelli, con il labbro piuttosto svi-luppato in altezza, il piede con un solo anello plastico e l’ampia base con solcatura orizzontale. La vicinanza dei due esemplari, certamente usciti da un medesimo atelier ceramico, permette di datare il calice di Ver-celli, contestualmente al corredo della tomba 4 della Cannicella, alla prima metà del VI secolo, probabil-mente nell’ambito del secondo quarto.
Il fregio presenta le consuete caratteristiche dei motivi a cilindretto orvietani, già distinte da Cam-poreale: il rilievo basso e piatto con un contorno netto delle figure, l’orientamento univoco degli animali della teoria e la limitazione del fregio tra-mite una cornice puntinata. In questo caso il fregio prevede una teoria di animali reali e fantastici volti verso sinistra; a partire da destra compare un grifo con becco adunco, ala falcata sul dorso e alta coda
Fig. 119. Vercelli. Museo Leone. Calice in bucchero (inv. n. 555) (dis. e foto A. Martelli).
NOTIZIARIO 215
ricurva in avanti, un cavallo, un quadrupede seduto sulle zampe posteriori con muso sottile e alta coda curvata a S, identificabile, come è già stato osservato (P et al. 1993, p. 79, nota 257), con un cane piuttosto che con un felino, uno stambecco e un cer-vo, entrambi pascenti con la testa abbassata.
Il secondo calice (inv. n. 554; h. 15,2 cm; d. orlo 13,5 cm; d. piede 10,2; integro, con rare incrostazioni e scheggiature superficiali; bucchero nero) presenta un labbro svasato, non molto sviluppato in altezza, vasca poco profonda con carena a spigolo, decorata da tratti obliqui, e alto piede a tromba, caratterizza-to all’attacco e poco sopra la metà del fusto da due anelli plastici che delimitano una breve porzione del fusto a profilo convesso. La base del piede è decorata sul margine da una solcatura orizzontale. Il labbro e la parte inferiore del piede sono ornati da due di-stinti motivi a cilindretto; in alto vi è un fregio con figure maschili e figure femminili alternate, mentre sul piede un fregio con motivo a treccia (fig. 120).
Le caratteristiche morfologiche dell’esemplare permettono di ricondurlo alla varietà 2 del tipo 7a di Tamburini (T 2004, p. 206, forma XV, tav. 9), caratterizzata da due collarini sul fusto del pie-de, e genericamente riferibile al tipo Rasmussen 2c, attestato nell’Etruria meridionale dalla seconda metà del VII secolo a.C. (R 1979, pp. 97-98, n. 135, tav. 27).
Il motivo sul labbro è invece identificabile con il fregio XXVI di Camporeale (C 1972,
pp. 81-82), già attribuito da F. Scalia a produzio-ne chiusina (S 1968, p. 387, motivo XXXIX, fig. 9e), ma di cui è ormai accertata la pertinenza orvietana. Il motivo sul piede presenta invece una treccia a duplice banda con un puntino al centro di ogni occhiello e negli spazi lasciati vuoti dalle vo-lute, delimitata sul lato superiore e inferiore da una cornice a trattini verticali e da una solcatura. Si trat-ta del fregio XXIX della serie orvietana, di cui era-no noti fino a ora cinque esemplari (C 1972, pp. 86-88): un’olletta biansata del tipo Tambu-rini 1(a)1 (T 2004, p. 196, forma VIII, tav. 5 B), un kantharos tipo 3c (T 2004, p. 200, forma XI, tav. 6), due calici, di cui uno solo identi-ficabile in tipologia con il calice 7(a)2 (T 2004, p. 206, forma XV, tav. 9) e infine una kylix tipo 1(a)2 (T 2004, p. 202, forma XII, tav. 7 A).
Il fregio XXVI era attestato invece su sette calici; questi, se escludiamo quello un tempo conservato all’Antikensammlung di Monaco, andato perduto in seguito agli eventi bellici, e gli esemplari di Heidel-berg e Braunschweig, di cui si conservano solo fram-menti di labbro, possono essere distinti in due tipi. Il primo, riconducibile al già citato calice 7a(1) di Tam-burini, è quello che fa capo all’esemplare della colle-zione Alla Querce di Firenze (C 1970, pp. 44 e sgg., n. 18, fig. 7, tav. IX b; 1972, p. 81, n. 1, tav. XXVI); quest’ultimo credo che per le strettissime somiglianze possa essere identificato con l’esemplare edito da Montelius e non rintracciato da Camporeale
Fig. 120. Vercelli. Museo Leone. Calice in bucchero (inv. n. 554) (dis. e foto A. Martelli).
216 NOTIZIARIO
(M 1895-1910, c. 1018, tav. 243.2; C- 1972, p. 81, n. 2). Alla stessa morfologia appar-tiene anche l’esemplare del Museo di Cracovia (C- 1972, p. 81, n. 6).
Un secondo tipo con vasca più ampia e piede ca-ratterizzato da due collarini, corrispondente al tipo 7a(2) (T 2004, p. 206, forma XV, tav. 9), è quello rappresentato dal calice del National Museum of Natural History di Washington (C 1972, p. 81, n. 7, tav. XXVII); quest’ultimo trova ora una replica puntuale con il nostro calice di Vercelli.
La ricerca che sto conducendo sulle produzioni a cilindretto dell’Etruria interna mi consente di inte-grare questo quadro, aggiungendo nuovi esemplari di calice tipo 7a(2), che impiegano contemporanea-mente i motivi XXVI e XXIX della serie orvietana.
Un calice con caratteristiche del tutto analoghe è conservato presso l’American Academy di Roma (fig. 121) e si trova attualmente in avanzata fase di pubblicazione insieme al resto dell’ampia collezione archeologica (inv. n. 00280; h. 15,2 cm; d. orlo 13,5 cm); vi è poi un altro esemplare (fig. 122), circolante sul mercato antiquario (Pandolfini 2011, n. 345), che condivide con gli altri le caratteristiche decorative, ma si distingue per il piede più basso e schiacciato, forse frutto di un restauro moderno.
Dunque complessivamente il fregio orvietano XXVI è ora attestato su dieci esemplari, i sette iden-tificati da Camporeale e i tre nuovi esemplari che si sono potuti aggiungere, mentre il fregio XXIX della
stessa serie è ora noto su otto esemplari. L’uso con-giunto di questi due motivi e lo studio delle forme su cui sono impressi ci consente di assegnarli entrambi alla prima metà del VI secolo a.C., probabilmente agli inizi del secondo quarto.
Per ultimo si deve considerare con maggiore atten-zione il motivo figurativo del cilindretto XXVI. Esso consta di una serie di figure rappresentate di profilo incedenti verso sinistra, alternativamente maschi-li e femminili. La donna porta la mano destra sulla spalla dell’uomo che precede, mentre porge quella sinistra all’uomo che segue, creando in questo modo una sequenza continua. Sia la tematica che riman-da al tema del choros, sia la rappresentazione delle figure trovano stretti confronti con l’ambiente dei cilindretti chiusini (M 2013), come del resto aveva già notato F. Scalia. Basti ad esempio confron-tare le figure femminili con il motivo Scalia XXX (S 1968, p. 382). Certamente non può essere messa in dubbio l’origine orvietana di questi esem-plari, vista anche la contemporanea attestazione del motivo XXIX di Orvieto, e tuttavia le somiglianze con i motivi chiusini appaiono così marcate nel trat-tamento delle figure da far sospettare una influenza di questo centro, se non addirittura una provenienza chiusina dell’artigiano che realizzò questa matrice.
Per l’autorizzazione allo studio e alla pubblicazione dei materiali ringrazio il Direttore del Museo Leone di Vercelli dott. L. Brusotto; sono grato al Soprintendente
Fig. 121. American Academy in Rome. Calice in bucchero (inv. n. 00280)
(foto A. Martelli).
Fig. 122. Calice in bucchero dal mercato antiquario (da Pandol-
fini 2011).
NOTIZIARIO 217
archeologo del Piemonte dott.ssa E. Micheletto e alla dott.ssa E. Panero, funzionario per la provincia di Vercelli, per aver voluto accogliere il contributo in questa sede. Per l’esame del calice conservato presso
l’American Academy di Roma, in fase di pubblicazio-ne da parte di R. De Puma, ringrazio la curatrice della collezione, dott.ssa V. Follo, per la possibilità di esami-nare il vaso e di proporne in questa sede un’immagine.
C G. 1970. La collezione Alla Querce. Materiali ar-cheologici orvietani, Firenze.
C G. 1972. Buccheri a cilindretto di fabbrica orvie-tana, Firenze.
H J.W. 1985. Etruscan and Italic pottery in the Royal On-tario Museum. A catalogue, Toronto.
M A. 2009. Etruschi in Piemonte, Torino (Quaderni della Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo, 3).
M A. 2009. Il bucchero, in Chiusi: lo scavo del Petriolo (1992-2004), a cura di P. Gastaldi, Napoli (Annali. Sezione di archeologia e storia antica. Quaderni, 17), pp. 103-177.
M A. 2013. Buccheri a cilindretto di produzione chiu-sina: repertorio, iconografia, immaginario, Tesi di dottorato, Sapienza - Università di Roma.
M O. 1895-1910. La civilisation primitive en Italie de-puis l’introduction des métaux, Stockholm.
Museo Leone 2008. Guida al Museo Camillo Leone Vercelli, a cura di A.M. Rosso, Vercelli.
Pandolfini 2011. Pandolfini. Casa d’aste. Arte orientale e reperti
archeologici, 21 novembre 2011. Cataloghi, Firenze.P F. et al. 1993. P F. unter Mitarbeit von A S. -
B M. - B G. - D V. - E M. - G K. - K D. - K C. - M M. - R B. - S P. - T A., Orvieto. Tübinger Ausgrabungen in der Can-nicella Nekropole 1984-1990. Vorläufiger Bericht, in Archäolo-gischer Anzeiger, pp. 5-99.
R T.B. 1979. Bucchero pottery from southern Etruria, Cambridge.
S F. 1968. I cilindretti di tipo chiusino con figure umane. Contributo allo studio dei buccheri neri a «cilindretto», in Stu-di etruschi, 36, pp. 357-401.
Storia di Orvieto 2003. Storia di Orvieto. 1. Antichità, a cura di G.M. Della Fina, Ponte San Giovanni.
T P. 2004. Dai primi studi sul bucchero etrusco al rico-noscimento del bucchero di Orvieto: importazioni, produzioni locali, rassegna morfologica, in Appunti sul bucchero. Atti delle giornate di studio, a cura di A. Naso, Firenze (Museo civico Gustavo VI Adolfo, Blera, 3), pp. 179-222.
Bibliogra�a
Vercelli, corso Libertà. Palazzo Centoris Ulteriori dati sulle fasi tardoantiche e altomedievali
Elisa Panero - Fabio Pistan
I recenti scavi condotti tra il 2011 e il 2012 per le opere di risanamento e restauro conservativo di Palazzo Centoris, nell’ambito del recupero com-plessivo promosso dal Comune di Vercelli, hanno consentito alla Soprintendenza per i Beni Archeo-logici del Piemonte di intervenire con una serie di indagini stratigrafiche (eseguite dall’archeologo dott. F. Pistan) sia negli ambienti cantinati sia nei vani del piano terreno dell’edificio. I dati archeolo-gici così ottenuti, affiancati anche a una lettura del-la stratigrafia muraria delle architetture esistenti, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte (arch. E. Frugoni), hanno quindi permesso di ricostruire alcune porzioni di vita di questo settore dell’abitato urbano nel corso dei secoli.
Quasi contemporaneamente (2013) i lavori di ristrutturazione della proprietà corrispondente ai civici 4 e 6 di via Giovenone hanno dato la possi-bilità di acquisire interessanti informazioni sul sito e sull’evoluzione di questo fabbricato denominato Casa Centoris, confinante a nord con la proprietà comunale di Palazzo Centoris, con la quale costi-tuiva probabilmente in origine un unico complesso immobiliare.
Gli interventi nel vano cantinato di Palazzo Cen-toris hanno portato alla luce fondazioni di epoca romana disposte secondo tre allineamenti planime-trici differenti. Senza entrare nel dettaglio (per cui si rimanda a P 2012, pp. 252-254), si può ri-cordare come, nell’area in oggetto, siano emerse una serie di strutture (per le quali si distinguono almeno due macrofasi) in ciottoli legati da malta di scarsa qualità e con pavimentazioni con vespaio in ciottoli, concentrate nel settore nord-ovest del vano di Pa-lazzo Centoris e databili tra la metà del I secolo a.C. e la primissima età imperiale sulla base dei manufat-ti ceramici, a cui succede una marcata sistemazione in senso monumentale (us 3), che costituisce una terza fase di sistemazione dell’area.
Per le fasi di vita tardoantiche e altomedievali an-cora pochi sono i dati a disposizione: alcune infor-mazioni arrivano però dalla vicina Casa Centoris (cfr. infra pp. 221-224). L’intervento in via Giovenone ha infatti permesso il rinvenimento di elementi di inte-resse archeologico (dall’età tardoantica a quella rina-scimentale) in 7 ambienti del fabbricato (vani A-G).
Per quanto riguarda quello che avviene al di sotto di Palazzo Centoris, il solo punto dove si sono trovate tracce pertinenti al periodo tardoantico-altomedievale