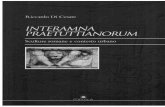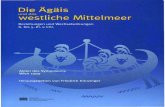Una nuova proposta interpretativa sui resti architettonici di via Orto
I modelli architettonici e le decorazioni graffite del San Gerolamo di Biella: testimonianze di...
Transcript of I modelli architettonici e le decorazioni graffite del San Gerolamo di Biella: testimonianze di...
BOLLETTINO DELLA SOCIETÀPIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA
E BELLE ARTI
NUOVA SERIE - LVII - LVIII2006 - 2007
BO
LLETTINO
DELLA
SOC
IETÀ PIEM
ON
TESED
IAR
CH
EOLO
GIA
EB
ELLEA
RTIN
UO
VASER
IE- LV
II - LVIII - 2006 - 2007
cop SPABA 09_2.qxd 12/05/2009 09:48 Pagina 1
BOLLETTINO
DELLA SOCIETÀ PIEMONTESEDI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI
NUOVA SERIE - LVII - LVIII2006 - 2007
MARCO AIMONE
I MODELLI ARCHITETTONICI E LE DECORAZIONI GRAFFITE
DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA:
TESTIMONIANZE DI RINASCIMENTO LOMBARDOIN PIEMONTE*
Sullo schienale di uno stallo del coro della chiesa di San Gerolamo, sorta nel secondo decennio del Cinquecento sulla collina che sovrasta il torrente Cervo, poco ad oriente di Biella, il pittore Defendente Ferrari ha rappresentato, in un serena atmosfera agreste, una veduta della chiesa stessa come si presentava verso il 1523, pochi anni dopo la fine dei lavori di costruzione1: la facciata dell’edificio appare ornata da un’elegante decorazione a racemi e volute vegetali su fondo chiaro, che ricoprono con armonioso disegno le superfici (fig. 1). Recentemente, un accurato restauro ha riportato alla luce parti consistenti di quelle decorazioni che Defendente Ferrari aveva potuto vedere intatte, poco dopo la loro realizzazione, e che erano scomparse da più di due secoli sotto uno strato di intonaco2. Nonostante le condizioni frammentarie, le parti superstiti permettono una precisa ricomposizione dell’aspetto originario dell’edificio; tale acquisizione risulta di notevole interesse per le vicende artistiche del complesso ed offre l’occasione di approfondire le ricerche su aspetti finora trascurati di questo importante monumento cinquecentesco, in particolare i modelli architettonici che hanno ispirato il progetto della chiesa. Edificato tra il 1512 e il 1517 per i padri dell’Ordine Gerolamino, il convento di San Gerolamo rappresenta, insieme alla chiesa lateranense di San Sebastiano nel centro di Biella,
* Mi è gradito qui ringraziare per l’aiuto, i consigli e l’incoraggiamento il dott. Lodovico Sella, presidente della Fondazione Sella; la prof. Claudia Bonardi della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino; la dott. Maria Teresa Baietto, appassionata studiosa delle vicende storiche e giuridiche del San Gerolamo.
1 Per le vicende storiche del monastero di San Gerolamo, cfr. MULLATERA, 1902, pp. 136-137 e 170; TORRIONE, 1950; BAIETTO, 1981; Biella tra polemica e storia, 1986; LEBOLE, 2004, pp. 391-518. Per gli aspetti architettonici ed artistici del complesso, cfr. ROCCAVILLA, 1905, pp. 33-39; ROCCAVILLA, 1924, anno IV, n. 9, pp. 7-10, e n. 10, pp. 6-11; ASTRUA, ROMANO, 1979, pp. 101-102; SCIOLLA, 1980, pp. 118-148; NATALE, 2003, pp. 25-30. Sul coro ligneo di San Gerolamo, cfr. da ultimi MANCHINU, 1998, pp. 37-42; LEBOLE, 2004, pp. 497-505, specialmente pp. 504-505 per lo stallo in cui è raffigurata la facciata di San Gerolamo.
2 Queste decorazioni, probabilmente già danneggiate, devono essere state ricoperte in occasione dei restauri alla facciata compiuti nel 1760, ricordati da un’iscrizione posta nella controfacciata e visibile nel sottotetto, che dichiara: RESTAURATA DIE V MENSIS JULII 1760. Una fotografia databile attorno al 1870 e pubblicata in Biella tra polemica e storia, 1986, p. 45, mostra la facciata della chiesa già completamente intonacata, come si presentava fino agli ultimi restauri.
107
108 MARCO AIMONE
la più significativa testimonianza del periodo rinascimentale in terra biellese3. Tuttavia, nonostante l’elegante architettura della chiesa e dell’annesso convento, i notevoli cicli di affreschi al loro interno, a grottesche e con figure di santi e paesaggi, i pregevoli stalli lignei del coro scolpiti e dipinti, un insieme di importanza non secondaria nel panorama artistico del primo Rinascimento piemontese, manca ancora sul San Gerolamo biellese una trattazione specifica ed organica4; analizzando le decorazioni riapparse sulla facciata della chiesa assieme ai modelli architettonici dell’edificio, si cercherà di colmare in parte questa lacuna5.
La facciata della chiesa si presenta sostanzialmente intatta, se si escludono il notevole abbassamento di quota del terreno antistante, dovuto a lavori della fine del secolo XIX, e la conseguente demolizione del protiro davanti al portale d’ingresso (fig. 2)6. Caratterizzato da un’armoniosa semplicità, questo prospetto presenta un profilo a capanna con doppio spiovente: in verticale è scompartito da due paraste tuscaniche, con basi su plinti e capitelli in pietra verde, in orizzontale da un fregio tra due cornici in cotto sagomate; ai lati esterni, due lesene senza capitelli chiudono i campi laterali. Il timpano triangolare ha profili rettilinei in cotto sagomato, mentre i due semitimpani laterali sono ingentiliti da cornici in pietra verde dal profilo concavo, con volute alle estremità. Sull’asse centrale si aprono il portale, un grande oculo e, nel timpano, una seconda finestra circolare di dimensioni minori; nelle specchiature laterali, invece, le uniche aperture sono due piccole finestre rettangolari. Il portale è incorniciato da stipiti in pietra verde, con modanature di disegno classicheggiante, e da un architrave dove campeggia, sulla faccia inferiore, il monogramma IHS; nella lunetta è racchiusa una grande conchiglia, sempre in pietra verde. Gli altri elementi della facciata presentano un ornato più semplice: l’oculo è decorato da un triplice giro di mattonelle in cotto con decorazioni lineari, mentre le paraste e il fregio sono lisci.
3 Le date entro cui si svolse la costruzione sono registrate in due epigrafi esistenti nel complesso: la prima, in pietra, è murata nel coro della chiesa e ricorda l’inizio dei lavori; la seconda, dipinta, corre lungo l’architrave del piano superiore dei quattro lati del chiostro e ne celebra la conclusione. Tale cronologia è confermata anche a livello documentario. Cfr. BAIETTO, 1981, pp. 88-89; LEBOLE, 2004, pp. 495 e 511-512.
4 Come lamentava già SCIOLLA, 1980, p. 120; si vedano per ora specialmente la descrizione delle strutture architettoniche e delle decorazioni in LEBOLE, 2004, pp. 491-515, e l’analisi degli affreschi dell’interno della chiesa in NATALE, 2003, pp. 28-30.
5 Una prima, sintetica descrizione delle decorazioni graffite della facciata è stata presentata da AIMONE, 2003, pp. 12-23.
6 Cfr. SCIOLLA, 1980, pp. 167-168. Una fotografia databile al 1868 circa, pubblicata da LEBOLE, 2004, p. 401, mostra la facciata della chiesa prima di questi lavori di demolizione. Il protiro doveva essere un elemento originale, in quanto il suo tetto, con un profilo a due spioventi, compare chiaramente nel dipinto di Defendente Ferrari, dietro la bassa costruzione orizzontale che tale dipinto documenta come esistente davanti alla facciata: probabilmente questa manica, scomparsa già nell’Ottocento, chiudeva in origine il piazzale rialzato davanti alla chiesa, sul lato Ovest.
109MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
Sono cinque i settori della facciata che hanno restituito frammenti della decorazione antica: i tre campi del livello inferiore, tra le paraste, e i due superiori ai lati del rosone. Il settore centrale, attorno al portale, ha conservato i resti della decorazione nella zona alta e lungo la parasta sinistra, mentre del tutto mancante è la porzione attorno alla lunetta, agli stipiti dell’ingresso e nel settore destro (fig. 3)7: nelle zone superstiti un motivo a cerchi concentrici o intrecciati, disposti tra fasce rettilinee fa da cornice esterna; lo spazio interno è occupato da file orizzontali e sovrapposte di riquadri intrecciati, formati da sottili linee spezzate che si intersecano e si scavalcano in un complicato gioco di geometrie piane. Il settore destro ha restituito la decorazione antica unicamente negli spazi tra le paraste e la finestra (fig. 4): la cornice esterna è ornata da un motivo a coppie di S affrontate entro riquadri, invece lo spazio all’interno si presenta ricoperto da cerchi con rosette a cinque petali, a loro volta collegati da piccoli tondi. Nel settore sinistro i frammenti sono ancora più scarsi, pochi lacerti lungo le paraste laterali sempre all’altezza della finestra (fig. 5): sono comunque sufficienti per ricostruire una trama decorativa identica a quella nel campo opposto della facciata. Nella zona superiore, precisamente nei due campi ai lati dell’oculo, la conservazione di quanto è stato riportato alla luce è notevolmente migliore. Nella parte destra compare un grande cespo di acanto da cui nascono quattro volute floreali e numerosi piccoli racemi con viticci, che si dispongono a riempire lo spazio secondo un disegno complesso, ma rigidamente simmetrico nel suo schema (fig. 6); a sinistra invece, una rosa costituisce il centro di una ruota formata da otto bracci radiali di sottili virgulti di acanto, da cui ha origine una selva di pampini circolari che ricoprono gli spazi con ordinata regolarità, ben percepibile sotto il loro fitto sviluppo (fig. 7). Una sottile fascia bianca inquadra questi motivi decorativi. In cima al braccio centrale della ruota nel campo sinistro, è inserita una tabula ansata sostenuta da due delfini, in cui si legge un’epigrafe che ricorda, con ogni probabilità, la fine dei lavori di decorazione: M CCCCC XVI DIE V / MENSIS IVNII8. Nel dipinto di Defendente Ferrari anche le superfici del timpano, dei semitimpani laterali e del
7 Queste lacune, oltre che alla caduta dell’intonaco originale, sono attribuibili alla presenza in antico del protiro, la cui sagoma si indovina chiaramente dove la decorazione è mancante.
8 La scarna brevità dell’indicazione cronologica contenuta in quest’epigrafe conferma, in qualche modo, una notizia tramandata nell’anonima Vita manoscritta (vedi infra, nota 40) del beato Giovanni Gromo, promotore della fondazione del monastero: vi si narra che, durante i lavori di costruzione, fosse stata posta in facciata l’epigrafe in pietra oggi murata nel coro (+ IO DE GROMIS / ARCHIPRESBITER / VERCEL. COLLEM / EX PROPHANO / RELIGIOSUM / AD HONOREM SAN/ HIERONIMI FECIT / ANNO SALUTIS / 1512), per celebrare l’inizio dei lavori e soprattutto la generosità del Gromo, ma che questi, giunto in visita al cantiere, avesse ordinato, per umiltà, di rimuoverla (f. 8 del manoscritto della Vita); forse, l’epigrafe graffita oggi riscoperta, che si riferiva semplicemente alla conclusione dell’opera, era più adatta alla modestia del personaggio.
110 MARCO AIMONE
fregio sopra le paraste presentano decorazioni a racemi e volute, ma in questi spazi i restauri non hanno messo in luce alcun frammento di decorazioni: forse gli agenti atmosferici ne hanno cancellato ogni traccia9.
Quanto si conserva permette di ricostruire il programma decorativo generale, certamente pensato in stretta associazione con l’architettura della facciata. Il prospetto si presentava movimentato dalle membrature in aggetto e vivacizzato, a livello cromatico, dal verde scuro dei capitelli e del portale in pietra, dal rosso brillante delle cornici e dei fregi in cotto; come elemento di sfondo, si stendevano le superfici piane di tonalità grigio scuro con le loro complesse, quasi brulicanti composizioni a motivi geometrici e vegetali, di colore bianco brillante. Queste decorazioni sono state realizzate con la tecnica del “graffito”, ottenuta stendendo in successione più strati di intonaco, di colore differente, e incidendoli, di volta in volta, mediante un chiodo o una spatola di metallo, in modo da creare i disegni voluti, facendo emergere gli strati sottostanti e sfruttando il contrasto cromatico10. Nel caso di San Gerolamo, si riscontra l’uso simultaneo di due tecniche di esecuzione parzialmente differenti nell’effetto finale: nella maggior parte delle superfici, a un uniforme strato di intonaco grigio scuro è stata sovrapposta una stesura di intonaco chiaro, inciso poi a fresco asportandone ampie porzioni, così da riportare in luce vaste zone dello strato più scuro; invece, nel settore in basso a destra, l’intonaco chiaro è stato segnato con fitte linee orizzontali o diagonali, in modo da creare, con un gioco di tratteggio, un minore contrasto tra figure e sfondo. In entrambi i casi
9 Nel dipinto i colori delle decorazioni sono differenti, essendo il fondo chiaro e le decorazioni scure, mentre nella realtà è il fondo ad essere scuro e i disegni chiari; probabilmente sarebbe risultato difficile per il pittore rendere l’effetto reale su una tavola come questa, di dimensioni ridotte, mentre con questa inversione cromatica le decorazioni spiccano con grande risalto nell’insieme.
10 Per questa tecnica decorativa, cfr. in generale Le tecniche artistiche, 1973, p. 323. È interessante ricordare quanto scriveva Giorgio Vasari nella sezione dedicata alla Pittura dell’Introduzione alle sue Vite (cap. XII) a proposito Degli sgraffiti delle case che reggono l’acqua, essendo il primo scrittore ad aver fornito particolari circa questa tecnica; cfr. VASARI, 1996, pp. 225-226 (e note di commento alle pp. 281-282): «Hanno i pittori un’altra sorte di pittura, che è disegno e pittura insieme, e questo si domanda sgraffito, e non serve ad altro che per ornamenti di facciate di case e palazzi, che più brevemente si conducono con questa spezie, e reggono all’acqua sicuramente; perché tutt’i lineamenti, in vece di essere disegnati con carbone o con altra materia simile, sono tratteggiati con un ferro dalla mano del pittore. Il che si fa in questa maniera: pigliano la calcina mescolata con la rena ordinariamente, e con paglia abbruciata la tingono d’uno scuro che venga in un mezzo colore che trae in argentino, e verso lo scuro un poco più che tinta di mezzo, e con questa intonacano la facciata. E fatto ciò, e pulita col bianco della calce di travertino, l’imbiancano tutta; ed imbiancata, ci spolverano su i cartoni, ovvero disegnano quel che ci vogliono fare, e di poi, aggravando col ferro, vanno dintornando e tratteggiando la calce, la quale, essendo sotto di corpo nero, mostra tutti i graffi del ferro come segni di disegno. E si suole ne’ campi di quelli radere il bianco, e poi avere una tinta d’acquerello scuretto molto acquidoso, e di quello dare per gli scuri, come si desse a una carta; il che di lontano fa un bellissimo vedere; ma il campo, se ci è grottesche o fogliami, si sbattimenta, cioè ombreggia con quello acquerello. E questo è il lavoro che per esser dal ferro graffiato, hanno chiamato i pittori sgraffito».
111MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
comunque, le decorazioni geometriche e vegetali devono essere state realizzate mediante cartoni preparatori appoggiati alle superfici, oppure mediante schemi di base trasportati sulla parete con l’aiuto di righelli, squadre, compassi e cordicelle.
Allo stato attuale delle conoscenze, le decorazioni descritte rappresentano un unicum per il primo Cinquecento biellese11. È necessario quindi stabilire il luogo di provenienza di questa tecnica decorativa e del suo repertorio formale: a questo proposito, confronti assolutamente puntuali si possono individuare nella Lombardia della fine del Quattrocento e dell’inizio del Cinquecento. La tecnica della decorazione “a graffito” delle superfici murarie, nota e diffusa già nell’Antichità e nel Medioevo, aveva conosciuto singolare fortuna durante il Quattrocento precisamente in area lombarda, come ornamento di facciate e interni, anche in associazione a fasce di mattoni sagomati12. Di realizzazione veloce ed economica, inizialmente questa tecnica permetteva di coprire ed uniformare in maniera elegante murature poco accurate o appartenenti a fasi differenti, oppure serviva come supporto preparatorio per intonaci dipinti; nella seconda metà del secolo poi, essa ha acquistato una dimensione artistica propria, assumendo un carattere autonomo e sviluppando un repertorio specifico di decorazioni geometriche e vegetali, con soggetti animati o raffigurazioni architettoniche. Numerosi esempi risalenti a quest’epoca sono ancora visibili in centri lombardi influenzati dall’arte sforzesca, come Abbiategrasso e Pavia, e li si incontra in chiese, palazzi pubblici e abitazioni private13; ma è soprattutto a Milano che sono sopravvissuti gli esempi di livello qualitativo più alto: qui, in questi anni, operava anche Donato Bramante, a cui è stata ipoteticamente assegnata la celebre decorazione a graffiti (datata all’ultimo decennio del Quattrocento) sulle superfici interne della cupola di Santa Maria delle Grazie, con figure di santi tra motivi geometrici e vegetali, che rappresenta probabilmente il vertice raggiunto da tale tecnica decorativa a livello di possibilità espressive14.
11 Non mancano invece a Biella esempi di decorazioni affrescate su esterni, di soggetto architettonico o figurato, databili tra il tardo Quattrocento e il primo Cinquecento, come quelli ancora esistenti sulle facciate della chiesa e del convento di San Sebastiano (AIMONE, 2002, pp. 17-30), di palazzo Scaglia al Piazzo (ROCCAVILLA, 1905, pp. 17-18) e di casa Masserano al Vernato (GHIRALDELLO, 2005, pp. 7-20): il portale in cotto di questo palazzotto di inizio XVI secolo era circondato da una cornice dipinta con racemi e girali chiari su fondo scuro (quasi scomparsi), che potrebbero essere stati ispirati dalla decorazione del San Gerolamo.
12 Per un rapido inquadramento del problema delle decorazioni sulle facciate lombarde quattrocentesche, cfr. MACIOCE, 1984, pp. 43-47. Per la storia, la tecnica e le iconografie delle decorazioni graffite quattrocentesche di area lombarda, cfr. GRASSI, 1978, pp. 236-241; GRASSI, 1982, pp. 498-502; GRASSI, 1983, pp. 472-479.
13 Si possono ricordare le decorazioni nel portico di Santa Maria Nova ad Abbiategrasso (1450-70), per cui cfr. MEZZANOTTE, 1939, pp. 105-114, oppure alcuni esempi di area pavese di primo Cinquecento, come quelle nelle ville del Belvedere (motivi floreali entro riquadri) e di Branduzzo (architetture in prospettiva), per cui cfr. GIORDANO, 1978, pp. 225-268.
14 Per una sintesi sull’attività milanese di Bramante, cfr. da ultimi PATETTA, 2001, pp. 13-37,
112 MARCO AIMONE
Un caso già indagato della diffusione di questa tecnica dal vicino ducato verso l’area piemontese, contestualmente all’arrivo di progetti architettonici e maestranze incaricate di realizzarli, è offerto dalla chiesa dell’Assunta a San Giorgio Canavese, costruita tra il 1523 e il 1527 per volere di Benvenuto dei conti di Biandrate, uomo politico di spicco e storico insigne, investito nel 1523 dall’imperatore Carlo V dello stesso feudo di San Giorgio; sulla facciata meridionale si conserva ancora parte dell’originale decorazione graffita, con riquadri chiari e scuri, fregi vegetali e candelabre. Le forme della chiesa sono riconoscibili come bramantesche e il tipo di decorazione esterna è accostabile, sotto il profilo tecnico e iconografico, ai modelli lombardi di fine Quattrocento - inizio Cinquecento15. Nel caso del San Gerolamo, tuttavia, i confronti risultano ancora più stringenti non solo per la tecnica impiegata, ma soprattutto per l’assoluta identità di motivi decorativi rispetto ad alcuni esempi lombardi di elevata qualità formale. Il motivo ad S affrontate nelle cornici dei campi laterali, così come quello a cerchi con rosette erano stati impiegati identici a Milano, in Santa Maria delle Grazie, sulle superfici interne del coro: qui, le fasce ad S inquadrano le immagini dei santi domenicani, mentre gli sfondi con cerchi e rosette campiscono la grande volta a ombrello, le lunette laterali e la parete curva dell’abside; la data di questi graffiti, attribuibili non direttamente a Bramante, ma piuttosto a maestranze attive dopo la sua partenza da Milano (avvenuta nel 1499), cade tra il 1500 e il 151016. Sempre nodi, intrecci e tondi con rosette analoghi a quelli biellesi ritornano nelle decorazioni graffite della Cascina Pozzobonelli, alla periferia di Milano, nella cupola della cappella e sulle volte dell’antistante portico: come alle Grazie, cornici decorative ed elementi floreali affollano le superfici tra ritratti, angeli e figure di santi; la loro cronologia, pur con incertezze, è stata fissata agli ultimi anni del XV secolo17. La duplice serie di cerchi inscritti e intrecciati, che in San Gerolamo orna il bordo del campo attorno al portale, trova un esatto confronto nelle cornici dei graffiti riportati alla luce in un
con bibliografia di riferimento, e i contributi raccolti in Bramante milanese, 2002. Sui graffiti della tribuna di Santa Maria delle Grazie, la cui attribuzione a Bramante non è universalmente accettata, cfr. BRUSCHI, 1969, pp. 792-795; BORA, 1983, pp. 140-187, in particolare pp. 140-143; MULAZZANI, 1998, pp. 168-267, in particolare pp. 211-217. Sul rapporto tra architettura e apparati decorativi nella chiesa delle Grazie e più in generale nell’architettura lombarda di quei decenni, cfr. FERRI PICCALUGA, 1974, pp. 171-176; ADORNI, 2002.
15 La struttura architettonica e le decorazioni di questa chiesa, oltre che la figura del suo committente, sono esaminate da DE BERNARDI FERRERO, 1966.
16 BORA, 1983, pp. 142-144: una datazione posteriore all’occupazione francese di Milano sembra confermata dalla mancanza, in tali decorazioni, delle insegne di Ludovico il Moro, che aveva voluto la costruzione della tribuna come suo mausoleo; i soggetti figurativi rappresentati, i grandi santi domenicani, lascerebbero supporre piuttosto una committenza da parte dell’Ordine dei Predicatori, che appunto possedeva la chiesa e l’annesso convento.
17 ALESSANDRINI, 1988, pp. 121-126; PONTICELLI RIGHINI, 1988, pp. 114-118.
113MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
salone del tardoquattrocentesco palazzo Vimercati a Osnago, alla periferia orientale di Milano: qui sono inseriti all’interno di una composizione a pannelli rettangolari tra paraste con candelabre, che sorreggono un fregio a racemi; tale composizione di tipo architettonico, interamente realizzata a graffito, richiama nelle sue forme le stesse architetture dell’epoca, a riprova dello stretto legame tra struttura dei prospetti e apparati decorativi: al centro di ogni pannello si trova un tondo ornato da differenti soggetti, e questi tondi sono circondati dai consueti motivi a cerchi con rosette, qui intrecciati in modo più fantasioso e libero rispetto agli esempi precedenti. La datazione del ciclo di Osnago cade, ancora una volta, sullo scorcio del secolo XV18.
Passando ai motivi decorativi accanto all’oculo, il grande cespo di acanto con girali trova un confronto immediato nel fregio a elementi vegetali che chiude in alto la decorazione di palazzo Vimercati, dove però cespo e racemi, ripetuti e moltiplicati in successione, sono disposti orizzontalmente, in modo da riempirne l’intero spazio allungato. Diversamente, per la ruota floreale e vegetale un modello non troppo remoto può essere individuato nelle grandi ruote con i raggi a forma di balaustro che decorano l’esterno e l’interno della tribuna delle Grazie19; tale caratteristico motivo, nella chiesa milanese reso in forme rigidamente architettoniche, è stato trasformato nell’edificio biellese in una composizione di tipo naturalistico, più libera anche se ugualmente sorretta da uno schema geometrico. Il passaggio da forme architettoniche a vegetali potrebbe essere avvenuto nell’ambito delle maestranze specializzate che, lavorando nei grandi cantieri ducali oltre che per privati, elaboravano i motivi decorativi adatti alle particolari situazioni, ispirandosi ai modelli diffusi: un’identica libertà nel trasformare motivi ornamentali precedenti, con lo scopo di campire superfici di varia forma, si riconosce nei graffiti a intrecci fogliacei sulle volte del portico della Casa dei Grifi, sempre a Milano (fine del Quattrocento)20, a cui possono essere in qualche misura accostati, per la complessa e fantasiosa composizione di forme geometriche piane, i motivi a riquadri intrecciati del campo attorno al portale di San Gerolamo, per i quali non si sono individuati confronti puntuali tra gli esempi noti. I due differenti metodi impiegati per rifinire sulla facciata biellese l’ultimo strato di intonaco, asportandone ampi settori o incidendo linee parallele, sono attestati entrambi nei monumenti lombardi ricordati.
18 GRASSI, 1978, pp. 183-262, in particolare pp. 239-241; GRASSI, 1982, pp. 450-517, in particolare pp. 501-502.
19 Per palazzo Vimercati, cfr. GRASSI, 1978, pp. 239-241; GRASSI, 1982, pp. 501-502. Per le grandi ruote nella decorazione esterna ed interna della tribuna delle Grazie, che ritornano anche nella celebre Incisione Prevedari, cfr. ALBERICI, 1978, pp. 3-55; BRUSCHI, 1983, pp. 35-89, in particolare pp. 57-81; BORA, 1983, pp. 142-144.
20 GRASSI, 1978, p. 239; GRASSI, 1982, pp. 501-502. Per il processo di elaborazione di queste decorazioni, cfr. anche GRASSI, 1983, pp. 417-501, in particolare p. 475.
114 MARCO AIMONE
Nel coro delle Grazie e nella Cascina Pozzobonelli, gli spazi tra le figure sono campiti da spesse linee che creano un fitto tratteggio, mentre, nella cupola sempre delle Grazie e a Palazzo Vimercati, gli sfondi delle decorazioni sono uniformemente scuri, come risultato della completa asportazione dell’intonaco chiaro tra le figure21. Considerando come l’effetto visivo derivato sia abbastanza differente, è curioso che a San Gerolamo le due tecniche di rifinitura siano state adoperate una accanto all’altra, senza apparente intento stilistico: forse si può pensare semplicemente alla contemporanea presenza di più squadre di artigiani al lavoro nel cantiere.
Ampliando ora il campo d’indagine all’architettura della chiesa, emergono altri legami, numerosi e significativi, che ricollegano l’edificio all’area lombarda. La forma della pianta e dell’elevato, così come i particolari dell’ornamento denunciano una dipendenza diretta dalla chiesa di San Sigismondo di Cremona, prestigiosa fondazione sforzesca e tra le più importanti sedi dell’Ordine Gerolamino nel ducato milanese, un edificio di notevoli dimensioni che veniva completato nelle sue strutture negli stessi anni in cui si apriva il cantiere del San Gerolamo (fig. 8)22. La grande chiesa cremonese ha conservato quasi intatto il suo aspetto originale, rendendo possibile un confronto molto approfondito con l’edificio biellese. La costruzione del San Sigismondo attuale, iniziato nel 1463 in sostituzione di una precedente chiesa, era stata decisa e finanziata da Bianca Maria Visconti, moglie del duca di Milano Francesco Sforza, in seguito all’affidamento di questo antico cenobio all’Ordine Gerolamino, protetto dalla duchessa23. Dopo la morte di Bianca Maria (1468), i lavori ripresero solo nel 1488 per volere e con il sostegno di Ludovico il Moro: proprio al tempo del suo governo è assegnata, su base documentaria e stilistica, la costruzione della maggior parte delle strutture, anche se i lavori sembra siano continuati dopo la caduta definitiva del Moro (1500), dato che la decorazione pittorica poteva iniziare solo nel 153524. Alcune testimonianze, non del tutto
21 GRASSI, 1978, pp. 239-240; BORA, 1983, pp. 143-144; ALESSANDRINI, 1988, pp. 121-126.22 Sulle vicende storiche del monastero di San Sigismondo a Cremona, cfr. i contributi di FERRARI,
1971; FERRARI, 1974*; FERRARI, 1974**, pp. 817-836; CICINELLI, 1998, pp. 15-28; FOGLIA, 1998, pp. 29-46.
23 Bianca Maria Visconti aveva sposato Francesco Sforza il 25 ottobre del 1441 proprio nella chiesa di San Sigismondo (quella precedente l’attuale), e anche per tale ragione la duchessa era legata a questo antico cenobio, che avrebbe beneficiato della protezione degli Sforza fino alla caduta della dinastia. Sulla figura di Bianca Maria e sul suo ruolo nella ricostruzione del complesso cremonese, cfr. FERRARI, 1974*, pp. 5-14; CICINELLI, 1998, pp. 15-28.
24 La ricostruzione delle vicende edilizie della chiesa e del convento di San Sigismondo è stata condotta da FERRARI, 1974*, pp. 17-36, che all’indagine sui documenti d’archivio ha unito l’analisi delle murature e degli stili delle strutture ancora esistenti. Le sue conclusioni possono essere così riassunte: la parte più antica del complesso comprende i locali lungo i lati meridionale e occidentale del chiostro; seguono poi i vani paralleli al lato meridionale della chiesa, presso l’ingresso occidentale al chiostro; dopo viene la chiesa, che si addossa con le sue strutture al convento, anche se rimane problematico definire con esattezza l’ordine di costruzione delle sue varie parti: le più antiche
115MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
sicure, attribuirebbero il progetto originale della chiesa e dell’annesso convento all’architetto cremonese Bartolomeo Gadio (1414-1484), noto per la sua opera di ingegnere militare al servizio degli Sforza25: benché la questione rimanga aperta, l’analisi stilistica delle strutture e la ricostruzione delle fasi di cantiere hanno permesso di riconoscere varie modifiche al progetto primitivo, verosimilmente decise durante i lavori degli ultimi anni del secolo, per influsso delle importanti novità nelle forme architettoniche che si andavano sviluppando negli altri centri padani in contatto con Cremona, quali Ferrara, Mantova e soprattutto Milano26.
Al termine delle prolungate vicende costruttive, il San Sigismondo è risultato un edificio a navata unica, con sei cappelle laterali per parte, transetto continuo largo quanto la navata e le cappelle, e profondo presbiterio chiuso da un’abside poligonale a tre lati. L’esterno, caratterizzato da volumi geometricamente compatti tra loro affiancati, rivela ancora certi caratteri propri delle chiese tardogotiche lombarde: slanciati contrafforti, che in facciata si prolungano nei pinnacoli; finestre rettangolari e circolari ritmicamente alternate e bordate di cotto; una lanterna quadrangolare nel punto di incrocio tra navata e transetto, dalla compatta sagoma appena alleggerita dalle esili monofore sotto il cornicione. Nettamente rinascimentale è invece il campanile a pianta ottagonale, ingentilito da paraste e frontoni che incorniciano le strette finestre ad arco. Anche la struttura interna è ormai lontana dalle forme tardogotiche: la navata è dominata dal profilo curvo della grande volta a botte lunettata; lungo le pareti laterali, archi a tutto sesto su pilastri fasciati da paraste corinzie danno accesso alle cappelle; lungo il piano d’imposta della volta corrono un architrave a tre fasce e un fregio ornato di tondi. Paraste corinzie e trabeazione scandiscono anche le pareti piene del coro, ma in corrispondenza degli angoli dell’abside poligonale le paraste sono duplicate, assumendo la caratteristica forma “a libro”. Il transetto continuo è scompartito da arconi trasversali in tre campate: quella centrale ha una superficie doppia delle laterali ed è coperta da una volta a padiglione su quattro vele per lato; volte a botte coprono invece le altre due campate e l’area presbiteriale, mentre volte a crociera coprono le cappelle laterali della navata. Esaminando le dinamiche progettuali del San Sigismondo, si conclude che forma e proporzioni della pianta sono state definite
dovrebbero essere la facciata, il transetto e l’abside. 25 LOI, 1998, pp. 178-180. Sul ruolo del Gadio nella progettazione del San Sigismondo, cfr. anche
ZAIST, 1774, pp. 34-37, che poteva utilizzare documenti d’archivio in seguito smarriti. 26 Si vedano le osservazioni e i confronti presentati da FERRARI, 1974*, pp. 17-36. Alle influenze
dei modelli tardogotici lombardi, che sembrano caratterizzare soprattutto la pianta della chiesa e del convento, così come le forme esterne della chiesa stessa e delle volte dei locali attorno al chiostro, si sono sovrapposti elementi che tradiscono suggestioni del primo rinascimento padano e toscano, come gli archi a tutto sesto e la volta a botte lunettata nell’interno della chiesa, fino ad arrivare ad alcune chiare influenze bramantesche, come i pilastri fasciati da paraste su alti plinti nella navata.
116 MARCO AIMONE
in base ad uno schema modulare ad quadratum, ottenuto ripetendo in lunghezza e in larghezza una serie di quadrati il cui lato, sempre uguale, costituisce il modulo dimensionale dell’edificio27; in questo modo, la navata centrale è risultata larga due moduli e lunga sei, le cappelle laterali sono lunghe e larghe un modulo, il transetto è largo quattro moduli e profondo due, il presbiterio infine è largo e profondo due moduli. Un simile schema progettuale, ancora caratteristico dell’architettura tardogotica, non è stato modificato nel corso dei lavori, tuttavia sono stati inseriti diversi elementi che rispecchiano le novità formali sviluppate nei centri del primo rinascimento padano, forse per intervento dell’architetto cremonese Bernardino de Lera (attestato tra il 1468 e il 1519)28: gli archi a tutto sesto delle cappelle inquadrati tra paraste su alti plinti, lo spesso cornicione ornato di tondi, la volta a botte della navata centrale con vele e finestre circolari, le paraste “a libro” che segnano gli angoli interni delle pareti dell’abside.
Questa coesistenza di motivi differenti, frutto di un progressivo aggiornamento del linguaggio architettonico, ha determinato l’aspetto finale dell’edificio che, nell’insieme, è risultato armonico oltre che grandioso. Proprio da questa chiesa il San Gerolamo biellese ha puntualmente derivato le forme della sua struttura, con la pianta a navata unica affiancata da cappelle quadrate, il transetto continuo ampio quanto navata e cappelle e il profondo presbiterio con abside poligonale; lo stesso vale per l’elevato: gli spazi della navata e del presbiterio sono dominati da una grande volta a botte lunettata con finestre circolari; pilastri fasciati da paraste inquadrano gli archi a tutto sesto all’ingresso delle cappelle e sorreggono il fregio alla base della volta; non manca neppure il campanile a pianta ottagonale accanto al presbiterio, con strette finestre ad arco incorniciate da paraste e frontoni. Anche il lessico decorativo dell’interno è derivato, nei principali dettagli, da quello di San
27 Questo progetto modulare è stata descritto da FERRARI, 1974*, p. 29, dove sono indicati vari confronti quattrocenteschi di area lombarda. Simili soluzioni progettuali erano assai diffuse nell’architettura medievale europea, con vari gradi di complessità; per un’analisi generale di simili schemi, cfr. HISCOCK, 2000, specialmente pp. 207-252, mentre, per la loro diffusione in terra lombarda durante il basso Medioevo, cfr. ROMANINI, 1964, pp. 18-24 e passim.
28 Sull’architetto cremonese Bernardino Bocoli, detto de Lera, cfr. PUERARI, 1969, pp. 102-103. Gli elementi di ispirazione rinascimentale presenti a San Sigismondo, dovuti ai contatti artistici tra Cremona e gli altri centri padani, quali Mantova o Milano, negli ultimi decenni del Quattrocento, sono stati messi in luce da FERRARI, 1974*, pp. 29-36; attraverso ricerche estese alla città e al territorio, la studiosa ha potuto evidenziare la forza di suggestione esercitata, in questi decenni, da tali modelli anche in altri monumenti coevi di Cremona e del suo contado. La proposta avanzata da FERRARI, 1974*, pp. 35-36, circa un possibile intervento nel cantiere di Bernardino de Lera, è motivata dal fatto che questi, in altre sue realizzazioni, aveva mostrato di essere al corrente delle novità formali introdotte da Bramante nelle sue realizzazioni milanesi. Per inquadrare meglio tali contatti artistici, bisogna ricordare che, nei decenni finali del Quattrocento e iniziali del Cinquecento, Cremona aveva assunto, nel panorama padano, un ruolo di una certa rilevanza anche per quanto riguarda le arti figurative (cfr. TANZI, 1990, pp. 13-19).
117MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
Sigismondo: nella navata, ad esempio, alti plinti stanno alla base delle paraste, mentre gli angoli interni delle pareti dell’abside poligonale sono scandite da paraste “a libro”29. Ugualmente, per definire i rapporti dimensionali della pianta è stato utilizzato uno schema modulare analogo a quello del San Sigismondo, basato sulla figura del quadrato il cui lato costituisce il modulo dimensionale dell’edificio. La lunghezza complessiva della chiesa è risultata di sette moduli, la larghezza di quattro: ogni cappella occupa uno di questi quadrati, la navata centrale ne occupa sei, il transetto otto e il presbiterio quattro. Una simile dipendenza presuppone un esame diretto del San Sigismondo, in base a cui sarebbero stati preparati i disegni per il progetto della chiesa biellese30; nessuno di questi è giunto fino a noi, è tuttavia sopravvissuto un importante documento, conservato in antico nell’archivio di San Sigismondo, che potrebbe confermare una tale pratica: due dettagliate planimetrie del monastero di San Gerolamo su un unico foglio, firmate da Angel Nani cremonese, un architetto vissuto tra la seconda metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, e noto anche da altri documenti31. Questo disegno fornisce la prova di quei contatti artistici esistenti tra i diversi monasteri gerolamini dell’Italia settentrionale, che includevano anche, all’occorrenza, lo scambio delle planimetrie dei rispettivi conventi32.
Le differenze tra il San Gerolamo e il San Sigismondo appaiono secondarie e ricollegabili soprattutto alle minori dimensioni della chiesa biellese, alla morfologia del sito, o ad un ulteriore aggiornamento stilistico dell’edificio. Essendo le dimensioni del complesso biellese proporzionalmente inferiori rispetto al modello, la lunghezza della navata è stata dimezzata e il numero delle cappelle ridotto a tre
29 Contemporaneamente alla demolizione del piazzale antistante alla chiesa, verso il 1870 è stato innalzato un muro di separazione tra la navata (oggi utilizzata come biblioteca) e il transetto (che serve ora da cappella assieme al presbiterio), modificando così la spazialità interna dell’edificio e la disposizione liturgica originale: l’altare è stato addossato al lato della parete divisoria verso il transetto, mentre anticamente si trovava contro la parete di fondo dell’abside; il coro ligneo, invece, in origine doveva essere sistemato nella campata centrale del transetto, su due file affrontate (come ancora si vede nel San Sigismondo), mentre ora è addossato alle pareti dell’abside.
30 Sull’utilizzo e sull’aspetto dei disegni architettonici nella seconda metà del Quattrocento e nella prima metà del Cinquecento, cfr. FROMMEL, 1994*, pp. 100-121; si vedano anche ACKERMAN, 1954; ETTLINGER, 2000, pp. 96-123.
31 Archivio di Stato di Milano, Documenti del Monastero di Ospedaletto, cart. 5290: disegno di mm 405x280 su carta bianca, tracciato a mano libera con inchiostro nero, recante in alto a sinistra l’intestazione Disegno della chiesa e mons.ro di S. Gerolamo di Biella di sopra e di sotto, e firmato lungo il margine destro Angel Nani cremonese. Rappresenta, in modo preciso e proporzionato, le piante dei piani terreno (a destra nel foglio) ed elevato (a sinistra) del monastero. Questo documento è stato scoperto e studiato da Maria Teresa Baietto, che desidero ringraziare per avermelo segnalato; per la sua descrizione cfr. BAIETTO, 1981, pp. 101-102. Sull’architetto Angelo Nani, attivo a Cremona tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento, cfr. GRASSELLI, 1827, p. 183.
32 Cfr. in proposito FOGLIA, 1998, pp. 36 e 46, nota 25.
118 MARCO AIMONE
per lato, sei in tutto a fronte delle dodici nell’originale: questa scelta si giustifica in relazione al numero di monaci, fin dall’inizio minore rispetto a quello cremonese33; per ragioni analoghe sono state eliminate le finestre delle cappelle laterali, non più necessarie per l’illuminazione di spazi meno ampi. Inoltre, mentre il complesso di San Sigismondo era sorto su un terreno pianeggiante, la chiesa e il convento di San Gerolamo sono stati innalzati sulla sommità di un colle, preventivamente terrazzato: ragioni di statica devono aver suggerito di eliminare la lanterna per non gravare eccessivamente i pilastri del transetto, la cui campata centrale è stata coperta con una volta a padiglione, invisibile all’esterno sotto le falde del tetto; per le stesse ragioni, anche il campanile è stato innalzato lungo il lato sinistro, non destro, dell’area presbiteriale34. Infine, rispetto al modello, certi particolari della chiesa biellese appaiono ancora più aggiornati in senso bramantesco, come i profili curvi con volute nei semitimpani laterali della facciata; tali particolari trovano una sorprendente corrispondenza in un noto disegno di fine Quattrocento - inizio Cinquecento, oggi conservato al Louvre di Parigi, attribuito alla cerchia milanese di Bramante e ritenuto il progetto per la facciata di una chiesa non sicuramente identificabile35. Meno visibile, ma altrettanto significativa, è stata la sostituzione, nelle cappelle laterali, delle volte a crociera, di gusto ancora gotico, con più elaborate volte composite di gusto pienamente rinascimentale.
Com’è possibile dare ragione, sul piano storico, dell’imitazione così fedele di un modello architettonico lombardo in terra biellese? La risposta può venire unicamente dai documenti relativi alla costruzione del monastero di San Gerolamo e all’opera del suo “fondatore” – meglio sarebbe dire promotore –, Giovanni Gromo dei conti di Ternengo (circa 1450-1520)36. La vita dell’illustre prelato, che
33 Stando alla documentazione d’archivio, il convento di San Gerolamo non fu mai occupato da più di una decina di monaci contemporaneamente (cfr. LEBOLE, 2004, pp. 424, 467 e 471).
34 Il San Gerolamo biellese sorge sulla cima di una collina con forte pendenza soprattutto sui fianchi est, ovest e sud: una simile collocazione, se ha accentuato la visibilità della chiesa, le cui strutture sovrastano l’adiacente convento che sta ad una quota più bassa, ha posto una serie di problemi che i costruttori del San Sigismondo non avevano dovuto affrontare, rendendo inevitabili una semplificazione delle strutture e una loro diversa disposizione. Anche gli accessi erano organizzati, di conseguenza, in modo diverso, come si può desumere dalla pianta di Angelo Nani (vedi supra, nota 31): all’area antistante la chiesa, elevata sul terrapieno oggi scomparso, si accedeva attraverso una rampa a gradini, anch’essa demolita verso il 1870, che attraverso un protiro immetteva alla manica porticata che chiudeva verso sud il sagrato; sempre sotto questo portico si trovava l’ingresso principale al convento, sul piano elevato del chiostro.
35 Parigi, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, Inv. MI 1105. Questo disegno è stato recentemente datato da FROMMEL, 1994**, p. 467, al 1504 circa. Le navatelle esterne sono concluse in alto da semitimpani identici a quelli del San Gerolamo, ossia curvi con volute terminali.
36 Per la vita e le opere di questo nobile ecclesiastico, cfr. principalmente GALLIZIA, 1757, pp. 210-239; ENRIETTI, 1822; Biella tra polemica e storia, 1986, pp. 41-62; LEBOLE, 2004, pp. 394-416 (con bibliografia completa). Si osservi che, negli studi citati, il “beato” Gromo è sempre considerato
119MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
la devozione popolare avrebbe chiamato “beato”, la sua carriera ecclesiastica tra le chiese di Vercelli, Ivrea e Torino, la sua cultura umanistica e teologica sono tutti aspetti più volte indagati; in questo contesto, è importante concentrare l’attenzione sui legami del Gromo con quegli ambienti che potevano metterlo in contatto con artisti e maestranze attive nei luoghi da lui visitati. Non si deve infatti trascurare che la personale pietà del Beato lo aveva portato a patrocinare l’edificazione o il restauro di costruzioni religiose in diverse parti del Piemonte37; inoltre, la sua carica di vicario generale dell’arcivescovo di Torino Domenico Della Rovere (tra il 1486 e il 1494, e ancora nel biennio 1497-98) lo metteva in stretto contatto con il cantiere, aperto nel 1491, per la costruzione del Duomo nuovo, grandioso edificio patrocinato dal cardinale Della Rovere, e con Meo del Caprina, architector et magister fabricator della nuova chiesa, e quindi con il mondo artistico da lui rappresentato: la fabbrica del Duomo nuovo aveva infatti introdotto in Piemonte le più aggiornate soluzioni formali elaborate nei cantieri romani degli ultimi decenni del Quattrocento38.
Per altro, contatti altrettanto importanti esistevano tra il Gromo e l’area milanese e proprio questi devono essere stati assai più determinanti nella costruzione del San Gerolamo. Si trattava dei rapporti personali che lo univano all’Ordine Gerolamino, detto anche “dell’Osservanza Lombarda”, a cui era destinato il monastero biellese e che proprio nella Lombardia degli Sforza aveva allora le case conventuali più ricche e prestigiose. È opportuno ricordare brevemente i momenti essenziali della
il fondatore del monastero biellese, benché nessun documento tra quelli coevi confermi una simile circostanza: i suoi generosi lasciti, assieme a quelli del fratello Bartolomeo, sono elencati nell’Atto di donazione a favore del monastero, datato 13 luglio 1519 (Archivio di Stato di Torino, Sezione Corte, Regolari di qua da monti, mazzo 9, Gerolamini, Biella, fasc. 1), ma in esso egli non figura come fondatore. L’epigrafe che corre lungo il cornicione del chiostro del monastero (ANNO SALUTIS 1517 QUINTO POST IACTUM PRIMARIUM LAPIDEM IO GROMIS ECCLESIAE / VERCELLENSIS ARCHIPRESBITER FUNDATOR COLLEM HUNC EX PROPHANO RELIGIOSUM / EX STERILI UBEREM FACTUM AD HONOREM SANCTI DOCTORIS HIERONYMI SACRARI CURAVIT / UT FIERET MONS PINGUIS MONS IN QUO BENEPLACITUM ESSET DEO HABITARE IN EO USQUE IN FINEM AMEN) è stata dipinta dopo la sua morte, e posteriore di molti decenni è poi l’anonima Vita manoscritta a lui dedicata (cfr. infra, nota 40), che ugualmente gli attribuisce il titolo di fondatore: lo scopo di questi testi era quello di nobilitare il convento di San Gerolamo attraverso la fama di santità che circondava la memoria del “beato”, e quello di rivendicare ai Gromo il merito della sua fondazione. L’esatto ruolo giuridico avuto da Giovanni Gromo, che aveva unicamente agevolato e sostenuto la venuta dei Gerolamini nel Biellese, è stato chiarito, attraverso l’esame critico dei documenti, da BAIETTO, 1981, p. 91, nota 70, e pp. 263-273.
37 Cfr. SCIOLLA, 1980, p. 119; LEBOLE, 2004, pp. 394-416.38 GENTILE, 1990, pp. 107-200; CARITÀ, 1990, pp. 201-228, in particolare pp. 201-217 e 220. Un
possibile legame iconografico tra le facciate del Duomo nuovo di Torino e il San Gerolamo di Biella è stato ipotizzato da LEBOLE, 2004, p. 491, in rapporto al profilo curvo dei semitimpani laterali, presente in entrambi gli edifici: l’anteriorità del caso torinese comporterebbe quindi una derivazione da esso per la chiesa biellese.
120 MARCO AIMONE
storia di questo Ordine religioso, detto “dei monaci eremitani di San Gerolamo dell’Osservanza di Lombardia”: riformato nel 1424 e poi rifondato nel 1429 dal frate spagnolo Lope de Olmedo (1370-1433), approvato da papa Martino V e con prima sede in Sant’Alessio sull’Aventino a Roma, si era diffuso con rapidità e fortuna singolari nei territori dell’Italia settentrionale, prima sotto i Visconti e poi sotto gli Sforza, godendo della costante protezione e del generoso sostegno dei signori di Milano39. Le circostanze dell’incontro tra Giovanni Gromo e i Gerolamini sono narrate da un’anonima Vita multum reverendi ac magnifici domini Johannis de Gromis Bugellensis, redatta in latino poco dopo la metà del Cinquecento40. Si tratta, con ogni probabilità, dell’opera di un monaco del monastero biellese; essa presenta toni fortemente agiografici ed è stata scritta con l’intento, neppure troppo velato, di esaltare il ruolo avuto dal Gromo nella fondazione e nella costruzione del San Gerolamo; nonostante ciò, il contenuto si è rivelato storicamente attendibile per quei dati storici altrimenti verificabili41. Sembra anche che l’anonimo redattore abbia potuto avvalersi di documenti d’archivio poi perduti, oppure dei ricordi di chi conosceva i fatti per averli vissuti: è ricordata, ad esempio, la testimonianza di un tale padre Eliseo di Milano presente ai lavori di costruzione, da cui l’autore afferma di aver ricavato alcune delle notizie esposte42.
La Vita narra di un pellegrinaggio compiuto dal Gromo a Milano attorno al 1495, con lo scopo di venerare l’immagine della Vergine conservata in Santa Maria presso San Celso: qui sarebbe avvenuto il fortuito incontro con i monaci dell’Ordine di San Gerolamo, che avevano offerto ospitalità al “beato” presso il monastero di Castellazzo, cenobio milanese dell’Ordine (ff. 3-4 della Vita).
39 Per una sintesi sulle vicende dell’Ordine Gerolamino in terra lombarda tra la fine del Medioevo e il Rinascimento, cfr. CATTANEO, 1961, pp. 509-720, in particolare pp. 656-658, ma anche BAIETTO, 1981, pp. 30-69, il cui esame dei documenti d’archivio ha aggiunto vari dettagli inediti alla storia di questo Ordine.
40 Il manoscritto originale della Vita, ancora inedito, è conservato presso l’Archivio della famiglia Gromis di Trana, a Sommariva Perno; si compone di sette fogli fittamene scritti sul retto e sul verso e a questa copia si fa riferimento qui per i brani citati. Certi dati presenti nel testo e la forma dei caratteri scrittori hanno permesso di stabilire, come data per la sua stesura, la seconda metà del XVI secolo; un’altra copia, posteriore di circa un secolo, esiste nell’Archivio Comunale di Biella, cass. 59, fasc. 2251, mentre una traduzione italiana, risalente alla metà del XVIII secolo e ampliata con note tratte da altri scrittori, si conserva nell’Archivio di Stato di Biella, Fondo Gromo di Ternengo, mazzo 39. Il manoscritto originale è stato studiato da TORRIONE, 1950, anno IV, n. 2, pp. 18-22, n. 3, pp. 17-24, e n. 5, pp. 25-32, e da LEBOLE, 2004, pp. 394-410; le reali finalità alla base della redazione di questa Vita, di provare cioè la santità del Gromo, i suoi stretti legami con il monastero e il suo ruolo di fondatore, sono state dimostrate, con ampiezza di argomenti, da BAIETTO, 1981, pp. 116-120.
41 Cfr. le varie osservazioni in TORRIONE, 1950, passim, e in LEBOLE, 2004, pp. 393-394, 410 e passim.
42 Si legge infatti al f. 8 della Vita: Haec autem et alia a Reverendo Patre Domino Eliseo Mediolanensi, qui utique praesens aderat, didici.
121MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
Da quest’incontro sarebbe nato il proposito di fondare a Biella un monastero di Gerolamini: ottenuto il sostegno della comunità milanese, il Gromo sarebbe ritornato a Biella accompagnato dai primi monaci e dal magister Christophorus de Castellacio, definito nella Vita “peritissimus architector” (ff. 4-5), già attivo presso lo stesso monastero milanese e pronto a collaborare alla nuova fondazione; costui sarebbe stato l’artefice della ricostruzione, tra il 1495 e il 1499, della chiesa parrocchiale del borgo di Chiavazza, presso Biella, prima sede assegnata ai monaci (ff. 5-6)43. In seguito, Giovanni Gromo avrebbe concepito il proposito di far costruire un nuovo convento in un luogo maggiormente appartato, più confacente alla vita eremitica e al rigore ascetico prescritti dalla regola di Lope de Olmedo: da ciò la decisione di far erigere il monastero di San Gerolamo sul colle detto di Bethleem, una boscosa collina che sovrasta Chiavazza (ff. 6-7). Ai lavori di costruzione avrebbero collaborato attivamente maestranze giunte specialmente da Cremona e Milano (f. 7), come espressamente attestato dal manoscritto44. Sfrondata dagli elementi agiografici e svincolata dall’ipoteca encomiastica, la Vita rimane una fonte sostanzialmente attendibile per le vicende della costruzione del monastero, confermando il determinante contributo di maestranze di origine lombarda nel progetto e nella realizzazione delle strutture; infatti, l’esame dei documenti d’archivio superstiti arricchisce, ma non modifica tale quadro45. Da essi emerge prima di tutto il ruolo centrale svolto dalle case della congregazione in Lombardia: da questi monasteri erano giunti i primi monaci e i loro superiori, tra cui il padre Gerolamo da Cremona, priore nell’anno 1517 alla conclusione dei lavori per la nuova chiesa, o quel padre Eliseo da Milano interrogato dall’anonimo; si deve inoltre ricordare che l’arrivo di monaci dalla Lombardia sarebbe continuato ininterrottamente anche nei secoli successivi46. In secondo luogo, la fondazione della casa biellese era stata approvata dal Capitolo Generale, come di norma, e la
43 La chiesa parrocchiale ricostruita per i Gerolamini e terminata nel 1499 non esiste più, tuttavia da descrizioni antiche e da un affresco del XVII secolo si può ricostruire a grandi linee un edificio a tre navate su colonne in pietra, con una facciata a capanna con duplice spiovente che sembra ricordare quella del San Gerolamo, di poco posteriore: cfr. LEBOLE, 1986, pp. 486-488 e 505-515; LEBOLE, 2004, pp. 416-417.
44 BAIETTO, 1981, pp. 69-91. La Vita così descrive il cantiere del monastero (f. 7): «[…] sparsa deliberationis eius fama [ossia la decisione del Gromo di fondare il nuovo convento], undique confluunt homines ligonibus, securibus, malleis et huiusmodi ferramentis armati. […] operariorum numerus etiam de longe venientium in dies augebatur, nam e Cremona magister Evangelista faber lignarius cum aliis sociis et e Mediolano multi diversorum operum periti advenerunt, ordinate disponuntur super intendentes, procuratores et scribae, qui operibus praeessent».
45 Per la documentazione d’archivio su San Gerolamo ancora esistente, cfr. BAIETTO, 1981, passim; GRISOLI, 1989, pp. 145-174, in particolare pp. 164-174; LEBOLE, 2004, pp. 435-447 e passim.
46 Si veda l’elenco dei priori del monastero in LEBOLE, 2004, pp. 489-490; per il profondo radicamento dell’Ordine dei Gerolamini in territorio lombardo dal XV al XVIII secolo, cfr. BAIETTO, 1981, pp. 63-69, 173-180 e 297-312.
122 MARCO AIMONE
sua costruzione era stata in buona parte finanziata ricorrendo alle rendite proprio dei monasteri lombardi, come alcuni documenti coevi attestano47. Gli stessi riferimenti al convento milanese di Castellazzo e alle maestranze giunte da Milano e Cremona sono altrettanto significativi: è già stato ricordato che il monastero di Castellazzo, oggi scomparso ma situato in antico nei pressi di Santa Maria presso San Celso, dove il beato avrebbe trovato ospitalità, era un centro molto importante dell’Ordine48; quanto al monastero cremonese di San Sigismondo, una delle più prestigiose case dei Gerolamini, protetto e beneficato generosamente dagli Sforza, esso era allora al culmine del suo splendore49. Infine, di grande interesse è la notizia riportata dalla Vita circa la presenza a Biella dell’“abilissimo architetto” Cristoforo da Castellazzo, altrimenti ignoto anche se verosimilmente lombardo, che si sarebbe occupato di sovrintendere i lavori, almeno per quanto riguarda la chiesa di Chiavazza50.
Risultano a questo punto più chiare le ragioni della ripresa, in contesto biellese, di un modello architettonico cremonese, come anche della presenza di decorazioni “a graffito” di tipo lombardo: progettista e maestranze erano state assoldate dai Gerolamini dei maggiori monasteri lombardi ed inviate, assieme ai fondi raccolti, per costruire la nuova casa dell’Ordine; è verosimile che, tra queste maestranze, fossero presenti artigiani specializzati nelle decorazioni parietali graffite che, come
47 Un Capitolare dell’Ordine, in data 30 aprile 1507, elencava i monasteri tenuti a contribuire alla costruzione del cenobio in Chiavazza e le relative somme di denaro (Archivio di Stato di Milano, Fondo di religione 55-56, cart. 2369: Castellazzo - Capitolari 1451-1525, t. I); poco tempo dopo, in una lettera datata 11 gennaio 1513, il preposito generale dell’Ordine Fra Nicola, ordinava ai conventi lombardi il versamento di 200 ducati d’oro, a titolo di contributo per la costruzione del nuovo monastero, secondo una deliberazione emanata dal Capitolo Generale (Archivio di Stato di Biella, Enti di culto, Chiavazza, cart. 51, fasc. 6). Su questi due documenti, cfr. BAIETTO, 1981, pp. 68 e 87; LEBOLE, 2004, pp. 438-439.
48 Tale monastero, fondato nel 1401 sotto gli auspici di Gian Galeazzo Visconti, godette della protezione ducale anche al tempo degli Sforza, che ripetutamente avevano concesso ai suoi monaci esenzioni fiscali e daziarie, ragion per cui, al tempo in cui fu visitato dal Gromo, questo cenobio doveva essere al culmine della sua ricchezza; cfr. BAIETTO, 1981, pp. 25 e 31. Il monastero sorgeva effettivamente nei pressi di Santa Maria presso San Celso: per quanto si conosce del suo aspetto, cfr. PATETTA, 1987, p. 363.
49 I contatti tra il cenobio di Biella e San Sigismondo erano continuati nel tempo: lo dimostra, tra l’altro, la pala dell’altare maggiore di San Gerolamo raffigurante la Vergine con il Bambino e santi, del pittore Anselmo Allasina (datata 1607), che è una copia fedele di quella posta sopra l’altare maggiore di San Sigismondo, dipinta da Giulio Campi e terminata nel 1539; la tela biellese ha ripreso dal modello non solo lo schema generale della scena e numerosi particolari, ma anche alcuni dei personaggi raffigurati in esso, tanto da non lasciare dubbi che sia stata eseguita in seguito alla visione dell’originale. Per la pala cremonese, cfr. FERRARI, 1974*, pp. 57-63; per quella biellese, LEBOLE, 2004, pp. 493-494.
50 Senza entrare nell’ardua questione dell’identità di Cristoforo da Castellazzo, si osservi solo che il ricordato disegno del Louvre (cfr. supra, nota 35), che presenta numerosi particolari in comune con la facciata del San Gerolamo, è stato recentemente attribuito da FROMMEL, 1994**, con convincenti argomenti, a Cristoforo Solari.
123MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
si è visto, tanto successo avevano riscosso in terra lombarda, specialmente negli anni di governo di Ludovico il Moro e oltre. Diventa così possibile formulare alcune considerazioni sul significato storico di questa presenza di modelli architettonici e tecniche decorative.
Riguardo alla fondazione del complesso, il ruolo svolto dal Gromo nell’ambito delle scelte artistiche appare decisamente ridimensionato rispetto a quanto finora ipotizzato, mentre si rivela centrale per gli interventi di tipo organizzativo e di supporto: in particolare l’individuazione e l’acquisto dei luoghi dove insediare i Gerolamini, la concessione di rendite che permettessero alla nuova comunità di avere introiti sicuri, la donazione di oggetti preziosi e libri con cui costituire il primo nucleo del patrimonio mobile del nuovo monastero51. Molto più determinante per i modelli architettonici e gli apparati decorativi deve essere stato il ruolo giocato dai monasteri lombardi dell’Ordine, di Castellazzo e Cremona in primis: l’aspetto finale di San Gerolamo è quindi il risultato della decisione di inviare in terra piemontese quelle maestranze, soprattutto a livello direttivo (il magister Christophorus) e di operai specializzati (tali erano gli artefici delle decorazioni graffite) allora operanti in Lombardia. Se rimane verosimile che il Gromo abbia messo al servizio della comunità di religiosi giunta nel Biellese le doti organizzative già dimostrate nel cantiere del Duomo torinese, è probabile che le scelte progettuali siano state discusse, prima di tutto, tra la committenza religiosa e le maestranze incaricate di realizzarle: certo è che queste ultime appaiono totalmente indirizzate verso modelli lombardi e sono piuttosto lontane da quelli documentati nella cattedrale di Torino.
Passando alla questione del modello architettonico, evidentemente il progetto della nuova chiesa è stato elaborato con l’intento di replicare un edificio esistente, al massimo modificando le dimensioni per adeguarlo alle necessità di una comunità che, fin dalle previsioni iniziali, non sarebbe stata numericamente troppo consistente. Nel campo dell’architettura monastica – e non solo –, la fedele ripresa, a livello di progetto, di un edificio esistente ritenuto particolarmente autorevole non è, naturalmente, una novità del San Gerolamo biellese, esistendo anzi una lunga tradizione in questo senso che risaliva fino ai primi secoli dell’arte cristiana52; si può inoltre osservare che il modo di operare ora delineato, con una gestione per così dire “centralizzata” delle scelte progettuali e decorative, sembra quasi anticipare di
51 Come suggeriscono le osservazioni sul ruolo giuridico del Gromo, basate sull’esame comparato della Vita e dei documenti d’archivio superstiti, svolte da BAIETTO, 1981, pp. 69-91.
52 Si potrebbe dire che San Gerolamo sia stato pensato come una “copia architettonica” di San Sigismondo, richiamando qui il concetto compiutamente definito da Richard Krautheimer in rapporto all’architettura paleocristiana e medievale, precisamente per le valenze simboliche e ideologiche legate a questo fenomeno: cfr. KRAUTHEIMER, 1993, pp. 98-150, specialmente pp. 99-124. Per la duplicazione di edifici all’interno degli ordini monastici medievali, come nel caso dei Cistercensi, si veda da ultimo TOSCO, 2003*, p. 35.
124 MARCO AIMONE
alcuni decenni quella pratica, adottata dalla Compagnia di Gesù e nota come “modo nostro”, di impostare la propria produzione edilizia secondo modelli e soluzioni uniformi53. In questo caso, però, la scelta di ispirarsi alle forme del San Sigismondo sottintendeva forse anche degli scopi al di là della semplice pianificazione organizzativa o del desiderio di uniformità per le case dell’Ordine: da una parte, l’intento di replicare in una terra soggetta ai Savoia (ma non troppo lontana dal confine lombardo) un monastero fondato e protetto dagli Sforza difficilmente poteva essere privo di valenze politiche; dall’altra, l’orgoglioso proposito di mostrare il livello artistico raggiunto nel Ducato milanese alla fine del Quattrocento doveva suonare come un’affermazione di potenza e ricchezza54. Per valutare correttamente tale ostentata fedeltà al linguaggio artistico dell’area geografica di provenienza dei monaci, non si deve dimenticare che quello biellese era il primo convento che i Gerolamini fondavano in territorio sabaudo, e che, all’inizio dei lavori (1512), le fortune degli Sforza non erano ancora definitivamente tramontate. La forte determinazione nel dare al convento di Biella un aspetto il più possibile “lombardo” ha fatto sì che il San Gerolamo abbia ripreso dal San Sigismondo tutti quegli elementi, progettuali e ornamentali, che nella chiesa cremonese erano stati elaborati o aggiunti nel corso del tempo, come risultato di influssi successivi e in seguito ad aggiornamenti del progetto di partenza55: in San Gerolamo, invece, essi sono stati adottati contemporaneamente, essendo sentiti come parti organiche del modello56. In più, però, per l’edificio biellese non è sembrato sufficiente adottare una versione ridotta della grande chiesa cremonese, ma si è voluto sottoporla ad una sorta di ulteriore revisione, in modo da adeguarne l’aspetto – specialmente in
53 Sul “modo nostro” dei Gesuiti, si vedano i contributi generali di BÖSEL, 1992, pp. 13-26, e di PALMERIO, 1992, pp. 109-114.
54 Anche in occasione dei lavori realizzati alla fine del Cinquecento nel monastero dei Santi Pietro e Paolo di Ospedaletto Lodigiano, oggi in parte scomparso, si era deciso di ispirarsi alle strutture e alle decorazioni del San Sigismondo. Il caso del monastero di Ospedaletto è parzialmente diverso da quello di San Gerolamo, in quanto Lodi faceva parte del Ducato di Milano, ma è comunque significativo perché i documenti relativi a tali lavori attestano quanto il complesso cremonese fosse allora ammirato per la bellezza degli edifici e il prestigio dei fondatori: cfr. FOGLIA, 1998, p. 36.
55 La scelta di imitare strettamente il modello architettonico offerto dal San Sigismondo fu sicuramente meditata: lo prova, fra l’altro, il fatto che nel San Gerolamo fu fedelmente replicato l’impianto modulare di tradizione medievale; ciò è significativo soprattutto facendo il confronto con la pianta modulare dell’altra importante chiesa biellese di inizio Cinquecento, il San Sebastiano, più “moderna” dato che nel suo progetto planimetrico era stato impiegato anche il rettangolo, seguendo una più aggiornata soluzione sperimentata nei cantieri di Bramante: cfr. TOSCO, 2003**, pp. 17-26, in particolare p. 20 e fig. a p. 22.
56 SCIOLLA, 1980, pp. 120 e 168 nota 69, ha creduto di individuare negli edifici del monastero di San Gerolamo influssi delle architetture ferraresi di Biagio Rossetti. In realtà, tali influenze non sono derivate da contatti diretti tra il Biellese e gli altri centri padani, bensì tramite il modello di San Sigismondo.
125MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
facciata – alle più recenti soluzioni formali di ambito bramantesco57. In definitiva, l’architettura della chiesa di San Gerolamo è risultata del tutto estranea agli altri edifici religiosi del Biellese di quei decenni, anche rispetto all’altra grande chiesa rinascimentale edificata nel territorio pochi anni prima, il già ricordato San Sebastiano, pure profondamente intriso di richiami lombardi e bramanteschi58.
Da ultimo, le decorazioni a graffito del San Gerolamo sono di qualità indubbiamente alta, pur rientrando all’interno di una pratica di cantiere ormai consolidata, come emerge dal confronto con gli esempi ricordati. Gli eleganti, seppur ripetitivi graffiti che campiscono le superfici inferiori della facciata tradiscono una lunga esperienza e forse per questa ragione si traducono essenzialmente in un puro gioco di linee, mentre ancora nei monumenti lombardi questo intreccio geometrico si univa in maniera più organica alle membrature architettoniche, oppure formava la cornice per inserti figurativi che costituivano l’elemento principale dell’insieme. Probabilmente, si è di fronte agli ultimi esiti espressivi di questa tecnica decorativa: la data iscritta nella tabula ansata che campeggia alta sulla facciata, 5 giugno 1516, indica la fine dei lavori di decorazione, mentre i confronti lombardi risalgono tutti all’ultimo decennio del Quattrocento o al massimo al primo decennio del Cinquecento; questo scarto temporale è la prova che l’opera delle maestranze inviate a decorare la nuova fondazione gerolamina continuava ad essere richiesta, ma che la loro tecnica decorativa aveva avuto il suo momento di apice al tempo di Ludovico il Moro. In conseguenza della crisi che aveva investito la Lombardia occupata dalle milizie francesi (1499), tali maestranze devono aver continuato ad operare secondo i modi elaborati nei decenni precedenti, ma senza ulteriori sviluppi, al servizio delle superstiti committenze laiche o religiose (e l’Ordine dell’Osservanza di Lombardia poteva essere un ottimo mecenate), spostandosi là dove la loro opera fosse richiesta.
In conclusione, l’insieme dei dati raccolti arricchisce non poco il quadro dell’arte rinascimentale biellese e, in particolare, permette di comprendere meglio un monumento complesso come la chiesa di San Gerolamo. Si apprezza ora, in modo più compiuto, il significato storico dell’edificio, come testimonianza diretta della presenza di maestranze lombarde nel Biellese durante il secondo decennio del Cinquecento, e della loro attività in uno dei cantieri rinascimentali più
57 Non sembra casuale che sia stata principalmente la facciata del San Sigismondo ad essere sottoposta ad una revisione: infatti, essa dovrebbe essere una delle parti più antiche della chiesa cremonese, come appare evidente tanto dai contrafforti, di sapore gotico, quanto dai pinnacoli alla sommità dei timpani, alti e slanciati; non per nulla FERRARI, 1974*, p. 35, ha ipotizzato che nella facciata fosse stato fedelmente seguito il progetto originario, forse del Gadio.
58 NATALE, 2003, pp. 25-26. Sugli aspetti architettonici e artistici della chiesa di San Sebastiano, cfr. anche DE BERNARDI FERRERO, 1966, pp. 511-516, in particolare 512-515; TOSCO, 2003**, pp. 17-26.
126 MARCO AIMONE
importanti del territorio; inoltre, si aprono nuove prospettive sia sulla fortuna e la sopravvivenza di tecniche decorative e modelli architettonici giunti ad alti livelli negli ultimi decenni del XV secolo in area ducale, sia sull’alta qualità formale delle realizzazioni portate a termine dalle maestranze specializzate lombarde anche dopo la chiusura dei maggiori cantieri sforzeschi; infine, bisogna osservare che la scoperta delle decorazioni sul prospetto di San Gerolamo restituisce un elemento essenziale della sua struttura originaria, offrendo la rara visione di una facciata del primo Rinascimento piemontese. Ma soprattutto, ed è forse il dato di maggiore portata, il caso qui esaminato permette di riconfermare la centralità degli Ordini religiosi “emergenti”, tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, nella diffusione in Piemonte del linguaggio artistico rinascimentale: se è già stato messo in luce il contributo dei Canonici Regolari Lateranensi, con gli interventi patrocinati a Novara (allora parte del Ducato milanese), Vercelli, Biella e Alessandria, un parallelo ruolo va attribuito anche ai Gerolamini, di portata certo più limitata, ma sicuramente di profondo significato per la qualità di un’opera quale appunto il San Gerolamo biellese59.
(Comunicazione effettuata il 19 giugno 2007)
59 Sul ruolo nella diffusione del linguaggio architettonico lombardo in Piemonte avuto dai Canonici Regolari Lateranensi, cfr. ad esempio CARITÀ,1990, pp. 218-228. Anche nel caso dell’altra grande fondazione biellese di primo Cinquecento, il San Sebastiano, la cui costruzione era stata patrocinata, si è sempre scritto, da un personaggio di primo piano quale Sebastiano Ferrero, i più recenti studi (LEBOLE, 2004, pp. 237-249) hanno attribuito il peso maggiore, a livello decisionale, all’Ordine religioso.
127MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
BIBLIOGRAFIA
ACKERMAN, 1954: James S. Ackerman, Architectural Practice in the Italian Renaissance, in «Journal of the Society of Architectural Historians», XIII, 3.
ADORNI, 2002: Bruno Adorni, Un lascito bramantesco all’architettura “lombarda” fra Quattrocento e Cinquecento: l’alzato caratterizzato da decorazioni geometriche, in Bramante milanese. Bramante milanese e l’architettura del Rinascimento lombardo, a cura di Christoph Luitpold Frommel, Luisa Giordano, Richard Schofield, Atti del Seminario di studi, Vicenza 1996, Venezia.
AIMONE, 2002: Marco Aimone, L’originaria facies esterna di San Sebastiano a Biella e altri esempi di pittura murale sul territorio, in Studi e ricerche sul Biellese, «Bollettino DocBi», 2002, Biella.
AIMONE, 2003: Marco Aimone, Riflessi rinascimentali a San Gerolamo, in «Rivista Biellese», anno 7, n. 4.
ALBERICI, 1978: Clelia Alberici, L’incisione Prevedari, in «Rassegna di studi e notizie», VI.
ALESSANDRINI, 1988: Giovanna Alessandrini, Gli intonaci della cascina Pozzobonelli. Prime indagini sui materiali e sulle tecniche di preparazione, in «Arte Lombarda», 86-87.
ASTRUA, ROMANO, 1979: Paola Astrua, Giovanni Romano, Vercelli, in Guida breve al patrimonio artistico piemontese, Torino.
BAIETTO, 1981: Maria Teresa Baietto, Ricerche storico-giuridiche sul monastero di San Gerolamo in Biella, Tesi di Laurea in Storia del Diritto Italiano, rel. prof. Maria Ada Benedetto, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1980/1981.
Biella tra polemica e storia, 1986: Biella tra polemica e storia nel “Ragionamento” di Carlo Antonio Coda (1614-1670), a cura di Mario Coda, Biella.
BORA, 1983: Giulio Bora, La decorazione pittorica: sino al Settecento, in Santa Maria delle Grazie in Milano, Milano.
BÖSEL, 1992: Richard Bösel, Tipologie e tradizioni architettoniche nell’edilizia della Compagnia di Gesù, in L’architettura della Compagnia di Gesù in Italia, XVI-XVIII secolo, a cura di Luciano Patetta, Stefano Della Torre, Atti del Convegno, Milano 1990, Genova.
Bramante milanese, 2002: Bramante milanese. Bramante milanese e l’architettura del Rinascimento lombardo, a cura di Christoph Luitpold Frommel, Luisa Giordano, Richard Schofield, Atti del Seminario di studi, Vicenza 1996, Venezia.
BRUSCHI, 1969: Arnaldo Bruschi, Bramante architetto, Bari.
128 MARCO AIMONE
BRUSCHI, 1983: Arnaldo Bruschi, L’architettura, in Santa Maria delle Grazie in Milano, Milano.
CARITÀ, 1990: Giuseppe Carità, Il cantiere del Duomo nuovo di Torino, in Domenico della Rovere e il Duomo nuovo di Torino. Rinascimento a Roma e in Piemonte, a cura di Giovanni Romano, Torino (Arte in Piemonte, 5).
CATTANEO, 1961: Enrico Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in Storia di Milano, IX, Milano.
CICINELLI, 1998: Aldo Cicinelli, Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza duchi di Milano e la chiesa cremonese di San Sigismondo, in Il coro di San Sigismondo a Cremona, Cinisello Balsamo.
DE BERNARDI FERRERO, 1966: Daria De Bernardi Ferrero, L’architettura piemontese all’inizio del ’500: l’Assunta di San Giorgio Canavese e il San Sebastiano di Biella, in Arte in Europa. Scritti di storia dell’arte in onore di Edoardo Arslan, I, Milano.
ENRIETTI, 1882: Gian Pietro Enrietti, La vita del Beato Giovanni Gromis, in Vite di santi celebri negli stati della reale casa di Savoja e paesi limitrofi compilate per servire d’aggiunta alla prima raccolta delle vite de’ santi del P. Massimi, t. II, Ivrea.
ETTLINGER, 2000: Leopold D. Ettlinger, The emergence of the Italian architect during the fifteenth century, in The architect. Chapters in the history of the profession, edited by Spiro Kostof, Berkeley-Los Angeles-London.
FERRARI, 1971: Maria Luisa Ferrari, Documenti per la storia dell’Abbazia di San Sigismondo in Cremona, in «Annali della Biblioteca statale e Libreria civica di Cremona», XXII, fasc. I.
FERRARI, 1974*: Maria Luisa Ferrari, Il tempio di San Sigismondo a Cremona. Storia e arte, Milano.
FERRARI, 1974**: Maria Luisa Ferrari, Il giornale della fabbrica di S. Sigismondo in Cremona, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», s. III, IV.
FERRI PICCALUGA, 1974: Gabriella Ferri Piccaluga, Rapporti tra decorazione e architettura nel Bramante lombardo, in Studi Bramanteschi, Atti del Congresso Internazionale, Milano-Urbino-Roma 1970, Roma.
FOGLIA, 1998: Andrea Foglia, Dai Vallombrosani ai Gerolamini. Brevi cenni alla storia delle due comunità monastiche tra XII e XVIII secolo, in Il coro di San Sigismondo a Cremona, Cinisello Balsamo.
FROMMEL, 1994*: Christoph Luitpold Frommel, Sulla nascita del disegno architettonico, in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, a cura di Henry Millon, Vittorio Magnano Lampugnani, Catalogo della mostra, Milano.
129MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
FROMMEL, 1994**: Christoph Luitpold Frommel, Cristoforo Solari (?). Progetto per la facciata di S. Maria delle Grazie a Castelnovo Fogliani, in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, a cura di Henry Millon, Vittorio Magnano Lampugnani, Catalogo della mostra, Milano.
GALLIZIA, 1757: Pier Giacinto Gallizia, Atti de’ Santi che fiorirono ne’ dominj della Real Casa di Savoja da un Codice manoscritto, t. VI, Torino.
GENTILE, 1990: Guido Gentile, «Io maestro Meo di Francescho Fiorentino ...». Documenti per il cantiere del Duomo di Torino, in Domenico della Rovere e il Duomo nuovo di Torino. Rinascimento a Roma e in Piemonte, a cura di Giovanni Romano, Torino (Arte in Piemonte, 5).
GHIRALDELLO, 2005: Claudia Ghiraldello, Gli inediti di Casa Masserano, Biella.GIORDANO, 1978: Luisa Giordano, Le ville, in Pavia. Architetture dell’età sforzesca,
Torino. GRASSELLI, 1827: Giuseppe Grasselli, Abecedario biografico de’ pittori, scultori e
architetti cremonesi, Milano.GRASSI, 1978: Liliana Grassi, Gli Sforza e l’architettura del Ducato, in Gli Sforza
a Milano, Milano.GRASSI, 1982: Liliana Grassi, Note sull’architettura del Ducato Sforzesco, in Gli
Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati italiani ed europei (1450-1530), Atti del Convegno internazionale, Milano 1981, Milano.
GRASSI, 1983: Liliana Grassi, Trasmutazione linguistica dell’architettura sforzesca: splendore e presagio al tempo di Ludovico il Moro, in Milano nell’età di Ludovico il Moro, Atti del Convegno internazionale, Milano 1983, Milano.
GRISOLI, 1989: Piera Grisoli, Le carte di due ordini religiosi negli archivi mauriziani: i Gerolamini dell’osservanza e i Canonici lateranensi di Novara, in Archeologia ed arte nel Cusio, Atti del Convegno, Orta San Giulio 1987, Savigliano.
HISCOCK, 2000: Nigel Hiscock, The wise Master Builder. Platonic Geometry in Plans of Medieval Abbeys and Cathedrals, Aldershot-Brookfield.
KRAUTHEIMER, 1993: Richard Krautheimer, Introduzione a un’iconografia dell’architettura sacra medievale, in Richard Krautheimer, Architettura sacra paleocristiana e medievale e altri saggi su Rinascimento e Barocco, Torino.
LEBOLE, 1986: Delmo Lebole, Storia della Chiesa biellese. La Pieve di Biella, III, Biella.
LEBOLE, 2004: Delmo Lebole, Storia della Chiesa biellese. Ordini e congregazioni religiose, II, Gaglianico.
LOI, 1998: Maria Cristina Loi, voce Gadio, Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LI, Roma.
130 MARCO AIMONE
MACIOCE, 1984: Stefania Macioce, Sulle facciate dipinte nell’Italia settentrionale, in Giovanna Rotondi Terminiello, Farida Simonetti, Facciate dipinte. Conservazione e restauro, Atti del Convegno di studi, Genova 1982, Genova.
Le tecniche artistiche, 1973: Le tecniche artistiche, a cura di Corrado Maltese, Milano.
MANCHINU, 1998: Paola Manchinu, Gli esordi biellesi di Defendente Ferrari, in «Rivista Biellese», anno 2, n. 1.
MEZZANOTTE, 1939: Paolo Mezzanotte, I graffiti sforzeschi recentemente scoperti a Santa Maria Nova di Abbiategrasso, in Atti del IV Convegno nazionale di Storia dell’Architettura, Milano 1939, Milano.
MULAZZANI, 1998: Germano Mulazzani, Interventi decorativi, in Santa Maria delle Grazie, Milano.
MULLATERA, 1902: Giovanni Tommaso Mullatera, Le memorie di Biella, ed. critica a cura di Emanuele Sella, Melchiorre Mosca, Biella (prima ed. Biella, 1778).
NATALE, 2003: Vittorio Natale, Committenze e artisti a Biella nella prima metà del secolo, in Arti figurative a Biella e Vercelli. Il Cinquecento, a cura di Vittorio Natale, Candelo.
PALMERIO, 1992: Giancarlo Palmerio, La tematica del «modo nostro» gesuitico e il collegio di Sezze, in L’architettura della Compagnia di Gesù in Italia, XVI-XVIII secolo, a cura di Luciano Patetta, Stefano Della Torre, Atti del Convegno, Milano 1990, Genova.
PATETTA, 1987: Luciano Patetta, L’architettura del Quattrocento a Milano, Milano.
PATETTA, 2001: Luciano Patetta, Bramante architetto a Milano e la sua cerchia, in Bramante e la sua cerchia a Milano 1480-1500, a cura di Luciano Patetta, Catalogo della mostra, Milano.
PONTICELLI RIGHINI, 1988: Sylvia Ponticelli Righini, Nuove indagini sulla cascina Pozzobonelli a Milano, in «Arte Lombarda», 86-87.
PUERARI, 1969: Alfredo Puerari, voce Bocoli, Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani, XI, Roma.
ROCCAVILLA, 1905: Alessandro Roccavilla, L’arte nel Biellese, Biella. ROCCAVILLA, 1924: Alessandro Roccavilla, Il monastero di San Gerolamo e il suo
fondatore, in «La Rivista Biellese», anno IV, nn. 9 e 10.ROMANINI, 1964: Angiola Maria Romanini, L’architettura gotica in Lombardia, I,
Milano. SCIOLLA, 1980: Gianni Carlo Sciolla, Il Biellese dal Medioevo all’Ottocento,
Torino.
131MODELLI E DECORAZIONI DEL SAN GEROLAMO DI BIELLA
TANZI, 1990: Marco Tanzi, Fra Quattrocento e Cinquecento: un crocevia culturale al centro della valle Padana, in Pittura a Cremona dal Romanico al Settecento, a cura di Mina Gregori, Cinisello Balsamo.
TORRIONE, 1950: Pietro Torrione, L’abbazia di San Girolamo di Biella, in «Rivista Biellese», anno IV, nn. 2, 3 e 5.
TOSCO, 2003*: Carlo Tosco, La casa, il castello, la chiesa. Architettura e società nel Medioevo, Torino.
TOSCO, 2003**: Carlo Tosco, San Sebastiano a Biella e il primo Rinascimento in Piemonte, in Nicola M. Tarino 1765-1829. Un architetto tra Illuminismo e Positivismo, Catalogo della mostra, Biella.
VASARI, 1996: Giorgio Vasari, Le tecniche artistiche, Introduzione e commento di Gerald Baldwin Brown, Vicenza.
ZAIST, 1774: Giovanni Battista Zaist, Notizie istoriche de’ pittori, scultori, ed architetti cremonesi, I, Cremona.
Marco Aimone - Modelli e decorazioni del San Gerolamo di Biella
FIG. 1. Defendente Ferrari, Particolare della Veduta della chiesa di S. Gerolamo, 1523. Biella, coro della chiesa di San Gerolamo.
FIG. 2. Biella, chiesa di San Gerolamo: la
facciata.
Marco Aimone - Modelli e decorazioni del San Gerolamo di Biella
FIG. 3. Biella, chiesa di San Gerolamo: particolare del campo centrale della facciata.
FIG. 4. Biella, chiesa di San Gerolamo: particolare del campo laterale destro.
FIG. 5. Biella, chiesa di San Gerolamo: particolare del campo laterale sinistro.
Marco Aimone - Modelli e decorazioni del San Gerolamo di Biella
FIG. 6. Biella, chiesa di San Gerolamo: particolare del campo superiore destro.
FIG. 7. Biella, chiesa di San Gerolamo:
particolare del campo superiore sinistro.
FIG. 8. Piante delle chiese di San Sigismondo a Cremona (a sinistra) e di San Gerolamo a Biella (a destra), nella stessa scala. Disegno Marco Aimone.