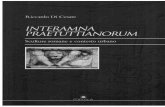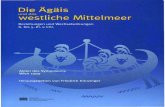A.M. Moretti Sgugubini, L. Ricciardi, Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi, in I....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of A.M. Moretti Sgugubini, L. Ricciardi, Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi, in I....
Chapter 10
Vulci: materiali architettonici di vecchie nuovi scavi
Anna Maria Moretti Sgubini e Laura Ricciardi
Nuovi dati per la conoscenza delle terrecottearchitettoniche di Vulci si sono acquisiti grazie sia allarevisione dei materiali conservati nei depositi, sia arecenti indagini archeologiche effettuate nell’area delParco Ambientale Archeologico (Fig. 10.1).
Per quanto riguarda i primi si presenta anzitutto ungruppo di frammenti ritornati in luce nell’area urbananel corso degli scavi diretti da Renato Bartoccini econdotti da Sergio Paglieri.1
Si tratta di un’antefissa a protome di Gorgone (Fig.10.4), rinvenuta nel 1956, conservata per poco più dellametà e proveniente “dallo sterro dell’humus” incorrispondenza della stipe di Porta Nord.2
L’esemplare, che al momento si pone come la piùantica delle terrecotte architettoniche di Vulci, ha trattifortemente dedalici ed è accostabile agli esemplariromani del Lapis Niger e della Regia;3 esso concorre adocumentare la diffusione in Etruria in quest’epocadelle antefisse a testa di Gorgone già attestate a Murlo,ma secondo uno schema iconografico diverso daquello di Vulci.4 Il tipo, derivato da modelli importatida Corinto e rielaborati in Etruria tra l’età tardoorientalizzante e quella arcaica,5 offre con la suadiffusione spunti di riflessione circa i rapporti chelegarono Vulci a Roma attraverso la Valle del Tevere ei centri dell’interno,6 che acquistano ulteriore visibilitàgrazie anche ad altri elementi quali quelli legati alladiffusione di analoghi tipi di fregi animalistici.7
Analogo soggetto viene riproposto da altri dueframmenti. Di questi il primo8 (Fig. 10.5), anch’essorinvenuto nel 1956 a Porta Nord e solodubitativamente pertinente ad un’antefissa, richiamal’esemplare di Vignanello;9 il secondo10 (Fig. 10.6),sicuramente di antefissa, fu rinvenuto nello stessoanno a Porta Est, ma differisce dai precedenti percaratteri tecnico-stilistici.
A Murlo11 e a Poggio Buco12 fa guardare peraltro unframmento di lastra di rivestimento sempre dai vecchiscavi nell’area della città, decorato alla base da una
guilloche a rilievo e che conserva del fregio figurato legambe di due probabili guerrieri in movimento versodestra13 (Fig. 10.7). Tale “nuova” testimonianza muta itermini del problema relativo al centro elaboratore deirivestimenti fittili del tipo attestato a Murlo e PoggioBuco, ora più convincentemente rapportabile a Vulci.
Trovano inoltre ora attestazione nel nostro centro ifregi animalistici a stampo già noti a Roma, Veio,Tarquinia e Poggio Buco:14 si tratta di due frammentidi sima e di un frammento di lastra o di sima15 (Fig.10.8) che conservano resti di teorie di felini, diascendenza corinzia, uno dei quali con scena di leonein atto di azzannare un quadrupede. Potrebberointerpretarsi come annotazioni paesistiche gli elementi(massi ?) ricorrenti sotto le zampe dei felini. Uno deiframmenti di sima conserva parte di uno robusto torodi base decorato con motivo di losanghe dipinte,elemento che resta isolato nell’ambito degli esemplarinoti se escludiamo la più tarda sima di Praeneste conscena di processione,16 mentre si può istituire uncollegamento più stretto con le sime rampanti delprimo Tempio di S. Omobono,17 con un frammento daPiazza d’Armi di Veio18 e forse con altri frammentidagli scavi Stefani, sempre da Piazza d’Armi e daPortonaccio.19
Altri dati sono relativi alle terrecotte architettonichedi seconda fase. Si presenta anzitutto un’antefissaframmentaria a testa di menade20 (Fig. 10.9a) del tipo6F del Riis attestato a Vulci e a Volsinii ma anchealtrove;21 alla stessa serie potrebbe ricollegarsi un’altraantefissa (Fig. 10.9b), rinvenuta come la prima ingiacitura secondaria nella zona fuori Porta Est22 ove èpossibile ipotizzare la presenza di un complessocultuale ancora da localizzare.
Sempre ad età tardo arcaica è ascrivibile unframmento di antefissa a testa di Sileno23 (Fig. 10.10a)proveniente dagli scavi condotti in questi ultimi anninella c.d. area I, che non trova puntuali confronti, maè forse accostabile al tipo 4G del Riis attestato oltre che
Anna Maria Moretti Sgubini e Laura Ricciardi104
Fig. 10.1. Vulci. Planimetria generale con localizzazione dei rinvenimenti di terrecotte architettoniche.
Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi 105
Fig. 10.2. Vulci, Tempio di Ponte Sodo. Lastra dirivestimento architettonico: restituzione grafica.
Fig. 10.3. Vulci, Tempio di Ponte Sodo. Lastra dirivestimento architettonico: restituzione grafica.
Fig. 10.4. Vulci. Antefissa a protome di Gorgone: veduta diprospetto e di profilo.
Fig. 10.5. Vulci. Elemento architettonico a protome diGorgone.
0 5cm
Fig. 10.6. Vulci. Antefissa a protome di Gorgone.
Fig. 10.7. Vulci. Lastra di rivestimento.
Anna Maria Moretti Sgubini e Laura Ricciardi106
a Vulci, a Tarquinia, Chiusi e Populonia.24 Da PortaOvest proviene parte di una antefissa a testa diMenade25 (Fig. 10.10b) riconducibile al tipo Riis 15 F daSatrico26 che è peraltro attestato anche da un frammentodi volto femminile del tipo pertinente le note antefissecon Satiro e Menade danzanti restituito dall’area I.27 Siricorda che le terrecotte architettoniche della c. d. areaI, documentano, con i numerosi materiali votivi adesse associati, come già anticipato in altra sede28 lapresenza di un santuario da ricercare sulla propagginesud-occidentale dell’acropoli, in un’area dunquediversa da quella ove si localizzano i precedentiritrovamenti dall’acropoli resi noti già dal Bartoccini.29
Al 480 a.C. circa sembrano assegnabili altri dueframmenti di antefisse probabilmente a testa
femminile con base decorata da baccelli dipinti e restidi una ricca veste resa a rilievo che conserva ancorauna vivida policromia30 (Fig. 10.11).
Queste furono rinvenute nel 1969 nelle “Terme”della Domus del Criptoportico31 insieme a frammentidi anthemion con resti di policromia e a vari frammentidi tegole di gronda dipinte con motivi a meandro,angolari, a rete di rombi e vegetali, tutti di secondafase, probabilmente riferibili, come le antefisse, ad unedificio contiguo all’impianto romano.
Altre parti di tegole di gronda sono state rinvenutein più settori della città interessati dagli scavi recenti:tra queste si segnalano in particolare tre frammentidall’area I che, decorati da palmette inscritte in spiraliad S32 (Fig. 10.12), richiamano esemplari da Orvieto.33
Fig. 10.8. Vulci. a-b: sime, c: sima o lastra.
Fig. 10.9. Vulci. Antefisse a testa di menade. Fig. 10.10.* Vulci. Antefisse a testa di satiro (a) e a testa dimenade (b).
a
b
Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi 107
Si segnala anche un cospicuo frammento di tegoladi gronda con motivi angolari tra fasce34 reimpiegatocon altri elementi architettonici in una vasca delladomus imperiale presso l’incrocio fra il cardine e ildecumano della città di età romana. Insieme a taleelemento, in occasione dei recenti lavori, sono staterecuperate35 anche parti di sime e di lastre dirivestimento che per tipo di impasto e decorazionesembrano riconducibili alle terrecotte della prima fasedecorativa del Tempio Grande, edificio cui sembra daporre in rapporto anche un gruppo di terrecotte,sempre frammentarie, costituito da parti di sime e dilastre di rivestimento rinvenute nello scavo del trattooccidentale del decumano insieme a parti di due figurepanneggiate, una delle quali in movimento36 (Fig.10.13).
Tra i materiali di fase più recente resta per oraisolato un frammento di testa femminile diademata37
(Fig. 10.14), di proporzioni maggiori del vero,proveniente dall’area I: i tratti del volto e l’acconciaturadei capelli spartiti al centro e disposti in ciocche
ondulate, sui quali s’imposta un diadema a rosette,documentano la compiuta ricezione di modellifigurativi elaborati nella Grecia di età classica,rinviando ad esperienze note nella scultura38 e nellapiccola plastica.39
Anna Maria Moretti Sgubini
Fig. 10.13. Vulci. Figura panneggiata.
Fig. 10.11.* Vulci. Antefisse a testa femminile.
Fig. 10.12.* Vulci. Tegola di gronda.
Fig. 10.14.* Vulci. Testa femminile diademata.
Anna Maria Moretti Sgubini e Laura Ricciardi108
Ancora dall’area I proviene un gruppo di antefisse. Sitratta di un’esemplare a testa di sileno40 (Fig.10.15a)accostabile al tipo 12 G del Riis (425–325 a.C.) attestatoad Orvieto e a Volsinii,41 mentre al momento senzaconfronti sembrerebbero un’antefissa a testa digiovane satiro dal morbido modellato42 (Fig. 10.15b) edue altre a testa maschile barbata, con mossacapigliatura a ciocche ondulate, entro nimbo a baccelliconcavi43 (Fig. 10.16); per queste ultime, oltre allavivace policromia dell’esemplare più integro, sisegnala la presenza del singolare elemento che ilpersonaggio sembra stringere fra i denti, che ricorda ilc.d fulmine-fiore (di fuoco) nella iconografia nota,attributo di alcune divinità folgoratrici.44
Già presentate in altra sede e provenienti dallastessa area sono inoltre un’antefissa frammentaria atesta di menade, un’altra a testa di sileno di un tipoattestato allo Scasato di Falerii nonché un’altra, ancorapiù tarda, a testa di Minerva entro nimbo decorato dafiori e racemi appartenente al tipo 15 C del Riis.45
Si ricorda che le indagini archeologiche all’area Ihanno restituito anche alcuni frammenti di lastre dirivestimento a stampo ellenistiche con motivianimalistici: uno con fregio di delfini di un tipoattestato a Vulci e in area chiusina , altri due con fregiodi animali in lotta che, accostabile ad esemplari diFalerii, evoca esperienze diffuse in area magnogreca ericorrenti su sarcofagi in pietra nonchè, nella stessaVulci, nel fregio minore della Tomba François.46
Un’antefissa a testa di menade da vecchi scavi (Fig.10.17) è del tipo 9 E del Riis47 (425–325 a.C.), attestatoad Orvieto.
S’arricchisce inoltre di altri quattro esemplariprovenienti da diversi settori della città,48 il tipo diantefissa a testa di menade entro nimbo circolaredefinito da una fascia di ovoli, del tipo 14 C del Riis,(fine IV- inizi III sec. a.C.),49 già noto dagli scaviBendinelli50 e da un esemplare degli scavi Campanarial Vaticano.51 La serie inoltre acquisisce ora lacontroparte maschile, a testa di sileno calvo, grazie aduna terracotta frammentaria rinvenuta tra i materialidei vecchi scavi della città di Vulci, purtroppo priva diulteriori indicazioni52 (Fig. 10.18).
Due piccole teste femminili forse di menade53 (Fig.10.19a-b), potrebbero essere poste in rapporto, ancheper le caratteristiche dell’impasto, con una basedecorata da foglie di acanto54 (Fig. 10.19c) (una diqueste testine e la base provengono dallo stesso settoredi scavo presso il tratto di acquedotto poco fuori PortaOvest), richiamando per impostazione complessivaquel tipo di antefissa con Gorgone su cespo di acantoattestato, con esemplari tardi, a Vulci stessa (Buranelli)e a Roma.55
Tra i vari frammenti, spesso minuti, di lastre dirivestimento architettonico recuperati in vari puntidella città e adiacenze nel corso delle recenti indagini,si segnalano tre lastrine di porta, delle quali solo unapressocchè intera (Fig. 10.20), rinvenute nella zona aldi fuori della Porta Est,56 che si pongono a variantedegli esemplari di III sec. a.C. del tipo A:22 di Pyrgi,attestato anche a Punta della Vipera;57 all’incirca coevoè il tipo di lastra decorato da nastri incrociati e fiori,
Fig. 10.15. Vulci. Antefisse a testa di satiro (a) e a testa digiovane satiro (b).
Fig. 10.16.* Vulci. Antefissa a testa di divinità folgoratrice(?).
Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi 109
restituito da un frammento proveniente dai recentiscavi per la rimessa in luce del tratto occidentale deldecumano, tipo già documentato a Vulci nell’ultimafase decorativa del Tempio Grande, ma noto anche aCosa, Tarquinia, Punta della Vipera, Volterra, ecc.;58
sembra confrontabile con una cornice di Orvieto unframmento, recuperato nel saggio di scavo dietro iltratto di cinta muraria dell’area I, decorato con motivo
di gigli in sequenza peraltro ricorrente nel III sec. a.C.su sime e lastre note a Cosa, Talamone, Arezzo,Perugia e Punta della Vipera, ecc.,59 mentre un tipo dicornice di porta con nastri ad estremità ricurva e bordoad ovoli databile (III–I a.C.) ci è restituito sia dai vecchiscavi nell’area della città sia dalle recenti indaginipresso il mitreo.60
Venendo al territorio, si segnala anzitutto un piccolo
Fig. 10.17. Vulci. Antefissa a testa di menade.
Fig. 10.18. Vulci. Antefissa a testa di sileno calvo.
Fig. 10.19. Vulci. Parti di antefisse con base a cespo diacanto.
Fig. 10.20. Vulci. Lastrina di porta.
Anna Maria Moretti Sgubini e Laura Ricciardi110
gruppo di materiali architettonici rinvenuti nel 1963nell’area della Cuccumella.61 Si tratta di pochiframmenti di cornici traforate e di lastre condecorazione ad anthemion, anche del tipo già attestatosull’acropoli e al santuario di Fontanile di Legnisina.62
Tale acquisizione consente di localizzare in questoimportante settore dei sepolcreti orientali strutture,probabilmente legate al culto funerario, già peraltroindiziate dai dati offerti dagli scavi ottocenteschi e dalritrovamento nel 1989 di un modesto frammento dicornice baccellata nella zona adiacente al grande altarefunerario.63 Non si può escludere che a impianti delgenere, ai quali ricondurrebbero pure i ritrovamentisegnalati da Marcelliani,64 facciano capo anche imateriali architettonici già localizzati nella contiguaarea della Polledrara.65
Infine una vera e propria scoperta è quella relativaad un gruppo di materiali architettonici rinvenuti nel1955 a Ponte Sodo, che vanno ad aggiungersi a quellibrevemente segnalati da Bartoccini ma successiva-mente non più rintracciati,66 pertinenti probabilmentelo stesso tempio nuovamente individuato nel 1986.67
Tra questi materiali,68 riferibili a due distinte fasiedilizie della struttura, una di età tardo arcaica, l’altraellenistica, si segnala anzitutto un frammento diantefissa a testa di menade, databile tra il 500 e il 480a. C., analogo ad un esemplare già noto e per il qualeera stata proposta, solo a livello di ipotesi, laprovenienza dal tempio in questione che risulta ora
pienamente confermata.69 Alla stessa fase sonoriferibili, oltre a parte di un nimbo di antefissa conbaccelli concavi dalla policromia ben conservata, unalastra tripartita che si è potuta ricomporre daframmenti e che risulta interessata, nella fascia pianatra la cornice baccellata e l’anthemion, da una insolitadecorazione pittorica costituita da un fregioanimalistico70 (Fig. 10.2, 10.21). Due animali, di cuiquello a sinistra sembra un felino, sono resiesclusivamente a pittura di colore rosso bruno sufondo crema con dettagli in nero; di difficile letturarisulta l’animale a destra affrontato all’altro e resocome quello in maniera piuttosto schematica. Fasceoblique dipinte sui listelli superiore e inferiore dellafascia piana arricchiscono la policromia che giàinteressa, per quanto in parte evanide, cornice edanthemion. Sono altresì presenti resti di tegole digronda dipinte a rombi neri con più piccoli rombi rossiall’interno, accostabili a quelli rinvenuti nel 1969presso la Domus del Criptoportico, ai quali siaccompagnano parti di lastre, forse parietali, chesembrano conservare tracce di figure dipinte in rossocon linea di contorno in bruno: in particolare su unframmento sembra di riconoscere la parte superioredelle gambe di un personaggio, su un altro è unelemento interpretabile come una freccia o una puntadi lancia71 (Fig. 10.22). Alla fase ellenistica sono invecepertinenti parti di lastre con disegno a serpentina chein un caso (Fig. 10.3) richiama quello presente su lastredello Scasato, datate da Andrén alla fine del III sec.a.C. e del tempio B di Cosa (fase di ristrutturazione,tra la fine del II e gli inizi del I sec. a. C.).72
Laura Ricciardi
Fig. 10.21.* Vulci, Ponte Sodo. Lastra di rivestimentoarchitettonico.
Fig. 10.22. Vulci, Ponte Sodo. Lastre dipinte.
Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi 111
A conclusione di questa pur sintetica rassegna si puòanzitutto osservare come i nuovi dati, oltre ariconfermare come Vulci sia interessata da un’attivitàedilizia particolarmente intensa in età tardo arcaica enel primo ellenismo, offrano documentazione di variluoghi di culto tra i quali si desidera evidenziare quelli,finora sconosciuti, da ricercarsi all’esterno delle PorteOvest ed Est, tornando a sottolineare il concetto disacralità del passaggio.
Acquista d’altra parte ulteriore consistenza lapresenza e la fisionomia di una scuola di cloroplastivulcenti capace di elaborazioni originali e aperta, sindalla prima metà del VI sec. a. C., ai contatti con icentri etruschi più meridionali e con la stessa Roma,come documentano i più antichi rivestimentiarchitettonici che asseverano Vulci quale centroelaboratore di modelli poi ritrasmessi negliinsediamenti del suo territorio e nell’Etruria interna.
Ancora sulla base della documentazione esaminatasembrano delinearsi nell’ambito della produzionedelle officine vulcenti attive in età tardo arcaica duedistinte linee di tendenza forse rapportabili a botteghediverse. Se infatti le maestranze impegnate nelprogramma decorativo della prima fase del TempioGrande appaiono recepire e rielaborare con originalitàsuggestioni loro derivanti dalle coeve esperienzemagnogreche che, diffuse nel Lazio e in Etruriameridionale, raggiungono Vulci seguendo itineraricostieri da tempo collaudati,73 la bottega responsabiledelle terrecotte decorative del tempio di Ponte Sodosembra caratterizzata da un gusto più conservatorecome suggerisce la scelta di soggetti animalistici che,già adottati nei più antichi fregi a stampo, continuanoad incontrare il favore della comunità vulcenterisultando tra i temi più diffusi sia nelle cosiddette artiminori, sia nel repertorio dei ceramografi etruschi dietà tardo arcaica.
Si confermano e si consolidano peraltro i legami giàrilevati con Volsinii e con Satrico, centri ai quali siaffiancano Tarquinia e Falerii, delineando rapporti cherestano evidenti anche in età tardo classica edellenistica, epoca in cui peraltro si registra anche unrinnovato influsso di esperienze magnogreche.
Con il procedere del tempo Vulci sempre piùcompiutamente appare inserita in un orizzonteculturale che, comune anche ad altri centri, è ormairicollegabile al processo di romanizzazionedell’Etruria.
Dott.ssa Anna Maria Moretti SgubiniSoprintendenza archeologica per l’Etruria
meridionale, Roma
Dott.ssa Laura RicciardiSoprintdendenza archeologica per l’Etruria
meridionale, Roma
Notes* Il restauro dei materiali considerati nel presente lavoro è
dovuto alle signore F. L. Bellomarini, M. Scoponi, dellaSoprintendenza, e ai tecnici del Laboratorio di Analisi eRestauro di Montalto di Castro diretti dalla dott.ssa A. M.Tocci della Società Mastarna; la documentazione grafica dicui alle Fig. 10.2–3 è opera della dott.ssa S. Costantini dellaSoprintendenza; la documentazione fotografica è dovutaai signori B. Fioravanti e M. Benedetti dellaSoprintendenza.
1 Per tali interventi si dispone solo di poche notizie offertedai giornali di scavo e delle relazioni preliminari delPaglieri 1959, 102–111 e del Bartoccini 1961, 257–281.
2 N. provv. Vulci, Porta Nord 26.5.1956, n. 1 : antefissa atesta di gorgone. Proviene esattamente “dall’humus al disopra della stipe”. Frammentaria: rimane la parte destradel volto, con la gran parte del naso, e porzione del copporetrostante. Terracotta di colore bruno-rossastro. Alt. cons.12,4; largh. cons. 9,5. Occhio destro, grande e allungato,con palpebre e sopracciglio rilevati e breve parte dell’altroocchio, naso tripartito orizzontalmente con volute per lenarici, parte dell’ampia bocca rilevata, capigliatura di tipodedalico consistente in due spessi boccoli laterali.L’antefissa conserva anche parte del coppo.
3 Per l’esemplare del Lapis Niger v. De Santis 1990, 57, n. 34,con rif., datata al secondo quarto del VI sec. a. C.; perquello della Regia v. Downey 1993, 238–239, fig. 8, con altririferimenti relativi all’antefissa del Lapis Niger (riprodottaa fig. 9); v. anche 238, nota 15 per un altro esemplare che,proveniente dagli scavi del Tempio di Castore e Polluce,dovrebbe appartenere allo stesso tipo; Downey 1995, 32,78, n. 12, fig. 18.
4 Neils 1976, 4–5, fig. 1, tav. 3.2.Per un commento sulla diffusione del Gorgoneion inEtruria in terrecotte architettoniche v. R. Sutton, in PoggioCivitate 1970, 42–44; v. anche L.L. Lacy, in Case e palazzi1985, 114–116.
5 Il motivo ritorna anche ad Acquarossa sugli acroteridecorati ad intaglio: Rystedt 1983, 62–64, 131–134, fig. 34,tavv. 2–3.
6 Sui rapporti che dalla fine dell’VIII sec. a.C. legano Vulci alcomparto falisco e alla bassa valle del Tevere cfr. MorettiSgubini e Ricciardi 2001, cds, con rifer.; Moretti Sgubini2002, cds., con rifer.
7 Cfr. infra.8 N. provv. Vulci, Porta Nord 26.5.1956, n. 2: piccolo
frammento di terracotta con bocca di gorgoneStessa provenienza dell’esemplare precedente. Terracottadi colore bruno-rossastro. Cm. 6,7 × cm. 5. Sul frammento,in bassorilievo, parte delle labbra aperte con mostra dialcuni denti, tra cui due a zanna. La parte posteriore delframmento è piatta.
9 Cfr. Andrén 1939–1940, 150–151, n. 2, tav. 57:186; Rystedt1983, 134, fig. 98, con rif.; per il tipo del Gorgoneion v.anche Cavagnaro Vanoni 2000–2001 [2002], 388–391.
10 N. provv. Vulci, Porta Est 8.11.1956 , n. 1 : parte di antefissaa testa di gorgone. Terracotta di colore rosato. Rimanepoco meno della metà longitudinale destra della protome,con porzione laterale. Alt. cons. 17,2; largh. cons. 8. Voltoschiacciato con grande occhio sporgente con palpebre esopracciglio rilevati, parte dell’ampia bocca dalle labbra afascia leggermente convessa, grande orecchio, porzionelaterale di capigliatura compatta.
11 Sui fregi di Murlo v.: Pairault Massa 1993, 123–134; Rathje
Anna Maria Moretti Sgubini e Laura Ricciardi112
1993, 135–138; von Mehren 1993, 139–145; v. inoltre Torelli1997a, 87–121.
12 Da ultimo v.: Pellegrini 1999, 88–91, con altri rif.13 N. provv. Vulci, Deposito, n. 3: frammento di lastra con
teoria di guerrieri (?) a stampo. Terracotta dura di colorerosso scuro-marrone con anima grigia. Pittura perduta:restano solo tratti di patina gialla sull’asta. Alt. cons. cm.12,3; largh. cons. cm. 9,3; spessore cm. 2 ca.Sulla fascia piana rimangono tre gambe nude di duepersonaggi maschili gradienti a destra tra le quali siinterpone un’asta bipartita in senso longitudinale perbuona parte della sua lunghezza. L’anatomia delle gambeè ben delineata. Alla base cornice a guilloche in rilievo.
14 Su tali attestazioni da ultimo vedi ten Kortenaar 2001a, 33–34; per l’attestazione di Tarquinia: Cataldi 1993, 212, n. 28,fig. 15.
15 1) N. provv. Vulci, Deposito, n. 1 : angolo laterale inferioresinistro di sima a stampo con felini. Terracotta friabile dicolore giallastro con anima arancio chiaro. Decorazione arilievo e a pittura. Alt. cons. cm. 11 ca.; largh. cons. cm.14,7; spessore cm. 3,5 (spessore toro cm. 6). Il frammentoconserva tratto del toro di base decorato, ancheinferiormente, a pittura con motivi angolari di colore rossoe nero su fondo bianco. Sulla fascia piana rimangono, al disopra di un breve listello, due zampe feline in rilievo, lapiù avanzata delle quali poggia su un piccolo masso. Fondodi colore nero, colore celeste sul listello e sul piccolo masso,colore ocra sulle zampe.2) N. di scavo V02.Acq/2226.1: frammento di lato sinistrodi sima a stampo con felini (dall’area dell’acquedotto al difuori di Porta Ovest). Terracotta di colore arancio chiaro;pittura, solo in parte conservata. Alt. cons. cm. 10,5 ca.;largh. cons. cm. 12 ca.; spessore cm. 3,5 ca. Sul frammento,che sembra con ogni probabilità spettare ad una sima dellostesso tipo del precedente, restano le zampe posteriori diun felino gradiente a destra, con coda sinuosa, su brevelistello di base; una delle zampe poggia su un piccolomasso. All’estrema sinistra sovrapposizione di elementi dinon chiara lettura (sul superiore color rosso). Resti di colorbruno sul fondo, di celeste sul massetto, di bianco e ocrasul corpo dell’animale.3) N. provv. Vulci, Deposito, n. 2: frammento di sima o dilastra con fregio di animali a stampo. Terracotta di colorerossastro-arancio. Decorazione a rilievo e a pittura. Alt.cons. cm. 11 ca.; largh. cons. cm. 9,5 ca.; spessore cm. 3,5 ca.Sulla fascia piana rimangono parte della testa, del collo edel dorso (con larghe ciocche rilevate del pelame), nonchéle due zampe anteriori, di un felino rivolto a destra: lazampa destra poggia su un piccolo masso, la zampa sinistrapoggia sulla zampa di un quadrupede in fuga versosinistra. Fondo di colore nero, corpo del felino di colorebruno velato (?) di celeste con ciocche nere; colore biancosull’occhio del felino e in piccoli punti sul corpo dello stesso,nonché sulla zampa del quadrupede; colore rosso per labocca del felino; colore celeste con punti di blu sul piccolomasso.
16 Gatti 1990, 166–168.17 Arata 1990, 128, nn. 35–36.18 ten Kortenaar 2001a, 33–34.19 ten Kortenaar 2001a, 33.20 N. di scavo V.01.AB.8033.9: antefissa a testa femminile.
Terracotta di color crema/arancio; resti di color bruno erossastro. Alt cons. cm. 15; largh. cons. cm. 11,5 ca.Scheggiature al naso e ad un occhio. Rimane parte delvolto, conservato fino alla bocca, con pettinatura spartita
al centro in due bande ondulate e trattenuta da trecce ocordoncini.
21 Riis 1981, 57, tipo 6F; Winter 1978, 42, che data il tipointorno al 500–480 a.C.
22 N. di scavo V.01.AB.8033.8: antefissa a testa femminile.Terracotta di color rosato/nocciola. Alt. cons. cm. 22 ca.;largh. cons. cm. 20 ca. Ampia scheggiatura che interessaanche la fronte, parte degli occhi e del naso; conservato unsolo orecchio. Volto femminile con pettinaturaapparentemente a piccoli riccioli, non visibile se spartita alcentro per via della scheggiatura, orecchio a spirale, conorecchino circolare da cui pendono elementi nastriformi(ove non si tratti dei capelli).Le due antefisse sono tornate in luce nello scavo al di sottodel pavimento di una parte dell’edificio con lungo muroperimetrale probabilmente adibito all’ immagazzinaggiodi prodotti trasportati per via fluviale fino ad età imperialetarda.
23 N. di scavo V.01.I.7764.3: antefissa a testa di silenoTerracotta di color crema-arancio; alt. cons. cm. 14,8 ca.;largh. cons. cm. 19,5. Frammento inferiore conservante labarba, a cordoncini, e tre boccoli di capelli per parte, tuttiinteressati dal color nero, nonché resti di spirali decorativelaterali puntinate in rosso, su una base decorataesclusivamente a pittura da linea a meandro (di colorcrema, su campo rosso in alto e nero in basso).
24 Riis 1981, 56–57.25 N. di scavo. V.01.BN.3469.7: antefissa a testa di menade.
Terracotta di color giallastro; colorazione in brunoconservata su occhi, sopracciglia, capelli, e in rossastro sullacuffia. Alt. cons. cm. 11 ca.; largh. cons. cm. 16,5. Rimanesoltanto la parte superiore della testa, con capigliaturadivisa in due bande compatte e ondulate e grandi occhiaperti.Dall’esterno delle mura a Porta Ovest provengonoframmenti di altre terrecotte architettoniche tra cui siricordano un frammento di lastra a stampo condecorazione floreale, parte di un nimbo di antefissadecorato ad anthemion, nonché due frammenti (uno daun saggio di approfondimento dell’ottobre 2002 a sud delbraccio meridionale del lastricato in fase con la strutturadifensiva triangolare e l’altro da strato a quota superioredel braccio nord del medesimo lastricato) con palmettaappartenenti al tipo 1 delle cornici traforate di Fontanile diLegnisina (Massabò 1988–1989, 130, fig. 33).
26 Riis 1981, 33.27 Il frammento è stato già presentato in sede di convegno a
Perugia: Moretti Sgubini et al. 2000, cds.28 Moretti Sgubini et al. 2000, cds.29 Bartoccini 1961, 19, tav. VIII,230 Le due antefisse sono di un tipo analogo pur differenziando
tra loro nei dettagli. L’impasto è crema-giallino non moltoconsistente, le parti conservate delle figure sono in breverilievo con decorazione dipinta conservata. Ad esse è statoaccostato un piccolo frammento dubitativamentepertinente un’antefissa di tipo similare.1) N. provv. Vulci, “Terme” (12.9.1969), n. 1 : parte inferioredi antefissa a testa presumibilmente femminile. Alt. cons.cm. 10,5 ca. ; largh. cons. cm. 12,8; spessore cons. cm. 5/5,5.Base decorata esclusivamente a pittura con baccelli rossi abordo bianco su fondo nero. In bassorilievo e pittura loscollo della veste che presenta pieghe laterali del panneggiodi colore rosso decorate da bordi bianchi a punti neri,mentre la parte centrale è bianca con bordura costituita dauna fila di punti rossi al di sopra di tre cerchielli disegnati
Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi 113
in nero con tondino centrale campito di rosso.2) N. provv. Vulci, “Terme” (12.9.1969), n. 2: parte inferioredi un’antefissa simile alla precedente.Alt. cons. cm. 10,5 ca.; largh. cons. cm. 10,5 ca.; spessoreconservato cm. 6 ca. Base decorata esclusivamente a pitturacon baccelli bianchi, con cuore alternativamente rosso enero, collegati tra loro da una bordura nera su fondobianco. Scollo della veste in bassorilievo e pittura simileper resa del panneggio e colori all’esemplare precedente;della bordura della parte centrale rimane solo un cerchiellolaterale in nero (di dimensioni maggiori rispetto a quellivisti nel precedente esemplare) con più piccolo cerchio alcentro.3) N. provv. Vulci, “Terme” (12.9.1969), n. 3: piccoloframmento di antefissa. Alt. cons. cm. 3,5; largh. cons. cm.4,5. Si tratta di frammento della base bordata di nero e conparte di un baccello dipinto in rosso su fondo bianco.La decorazione a baccelli contraddistingue la base di inun’antefissa a testa di Gorgone da Orvieto, Campo dellaFiera (cfr. Andrén 1939–1940, 192, I:5, tav. 72:243) e siritrova anche su un esemplare frammentario sempre diantefissa da Capua presentato in questa stessa sede (v.Sampaolo e Grassi, cds.); analoga decorazione ritornaanche su elementi architettonici di recente scavo a Campodella Fiera come nel corso di questo convegno reso notodalla dott.a Stopponi.
31 Per l’area delle “Terme” v. Bartoccini 1961, 17, fig.3.32 Il frammento più grande (N. di scavo V.01.I.7767.3), in
terracotta di colore crema/rosato con pittura di color rossoe bruno, misura cm. 26 × 17 ca.
33 Si veda Andrén 1939–1940, 170–175, I:4, tav. 63:204; 196,I:5, tav. 74: 251. Dello stesso genere sembra anche unesemplare da Tarquinia, Cataldi 1993, 214, n. 39, fig. 30.
34 N. di scavo V.01.G.7: frammento di tegola di gronda.Terracotta di color rosato-nocciola, pittura di color rosso ebruno sulla scialbatura di base. Lungh. cons. cm. 30; largh.cons. cm. 17; spessore cm. 3,8.
35 L’intervento è stato curato dai tecnici del Laboratorio diAnalisi e di Restauro di Montalto di Castro, diretti dalladott.ssa A.M. Tocci.
36 Potrebbe trattarsi di decorazioni frontonali o acroteriali:1) N. di scavo V.01.AA.9064/1.4: parte di una figurapanneggiata in movimento. Impasto crema con resti dicolor rosso/bruno (piuttosto rosso sulla parte sotto ilginocchio spinto in avanti). Si conserva parte inferioreincompleta di una figura. Alt. cons. cm. 39.2) N. di scavo V.01.AA.9064/1.2: frammento probabil-mente di spalla con panneggio, in impasto rosato. Alt. cm.13; largh. cm. 21.
37 N. di scavo V.02.I.US7780 (30.9.2002): testa femminilediademata. Terracotta di colore rossastro. Resti di colorerosso sul diadema. Alt. cons. cm. 22 ca.; largh. cm. 26 ca. Siconserva parte del volto fino a tutto il naso. Diadema arosette circolari con punto centrale e punti intercalari.Capigliatura bipartita da scriminatura centrale in duebande fortemente ondulate e cordonate, sotto le arcatesopracciliari grandi occhi a palpebre rilevate dove sonosegnate ad incisione l’iride e la pupilla.
38 Si ricorda in particolare la c.d. Giunone Curite dal Tempiodi “Minerva” allo Scasato (Colonna 1992, 107–108, tavv.VII–VIII). Lo stesso modello sembra alla base di antefissecome quelle attestate, ad esempio, a Tarquinia (Cataldi2001, 70, fig. 84) e a Punta della Vipera (Stopponi 1979,268, tav. XIII, 2).
39 V. ad es. Haynes 1985, 292–293, nn. 128–129 (= Cristofani
1985, 270, nn. 51–52).40 N. di scavo V.02.L.7461.1 (rinvenuta dietro le mura all’area
I): testa di satiro. Terracotta di colore arancio. Superficieconsumata in alcuni punti. Resti di colore rosso (sulleguance in particolare) e di colore nero sulla barba. Alt.cons. cm. 14; largh. cons. cm. 9. Presenta due bozzetti nellaparte alta della fronte che è leggermente corrugata. Occhiinfossati con palpebre rilevate e pupila e iride segnati adincisione, naso largo, bocca carnosa, baffi e barba a cioccheondulate.
41 Riis 1981, 58.42 N. provv. V.02.I.7444.1: antefissa a testa di giovane satiro.
Terracotta color crema. Scheggiatura di lieve entità al naso.Alt. cons. cm. 11,5; largh. cons. cm. 12. I capelli, bipartiti etrattenuti da un cercine, ricadono in lunghi riccioli ondulatisotto le orecchie; il volto è largo e paffuto, con occhiinfossati, dalle palpebre rilevate sotto arcate sopracciliaririgonfie, e con iridi rilevate volte leggermente verso destra;piccola bocca carnosa ben disegnata.
43 N. provv. V.02.I.7780.A.: antefissa a testa di personaggiomaschile barbato entro nimbo baccellato. Terracotta dicolor nocciola. Lacune al bordo del nimbo. Esteso è il colorerosso sul volto, le labbra sono di un rosso più intenso, labarba di color bruno e rosso intenso, i denti sono bianchi,gli occhi di colore bruno con accenno di pupilla in bianco,l’elemento serrato tra i denti è di color giallo. I baccelli nonmolto convessi del nimbo sono bianchi, con internoalternativamente di color celeste e rosso, contornati di nero;colore celeste alla base dell’antefissa. Alt. cm. 21,3; largh.cm. 22,2. La testa del personaggio è volta leggermente adestra, i capelli sono resi con ciocche distinte e ondulate,gli occhi sono infossati sotto le arcate sopracciliari conpalpebra superiore pesante, il naso è diritto, le labbra,carnose, sono dischiuse e tra i denti è serrato un elementodesinente da ambo i lati con tre terminazioni in cuipotrebbe riconoscersi un fulmine.Un frammento di antefissa dello stesso tipo era statorinvenuto nella stessa area nel 1996: n. di scavo V.96.I.sporadico, parte inferiore conservata fino all’attacco degliocchi. Terracotta di color nocciola, in alcune parti rosato-giallastro. Pochi resti di latte di calce e piccolissima tracciadi colorazione rossa sulle labbra. Tracce di bruciato. Nellaparte posteriore evidente il punto di attacco del coppo.Alt. cons. cm. 12; largh. cm. 16.
44 Cfr. Colonna 1991–1992, 104–105, fig. 46, con riferimenti.45 Moretti Sgubini et al. 2000, cds.46 Moretti Sgubini et al. 2000, cds.47 N. provv. Vulci, Deposito, n.15: antefissa a testa femminile
entro nimbo ad anthemion. Terracotta di colore crema-rosato. Mancante di porzioni del nimbo e della più partedel coppo; scheggiature su fronte, naso e mento, superficieconsumata. Alt. cons. cm. 17.5 ca.; largh. cons. cm. 20 ca.Capigliatura con scriminatura centrale e due bande dicapelli, bipartite, che inquadrano la fronte e scendono inlunghe ciocche ondulate a lato del collo; orecchini a discocon bottone centrale. Le palmette ei i fiori di loto dell’anthemion sono scarsamente leggibili. Cfr. Riis 1981, 57.
48 Uno proveniente dai recenti scavi nell’area del mitreo, unaltro dai vecchi scavi dell’area della città senza ulterioriindicazioni, un altro ancora dallo sterro del decumano, nel1956, presso Porta Est, uno, infine dall’intervento condottonel 1969 nella DCmus del criptoportico:1) N. di scavo V98.J.6016.506 Parte di antefissa a testafemminile dall’area del Mitreo. Terracotta piuttosto duradi colore arancio. Ricomposta da due frammenti. Priva di
Anna Maria Moretti Sgubini e Laura Ricciardi114
resti di colore. Alt. cons. cm. 13 ca.; largh. cons. cm. 9,5. Delnimbo si conserva minima parte con tratto di unacostolatura. Del volto è conservata buona parte del latodestro, con un orecchio, mentre manca dalla guanciasinistra in giù compresa parte della bocca.2) N. provv. Vulci, Deposito, n. 13 : parte di antefissa atesta di menade entro nimbo circolare. Mancano la piùparte del nimbo con il coppo e il collo della menade.Superficie consumata e scheggiature. Non restaurato:incrostazione terrosa. Terracotta di colore crema-rosato.Alt. cons. cm. 17,5 ca. ; largh. cons. cm. 14,5 ca.; profonditàcm. 18,5 ca. Capigliatura con scriminatura centrale e duebande di capelli ondulati che inquadrano la fronte; allasommità della testa i capelli sono invece suddivisi incordoncini trattenuti da una sorta di treccia mentre duelunghe ciocche a serpentina scendono ai lati del collo (nerimane una a sinistra per chi guarda). Con moltaprobabilità presenza di orecchini. Il nimbo, circolare, èinteressato da una scanalatura concentrica delimitata dadue cordoncini; in luogo degli ovoli sono grossi puntirilevati, rapportabili ad una variante del tipo.3) N. provv. Vulci, Porta Est 13.6.1956, n. 1 : frammento diantefissa a testa femminile. Proviene esattamente “dallosterro sopra il selciato”. Terracotta di colore crema-rosato.Superficie consumata. Alt. cons. cm. 8,3; largh. cons. cm.10,5; prof. cons. cm. 8,5 ca. Rimane soltanto la partesommitale della capigliatura, divisa in due bande ondulate,con tratto di porzione superiore del nimbo.4) N. provv. Vulci, “Terme” (12.6.1969), n. 5: parte diantefissa a testa femminile. Terracotta di colore crema-rosato. Superficie consumata e scheggiata. Non restaurato:incrostazione terrosa. Alt. cons. cm. 12 ca.; largh. cons. cm.10,5/11. Rimane la testa femminile, mancante allasommità, con l’attacco del nimbo e brevissima parte delcoppo.
49 Riis 1981, 58.50 Bendinelli 1921, 355–356, fig. 7.51 Buranelli 1991, 206, n. 24.52 N. provv. Vulci, deposito, n. 12 : parte di antefissa a testa
di sileno calvo entro nimbo circolare.Terracotta di colore arancio. Alt. cons. cm. 15 ca.; largh.cons. cm. 18. Rimane la parte superiore della testa delsileno, con un occhio e la sommità di un orecchio, nonchèporzione del nimbo con nervatura concentrica e bordo adovoli.
53 Si conserva in ambedue i casi soltanto il volto, scheggiatoal mento, incorniciato dalla capigliatura spartita in duebande a ciocche mosse, gli occhi sono infossati, il naso unpo’ grosso; terracotta di color rosato tendente al grigio-nocciola. L’esemplare meglio conservato provienedall’indagine di scavo nello spazio retrostante le muraall’Area I: n. di scavo V.01.L.7448.1; sono segnate le iridi;alt. cons. cm. 10; largh. cons. cm. 7,5. L’altro esemplare (n.di scavo V.02.ACQ.2298.1, dalla superficie consumata, èstato restituito dallo scavo presso il tratto dell’acquedottoal di fuori di Porta Ovest; alt. cons. cm.9; largh. cons. cm.7,5ca.
54 N. di scavo V.02.ACQ.2239.4. Parte inferiore di antefissa.Ricomponibile da due frammenti, in terracotta di colorrosato-grigio. Al di sopra di un breve listello è un cespo diacanto con due foglie per parte inquadranti il collo di unafigura tra ciocche ondulate di capelli; alt. cons. cm. 14 ca.;largh. cons. cm. 32,5.
55 V. Buranelli 1991, 210–211, commento al n. 28, conriferimenti anche a Roma.
Per quanto riferibili ad edifici della città ormaicompletamente romanizzata si ricordano un’antefissalacunosa con menade e pantera (n. di scavo V.01.AA.9064.50), di matrice analoga a quella di un gruppo di esemplarid’ispirazione neoattica conservati nel Museo NazionaleRomano (Pensabene e Sanzi Di Mino 1983, 130–132) e unnucleo di frammenti di lastre Campana di variaprovenienza.
56 Provengono tutte dallo scavo di un impianto che, sorto inetà imperiale romana presso un ramo morto della strada inuscita da Porta Est, si serviva dell’acqua incanalata, tradue argini di pietre basaltiche, dal vicino fiume Fiora edera provvisto di una vasca intonacata, forse adibita adallevamento pesci, nonché di strutture annesse in parteanch’esse realizzate con massi di basalto : la lastrina (n. discavo V.02.AB.US 8136, intera salvo che per un angoloricomponibile con lacuna; alt. cm. 25,5; largh. cm. 25) erastata riutilizzata come parete di una piccola vasca; essa èinteressata da sette fori passanti su tre file, l’impasto èrossastro, crema in superficie, la cornice è a fascia piana, adifferenza degli esemplari di Pyrgi (Rallo 1970, 228–231,tipo A:22) e di Punta della Vipera (Stopponi 1979, 256–257,fig. 4, tav. VI,29) che presentano una cornice a baccelliconcavi. Parti di cornici in terracotta arancio di un tipodiverso dalle precedenti, decorate con spirali ad esse epiccoli motivi vegetali, erano state reimpiegate invece perla costruzione di una condotta in terracotta (n. di scavoV.02.AB.US 8135).Ci troviamo in un punto diverso ma non troppo distantidal luogo di rinvenimento delle due antefisse sopramenzionate di epoca più antica (v. note 20 e 22)
57 Vedi supra.58 Cfr. Stopponi 1979, 263, fig. 6,2 e tav. X, 1–2, con riferimenti
ad altre località; Moretti Sgubini 1997, 164. V. anche Cataldi1985, 74–75, 4.4.A.8–4.4.A.9 (Tarquinia, Ara della Regina).Il nostro frammento (n. di scavo V.01.AA.9001.21) conservaun fiore ad ampia corolla, un braccio del nastro incrociato,la punta dei petali di una rosa, nonché tratto del listellocon minime parti della decorazione sovrastante; terracottadi color crema-rosato, tendente al nocciola, con superficiecrema; tracce di color bianco; cm. 16 × cm. 14 ca.
59 Per la frequenza del motivo decorativo di gigli in sequenzain Etruria nel III sec. a. C. v. Stopponi 1979, 261–263 e nota103; v. anche Zamarchi Grassi su Castiglion Fiorentini inquesti Atti, infra. Per Cosa v. Strazzulla 1985b, 99, fig. 99,con rif. Il nostro frammento (n. di scavo V.02.I.mura/7453.2; terracotta arancio, resti di color bianco sui motivivegetali e di color bruno sullo sfondo; un lato delframmento è finito), nonostante le ridotte dimensioni (cm.13 × cm. 8), sembrerebbe piuttosto confrontabile conl’esemplare ad Orvieto (cfr. Andrén 1939–1940, 181–182,II:39, tav. 69:227).
60 Il frammento dal mitreo (n. di scavo. V.01.J.6144 /215), interracotta rossastro-nocciola dura, è di ridotte dimensioni(cm. 9,8 × cm. 7,5). Dai vecchi scavi nell’area di Vulciproviene una porzione di cornice di porta a stampo dimaggiori dimensioni (n. provv. Vulci, deposito, n. 4),ricomposta da tre frammenti con qualche scheggiatura euna zona a superficie consumata. Terracotta dura di colorerosso-arancio. Cm. 14,5 × cm. 12,4; spessore cm. 2 ca.Decorata da nastri desinenti in volute e da altro elementoillegibile, con bordo a listello interessato da decorazione aovoli.Richiamano un tipo di cornice di porta documentato aCivita Castellana, cfr. Andrén 1939–1940, 119–120, III.3,
Vulci: materiali architettonici di vecchi e nuovi scavi 115
tav. 45:146.61 I frammenti di terrecotte architettoniche sono 19, dei quali
cinque (nn. 12, 13, 14, 15 e 22) pertinenti cornici traforate,quattro frammenti (nn. 5, 6, 9, 10 e dubitativamente unquinto, n. 8, con parte di una palmetta, a petali rettilinei,sagomata al bordo) appartengono a lastre tripartite deltipo 1 o del tipo 2 di Legnisina (cfr. Massabò 1988–1989,124–128, figg. 27–29; per il tipo 1 v. anche Costantini 2001b,185–186, III.A.5.2), alle quali potrebbero spettare anche dueframmenti di cornice a baccelli concavi (nn. 18–19). Si rilevache nei depositi di Vulci, proveniente dai vecchi scavi nellacittà, si conserva parte di una lastra assegnabile al tipo 1delle lastre della Legnisina che, come noto, coincide con iltipo degli esemplari rinvenuti a suo tempo dal Bartoccini(1961, 273) sull’acropoli. Un terzo frammento di cornice abaccelli più piatti (n. 16) ricorda invece la cornice dellelastre di tipo 3 di Legnisina (Massabò 1988–1989, 128–129,figg. 30–31). Quattro frammenti (nn. 1–4, il primoricomposto da due frammenti), in impasto crema, per lopiù con parte interna arancio, sembrano riferibili ad ununico tipo di lastra a stampo, decorata ad anthemion conviticci a spirale e punti rilevati nel campo, alle volte riunitiin gruppi di tre. Si aggiungono altri due frammenti dilastre con decorazione ad anthemion, in impasto arancio asuperficie crema (nn. 7 e 11).
62 Vedi supra.63 Sgubini Moretti 1994, 37, nota 141.64 Cfr. supra.65 Le indagini di scavo condotte nel 1986 nell’ “area sacra
della Polledrara” non portarono in luce alcuna traccia distrutture riferibili ad un tempio (Massabò 1988, 40, conbibl. precedente).
66 Bartoccini 1961, 261. Si deve rilevare peraltro che iframmenti ora rintracciati vennero recuperati dal Prof.Lotti a Ponte Sodo l’ 1.10.1955 come indicato sul cartellinod’accompagno.
67 Nel 1986 venne riportato in luce un tratto del muroorientale del podio di un tempio che non fu comunque concertezza identificato con le strutture di cui parlavaBartoccini; nel corso dello scavo si rinvenne solo unframmento di terracotta architettonica (Massabò 1988, 40,figg. 20–21).
68 In tutto trattasi di 27 terrecotte architettoniche per lo piùin stato estremamente frammentario. L’antefissa (PS 1), di
cui rimane parte superiore della testa con un occhio el’attacco del naso, è conservata per un’altezza di cm. 10,5e una larghezza di cm. 8, con uno spessore residuo di cm.8; la pasta è rosata con parti di colore grigio, tracce dicolore rosso. Il frammento di nimbo (PS 2), in impastocrema, presenta baccelli concavi bianchi profilati in nero econ cuore alternativamente nero e rosso; alt. cons. cm. 10,4e largh. cons. cm. 10,9.
69 Moretti Sgubini 1997, 162, fig. 19.70 La lastra (n. provv. Vulci.PS 3), ricomposta da frammenti
con lacune, misura cm. 45 × cm. 45 e presenta uno spessoredi cm. 2,5 (spessore massimo cm. 3,5). Terracotta di colorecrema tendente all’arancio. La lastra è interessata da settefori passanti; in origine i fori dovevano essere sicuramenteotto se non nove. Strisce longitudinali, alternativamentenere e rosse, interessano la parte centrale dei baccelli dellacornice, che presentano la sommità di colore nero; sui listellisono fasce oblique rosse e nere; contrasto dei colori rosso enero anche per la decorazione dell’anthemion (decorazionein nero su fondo rosso per la parte superiore, in rosso consu fondo nero dove sono le palmette, in nero su fondorosso dove si trovano i bocci di loto); bordo inferiore dellalastra di colore rosso.
71 Trattasi di otto frammenti di cui due ricomposti (PS 15 –22: rispettivamente di cm. 28,4 × cm. 17,5 – quello decoratocon parte di una gamba umana – ; cm. 8,9 × cm. 19,8 – purepresentante parte di un possibile arto umano –; cm. 14 ×cm. 8,5; cm. 7,5 × cm. 13; cm. 13,5 × cm. 19,5; cm. 15,4 × cm.16; cm. 14,5 × cm. 19 ca.; cm. 7,3 × cm. 7,8) accomunabiliper caratteristiche dell’impasto, di colore nocciola-rosato agrana sottile, e spessore (da cm. 3 a cm. 3,5).Si ricorda che un gruppo di lastre veienti dipinte dagliscavi Stefani a Villa Giulia, datate al secondo quarto del Vsec. a. C., sono state riferite al rivestimento parietale internodel tempio con decorazione a fregio continuo (Fortunati1985, 107, E.1, con commento).
72 Cfr. Andrén 1939–1940, 140–141, III:9, fig. 27, tav. 53:171;Richardson 1993, 165–166, tav. 119. Il nostro frammento(PS 8), ricomposto con lacune, è realizzato in una pastacrema tendente al rosato. Alt. cons. cm. 25, largh. cons. cm.20. Ad esso è ricollegabile un ulteriore più piccoloframmento (PS 9), dello stesso impasto (cm. 12 × 10), conpalmetta.
73 Moretti Sgubini 1997, 154, 161, con rifer.