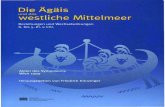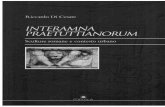Analisi tipologiche e mineralogico-petrografiche sui conglomerati architettonici delle capanne...
Transcript of Analisi tipologiche e mineralogico-petrografiche sui conglomerati architettonici delle capanne...
ISTITUTOITALIANO DI PREISTORIA
E PROTOSTORIA
ATTI DELLA XLIRIUNIONE SCIENTIFICA
DAI CICLOPI AGLI ECISTISOCIETÀ E TERRITORIO
NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA
San Cipirello (PA), 16-19 novembre 2006
FIRENZE 2012
ENTI PROMOTORI
Istituto Italiano di Preistoria e ProtostoriaAssessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e P.I.Comune di San CipirelloUnione de Comuni Monreale JetasCentro Siciliano di Preistoria e Protostoria Archeoclub di Corleone
COMITATO D’ONORE
A. Buttitta, N. Bonacasa, E. De Miro, S. Lagona, V. La Rosa, G. Rizza, E. Tortorici,M. Tosi, V. Tusa, G. Voza
CON IL SOSTEGNO DI
Soprintendenza BB CC AA AgrigentoSoprintendenza BB CC AA CaltanissettaSoprintendenza BB CC AA CataniaSoprintendenza BB CC AA EnnaSoprintendenza BB CC AA MessinaSoprintendenza BB CC AA PalermoSoprintendenza BB CC AA RagusaSoprintendenza BB CC AA SiracusaSoprintendenza BB CC AA TrapaniSoprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”Museo Archeologico Regionale, AgrigentoMuseo Archeologico Regionale “A. Salinas”, PalermoMuseo Archeologico Regionale “P. Orsi”, SiracusaMuseo “Agostino Pepoli”, TrapaniMuseo Archeologico Regionale della Villa del Casale di Piazza ArmerinaMuseo Archeologico Regionale di CamarinaMuseo Archeologico Regionale di GelaMuseo Archeologico Regionale Eoliano “L. Bernabò Brea”Museo della Ceramica di CaltagironeMuseo di storia naturale e del carretto di Palazzo d’Aumale, TerrasiniParco Archeologico Regionale di Agrigento
COMITATO SCIENTIFICO
Paleolitico e Mesolitico: M.R. Iovino, F. MartiniNeolitico: V. Tinè, S. Tusa Eneolitico: A. Cazzella, D. Cocchi Genik, L. Maniscalco Età del Bronzo: N. Bruno, M. Cavalier, M.C. Martinelli, F. Nicoletti, E. Procelli, S. Tusa Età del Ferro: R.M. Albanese ProcelliInterazioni Sicilia - Mediterraneo: A.M. Bietti Sestieri, M. Marazzi Coordinamento: S. Tusa
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C. Buccellato, A. Scuderi, A. Vintaloro, E. Viola
REDAZIONE DEGLI ATTI
Enrico Procelli
In copertina: Vaso della cultura di Serrafarlicchio
© Istituo Italiano di Preistoria e Protostoria, 2012Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenzetel. 055/2340765 - fax 055/5354821www.iipp.it - e-mail: [email protected]
FABRIZIO NICOLETTI* - GIORGIO TROJSI* -
SEBASTIANO TUSA*
Analisi tipologiche e mineralogico-petrografichesui conglomerati architettonici delle capanne
dell’età del Bronzo di Mursia (Pantelleria)
Tra le novità più rilevanti dei recenti scavi nell’abitato dell’età delBronzo di Mursia (Ardesia et alii 2006) vi è stata la scoperta di conglome-rati architettonici all’interno di gran parte delle capanne. Essi venivanousati sia per l’apprestamento di manufatti immobili di uso specifico (ingenere piastre focolare e podi), sia come rivestimento delle strutture ca-pannicole (battuti pavimentali, intonaci, falde impermeabilizzanti dellecoperture), sia, infine, per colmare i giunti di alcuni manufatti lapidei.
Quasi tutti gli ambienti indagati, siano essi edifici curvilinei o rettilinei,contenevano una o più piastre focolari al loro interno, spesso associate adalari e strutture di combustione di altro genere. Nella fase arcaica del sitosono testimoniati focolari di svariati tipi: distese di conglomerato argillo-so su un vespaio di ciottoli, focolari quadrangolari ricavati nel battuto pa-vimentale mediante una scanalatura (fig. 2.5), potsherds pavements.
Nelle fasi successive i focolari si uniformano al tipo a piastra circolaredi argilla concotta, vero marker dell’insediamento, che si rinviene anchein aree all’aperto (fig. 1.1). Questo manufatto, spesso concepito insiemeal battuto, al quale è unito, è una sorta di disco con sezione troncoconica,rialzato sul piano pavimentale fino a 15 cm. La sua superficie esterna èperfettamente lisciata, sia nell’alzata che al piano sommitale, quest’ultimoa profilo appena concavo. Il conglomerato argilloso riveste uno scheletrodi piccole vulcaniti spugnose scarsamente cementate (fig. 1.2). Il diame-tro di questi manufatti è alquanto vario: nell’esemplare minore (capannaD2) è di appena 40 cm (fig. 1.3); il maggiore, entro la capanna D14, rag-giunge 1,45 m di ampiezza e lascia poco spazio per la deambulazione aisuoi lati (fig. 1.4). Gran parte delle piastre, tuttavia, oscilla tra i 60 e i 70 cm di diametro. Le piastre non occupano uno spazio prestabilito, ed anzi
* Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli. E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected].
818 F. NICOLETTI - G. TROJSI - S. TUSA
Fig. 1 - Mursia (Pantelleria), abitato dell’età del Bronzo, strutture architettonichein conglomerato. 1) piastra (area RMO-RNK); 2) scheletro interno diuna piastra (capanna D11, liv. superiore, campione 10); 3) piastra (ca-panna D2); 4) localizzazione della piastra entro una capanna (D14, cam-pione 16); 5) battuto pavimentale (capanna D10, campione 7); 6) lastri-cato sottostante un battuto (capanna D13); 7) battuto con fori (capannaA8); 8) intonaco parietale (capanna D1, campione 12).
ANALISI TIPOLOGICHE E MINERALOGICO-PETROGRAFICHE SUI CONGLOMERATI 819
Fig. 2 - Mursia (Pantelleria), abitato dell’età del Bronzo, strutture architettonichein conglomerato. 1) banchina intonacata (capanna D2, campione 2); 2)intonaco su parascintille di focolare (capanna A9); 3-4) crollo e fram-menti di una falda di copertura (edificio D15-DIII); 5) battuto pavimen-tale in conglomerato bianco (capanna D7); 6-7) vaso litico della capannaD11 contenente i campioni 17 (malta) e 18 (argilla sedimentaria); 8) pa-netto di argilla sedimentaria (capanna D2, campione 1).
820 F. NICOLETTI - G. TROJSI - S. TUSA
compaiono in punti diversi di uno stesso ambiente quando vi sono diversilivelli di frequentazione.
È interessante notare una singolare convergenza formale tra questi ma-nufatti ed i ben noti focolari a podio, in genere più ampi, che si posizio-navano generalmente al centro delle stanze cerimoniali dei palazzi meso-e tardo-elladici.
Il piano pavimentale degli ambienti è spesso realizzato con un conglo-merato di argilla, quasi sempre concotta, sgrassanti ed altre componenti(fig. 1.5). L’impasto veniva steso attraverso straterelli successivi, spessipochi millimetri o al massimo un centimetro che, sommati insieme, porta-vano lo spessore del battuto ad una potenza oscillante tra i cinque e i ven-ti centimetri. Sotto il battuto si trova quasi sempre uno strato di prepara-zione, costituito nei casi migliori da un vespaio di ciottoli fluitati o da unlastricato (fig. 1.6). In altri casi sono testimoniati accumuli di sedimentoinerte o persino i crolli di pietre delle strutture sottostanti. Nelle capannepiù antiche il battuto è stato allettato direttamente sulla roccia, forse do-po averla spianata e comunque dopo averne colmato le fenditure con se-dimento inerte.
Una caratteristica dei battuti di Mursia, non sempre testimoniata, è lapresenza di fori del diametro di 1-2 cm che attraversano lo spessore delconglomerato e che si dispongono, anche a centinaia, in modo caoticosulla superficie pavimentale o solo su porzioni di essa (fig. 1.7). Questibuchi sono certamente artificiali, perché nei casi di battuti sovrappostinon vi è coincidenza fra i superiori e gli inferiori e perché la loro superfi-cie interna appare lisciata ad arte. È probabile che siano stati fatti impri-mendo una pertica nel conglomerato ancora fresco. Dato che gli edificiavevano il piano pavimentale sotto quota rispetto all’esterno, è possibileche i fori servissero a drenare le infiltrazioni meteoriche, i cui ristagni era-no certo favoriti dalle componenti argillose dei battuti. (ST)
La maggior parte degli edifici di Mursia aveva le pareti interne intona-cate (fig. 1.8). Gli intonaci sono formati da conglomerato argilloso, in ge-nere concotto, quasi sempre raccordato mediante angoli curvi, cioè senzasoluzione di continuità, a quello dei battuti. Nei casi meglio conservatil’impasto copre uniformemente la faccia interna dei muri, fino allo spic-cato massimo preservato, e spesso anche gli elementi di arredo architetto-nico interno, quali banchine perimetrali (fig. 2.1) o ciste di combustione(fig. 2.2). Tra l’intonaco vero e proprio, una crosta a superficie lisciata di1-2 centimetri di spessore, e la faccia del muro lapideo si trova uno strate-rello di malta di fango che regolarizza le asperità della superficie e colmagli interstizi tra le pietre.
Non è chiaro in quale misura i conglomerati architettonici venissero
ANALISI TIPOLOGICHE E MINERALOGICO-PETROGRAFICHE SUI CONGLOMERATI 821
applicati alle falde dei tetti. Tra le capanne curvilinee solamente una (ca-panna A9) ha restituito consistenti tracce di una copertura in conglome-rato di argilla concotta, lisciato esternamente e con impronte di puntoniaccoppiati sul lato interno. Nei crolli delle capanne curvilinee, essenzial-mente composti da pietrame analogo a quello dei muri, non si rinvengo-no mai grossi frammenti di argilla concotta, ancor meno con impronte diincannicciata, nemmeno in strutture chiaramente incendiate. Gli edificimodulari a pianta rettilinea hanno invece restituito cospicue tracce di unacopertura basata su un ordito ligneo tamponato con conglomerato argil-loso concotto. Uno, in particolare, ha restituito svariate centinaia di pezzidi argilla combusta, anche di notevoli misure. La maggior parte dei fram-menti porta impronte di un ordito ligneo formato da grossi puntoni, pa-ralleli a puntoni di dimensioni minori, questi ultimi allineati in serie (fig.2.4 a destra). Numerosi frammenti riportano invece impronte di correnti(larghi 3-4 cm) disposti anch’essi in parallelo o alternati ad impronte dibacchette, forse una sorta di tavolato di cui non è chiara la disposizionerispetto ai puntoni, soprattutto quelli minori, con i quali tamponava vero-similmente l’ordito (fig. 2.4 a sinistra e al centro). Sia l’interno chel’esterno di questo telaio erano intonacati con lo stesso conglomerato checolmava gli interstizi della trama lignea, come mostrano alcuni frammentiche conservano in sezione entrambe le facce artatamente lisciate (fig. 2.4a destra) e da cui si deduce che almeno in alcuni punti il tetto era non piùspesso di 20 cm.
Fra tutti i conglomerati architettonici a base di argilla rinvenuti a Mur-sia, si conosce un solo caso di impasto crudo, di colore verde chiaro, usa-to come intonaco di una banchina (capanna D2); un altro caso, un picco-lo lembo di intonaco parietale (capanna D9), appare di cottura incerta ocondotta a basse temperature. Tutti gli altri conglomerati sono stati cottia temperature assai elevate, 800-900° C, come risultato dalle analisi di uncampione. Tuttavia, fatta eccezione per quattro edifici, chiaramente di-strutti da un incendio e che forse non per caso sono quelli che hanno re-stituito tracce della copertura, le strutture non offrono evidenze di com-bustioni accidentali, nemmeno di tipo parziale. È lecito pertanto chieder-si se i conglomerati non venissero cotti in modo controllato.
Non vi sono macroscopiche differenze tra gli impasti usati per diversepartizioni strutturali. Nei concotti spettanti alle coperture è evidente unimpasto maggiormente poroso e ricco di vacuoli, derivato da un consi-stente tenore di fibre straminee nella miscela. Gli impasti più compattiappaiono quelli dei battuti, forse perché a struttura lamellare o più sem-plicemente perché compressi dal calpestio. Tutti hanno comunque il me-desimo aspetto, leggero, poroso e friabile al nucleo; liscio ma talora non
822 F. NICOLETTI - G. TROJSI - S. TUSA
privo di asperità in superficie. Il colore è rosso chiaro all’esterno, più scu-ro o anche nero all’interno. Le analisi hanno chiarito che la base di que-sto impasto è la cosiddetta argilla delle favare, un sedimento plastico dicolore rosso, ricco di sgrassanti, eruttato dai soffioni di vapore presentisull’isola e depositatosi per sublimazione. Questa argilla, che avrà largafortuna in epoca tardoantica per la produzione della pantellerian ware(Santoro Bianchi et alii 2003), era usata nell’insediamento di Mursia an-che per il vasellame (Trojsi e Ursini 2006).
Soltanto nei battuti (in un caso anche per rivestire una banchina) ap-pare saltuariamente usato un conglomerato del tutto diverso (fig. 2.5). Lasua tessitura lamellare è simile a quella dei conglomerati rossi solitamenteusati nei pavimenti, sebbene sia di consistenza più dura e fragile. Il coloreè invece bianco per l’alta percentuale di carbonato di calcio mescolato al-l’impasto. Le calciti e tutti i suoi derivati sono notoriamente estranei allanatura geologica dell’isola, che è effusiva (Civetta et alii 1988). Del resto,che per i conglomerati architettonici fossero in uso anche componenti al-logene lo indizia l’unico caso di intonaco crudo, che già ad un esame au-toptico è sembrato a base di argilla sedimentaria.
Nei livelli di frequentazione di diverse capanne sono stati rinvenuti pa-netti o semplici noduli di argilla vergine, cruda, di colore variante fra ilverde chiaro e il bianco (fig. 2.8). Che possa trattarsi di riserve domesti-che di materia prima lo indicherebbe il contenuto di un vaso litico, infis-so nel pavimento della capanna D11 (fig. 2.6-7), formato da strati di argil-la verde depurata alternati a croste argillose a base di carbonato di calcio.Le analisi assimilano queste ultime a malta di calce, mentre confermanola natura sedimentaria delle componenti argillose.
Se non vi sono dubbi sulla provenienza allogena della malta di calce,rimane da confermare quella delle argille sedimentarie, che potrebbe an-che derivare dalla manipolazione di fanghi sedimentari presenti sull’isola,in particolare al Lago di Venere. Tuttavia, almeno uno dei campioni esa-minati conteneva fossili incompatibili con la storia geologica di Pantelle-ria. (FN)
Entrando nel dettaglio delle analisi, i campioni esaminati (tab. I) sonocostituiti da 18 reperti archeologici (intonaci, piastre, battuti e concotti)provenienti dalle capanne D1, D2, D6, D7, D8, D10, D11, D14 e 10 ar-gille geologiche provenienti dai depositi panteschi di Cala Cinque Denti,Campobello e Serraglio.
Le indagini archeometriche dei campioni sono state effettuate median-te diffrazione dei raggi X e analisi in microscopia ottica su sezione sottile,allo scopo di determinarne le caratteristiche mineralogico-petrografiche.
Dal punto di vista geologico l’isola di Pantelleria è costituita esclusiva-
ANALISI TIPOLOGICHE E MINERALOGICO-PETROGRAFICHE SUI CONGLOMERATI 823
mente da vulcaniti di tipo basico e acido. Le vulcaniti basiche si rinven-gono nella parte settentrionale (ad esempio nella zona delle Cuddie, a Ca-la dell’Alca, ecc.) e risultano costituite da modesti spessori e da edifici co-niformi di scorie. Le vulcaniti acide sono costituite perlopiù da sodatra-chiti che si rinvengono in altre zone dell’isola, ad esempio a MontagnaGrande e Monte Gibele (Rittman 1967).
Per quanto riguarda le rocce di origine sedimentaria, ad oggi, sembra-no essere del tutto assenti, o altrimenti presenti a diversi chilometri diprofondità.
Sulla base delle analisi, gli impasti dei campioni archeologici sembre-rebbero essere tutti compatibili con la geologia della zona essendo media-mente composti da feldspati, pirosseni e in minor presenza da quarzo, an-fiboli e ossidi di ferro e da una componente litica con forte attestazione dirocce laviche (con l’eccezione di 5 campioni). Inoltre, in molti reperti, lapresenza dell’enigmatite (o cossirite), minerale particolare (anfibolo) dif-fuso, nel Mediterraneo, quasi unicamente sull’isola di Pantelleria, sem-brerebbe confermare un’origine autoctona di buona parte dei campionidi Mursia.
I concotti rinvenuti nelle capanne D1 e D14, presentano una matricemarrone-rossastra con una porosità medio-alta, composizione mineralogi-ca a base di pirosseni, feldspati, ossidi di ferro e anfiboli e rare tracce diimpronte vegetali. Da notare che il reperto Mursia 8 si contraddistingueper una matrice di colore nero (concotto bruciato), trattandosi di unframmento esposto a temperature molto elevate (accentuata vetrificazio-ne) e per la marcata “bollosità” dell’impasto data dalla liberazione diCO2 da parte della decomposizione dell’argilla (fig. 3.1).
I frammenti di piastra esaminati provengono dalle capanne D6, D7,D11 (fig. 1.2) e si caratterizzano per una matrice mediamente bruno-ros-sastra, una composizione mineralogica a base di feldspati, pirosseni, ossi-di di ferro e in parte olivine e una componente litica rappresentata darocce laviche e in parte quarzose. Da considerare che il frammento Mur-sia 6 si diversifica, nella parte probabilmente esposta (di colore nero), perla temperatura molto alta testimoniata dall’evidente vetrificazione e dallamarcata “bollosità” dell’impasto e per una elevatissima porosità (fig. 3.2).
I battuti campionati in alcune capanne dello scavo (D8, D10, D14)hanno rilevato la presenza di una matrice marrone-rossastra caratterizzatada una scarsa porosità, da una componente mineralogica a base di feld-spati, pirosseni e ossidi di ferro e da una parte litica contraddistinta darocce laviche basiche (fig. 3.3).
Fig. 3 - Mursia (Pantelleria), ingrandimenti fotografici (40x, N+) dei conglome-rati architettonici sottoposti ad analisi: 1) concotto (capanna D14); 2) piastra (capanna D11); 3) battuto (capanna D8); 4) intonaco (capanna D2); 5) argilla sedimentaria (capanna D2); 6) argilla locale da c.da Serra-glio.
Per quanto riguarda gli intonaci, comprendenti i campioni dalle ca-panne D2, D7, D8, essi sono caratterizzati dalla presenza di una matriceargillosa marrone-rossastra, porosità più o meno marcata, una compo-nente mineralogica a base, perlopiù, di feldspati, pirosseni e ossidi di fer-ro e frammenti più o meno abbondanti di rocce laviche e, in parte, quar-zose (fig. 3.4).
L’ultimo gruppo, di natura calcarea, comprende probabili panetti diargilla sedimentaria (dalle capanne D2, D11 e D14) e i campioni Mursia17 e 18 (fig. 2.6-7), il primo simile a malta di calce, il secondo ad argillasedimentaria depurata, rinvenuti stratificati entro il già citato vaso liticodella capanna D11. In questi campioni si evidenzia la presenza diffusa dicarbonati di calcio, in associazione con pirosseni, quarzo, ossidi di ferro efeldspati (in quantità assai limitate) che, come già affermato in preceden-za, a proposito dell’assenza di rocce sedimentarie nell’isola, potrebbero
824 F. NICOLETTI - G. TROJSI - S. TUSA
ANALISI TIPOLOGICHE E MINERALOGICO-PETROGRAFICHE SUI CONGLOMERATI 825
testimoniare la possibilità di un importazione esterna (presumibilmenteSicilia occidentale, Tunisia o Malta), come ben documentato dalla sezionesottile di Mursia 1 (fig. 2.8) in cui sono presenti numerosi fossili foramini-feri planctonici (fig. 3.5). Per quanto riguarda le argille, non derivanti dadepositi sedimentari (marini, lacustri, ecc.), ma dall’alterazione di roccevulcaniche, le analisi hanno evidenziato una sostanziale uniformità e com-patibilità con i reperti archeologici in questione (fig. 3.6), eccezion fattaper l’argilla di Campobello che presenta un corpo troppo pomiceo perpoter essere stato utilizzato. (GT)
Tab. I - Mursia (Pantelleria). Quadro sinottico dei campioni archeologici e geo-logici analizzati.
NUMERO ANALISI PROVENIENZA DESCRIZIONE
Mursia 1 Mrs D2 US 181 c.130 (2002) Argilla sedimentaria
Mursia 2 Mrs D2 US 166 (2002) Intonaco rosso
Mursia 3 Mrs D7 US 237 c.173 (2004) Intonaco
Mursia 4 Mrs D7 US 343 (2004) Piastra
Mursia 5 Mrs D11 US 280 c 706 (2004) Argilla sedimentaria
Mursia 6 Mrs D6 US 180 (2003) Piastra
Mursia 7 Mrs D10 US 249 (2003) Battuto
Mursia 8 Mrs D14 US 363 c.176 (2004) Concotto bruciato
Mursia 9 Mrs D8 US 249 (2003) Battuto
Mursia 10 Mrs D11 US 275 (2004) Piastra
Mursia 11 Mrs D2 US 154 (2002) Intonaco
Mursia 12 Mrs D1 US 44 (2002) Concotto
Mursia 13 Mrs D7 US 233 c.200 (2004) Intonaco
Mursia 14 Mrs D14 US 363 c.163 (2004) Conglomerato calcareo
Mursia 15 Mrs D8 US 234 (2003) Intonaco
Mursia 16 Mrs D14 US 375 c. 201 (2004) Battuto
Mursia 17 Mrs D11 US 325 c. 148 (2004) Calce
Mursia 18 Mrs D11 US 325 c. 149 (2004) Argilla sedimentaria
Srg1 Serraglio1 Argilla
Srg2 Serraglio2 Argilla
Srg3 Serraglio3 Argilla
Srg4 Serraglio4 Argilla
Campobello Campobello Argilla
C5D1 Cala Cinque Denti 1 Argilla
C5D2 Cala Cinque Denti 2 Argilla
C5D3 Cala Cinque Denti 3 Argilla
C5D4 Cala Cinque Denti 4 Argilla
826 F. NICOLETTI - G. TROJSI - S. TUSA
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ARDESIA V., CATTANI M., MARAZZI M., NICOLETTI F., SECONDO M., TUSA S.2006, Gli scavi nell’abitato dell’età del Bronzo di Mursia, Pantelleria (TP). Re-lazione preliminare delle campagne 2001-2005, RSP, 46, pp. 293-367.
CIVETTA L., CORNETTE Y., GILLOT P.Y., ORSI G. 1988, The eruptive history ofPantelleria (Sicily Channel) in the last 50 ka, Bulletin of Volanology, 50, pp.47-57.
RITTMAN A., 1967, Studio geovulcanologico e magmatologico dell’isola di Pantelle-ria, Rivista Mineraria Siciliana, pp. 106-204.
SANTORO BIANCHI S., GUIDUCCI G., TUSA S. 2003, Pantellerian ware. Archeolo-gia subacquea e ceramiche da fuoco a Pantelleria, Palermo.
TROJSI G., URSINI D., Origini preistoriche della pantellerian ware, AttiIIPP XLI,in questo volume.
RIASSUNTO. - ANALISI TIPOLOGICHE E MINERALOGICO-PETROGRAFICHE SUI
CONGLOMERATI ARCHITETTONICI DELLE CAPANNE DELL’ETÀ DEL BRONZO DI MUR-SIA (PANTELLERIA). - Nell’abitato di Mursia sono stati rinvenuti conglomerati ar-chitettonici all’interno di molte capanne, usati sia per l’apprestamento di manu-fatti immobili (in genere focolari), sia come rivestimento delle strutture capanni-cole (intonaci, battuti pavimentali, falde delle coperture). I conglomerati, analiz-zati mediante diffrattometria a raggi X e analisi in microscopia ottica su sezionesottile, appartengono a due categorie, distinguibili soprattutto per il colore, in uncaso bianco, nell’altro rosso. Specifica importanza assume la definizione deicomponenti dei conglomerati di colore bianco, a base di carbonato di calcio, uncomposto assente nell’isola al pari della malta di calce. Il legante dei conglomera-ti è costituito da una singolare argilla vulcanica prodotta dalle favare dell’isola.Tuttavia, all’interno di alcune capanne sono stati rinvenuti panetti di argilla sedi-mentaria, di provenienza allogena.
SUMMARY. - TYPOLOGICAL, MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL ANALYSIS
OF THE ARCHITECTONIC CONGLOMERATES FROM THE MURSIA BRONZE AGE DWEL-LINGS (ISLAND OF PANTELLERIA). - Inside many dwellings of the Bronze age villa-ge at Mursia have been discovered architectonic conglomerates, used to createhearths, pargets, floorings and roofings. The conglomerates, analysed by x-rayrefraction and thin-section optical microscopy, belong to two categories, the firstwhite, the second red in colour. The first one include calcium carbonate, an im-ported compound as well as the quicklime also used in the village. The conglo-merates binder is a local volcanic clay, but inside the dwellings have been disco-vered also sedimentary clods, probably imported.