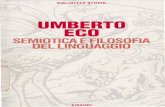Laura Mecella-Umberto Roberto, Isotimia tra Roma e la Persia. Una testimonianza dell’età di...
Transcript of Laura Mecella-Umberto Roberto, Isotimia tra Roma e la Persia. Una testimonianza dell’età di...
PAROLE IN MOVIMENTOLINGUAGGIO POLITICO
E LESSICO STORIOGRAFICO
NEL MONDO ELLENISTICO
atti del convegno internazionale
roma, 21 -23 febbraio 2011
a cura di manuela mari e john thornton
P I S A · R O M A
F A B R I Z I O S E R R A E D I T O R E
M M X I I I
STUDI ELLENISTICI
x x v i i · 2 0 1 3
P I S A · R O M A
F A B R I Z I O S E R R A E D I T O R E
M M X I I I
Rivista annuale · A Yearly Journal
*
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 Pisa,tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, [email protected]
AbbonamentiI prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.netPrint and/or Online official subscription rates are available
at Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard).
*
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 13 del 15 aprile 2005Direttore responsabile: Fabrizio Serra
*
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione,l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso
e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica,il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc.,
senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra editore, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2013 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
www.libraweb.net
*
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 1828-5864isbn 978-88-6227-561-3 (brossura)isbn 978-88-6227-562-0 (rilegato)
SOMMARIO
Manuela Mari, Introduzione : Parole in movimento 9
dynasteiai. dal riemergere della regalità nella grecia del iv sec. a.c. alle percezioni
dell’imperium Romanum
Mario Mazza, « L’atto di nascita dell’Ellenismo » ? Qualche considerazione sulla c.d. Lettera di Aristotele ad Alessandro sulla politica verso le città 29Stefania De Vido, Tuvranno~, strathgo;~ aujtokravtwr, dunavsth~. Le ambi- gue parole del potere nella Sicilia di iv secolo 45Miltiades B. Hatzopoulos, Le vocabulaire de la prise de décision dans les sources littéraires et épigraphiques de la Macédoine antique 61Paolo Desideri, Terminologia imperiale in Polibio 71Andrew Erskine, Expressions of Power in Polybius’ Histories 81Giuseppe Zecchini, ∆Adhvrito~ in Polibio 93Laura Mecella, Umberto Roberto, ∆Isotimiva tra Roma e la Persia : una te- stimonianza dell’età di Severo Alessandro 99
dentro la città, oltre la città. le dinamiche politiche interne alle poleis
Stefano Ferrucci, L’ambigua virtù. Filotimiva nell’Atene degli oratori 123Benjamin D. Gray, The Polis becomes Humane ? Filanqrwpiva as a Cardinal Civic Virtue in later Hellenistic Honorific Epigraphy and Historiography 137Andrea Raggi, Il lessico dei privilegi fiscali nell’Oriente greco tra età ellenistica e romana 163Cinzia Bearzot, Il lessico dell’opposizione politica in Polibio 175Paolo A. Tuci, Il lessico della collaborazione politica in Polibio 185Adolfo La Rocca, Apuleio e gli ejkklhsiastaiv 207
difetti di traduzione. il linguaggio dei rapporti interstatali
e della comunicazione tra poleis e regni ellenistici
Anna Magnetto, Ambasciatori plenipotenziari delle città greche in età classi- ca ed ellenistica : terminologia e prerogative 223Biagio Virgilio, Forme e linguaggi della comunicazione fra re ellenistici e città 243Paola Lombardi, Parole nuove per nuovi equilibri. Su alcuni termini del lessico epigrafico politico di età ellenistica 263Paschalis Paschidis, Fivloi and filiva between Poleis and Kings in the Helle- nistic Period 283
sommario8
Alice Bencivenni, Il giuramento civico di Mileto, il figlio di Tolemeo II e il potere del linguaggio in I. Milet i 3, 139 299Daniela Motta, I soldati nelle città : osservazioni sul lessico epigrafico di età ellenistico-romana 317
lessico, narrazione e (ri)scrittura degli eventi nella storiografia ellenistica: oltre polibio
Angelos Chaniotis, Emotional Language in Hellenistic Decrees and Helleni- stic Histories 339John Thornton, Tragedia e retorica nella polemica sulla presa di Mantinea (Polibio ii, 56-58) 353Leone Porciani, Aspetti della nozione di « comune », « collettivo » e « generale » tra politica, società e storiografia : un profilo di koinov~ 375Guido Schepens, Lo sfruttamento militare e politico della memoria e della storia : a proposito del frammento di Sosilo sulla battaglia dell’Ebro (217 a.C.) 385
conclusioni
John K. Davies, Words, Acts, and Facts 413
Recapiti dei collaboratori del fascicolo 421
ISOTIMIA TRA ROMA E LA PERSIA : UNA TESTIMONIANZA
DELL’ETà DI SEVERO ALESSANDRO*
Laura Mecella · Umberto Roberto
1.
Nulla è più efficace di una guerra, soprattutto se vittoriosa, per rafforzare agli occhi dell’opinione pubblica interna un potere recentemente acquisito
o minato da conflitti intestini.All’intraprendente Ardašır, che attraverso una fulminea campagna militare dal
cuore del Fa ¯rs (la Persia propriamente detta) era arrivato a scalzare gli Arsacidi dal trono di Ctesifonte, dopo l’eliminazione dell’ultimo erede della dinastia partica la necessità di una legittimazione dovette apparire un obiettivo prioritario. Sebbe-ne la scarsità di fonti renda alquanto difficile la ricostruzione della sua ascesa, è possibile delineare almeno sommariamente il percorso che lo condusse al vertice del potere : sulle orme del padre Pa ¯pak, che nel 205-206 a Staxr aveva rovesciato il legittimo dinasta locale assumendo il titolo regio, Ardašır mosse ben presto dalla guarnigione di Darabgird, dove aveva prestato servizio, alla conquista dei territori limitrofi ; alla morte del padre e del fratello maggiore Šapur, sfidò diret-tamente il Gran Re Artabano in una ripetuta serie di scontri, sconfiggendolo defi-nitivamente a Hormizdaga ¯n il 28 aprile 224. Ormai signore dell’intero regno, egli ricevette la sottomissione dei nobili partici ancora legati alla vecchia corona, che lo riconobbero come il nuovo Šahan Ša ¯h (Re dei Re). 1 Rinasceva così, grazie alla famiglia dei Sasanidi (da Sasa ¯n, forse un antenato di Pa ¯pak), 2 il glorioso impero persiano : le fonti – sia di matrice orientale che di ambito greco-romano – sono concordi nell’attribuire ad Ardašır la ferrea volontà di ricostituire l’antico impero
* I paragrafi 1-3 sono a cura di L. Mecella, i paragrafi 4-5 a cura di U. Roberto. Gli autori ringraziano tutti gli intervenuti al convegno ed i curatori del volume per i preziosi suggerimenti.
1 Per una rapida introduzione a queste vicende e sull’opera di riorganizzazione della compagine statale compiuta dal primo dinasta sasanide si vd. G. Widengren, The Establishment of the Sasanian Dinasty in the Light of New Evidence, in La Persia nel Medioevo, Roma, 1971, pp. 711-782 ; J. Wiesehöfer, Ardašır I - History, in E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica, ii, London-New York, 1987, pp. 371-376 ; G. Gnoli, Il pericolo persiano : Ardashir e Shapur I, in Storia della società italiana, 3, La crisi del principato e la società imperiale, Mi-lano, 1996, pp. 399-433, partic. pp. 408-413 ; R. N. Frye, The political history of Iran under the Sasanians, in E. Yarshater (ed.), The Cambridge History of Iran, 3, Cambridge, 1983, pp. 116-180, partic. pp. 116-124 ; Id., The Sassanians, « cah », xii2, Cambridge, 2005, pp. 461-480, partic. pp. 461-467 ; D. O. A. Klose, W. Müseler, Statthalter, Rebellen, Könige. Die Münzen aus Persepolis von Alexander dem Großen zu den Sasaniden, München, 2008, pp. 74-80. Per una recente reinterpretazione dei rilievi di Fıruzabad con la raffigurazione delle sue gesta si vd. M. Grabowski, Ardašır’s struggle against the Parthians. Towards a reinterpretation of the Fıruzabad i relief, « ia », 46 (2011), pp. 207-233.
2 Sui problemi legati alla ricostruzione della complessa genealogia di Ardašır si vd. Wiesehöfer, Ardašır, p. 371 ; Frye, The political history of Iran, pp. 116-117 ; Id., The Sassanians, pp. 464-465.
laura mecella · umberto roberto100
achemenide, dopo l’onta subita ad opera di Alessandro Magno e secoli di domi-nio arsacide. 3 Ma quasi cinquecento anni di storia non potevano essere cancellati d’un colpo : se oggi si tendono a rivalutare soprattutto gli elementi di continuità tra l’impero partico e quello sasanide, sia su un piano politico-culturale che socio-economico, 4 qui preme soprattutto ricordare che la resistenza ad Ardašır non si arrestò con la morte dell’ultimo rappresentante dell’antica casa regnante. Un’op-posizione al nuovo regime sembra attestata a Seleucia fino al 228 e soltanto con fatica l’autorià del Re dei Re venne riconosciuta dai Kuša ¯na, nel Tu ¯ran (Belucistan) e a Marw (Turkmenistan) ; d’altro canto fu soltanto con la forza delle armi, e non semplicemente col peso del proprio prestigio, che il Sasanide riuscì ad imporsi sui potentati del Golfo Persico, dell’isola di al-Bahºrain e della costa arabica. 5
Per rendere stabile il suo potere e coeso l’impero Ardašır fece dunque leva su una politica di potenza capace di assicurargli una preminenza assoluta, e su una formidabile carica ideologica in grado di legittimarla : 6 all’indomani della sua ascesa al trono, egli si volse contro il suo nemico più temibile, l’impero romano, presentandosi quale erede degli Achemenidi e reclamando senza mezzi termini i possedimenti già appartenuti all’impero persiano prima dell’avvento di Alessan-dro. 7
Se tali rivendicazioni erano state avanzate, di tanto in tanto, anche dagli Ar-sacidi (si pensi per es. alle arroganti minacce degli ambasciatori di Artabano II a Tiberio), 8 esse tuttavia acquistavano ora una valenza nuova. E non solo per la
3 Per una rassegna delle fonti orientali cf. E. Winter, Die sa ¯sanidisch-römischen Friedensverträge des 3. Jahrhunderts n. Chr. – ein Beitrag zum Verständnis der außenpolitischen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten, Frankfurt am Main, 1988, p. 33 n. 2 ; Erodiano vi, 2.2 e Cassio Dione lxxx, 4.1 ; Zonara xii, 15 (iii, 121, 21-22 Dindorf). Sulla stigmatizzazione della figura di Alessandro il Macedone nell’Iran sasanide cf. G. Gnoli, Verso una cultura nazionale iranica, in C. Giuffrida, M. Mazza (a cura di), Le trasformazioni della cultura nella Tarda Antichità, ii, Roma, 1985, pp. 587-596, partic. pp. 588-589 ; J. Wiesehöfer, Grecs, Romains et Byzantins dans la tradition iranienne, in Id., Iraniens, Grecs et Romains, Paris, 2005, pp. 129-148, partic. pp. 142-144.
4 Cf. J. Wiesehöfer, Ancient Persia, London, 1996, p. 168, che tra l’altro sottolinea come il processo di accentramento politico e amministrativo dell’impero sasanide si faccia sensibilmente più marcato soltanto in un secondo periodo ; ma si vd. già E. Yarshater, Were the Sasanians Heirs to the Achaemenids ?, in La Persia nel Medioevo, pp. 517-531 (che considera i Sasanidi ‘eredi’ dei Parti, più che degli Achemenidi) e V. G. Lukonin, Political, social and administrative institutions : taxes and trade, in The Cambridge History of Iran, 3, pp. 681-746.
5 Widengren, The Establishment, passim e partic. pp. 745-756 ; Wiesehöfer, Ardašır, pp. 372-373 ; Winter, Die sasanidisch-römischen Friedensverträge, pp. 72-79 ; Gnoli, Il pericolo persiano, p. 411.
6 In quest’ottica gioca naturalmente un ruolo di rilievo anche la componente religiosa : un saggio di M.-L. Chaumont divenuto ormai classico (Le culte d’Ana ¯hita a Staxr et les premiers Sassanides, « rhr » 153 [1958], pp. 154-175) resta illuminante per comprendere la dimensione politica assunta dal culto di Anahita all’epoca dei primi Sasanidi, ancora una volta nel solco della tradizione achemenide. Sull’importanza del tempio di Staxr e del fattore religioso come elemento di stabilizzazione del potere insistono anche W. Enßlin, Die weltgeschichtliche Bedeutung der Kämpfe zwischen Rom und Persien, « Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Ju-gendbild », 4 (1928), pp. 399-415 (che abbraccia tutta la storia dell’impero sasanide), partic. pp. 402 ss. ; Gno-li, Il pericolo persiano, pp. 424-433 ; Id., Politica religiosa e concezione della regalità sotto i Sassanidi, in La Persia nel Medioevo, pp. 224-251, partic. pp. 245-251 ; Wiesehöfer, Ardašır, p. 376 ; Frye, The Sassanians, pp. 474-477.
7 Erodiano vi, 2.2 ; cf. anche Cassio Dione lxxx, 4.1.8 Tacito, Ann. vi, 31 : simul veteres Persarum ac Macedonum terminos seque invasurum possessa Cyro et
post Alexandro per vaniloquentiam ac minas iaciebat ; sulla vicenda anche Cassio Dione lviii, 26 e Hamza
isotimia tra roma e la persia 101
maggiore forza di attrazione che il richiamo all’antica Perside ebbe nell’autoco-scienza della dinastia sasanide e nella genesi e formazione del nuovo impero, 9 ma soprattutto perché alle parole subito si accompagnarono i fatti. La determi-nazione con cui Ardašır intraprese la sua marcia verso Occidente smentisce la tesi di un’interpretatio Romana della politica sasanide : 10 egli intendeva realmente, come sottolinea Enßlin, affiancare all’aspirazione al dominio universale propria di Roma quella del suo nuovo stato. 11 Già nel 226-227 attaccò H ºatrºa, pur senza ri-
al-Isfa ¯ha ¯ni (42, 7-17 Gottwaldt : non vidi) secondo cui un certo Ša ¯ pur (da identificare con Artabano II) si sarebbe presentato come il vendicatore di Dario III : per l’analisi di queste fonti si vd. Winter, Die sasanidisch-römischen Friedensverträge, pp. 29-30. Sulle componenti iraniche e i conseguenti richiami alla dinastia achemenide che caratterizzarono la politica degli Arsacidi insiste soprattutto J. Wolski, Iran und Rom. Versuch einer historischen Wertung der gegenseitigen Beziehungen, « anrw », ii 9.1, Berlin-New York, 1976, pp. 195-214 ; per l’ultimo periodo partico si vd. E. Dabrowa, Le programme de la politique en Occident des der-niers Arsacides. Essai de reconstitution, « ia », 19 (1984), pp. 149-165, partic. pp. 160 ss. ; cf. inoltre Wiesehöfer, Ancient Persia, pp. 133-134. K.-H. Ziegler, Die Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreich. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts, Wiesbaden, 1964, p. 86 tuttavia sottolinea opportunamente che, nonostante tali proclami, gli Arsacidi non avrebbero avuto un’aspirazione al dominio mondiale come invece i Romani e, più tardi, i Sasanidi.
9 Come sottolinea Gnoli, Il pericolo persiano, pp. 409-410, il nerbo della coalizione anti-arsacide fu co-stituito dalla nobiltà semi-feudale del Fars, non a caso una regione fortemente conservatrice : « l’eredità achemenide, anche se non fondata su una vera memoria storica, vi sopravvisse sempre in forme più o meno leggendarie […]. Se si riflette sul tema della resistenza orientale all’ellenismo, non si può fare a meno di pensare a questa regione […]. Ed è significativo, in un tale contesto, che le leggende monetarie della Perside fin dal iii secolo a.Cr. non fossero scritte in greco, ma in aramaico, e che i loro motivi iconografici risalissero senza alcun dubbio a tradizioni d’epoca achemenide » ; più recentemente si vd. anche Wiese-höfer, Grecs, Romains et Byzantins, pp. 134-146 e Id., Zeugnisse zur Geschichte und Kultur der Persis unter den Parthern, in Id. (hrsg. von), Das Partherreich und seine Zeugnisse (Beiträge des Internationalen Colloquiums, Eutin, 27.-30. Juni 1996), Stuttgart, 1998, pp. 425-434 (che comunque sottolinea come fino all’epoca sasani-de questa peculiare impronta non abbia avuto ricadute sul piano politico) ; Klose, Müseler, Statthalter, Rebellen, Könige, pp. 75-76 (per lo studio dell’arte figurativa) e ora soprattutto M. P. Canepa, Technologies of Memory in Early Sasanian Iran : Achaemenid Sites and Sasanian Identity, « aja », 114/4 (2010), pp. 563-596, che sottolinea, da parte degli Arsacidi, « ritual engagement with Achaemenid sites, creative reuse of Achae-menid architectural elements in newly created structures, and selective integration of Achaemenid visual culture in their own images » (p. 570).
10 Come sostenuto da E. Kettenhofen, Die Einforderung des Achämenidenerbes durch Ardasir : eine Inter-pretatio Romana, « olp », 15 (1984), pp. 177-190 ; si vd. pure Id., Einige Überlegungen zur sasanidischen Politik gegenüber Rom im 3. Jh. n. Chr., in E. Dabrowa (ed. by), The Roman and Byzantine Army in the East, Kraków, 1994, pp. 99-108, e Frye, The Sassanians, pp. 466 e 472 (con posizione diversa da quella assunta in The political history of Iran, p. 120) ; similmente anche Z. Rubin, The Roman Empire in the Res Gestae Divi Saporis - the Mediterranean World in the Sa ¯sanian propaganda, « Electrum », 2 (1998), pp. 177-185. Contra J. Wiesehöfer, Iranische Ansprüche an Rom auf ehemals achaimenidische Territorien, « Archäologische Mitteilungen aus Iran », 19 (1986), pp. 177-185, partic. pp. 181 ss. e Winter, Die sasanidisch-römischen Friedensverträge, pp. 37-41.
11 Enßlin, Die weltgeschichtliche Bedeutung, p. 402 : « [Ardašır] war gewillt, neben den Universalreichan-spruch Roms den seines neuen Staates zu stellen ». Molto diversa sarà, al contrario, la politica del figlio e successore Šapur I : come sottolinea Gnoli, Il pericolo persiano, p. 418, con lui « siamo lontani dalla prospet-tiva universalistica che era stata propria dell’impero achemenide […]. Le sue campagne in Siria, Cilicia, Cappadocia non sono tanto guerre di conquista, quanto rapide incursioni e razzie miranti a fiaccare il nemico con devastazioni e incendi e ad arricchire l’impero, oltre che con i bottini, con la deportazione dei prigionieri […]. Shapur modificò il titolo regio da ‘re dei re d’Iran’ a ‘re dei re d’Iran e non-Iran’, ma tale modifica non fu tanto l’espressione di una velleitaria aspirazione universalistica quanto il consapevole riflesso che ebbe nella titolatura ufficiale la realtà multinazionale dell’impero » ; sul punto si vd. anche Frye, The Sassanians, p. 469.
laura mecella · umberto roberto102
portarne alcun successo, 12 per poi passare all’invasione dell’Armenia ; 13 di lì a poco, nonostante una serie di contatti diplomatici con Alessandro, 14 nel 230 mosse con-tro Nisibi, la Cappadocia, la Mesopotamia e la Siria. 15 Sembravano così apparente-mente ribaltarsi i rapporti di forza tra le due potenze che avevano caratterizzato la storia dell’ultimo secolo.
Dalla campagna di Traiano in poi, i Romani avevano infatti condotto verso i Parti una politica sempre più aggressiva : tanto Lucio Vero e Marco Aurelio quan-to Settimio Severo non solo reagirono duramente alle provocazioni nemiche, ma ne approfittarono per intraprendere vere e proprie azioni di conquista a danno dei loro vicini orientali. 16 La pretestuosità del casus belli addotto da Caracalla per la sua guerra in Oriente dimostra come all’inizio del iii secolo Roma aspirasse ad imporre definitivamente la propria supremazia sullo scomodo rivale, anche a dispetto di qualsiasi criterio di ragionevolezza : 17 sebbene la caducità dei risultati
12 Cassio Dione lxxx, 3.2 ; sull’episodio in particolare si vd. B. Dignas, E. Winter, Rome and Persia in Late Antiquity. Neighbours and Rivals, Cambridge, 2007, pp. 154-155.
13 L’Armenia era sempre stata un territorio conteso tra le due potenze, Roma e la Partia, ma Ardašır aveva anche altri motivi per il suo attacco : in Armenia si era rifugiato uno dei figli di Artabano V e il suo re Chosroe I era legato agli Arsacidi da rapporti di parentela. La campagna si rivelò un fallimento, forse anche grazie all’intervento romano : sulle operazioni militari cf. Widengren, The Establishment, pp. 756-759 e M.-L. Chaumont, L’Arménie entre Rome et l’Iran. i. De l’avènement d’Auguste à l’avènement de Dioclétien, « anrw », ii 9.1, Berlin-New York, 1976, pp. 71-194, partic. pp. 158-162.
14 Come efficacemente rileva Erodiano vi, 2.5, a differenza di Alessandro, che sperava in una pacifica risoluzione del conflitto, Ardašır agiva o{ploi~ ajll∆ ouj lovgoi~ oijovmeno~ dei`n ta; pravgmata dioikei`sqai.
15 Si vd. Cassio Dione lxxx, 4.1 ; Erodiano vi, 2.1-2 ; vi, 2.5 ; cf. anche Zonara xii, 15 (iii, 121, 19-24 Din-dorf) ; Giorgio Sincello 437, 21-22 Mosshammer.
16 A prescindere dalle campagne di Settimio Severo, motivate dal desiderio di contrastare l’avanzata dei Parti in Mesopotamia favorita dalle guerre civili romane (Cassio Dione lxxv, 3 ; lxxvi, 9-12), il casus belli fu sempre offerto dalle contese per il predominio sull’Armenia : desideroso di sfruttare la situazione di debolezza del regno partico dilaniato da lotte dinastiche, Traiano prese a pretesto per la sua politica espansionistica la decisione di Osroe, uno dei pretendenti al trono di Ctesifonte, di insediare in Armenia un proprio candidato (Cassio Dione lxviii, 17-33) ; la spedizione di Lucio Vero (ma in realtà guidata da Avidio Cassio) fu la risposta all’occupazione del piccolo regno microasiatico da parte del Gran Re Vologese IV, e fu a tal punto decisa da guadagnare a Roma importanti territori nella Mesopotamia settentrionale (ha Marcus 8.6 - 9.2 ; ha Verus 7 ; Cassio Dione lxxi, 2.3 ; Ammiano xxiii, 6.24). Uniche eccezioni a questo quadro la situazione verificatasi sotto Antonino Pio, che preferì non intervenire militarmente durante un’ennesima occupazione dell’Armenia ad opera dei nemici (ha Antonin. 9.6 : Parthorum regem ab Armeniorum expugna-tione solis litteris reppulit), e la pace stipulata tra Macrino ed Artabano nel 218 (Cassio Dione lxxix, 26.8 – 27.3 ; Erodiano iv, 15.7-9 e v, 1.4 ; ha Macr. 8.3). Sull’escalation di violenza da parte romana che caratte-rizzò le crisi romano-partiche dall’età cesariana in poi (trasformando semplici azioni d’intervento su scala regionale in vere e proprie guerre di conquista) ha recentemente richiamato l’attenzione M. Sommer, Le ragioni della guerra : Roma, i Parti e l’ultimo imperativo di Cesare, in G. Urso (a cura di), Cesare : precursore o visionario ?, Pisa, 2010, pp. 123-140, partic. pp. 128-133, che comunque puntualizza come non si possa parlare « di un piano prestabilito a lungo termine, che mirasse ad uno stabile assoggettamento, perlomeno delle aree occidentali dell’impero partico. Piuttosto si tratta qui – da Gabinio fino a Caracalla – di azioni isolate, che non erano sottoposte ad alcun superiore calcolo strategico » (p. 133). Sul tema si vd. più diffusamente Ch. Lerouge, L’image des Parthes dans le monde gréco-romain. Du début du ier siècle av. J.-C. jusqu’à la fin du Haut-Empire romain, Stuttgart, 2007, pp. 149-169.
17 Caracalla approfittò di una guerra civile nel regno rivale per occupare l’Armenia e provocare la guer-ra, chiedendo contestualmente la mano di una delle figlie di Artabano : Cassio Dione lxxix, 1.1 ; dal can-to suo Erodiano iv, 10-11 presenta l’offerta come un inganno : l’imperatore si sarebbe introdotto come promesso sposo in territorio nemico soltanto per poter proditoriamente attaccare gli avversari accorsi a festeggiarlo. Sebbene una parte della critica consideri il particolare della richiesta di matrimonio frutto
isotimia tra roma e la persia 103
conseguiti da Traiano avesse dimostrato come la via di una duratura annessione di regioni quali l’Assiria, Babilonia o la Media Atropatene fosse di fatto imprati-cabile, e l’espansione territoriale operata da Lucio Vero avesse solo contribuito a rendere i confini più insicuri, 18 forte dei successi del padre Caracalla sembrò aver realmente vagheggiato la possibilità di impadronirsi delle terre del Levante.
Tanto più pericolose e scioccanti dovettero dunque apparire, ai Romani, le mi-nacce di Ardašır pochi anni dopo : non solo il nemico eterno non era ancora stato sconfitto, ma esso risorgeva dalle sue stesse ceneri più temibile di prima. Erodiano ci informa dettagliatamente sul clima di terrore suscitato a corte dai dispacci dei governatori orientali che riportavano i proclami del nuovo re persiano : essi giun-sero « improvvisamente e contro ogni aspettativa », destando nell’imperatore forti preoccupazioni. 19
Sebbene Alessandro avesse inizialmente intrapreso le vie della diplomazia, 20 a Ro-ma si accese ben presto il dibattito sull’eventualità di una guerra, anche perché nel frattempo Ardašır non aveva affatto cessato le sue azioni di disturbo in Mesopota-mia. Nelle pagine di Cassio Dione è possibile cogliere i timori di una parte dei ver-tici politici e militari romani, preoccupati per la scarsa preparazione delle truppe :
non è il fatto che [Ardašır] sembri in se stesso degno di una qualche considerazione, ma che le nostre armate siano in uno stato tale che le une si associano a lui, le altre non vogliono difendersi. Sono aduse ad una tale mollezza, indisciplina e licenza che quelle in Mesopotamia osarono uccidere il proprio comandante, Flavio Eracleo, e i Pretoriani mi incolparono presso Ulpiano di aver comandato con durezza le truppe in Pannonia, e richiesero il mio allontanamento, temendo che qualcuno li costringesse ad un comando simile a quello delle truppe pannoniche. 21
d’invenzione (si vd. per tutti D. Timpe, Ein Heiratsplan Kaiser Caracallas, « Hermes », 95 [1967], pp. 470-495), il suo proposito di porsi anche a capo del regno partico, sulle orme di Traiano e, soprattutto, di Alessandro Magno, sembra innegabile : cf. Ziegler, Beziehungen, pp. 137-138 ; J. Vogt, Zu Pausanias und Caracalla, « Hi-storia », 18 (1969), pp. 299-308, partic. pp. 303 ss. ; Dignas, Winter, Rome and Persia, pp. 15-16 ; G. Zecchini, Il bipolarismo romano-iranico, in C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini (a cura di), L’equilibrio internazionale dagli antichi ai moderni, Milano, 2005, pp. 59-82, partic. pp. 63-64. Sull’imitatio Alexandri che ha caratterizzato la politica dell’imperatore cf. Cassio Dione lxxviii, 7-8 ; Erodiano iv, 8.1-2, su cui si vd. U. Espinosa, La alejandrofilia de Caracala en la antigua historiografia, in J.-M. Croisille (éd. par), Neronia iv : Alejandro Magno, modelo de los emperadores romanos, Bruxelles, 1990, pp. 37-51 ; cf. inoltre Abd El-Mohsen El-Khachab, ÔO Karakavllo~ Kosmokravtwr, « jea », 47 (1961), pp. 119-133, partic. pp. 124 e 131-132 ; F. Millar, The Roman Near East : 31 bc - ad 337, Cambridge, 1993, pp. 142-144 ; G. Zecchini, Lo Pseudo-Alessandro del 221 d.C., « Aevum », 62 (1988), pp. 106-115, partic. pp. 106-108.
18 B. Isaac, The limits of empire. The Roman army in the East, Oxford, 19922, pp. 32-33 ; Sommer, Le ragioni della guerra, p. 133.
19 Erodiano vi, 2.3 : toiau`ta toivnun dhlwsavntwn kai; ejpisteilavntwn tw`n uJpo; tai`~ ajnatolai`~ hJgemovnwn, pro;~ th;n aijfnivdion kai; par∆ ejlpivda komisqei`san ajggelivan ouj metrivw~ oJ ∆Alevxandro~ ejtaravcqh… Sul passo si vd. anche T. Gnoli, From Praepositus Praetenturae to Dux Ripae. The Roman ‘Grand Strategy’ on the Middle Euphrates (2nd-3rd Cent. ad), in A. S. Lewin, P. Pellegrini (ed. by), The Late Roman Army in the Near East from Diocletian to the Arab Conquest (Proceedings of a colloquium held at Potenza, Acerenza and Matera, Italy. May 2005), Oxford, 2007, pp. 49-55, partic. pp. 49-50, che sottolinea la grave sottovalutazione del pericolo da parte degli apparati periferici dell’impero.
20 Erodiano vi, 2.3. Alessandro non avrebbe cessato di inviare legazioni al re persiano anche nel corso della successiva campagna, nell’inverno 231-232 : Erodiano vi, 4.4.
21 Cassio Dione lxxx, 4.1-2 : oujc o{ti aujto;~ lovgou tino;~ a[xio~ dokei`, a[ll∆ o{ti ou{tw ta; stratiwtika; hJmi`n
laura mecella · umberto roberto104
Il passo risente del classico topos sul lassismo delle legioni orientali 22 e della negati-va esperienza vissuta dallo storico ; esso però potrebbe non essere semplicemente frutto di una distorsione della realtà ma riflettere la condizione di difficoltà di almeno una parte dell’esercito, peraltro confermata anche da altri episodi di am-mutinamento oltre a quelli qui ricordati e noti da altre fonti. 23
2.
È proprio in questo clima di tensione che va collocato un interessante passo dei Kestoiv di Giulio Africano.
L’opera, in 24 libri di cui oggi rimangono solo alcuni frammenti, si configura come una poliedrica raccolta di notizie intorno ai più svariati campi del sapere : arte militare, medicina, botanica, chimica, veterinaria, metrologia e letteratura. 24 All’inizio del settimo libro, prevalentemente dedicato allo studio della scienza bel-lica, dopo un breve proemio l’autore osserva :
Kalo;n de; ejn pa`si kai; povlemon eijdevnai. pollavki~ ga;r kai; ejqauvmasa th;n aijtivan th`~ diafovrou tw`n ejnoplivwn ajgwvnwn rJoph`~ kai; ejk touvtwn me;n ÔRwmaivvwn ”Ellhna~, ÔEllhvnwn de; tou;~ Pevrsa~, mhdevpw de; uJpo; ÔRwmaivwn Pevrsa~ nenikh`sqai, ajll∆ eij~ ejleuqerivan qrasuvnesqai kai; th;n ijso-timivan biavzesqai pro;~ hJma`~ ølevgeinØ ta; a[nw th`~ ∆Asiva~ e[qnh. logismo;n de; ejmautw/ didouv~, eu|ron ouj pleonexivan strathghmavtwn oujde; stratiwtikh;n to; suvnolon ijscu;n (plhvqou~ ga;r ejn polevmw/ para; toi`~ ajgaqoi`~ lovgo~ oujde; ei|~), ajlla; th;n paraskeuh;n tw`n o{plwn kai; to; ei\do~ th`~ ejnualivou stolh`~.È bene soprattutto conoscere l’arte della guerra. Spesso infatti mi sono anche stupito della causa del diverso esito dei conflitti armati, e che dunque mentre i Greci sono stati vinti dai Romani, e i Persiani dai Greci, i Persiani invece non sono stati ancora battuti dai
diavkeitai w{ste tou;~ me;n kai; prostivqesqai aujtw`/ tou;~ de; oujk ejqevlein ajmuvnesqai. tosauvth/ ga;r a{ma trufh`/ kai; ejxousiva/ ajnepiplhxiva/ te crw`ntai w{ste tolmh`sai tou;~ ejn th`/ Mesopotamiva/ to;n a[rconta sfw`n Flavouion ÔHraklev-wna ajpoktei`nai, kai; tou;~ dorufovrou~ pro;~ tw`/ Oujlpianw`/ kai; ejme; aijtiavsasqai o{ti tw`n ejn th`/ Pannoniva/ stratiwtw`n ejgkratw`~ h\rxa, kai; ejxaith`sai, fobhqevnta~ mh; kai; ejkeivnou~ ti~ oJmoivw~ toi`~ Pannonikoi`~ a[rcesqai katanagkavsh/. Sulla visione « deeply pessimistic » di Cassio Dione cf. Millar, The Roman Near East, p. 147.
22 Tema ampiamente indagato in E.L. Wheeler, The laxity of Syrian legions, in D. L. Kennedy (ed. by), The Roman Army in the East, Ann Arbor, 1996, pp. 229-276 (partic. p. 252 per l’episodio in questione).
23 Cf. Cassio Dione lxxx, 4.1-2 ; Erodiano vi, 4.7 ; ha Sev. Alex. 53-54 ; Aurelio Vittore, Caes. 24.2 : sub hoc imperante (scil. Severo Alessandro) Taurinus Augustus effectus ob timorem ipse se Euphrate fluvio abiecit (epi-sodio datato però al regno di Elagabalo da Polemio Silvio, chron. i 521 Mommsen). Sull’usurpazione di un Oujravnio~ ricordata per l’ultimo anno di regno di Severo Alessandro da Zosimo i, 12.2 e Giorgio Sincello 437, 19-20 e 439, 7-8 Mosshammer – tuttavia probabilmente da ricondurre alla vicenda di Uranio Antonino del 253 – si vd. quanto osservato in L. Mecella, A proposito di Malala, chron. xii 26 : Uranio Antonino e i contadini di Emesa, « Bizantinistica », 11 (2009), pp. 79-109, partic. pp. 91-92.
24 Si vd. in proposito l’efficace descrizione di Giorgio Sincello 439, 18-20 Mosshammer (ma con un’er-rata indicazione del numero dei volumi) : ∆Afrikano;~ th;n ejnneavbiblon tw`n Kestw`n ejpigegrammevnhn pragma-teivan ijatrikw`n kai; fusikw`n kai; gewrgikw`n kai; cumeutikw`n perievcousan dunavmei~ ∆Alexavndrw/ touvtw/ prosfonei (= Giulio Africano, Cest. T3 Wallraff et al.) ; per la natura dell’opera utile anche il passo di Psello nel trattato Peri; paradovxwn ajkousmavtwn : T7 Wallraff et al. [ix 1, 316-321 Vieillefond]. I frammenti dei Kestoiv, già pubblicati da J.-R. Vieillefond, Les ‘Cestes’ de Julius Africanus. Étude sur l’ensemble des fragments avec édition, traduction et commentaires, Firenze-Paris, 1970, sono stati ora recentemente riediti : Iulius Africa-nus. Cesti. The Extant Fragments. Edited by M. Wallraff, C. Scardino, L. Mecella, Ch. Guignard. Translated by W. Adler, Berlin-New York, 2012.
isotimia tra roma e la persia 105
Romani, ma anzi i popoli dell’interno dell’Asia sono insolenti nella loro indipendenza e impongono con la forza l’isotimia con noi. Ma, riflettendoci, ho trovato come causa non la superiorità degli stratagemmi né la forza militare nel suo complesso (infatti in guerra il numero non ha alcun valore presso i valorosi), ma l’allestimento delle armi e la forma dell’equipaggiamento bellico. 25
Abbiamo ragione di credere che il brano sia stato scritto negli anni che immediata-mente precedettero la campagna persiana di Severo Alessandro, mentre con ogni verosimiglianza il suo autore si trovava a Roma alla corte dell’imperatore. Sebbe-ne poco note siano le sue vicende biografiche, 26 è possibile tentare un’approssima-tiva ricostruzione del decennio 221-231 : dopo aver terminato la stesura della sua prima opera, le Chronographiae, nel 221, 27 Africano fu investito dagli abitanti del vil-laggio palestinese di Emmaus 28 del compito di guidare l’ambasceria inviata a Ro-ma per ottenere la promozione del piccolo centro in città. 29 La scelta di Africano come capo della legazione non stupisce : anch’egli palestinese, originario di Aelia Capitolina, probabilmente insignito della cittadinanza romana anche prima della Constitutio Antoniniana, 30 come altri intellettuali della Seconda Sofistica si presen-
25 F12, 1, 1-8 Wallraff et al. (i 1, 1-9 [104-105 Vieillefond]). Per un’analisi del brano di carattere stilisti-co-letterario cf. B. Meißner, Magie, Pseudo-Technik und Paratechnik : Technik und Wissenschaft in den Kestoi des Julius Africanus, in M. Wallraff, L. Mecella (hrsg. von), Die Kestoi des Julius Africanus und ihre Überliefe-rung, Berlin-New York, 2009, pp. 17-37, partic. 18-21.
26 Una recente sintesi in Iulius Africanus. Chronographiae. The Extant Fragments, edited by M. Wallraff with U. Roberto and, for the Oriental Sources, K. Pinggéra. Translated by W. Adler, Berlin-New York, 2007, pp. xiv-xvii ; cf. anche Vieillefond, Les ‘Cestes’, pp. 13-22. Non sono attestati legami con la famiglia di senatori gallici degli Iulii Africani noti per il i sec. d.C., su cui si vd. da ultimo B. Kavanagh, Julius Africanus, senator ?, « Historia », 45 (1996), pp. 241-243.
27 Vd. infra, § 4 ; cf. inoltre Wallraff-Roberto, Iulius Africanus Chronographiae, pp. xvii-xix e U. Rober-to, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano. Storiografia, politica e cristianesimo nell’età dei Severi, Soveria Mannelli, 2011, p. 20 con n. 18.
28 Per la localizzazione e la storia del sito – da non confondere con l’omonimo centro menzionato in Lc 24, 13 –, si vd. M. Fischer, B. Isaac, I. Roll, Roman Roads in Judaea ii. The Jaffa-Jerusalem roads, Oxford, 1996, pp. 151-159.
29 Giulio Africano, Chron. T2a Wallraff-Roberto (= Eusebio, Chron. 224 Karst = Girolamo, Chron. 214h Helm = Chron. Pasch. 499, 5-7 Dindorf) ; T2b Wallraff-Roberto (Girolamo, De viris illustri-bus 63) ; T2c Wallraff-Roberto (= Niceforo Callisto Xanthopulo, Excerpta ex Historia ecclesiastica in codice Barocciano 142, f. 212r, l. 18-20, in C. de Boor, Neue Fragmente des Papias, Hegesippus und Pierius in bisher unbekannten Exzerpten aus der Kirchengeschichte des Philippus Sidetes, Berlin, 1888, pp. 165-184, partic. p. 169 ; sulla possibile derivazione del passo da Filippo di Side cf. K. Heyden, Die Christliche Geschichte des Philippos von Side. Mit einem kommentierten Katalog der Fragmente, in M. Wallraff [hrsg. von], Julius Africanus und die christliche Weltchronistik, Berlin-New York, 2006, pp. 209-243, partic. pp. 223-224) ; T2d Wallraff-Roberto (Giorgio Sincello 439, 15-20 Mosshammer). T2a-b collocano i fatti durante il regno di Elaga-balo ; T2d invece sotto Severo Alessandro ; nessuna indicazione cronologica in T2c. Sulla fondazione di Nicopolis cf. anche Eusebio, Onom. 90, 16 e 66, 21 ; W. Adler, Sextus Julius Africanus and the Roman Near East in the Third Century, « JThS », 55 (2004), pp. 520-550, partic. pp. 524-527 ; Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, pp. 173-178.
30 Un indizio è costituito dal probabile possesso dei tria nomina (Sextus Iulius Africanus) ; sebbene il prae-nomen sia attestato soltanto da una notizia della Suda (Giulio Africano, Chron. T12 Wallraff-Roberto = Suda A 4647 : ∆Afrikanov~, oJ Sevkto~ crhmativsa~), non vi sono motivi per dubitare della sua storicità, come invece ritenuto, e.g., da J. Crehan, Africanus, Julius, « tre », 1, Berlin, 1977, pp. 635-640, partic. p. 635, che interpretò il termine come sectus (traducendo « Africanus der Eunuch »), o da coloro che hanno preferito emendare il testo del lessicografo in Kestov~ (in analogia con l’epiteto Strwmateuv~ attestato per Clemente d’Alessandria, autore degli Strwmatei`~) : cf. sul punto Adler, Sextus Julius Africanus, pp. 523-524.
laura mecella · umberto roberto106
tava quale candidato ideale a fungere da trait d’union tra le istanze delle comunità locali e i rappresentanti del potere centrale. 31 L’operazione ebbe infatti successo, ed Emmaus venne rifondata con il nome di Nicopolis ; dal momento che la città cominciò a battere moneta con l’effigie di Elagabalo, 32 essa deve aver ricevuto il nuovo status o mentre l’imperatore era ancora in vita o poco dopo la sua morte (avvenuta l’11 o il 12 marzo 222), prima cioè che nelle province si diffondesse la notizia di un cambiamento di regime. 33 Non sappiamo se Africano sia poi ripartito per l’Oriente per ricevere da Nicopolis i dovuti onori (ipotesi più probabile) o se sia rimasto nella capitale ; certo è che negli anni seguenti egli ebbe ancora modo di distinguersi a Roma, dove ricoprì l’incarico di responsabile dell’organizzazio-ne di una biblioteca connessa al Pantheon. Parlando, nei Kestoiv, di un’edizione dell’Odissea, egli avverte infatti i suoi lettori della possibilità di trovarne una copia ejn ÔRwvmh/ pro;~ tai`~ ∆Alexavndrou qermai`~ ejn th`/ ejn Panqeivw/ biblioqhvkh/ th`/ kalh`/ h}n aujto;~ hjrcitektovnhsa tw`/ Sebastw``/. 34
Africano si presenta dunque come un personaggio di rilievo nell’entourage di Severo Alessandro : sebbene non sia facile precisare esattamente i suoi compiti (probabilmente ricoprì la direzione scientifica della biblioteca, 35 piuttosto che una carica amministrativa connessa al titolo di procurator 36 o la funzione di architetto nel senso moderno del termine), 37 il ruolo denota una posizione di una certa im-
31 Sulla paideia di Africano ed i suoi legami con il milieu culturale della Seconda Sofistica cf. W. Adler, The Cesti and the Sophistic Culture in the Severan Age, in Wallraff, Mecella (hrsg. von), Die Kestoi, pp. 1-15, e Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, pp. 38-45.
32 Cf. G. F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Palestine (Galilee, Samaria, and Judaea), London, 1914, p. 170 ; Y. Meshorer, City-Coins of Eretz-Israel and the Decapolis in the Roman Period, Jerusalem, 1985, p. 56.
33 Per la datazione della morte di Elagabalo cf. D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römi-schen Kaiserchronologie, Darmstadt, 19962, p. 172.
34 F10, 52-53 Wallraff et al. (v, 52-54 [290-291 Vieillefond]). Il passo è tradito dal P. Oxy. 412 (recto), su cui si vd. la recente analisi di J. Hammerstaedt, Julius Africanus und seine Tätigkeiten im 18. Kestos (P.Oxy. 412 col. ii), in Wallraff, Mecella (hrsg. von), Die Kestoi, pp. 53-69. Secondo un’acuta ipotesi di Bagnall, esso avreb-be fatto parte della biblioteca di Aurelia Tolemaide, una degli eredi di quell’Ermogene il cui testamento viene riportato nel verso dello stesso papiro. Ad Aurelia Tolemaide appartengono infatti anche altri papiri letterari : si vd. sul tema R. S. Bagnall, An Owner of Literary Papyri, « CPh », 87 (1992), pp. 137-140.
35 Di questo avviso già A. von Harnack, Julius Africanus, der Bibliothekar des Kaisers Alexander Severus, in Aufsätze Fritz Milkau gewidmet, Leipzig, 1921, pp. 142-146. Non abbiamo nessun motivo per affermare, con F. Granger, Julius Africanus and the Western Texts, « jts », 35 (1934), pp. 361-368, partic. pp. 365-367, che Africano abbia dotato la biblioteca di un ricco patrimonio di testi cristiani, così come rimane pura speculazione l’ipotesi di C. Wendel, Versuch einer Deutung der Hippolyt-Statue, « Theologische Studien und Kritiken », 108 (1937), pp. 362-369, secondo cui la statua di Ippolito a Roma sarebbe stata commissionata proprio da Africano per quell’edificio.
36 Come sottolinea H. Blanck, Il libro nel mondo antico, Bari, 20082 (München, 19921), pp. 299-300, il di-rettore di una biblioteca (per le più importanti generalmente un noto intellettuale) era figura ben diversa dal procurator bibliothecarum, cioè il sovrintendente delle biblioteche imperiali.
37 È difficile ritenere che Africano, pur nell’eclettismo della sua formazione, abbia potuto acquisire le competenze tecniche necessarie alla progettazione di edifici, nonostante la notizia riportata da Miche-le Siro vi, 7 (187, 29 Chabot) secondo cui Africano avrebbe avuto la supervisione del progetto edilizio all’epoca della fondazione di Nicopolis ; in ogni caso, esse non sembrano emergere dalla lettura dei Kestoiv. Analisi del problema in Adler, Sextus Julius Africanus, p. 541 (ma cf. la sua traduzione in Wallraff et al., Iulius Africanus. Cesti, ad loc.) e Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, p. 180 ; contra Vieil-lefond, Les ‘Cestes’, pp. 21-22.
isotimia tra roma e la persia 107
portanza. 38 I legami con la corte sono poi confermati dalla dedica dei Kestoiv a Se-vero Alessandro, attestata da una notizia di Sincello, 39 e d’altra parte l’imperatore era noto per i suoi interessi storici e letterari : 40 come già ad Edessa, dove era stato precettore del principe Ma‘nu, 41 anche a Roma Africano non avrà avuto difficoltà a farsi apprezzare per le sue doti intellettuali e artistiche, soprattutto dopo la com-posizione della sua opera cronografica. 42
È presumibile dunque che egli si trovasse nella capitale, e in stretto rapporto con l’ambiente di palazzo, negli anni in cui in Oriente risorgeva la minaccia persiana. Il passo sopra citato diviene infatti pienamente intellegibile solo alla luce dell’at-mosfera di attesa che accompagnò le prime relazioni diplomatiche con Ardašır e i preparativi per la campagna ; l’esplicita affermazione secondo cui i Persiani non sarebbero stati ancora sconfitti dai Romani fornisce d’altra parte un sicuro termi-nus ante per la sua redazione, certamente precedente alla marcia di Alessandro (231-233), che a Roma venne propagandisticamente celebrata come un clamoroso
38 Purtroppo è impossibile precisarne una datazione, a parte la generica indicazione dell’Augustato di Severo Alessandro (che sia lui il Sebastov~ menzionato è confermato dal fatto che i Kestoiv gli erano dedicati : sul punto vd. infra, n. s.). Il 227, anno in cui terminarono i lavori al complesso termale, a rigore costituisce soltanto il terminus post quem per la redazione del passo, ma non fornisce alcun indicatore cronologico per l’attività di Africano presso la biblioteca, che non appare essere in alcuna connessione strutturale con le terme : si vd. sul punto le osservazioni di Hammerstaedt, Julius Africanus, pp. 66-67 (con ampia bibliografia), che rimane scettico sulla possibilità di identificare sia la sede che il momento della costruzione della biblioteca. L’ipotesi avanzata da F. Coarelli, Bibliotheca Panthei, « ltur », i, Ro-ma, 1993, p. 197, secondo cui la biblioteca potrebbe essere identificata con la c.d. Basilica Neptuni, è ora respinta anche da G. Cantino Wataghin, Le biblioteche nella tarda antichità : l’apporto dell’archeologia, « AnTard », 18 (2010), pp. 21-62, partic. p. 31. Sulle Terme Alessandrine, in realtà rifacimento di un più an-tico impianto di epoca neroniana (62-64 d.C.), si vd. G. Ghini, Le Terme Alessandrine nel Campo Marzio, Roma, 1988 e Ead., Thermae Neronianae/Alexandrinae, « ltur », 5, Roma, 1999, pp. 60-62 ; cf. anche H. W. Benario, Severan Rome and the Historia Augusta, « Latomus », 20 (1961), pp. 281-290, partic. pp. 287-289. Più in generale sull’attività edilizia promossa da Severo Alessandro si vd. F. Coarelli, La situazione edilizia di Roma sotto Severo Alessandro, in L’Urbs. Espace urbain et histoire (ier siècle av. J.-C. - iiie siècle ap. J.-C.), Rome, 1987, pp. 429-456.
39 Giorgio Sincello 439, 20 Mosshammer = Giulio Africano, Cest. T3 Wallraff et al.40 ha, Sev. Alex. 16.3 ; sull’apertura dell’imperatore nei confronti dei cristiani (certamente dovuta anche
all’influsso di Iulia Mamea) si vd. inoltre ibid. 22.4 ; 27 ; 29.2 ; 43.6 ; 45.6 ; 49.6 ; 51.7-8 e Orosio vii, 19.2.41 Sul soggiorno di Africano ad Edessa cf. Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, pp. 45-57 ;
sul milieu culturale edesseno di quegli anni sono istruttivi S. K. Ross, Roman Edessa. Politics and Culture on the Eastern Fringes of the Roman Empire, 114-242 ce, London-New York, 2001, pp. 83-138 ; S. H. Griffith, Bey- ond the Euphrates in Severan Times : Mani, Bar Daysan, and the Struggle for Allegiance on the Syrian Frontier, in E. Bradshaw Aitken, J. K. Berenson Maclean (ed. by), Philostratus’s Heroikos. Religion and Cultural Identity in the Third Century c.e., Leiden, 2004, pp. 317-332 ; M. Mazza, Identità etniche e culture locali sulla frontiera dell’Eufrate (ii-iv sec. d.C.). Uno studio sui contatti culturali, in Id., Cultura guerra e diplomazia nella Tarda Anti-chità. Tre Studi, Catania, 2005, pp. 11-115, partic. pp. 66-73.
42 Per il successo ottenuto da Africano a Roma cf. F. Millar, The Emperor in the Roman World (31 bc – ad 337), London, 19922, pp. 495-496 ; Adler, The Cesti and the Sophistic Culture in the Severan Age, pp. 9-11 ; Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, pp. 181-186 (e ivi, pp. 32-37 per l’orgoglioso senso di appartenenza all’ecumene romana da parte di Africano). Più in generale, per la promozione di elementi africani e orientali da parte dei Severi cf. M. Hammond, Composition of the Senate, a.d. 68-235, « jrs », 47 (1957), pp. 74-81, partic. pp. 77 e 79 ; J.-P. Coriat, Les hommes nouveaux à l’époque des Sévères, « rd », 56 (1978), pp. 5-27, partic. pp. 8-11 ; M. Mazza, Un uomo forte al potere : il regno di Settimio Severo, in Storia della Società Italiana, 3, pp. 211-260, partic. pp. 247-248.
laura mecella · umberto roberto108
successo. 43 Sebbene sia da respingere la tesi secondo cui i Kestoiv sarebbero stati composti proprio in funzione della spedizione 44 – la pluralità di interessi riflessa nell’opera esula da mere esigenze di carattere militare – è certo che nel brano trovano eco problemi di stringente attualità.
La pretesa dei Persiani di porsi sullo stesso piano del nemico – la rivendicazione dell’ ijsotimiva, appunto, che Ardašır in quegli anni avanzava con la violenza delle armi – appare ad Africano del tutto illegittima ; significativamente, nelle sue parole trova eco la voce della propaganda ufficiale a noi nota grazie alla narrazione di Erodiano. Nella rappresentazione di quest’ultimo, Alessandro ribadisce senza ten-tennamenti la supremazia di Roma : nella missiva inviata per scongiurare la guerra, l’imperatore invita Ardašır ad accontentarsi dello status quo perché « non sarebbe stata per lui la medesima cosa aver di fronte i Romani anziché i barbari suoi vicini e consanguinei ». 45 Nella rievocazione delle gesta di Ardašır, impostosi sui picco-li dinasti locali fino alla conquista del potere centrale, attraverso l’abusato topos dell’inferiorità del barbaro emerge in filigrana soprattutto la contrapposizione, di carattere politico e culturale, tra l’unità e la compattezza dell’impero romano e la frammentarietà della struttura statuale avversaria, dai Romani ancora assimilata (e non poteva essere altrimenti) al vecchio assetto del regno partico. All’organizzazio-ne fortemente centralizzata del potere romano si contrapponeva la ben più fluida conformazione dello stato governato dagli Arsacidi : qui il Gran Re esercitava un controllo diretto soltanto su una piccola porzione di territorio, affidando il resto alla signoria di potentati locali, i cosiddetti ‘piccoli re’, a lui legati attraverso una complessa rete di rapporti personali. 46 Non stupisce dunque constatare lo sconcer-
43 Si vd. ha Alex. Sev. 55-57 ; Aurelio Vittore, Caes. 24.2 (cf. anche 24.7) ; Eutropio viii, 23 ; Festo 22 ; Girolamo, Chron. 215 Helm ; Orosio vii, 18.7 ; Giordane, Rom. 280 (36 Mommsen) ; Giorgio Sincello 439, 8 Mosshammer, con la discussione di A. Rösger, Die Darstellung des Perserfeldzugs des Severus Alexander in der Historia Augusta, « bhac », 1975/76, Bonn, 1978, pp. 167-174 e il confronto con la documentazione numismatica ed epigrafica operato da Winter, Die sa ¯sanidisch-römischen Friedensverträge, pp. 60-62. Per la ricostruzione della campagna si vd. principalmente Erodiano vi, 5-6, con l’analisi di M. Mazza, La dinastia severiana : da Caracalla a Severo Alessandro, in Storia della Società Italiana, 3, pp. 261-317, partic. pp. 309-311 ; cf. inoltre Winter, Die sasanidisch-römischen Friedensverträge, pp. 63-68. In realtà non ebbe luogo alcuna battaglia campale : entrambi gli eserciti si ritirarono – quello di Alessandro perché stremato dalla stanchezza e dalle epidemie, quello di Ardašır perché minato da gravi perdite e costretto ad intervenire nelle satrapie orientali – lasciando a Roma la Mesopotamia (e poco più tardi anche Nisibi) e alla Persia mano libera in Armenia.
44 T. Rampoldi, I Kestoiv di Giulio Africano e l’imperatore Alessandro Severo, « anrw », ii 34.3, Berlin-New York, 1997, pp. 2451-2470, partic. pp. 2456-2457 ; E. Wheeler, Why the Romans can’t defeat the Parthians : Julius Africanus and the strategy of magic, in W. Groenman-van Waateringe, B. L. van Beek, W. J. H. Willems, S. L. Wynia (ed. by), Roman Frontier Studies 1995 (Proceedings of the xvith International Congress of Roman Frontier Studies), Oxford, 1997, pp. 575-579.
45 Erodiano vi, 2.4 : mhde; ga;r oJmoivan e[sesqai mavvchn aujtw`/ pro;~ ÔRwmaivou~ oi{an scei`n pro;~ tou;~ geitniw`nta~ kai; oJmofuvlou~ barbavrou~ (trad. Cassola). Sul passo si vd. anche M. P. Canepa, The Two Eyes of the Earth. Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran, Berkeley-Los Angeles, 2009, p. 49.
46 E. J. Keall, How Many Kings Did the Parthian King of Kings Rule ?, « ia », 29 (1994), pp. 253-272 ; S. R. Hauser, Ecological limits and political frontiers : the ‘Kingdom of the Arabs’ in the eastern Jazira in the Arsacid period, in L. Milano, S. de Martino, F. M. Fales, G. B. Lanfranchi (ed. by), Landscapes. Territories, Fron-tiers and Horizons in the Ancient Near East, ii, Padova, 2000, pp. 187-201, partic. p. 191 ; M. Sommer, Roms orientalische Steppengrenze. Palmyra - Edessa - Dura-Europos - Hatra. Eine Kulturgeschichte von Pompeius bis Diocletian, Stuttgart, 2005, pp. 376-383 ; R. Fowler, King, Bigger King, King of Kings : Structuring power in the
isotimia tra roma e la persia 109
to di Africano, e con lui dei vertici politici di Roma, per l’aspirazione di Ardašır a presentarsi quale nuovo imperatore persiano e dunque degno antagonista della signora del mondo : a capo di una serie di piccoli regni piuttosto che di un grande impero, 47 agli occhi dei Romani egli non poteva che rappresentare semplicemente un barbaro ajlazwvn, come lo definisce Erodiano. 48 Non a caso Africano afferma che ad insolentire (qrasuvnesqai) per la ritrovata ejleuqeriva 49 e ad imporre con la forza (biavzesqai) l’ ijsotimiva con Roma sono ta; a[nw th`~ ∆Asiva~ e[qnh, i popoli dell’interno dell’Asia, 50 sottolineando così la disparità quasi ontologica, prima ancora che milita-re, tra le due parti in lotta ; 51 ed anche Erodiano altrove stigmatizza la disomogeneità della formazione nemica. 52 Che d’altra parte agli occhi di Africano sia de facto ancora l’ordinamento statale partico a contrapporsi all’impero emerge anche dal seguito del brano, dove si ribadisce che « coloro che, si potrebbe quasi dire, hanno sempre vinto i Greci raramente sconfissero quelli che dai Greci sono sempre stati sconfitti », ed a proposito dell’apparato bellico avversario si parla espressamente di ta; Pavrqwn bevlh. 53 Gli antichi Persiani che furono sconfitti dai Greci vengono dunque assimilati ai Parti non ancora domati dai Romani : benché, come già si è visto, nell’annoso braccio di ferro per il dominio dell’Oriente i Romani avessero talvolta riportato successi maggiori di quelli che Africano sia qui disposto ad ammettere, con i Parti si era ancora in attesa di una vittoria definitiva. Se l’autore si dimostra dunque ben consapevole dei mutamenti politici avvenuti all’interno del regno nemico e dei ma-nifesti propagandistici diffusi dal nuovo regime, appare tuttavia piuttosto restio a riconoscere sostanziali cambiamenti nell’organizzazione dello stato rivale.
Parthian world, in T. Kaizer, M. Facella (ed. by), Kingdoms and Principalities in the Roman Near East, Stutt- gart, 2010, pp. 57-77.
47 Per la visione romana dell’impero partico come associazione di regna piuttosto che stato unitario cf. Plinio, Nat. Hist. vi, 41 : Persarum regna, quae nunc Parthorum intellegimus ; si vd. anche ivi 112.
48 Erodiano vi, 2.5 : fuvsei d∆ w]n ajlazwvn, kai; tai`~ par∆ ejlpivda~ eujpragivai~ ejpairovmeno~ pavnta rJa/divw~ cei-rwvsasqai prosedovka.
49 Secondo Wheeler, Why the Romans can’t defeat the Parthians, p. 576, tale rivendicazione farebbe riferi-mento al trattato stipulato da Macrino nel 218.
50 Sulla nozione di a[nw ∆Asiva, che per tutta l’età ellenistico-romana stette ad indicare il mondo orientale « costituito dalle satrapie achemenidi di Babilonia Superiore, Media, Partia etc… – l’Oriente insomma della cwvra ‘feudale’ e delle kw`mai, del deserto, delle città carovaniere, delle grandi pianure alluvionali tra i fiumi, degli sterminati altopiani. Questa era appunto la a[nw ∆Asiva, l’Asia vera e propria », si vd. Mazza, Identità etniche e culture locali, pp. 15-16 (citazione a p. 15).
51 Sulla contrapposizione operata nel brano tra hJmei`~ (ijsotimiva pro;~ hJma`~) « che vuole senza dubbio indi-care i Romani nella loro dimensione di impero dotato di egemonia universale » e « l’indicazione dei Persiani come insieme di diverse popolazioni » si vd. già Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, p. 189 e le considerazioni svolte infra, §§ 4-5.
52 Erodiano vi, 7.1 : o}~ a{pax dialuqei;~ ouj rJa/divw~ hjqroivzeto a{te mh; suntetagmevno~ mhde; sunestwv~, ajll∆ o[clo~ ma`llon h] strato;~ uJpavrcwn.
53 F12, 1, 61 ss. Wallraff et al., cit. infra. Meno indicativa invece la menzione dei Parti in F12, 7, 12-13 Wallraff et al. (i 7, 13-14 [135 Vieillefond]) : ajlla; ga;r kai; Pavrqoi tou;~ i{ppou~ ou{tw~ tou;~ eJautw`n ej~ ta;~ mavca~ a[gousi sigw`nta~, che per il contesto del brano sembra avere carattere puramente aneddotico. Allo stesso modo, l’attributo oJ Pavrqo~ riferito a Bardesane (F12, 20, 25 Wallraff et al. (i 20, 29 [183 Vieille-fond]) viene così interpretato da Ross, Roman Edessa, p. 122 : « While there is no reason to believe that the author intentionally misrepresented the philosopher’s ethnicity, this report surely means no more than that Bardaisan looked and sounded like an ‘Oriental’ : he spoke Syriac and probably dressed in Eastern-style clothing like his patron the king » ; cf. inoltre Millar, Roman Near East, pp. 474-475.
laura mecella · umberto roberto110
3.
Nell’imminenza della guerra, l’aspetto più propriamente tecnico-tattico non pote-va naturalmente essere lasciato in secondo piano. Nella rappresentazione di Ero-diano, la paravklhsi~ rivolta da Alessandro all’esercito alla vigilia della partenza per l’Oriente si conclude con la netta affermazione della superiorità militare di Roma : « noi abbiamo invece il vantaggio della tattica e della disciplina, e abbiamo imparato a vincerli sempre ». 54 Pur con i dovuti distinguo, come vedremo, anche la riflessione di Africano si muove sulla stessa lunghezza d’onda : lungi dal temere, co-me Cassio Dione, la forza del nemico, egli si dimostra ottimista sulle potenzialità dell’esercito imperiale. L’autore dei Kestoiv appare molto più vicino alle posizioni di un Flavio Filostrato, che, come è stato recentemente sostenuto, con il suo Heroi-kos avrebbe inteso sostenere la campagna orientale di Severo Alessandro attraverso l’esaltazione dei valori della grecità contro i Persiani : richiamando la protezione dell’eroe Protesilao sulla Grecia, Filostrato lascerebbe trapelare la speranza di una vittoria contro i nuovi Troiani, dimostrando come una parte dell’élite intellettuale dell’impero non fosse affatto scettica sulla possibilità di un successo dell’impresa. 55 Ma se nell’operetta mitologica la problematica strettamente militare rimane sullo sfondo, essa è invece il principale oggetto della trattazione di Africano : dopo aver analizzato le forme di equipaggiamento greche e macedoni, 56 l’autore passa all’esa-me dell’armatura e del sistema di combattimento romani, rilevandone l’efficacia nello scontro frontale tra falangi – elemento che ha consentito la sopraffazione dei Greci – ma la sostanziale inadeguatezza di fronte alla potente missilistica partica. 57
Tou;~ ou\n uJpo; tw`n ÔEllhvnwn aijei; nenikhmevnou~ oiJ tou;~ ”Ellhna~ scedo;n eijpei`n ajei; nenikhkovte~ spanivw~ ejnivkhsan. ai[tion de; prw`ton me;n to; <mh;> i{esqai drovmw/ ej~ ta;~ sumploka;~ tw`/ mh; ta; skeuofovra ajpolipei`n: (ajei; de; tw`/ plinqivw/ th`~ stratia`~ ejgkevkleitai). kaqia`sivn te ej~ govnu, keramwvsante~ to;n strato;n tai`~ ejpibolai`~ tw`n ajspivdwn th`/ spoudh`/ tou ajnalw`sai ta; Pavrqwn bevlh: tovde de; to; ejpithvdeuma kai; ajpravktou~ h/| kai; ajpaqei`~ kaqivsthsin hJlivw/ kai; kovpw/ talai-pwroumevnou~ tw`n barbavrwn ejk diadoch`~ ejpiovntwn kai; ajnacwrouvntwn pavlin, tai`~ tw`n ejqnw`n ejk dialeivmmato~ ejpipompai`~ ajnapauomevnwn. e[ti de; kai; mavcetai ÔRwmai`o~ kaq∆ auJto;n oujdeiv~, oujdev ti~ givnetai pro;~ to; plh`qo~ monomacw`n ajristeuv~: tav te ajpo; sfendovnh~ blhqevnta tai`~ kefa-lai`~ to; kravno~ qlavsanta ejnduvnei, ejkneu`saiv te ferovmenon bevlo~ duvskolon tw`/ tou periaucenivou
54 Erodiano vi, 3.7 : hJmi`n de; kai; to; eu[takton a{ma tw/ kosmivw/ uJpavrcei, kai; nika`n aujtou;~ ajei; dedidavgmeqa [trad. Cassola].
55 Cf. Flavius Philostratus : Heroikos. Translated with an Introduction and Notes by J.K. Berenson Mac- lean, E. Bradshaw Aitken, Atlanta, 2001, pp. lxxxv-lxxxvii ; E. Bradshaw Aitken, Why a Phoenician ? A Proposal for the Historical Occasion for the Heroikos, in Ead., Berenson Maclean (ed. by), Philostratus’s He-roikos, pp. 267-284, partic. pp. 275-284. Diversa la posizione di M. Rahim-Shageyan, Philostratus’s Heroikos and the Ideation of Late Severan Policy toward Arsacid and Sasanian Iran, ibid., pp. 285-315, partic. pp. 303-315, che considera l’opera « written after Alexander Severus’s demise as a posthumous justification (Rechtferti-gungszeugnis) of the emperor’s cautious and defensive policy » (p. 312) ; l’ipotesi appare tuttavia piuttosto debole.
56 Giulio Africano, Cest. F12, 1, 9-44 Wallraff et al. (i 1, 10-49 [104-109] Vieillefond) con la fine ana-lisi di Meißner, Magie, Pseudo-Technik und Paratechnik, p. 21.
57 Per la parte precedente del brano, relativa al confronto tra l’armatura greca e quella romana, si vd. Giulio Africano, Cest. F12, 1, 45-60 Wallraff et al. (i 1, 50-67 [108-109] Vieillefond).
isotimia tra roma e la persia 111
sidhvrou tmhvmati. pro;~ de; touvtoi~ ou[te kekrimevna ajfia`sin ta; ajkovntia, ta; devka eij~ e{na tuco;n fovnon ajnalou`nte~, kai; kontoi`~ pro;~ tou;~ ejpiovnta~ iJppei`~ oujk ajpantw`si mikroi`~. Eij gou`n ti~ qwvraka ÔEllhniko;n kai; kravno~ stratiwvth/ ÔRwmaivw/ periqeivh, kai; konto;n doivh promhkevste-ron, kai; e{kaston tw`n doravtwn ejf∆ eJkavstou skopou bavllein kaq∆ auJtovn te e{kaston didavskoi mavcesqai, <kai;> e[sq∆ o{te katasthvseien drovmon, wJ~ ojxei`an genevsqai th;n ejnto;~ bevlou~ toi`~ polemivoi~ ejmbolhvn, oujk a]n bavrbaro~ koptovmeno~ ajrkevseie ÔRwmaivoi~.Dunque coloro che, si potrebbe quasi dire, hanno sempre vinto i Greci raramente sconfis-sero quelli che dai Greci sono sempre stati sconfitti. La prima causa è che non si lanciano di corsa nella mischia per non lasciare gli animali da soma (sempre circondati dal quadrato dell’esercito). Si piegano in ginocchio, coprendo a testuggine l’armata con file di scudi nello sforzo di neutralizzare i proiettili dei Parti : questa pratica però li rende inerti, poiché li lascia incolumi ma oppressi dal sole e dalla fatica, mentre i barbari compiono attacchi in successione per poi ritirarsi di nuovo, con assalti a intervalli da parte di genti che sono ristorate. E ancora, nessun Romano combatte per conto proprio, né eccelle combattendo da solo contro la folla ; i missili lanciati dalla fionda infrangono l’elmo e penetrano nel capo, ed è arduo schivare il dardo in arrivo muovendo la testa per il taglio del collare di ferro. Oltre a ciò non lanciano i giavellotti con discernimento, ma ne perdono dieci per uccidere eventualmente un solo uomo, e non possono respingere l’attacco della cavalleria nemica con le loro corte lance. Se dunque si procurassero al soldato romano un elmo e una corazza di tipo greco, e gli si desse una lancia più lunga, e a ciascuno si insegnasse a tirare ogni giavellotto contro un obiettivo specifico e a combattere per conto proprio, e qualche volta si imponesse la corsa per attaccare velocemente i nemici entro la traiettoria del missile, il barbaro, colpito, non resisterebbe ai Romani. 58
Se elmo e corazza si rivelano eccessivamente vulnerabili ai proiettili nemici, la formazione legionaria ‘a quadrato’ consente solo scarse possibilità di intervento contro il più mobile schieramento avversario : 59 Africano suggerisce così l’adozio-ne di un’armatura più vicina a quella un tempo adottata dai Greci e una migliore preparazione nelle tecniche d’assalto. L’invito ad adottare pratiche di combatti-mento meno statiche e ad addestrare le truppe al lancio di missili è operato attra-verso il ricorso ai modelli classici : come ha recentemente puntualizzato Meißner, il drovmo~ richiama la rapida avanzata dei Greci a Maratona descritta da Erodoto, 60 così come il monomacei`n viene esemplato sul paradigma dei valorosi opliti greci – capaci di combattere tanto in file serrate che individualmente – contrapposto alla compattezza monolitica della falange romana ; 61 infine, è sempre all’armatura
58 Giulio Africano, Cest. F12, 1, 61-79 Wallraff et al. (i 1, 68-88 [108-111] Vieillefond). Il giudizio di Africano si dimostra equilibrato, immune dagli eccessi della propaganda severiana secondo cui soltanto grazie all’aiuto dei transfughi romani giunti dopo la sconfitta di Pescennio Nigro i Parti sarebbero riusciti a migliorare i propri armamenti (Erodiano iii, 4.8-9). Valutazione affine a quella di Africano e.g. in Giu-liano, Caes. 25 c-d.
59 Cf. l’accurata analisi di Wheeler, Why the Romans can’t defeat the Parthians, pp. 576-577 e Meißner, Magie, Pseudo-Technik und Paratechnik, pp. 22-23.
60 Erodoto vi, 112 : … oiJ ∆Aqhnai`oi drovmw/ i{ento ej~ tou;~ barbavrou~ … ; cf. Meißner, Magie, Pseudo-Technik und Paratechnik, p. 22. A proposito della falange oplitica greca, Africano in precedenza aveva spiegato come proprio nella velocità risiedesse il segreto per attaccare incolumi nonostante i bersagli nemici : la lunga gittata dei lanci consente infatti ad un’armata che procede rapidamente di avanzare mentre il proiettile è ancora in aria (F12, 1, 19-22 Wallraff et al. = i 1, 22-25 [104-105 Vieillefond]). Il passo relativo ai Romani non si comprende se non alla luce della precedente descrizione della tecnica greca.
61 Per il richiamo al modo di combattere greco cf. quanto precedentemente notato da Africano (F12, 1,
laura mecella · umberto roberto112
oplitica che Africano guarda per la revisione di quella in uso ai suoi tempi. 62 Ma la ripresa di moduli più antichi e apparentemente anacronistici tratti dalle auctorita-tes del passato è un fenomeno tipico della trattatistica tecnica, non solo militare, del mondo ellenistico-romano (protrattosi anche in età bizantina) che non inficia il valore storico di questa testimonianza. 63 L’urgenza di un adeguamento dei pro-pri mezzi d’attacco alle strategie degli avversari trova piena corrispondenza nella realtà contemporanea : nonostante la patina letteraria del testo e senza voler ne-cessariamente fare del nostro autore uno specialista di arte militare, 64 è evidente l’interesse per quel dibattito sulla necessità di una riorganizzazione dell’esercito che proprio alla corte di Severo Alessandro dovette essere particolarmente acceso, come dimostra l’impulso dato proprio in questo periodo allo sviluppo delle unità di arcieri e della cavalleria pesante. 65
Per il suo soggiorno a Roma, i suoi legami con l’imperatore e lo spiccato interes-se per la scienza bellica Africano si pone dunque come un osservatore privilegiato dei delicati mutamenti che intercorsero, sia nel mondo romano che in quello al di là del Tigri, tra gli anni ’20 e ’30 del iii secolo e delle tensioni diplomatiche che ne seguirono, facendosi portavoce delle aspirazioni e delle istanze del governo impe-riale. 66 Con la positiva valutazione secondo cui, rinnovando tattiche e armamenti, oujk a]n bavrbaro~ koptovmeno~ ajrkevseie ÔRwmaivoi~, Africano risponde alle perples-sità di parte dell’opinione pubblica con una dimostrazione tecnico-scientifica di come, con un’adeguata preparazione, non vi fossero motivi per limitarsi ad una mera politica di contenimento. 67 L’erede romano di Alessandro il Grande aveva tutte le chances di sconfiggere il nuovo Artaserse. 68
15-16 Wallraff et al. = i 1, 17-18 [104-105 Vieillefond]) : sunaspivzein te h[/desan kai; e{kasto~ aujtw`n kaq∆ auJto;n ejmavceto, wJ~ ãei\naià th;n ajreth;n tou stratiwvtou diplh`n kai; koinh`/ kai; movnou.
62 A differenza di quello romano, l’elmo greco era diplou`~ (Giulio Africano, Cest. F12, 1, 9 Wallraff et al. = i 1, 10-11 [104-105 Vieillefond]) ; cf. ivi F12, 1, 9 ss. anche per la puntuale descrizione, oltre che di questa tipologia di pi`lo~, dell’armatura greca che secondo Africano sarebbe stata più adatta a fronteggiare le raffiche dei dardi nemici (per i Realien si vd. in generale J. K. Anderson, Military Theory and Practice in the Age of Xenophon, Berkeley-Los Angeles, 1970, pp. 13-42 e ivi pp. 84-93 sulle modalità di combattimento).
63 Meißner, Magie, Pseudo-Technik und Paratechnik, pp. 30-31.64 Sugli aspetti letterari del brano ha insistito da ultimo Meißner, Magie, Pseudo-Technik und Paratechnik,
passim ; priva di fondamento l’ipotesi secondo cui Africano avrebbe fatto parte dell’esercito avanzata da H. Gelzer, Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie, i, Die Chronographie des Julius Africanus, Leipzig, 1880, p. 8. 65 Erodiano vi, 7.8 ; ha Alex. Sev. 56.5.
66 Contra Wheeler, Why the Romans can’t defeat the Parthians, p. 576, secondo cui « Africanus openly que-stions Rome’s military superiority to Parthia, a view shared by Dio (40.14.3) and Justin (41.1.7) and he has, moreover, specific criticisms to support his case ». Una tale vis polemica sembra però estranea al dettato del brano, che nonostante tutte le criticità rilevate nel sistema militare romano si conclude con la piena fiducia nella possibilità di una riaffermazione sul nemico.
67 Sul valore della tevcnh nell’impianto argomentativo di Africano, anche nei restanti capitoli del settimo Kestov~, si vd. Meißner, Magie, Pseudo-Technik und Paratechnik, passim. Tralascio qui il problema degli aspetti ‘magici’ di alcune delle tecniche di guerra altrove proposte dall’autore, e dell’eredità della tradi-zione pseudo-democritea confluita nei Kestoiv : si vd. sul tema F. C. R. Thee, Julius Africanus and the Early Christian View of Magic, Tübingen, 1984 ; E. L. Wheeler, Cambyses and the Persea Tree : Magic in Damocritus’ Tactica and Julius Africanus’ Kestoiv, « Electrum », 1 (1997), pp. 209-220 ; Id., Why the Romans can’t defeat the Parthians, pp. 577-578 ; M. Wallraff, Magie und Religion in den Kestoi des Julius Africanus, in Id., Mecella (hrsg. v.), Die Kestoi, pp. 39-52 ; Wallraff et al., Iulius Africanus. Cesti, pp. xxvii-xxxii.
68 Sull’imitatio Alexandri dell’ultimo esponente della dinastia severiana cf. in partic. Erodiano v, 7.3 e
isotimia tra roma e la persia 113
4.
Il giudizio sui Persiani appare in piena sintonia con l’interpretazione complessiva della storia che Africano aveva già dato nella sua principale opera storica, le Chro-nographiae. Si è ben chiarito come secondo Africano la rivendicazione persiana dell’ ijsotimiva con Roma sia ‘illegittima’. Perfino la scelta lessicale sottolinea dra-sticamente l’assurdità della pretesa. La contrapposizione, infatti, non potrebbe essere più netta : da una parte ci sono i Romani (hJmei`~, e vale la pena soffermarsi sul significato di questo pronome utilizzato dal cristiano Africano) ; dall’altra, ta; a[nw th`~ ∆Asiva~ e[qnh, secondo la formula utilizzata per definire la disomogenea molteplicità delle genti sotto il dominio del principe sasanide Ardašır. L’uso di questa espressione invece del nome ‘Persiani’ non credo si spieghi con l’esigenza stilistica di evitare ridondanti ripetizioni. È invece di per sé un potente rifiuto del- l’ ijsotimiva, una chiara allusione a quella disparità tra Roma e il nuovo impero dei Sasanidi che si è definita come ‘ontologica’. Si intende di seguito analizzare le ra-gioni di tale disparità nel pensiero di Giulio Africano, per chiarire ulteriormente il rifiuto tanto drastico dell’ ijsotimiva.
Come presupposto del discorso, è bene riconsiderare i tratti più importanti della complessa identità di Africano. Nato tra il 170 e il 180 ad Aelia Capitolina, la città pagana fondata sulle rovine dell’antica Gerusalemme dopo la rivolta ebraica in età adrianea, Sesto Giulio Africano si forma in un ambiente dove convivono soldati, veterani romani ed ”Ellhne~. Come altri centri dell’Oriente romano, la colonia Aelia Capitolina è un’‘isola’ di cultura ellenistico-romana in un tessuto fortemen-te dominato dal sostrato giudeo-aramaico. Questo carattere incide sull’identità di Africano, esponente dell’élite municipale e intellettuale di cultura ellenistica nell’età della Seconda Sofistica ; ma anche orgoglioso cittadino romano, piena-mente in sintonia con la politica orientale della dinastia severiana da Caracalla a Severo Alessandro. È questo un carattere di grande importanza : gran parte delle élites municipali dell’Oriente romano aderisce al programma dei Severi, e aspira ad una maggiore unità dell’impero attraverso la collaborazione tra una monar-chia rinvigorita nei suoi poteri e nel suo carisma e un ceto aristocratico colto e ambizioso. Come vedremo, il caso di Africano è emblematico della tendenza di alcuni intellettuali ad assumere posizioni decisamente filogovernative e, come nel caso dei rapporti con i Persiani, perfino improntate ad un drastico conservatori-smo. 69
ha Alex. Sev. 50.4 (per gli altri riferimenti nella Historia Augusta si vd. L. Cracco Ruggini, Un riflesso del mito di Alessandro nella « Historia Augusta », « bhac », 1964/65, Bonn, 1966, pp. 79-89, partic. pp. 86-87 e J. M. Blázquez, Alejandro Magno, modelo de Alejandro Severo, in Croisille [éd. par], Neronia IV, pp. 25-36, che tende comunque a negare l’attendibilità delle informazioni discusse). Sulla contrapposizione tra Ardašır quale nuovo Artaserse ed Alessandro Severo novello Alessandro Magno si vd. in partic. W. Ball, Rome in the East. The Transformation of an Empire, London-New York, 2000, p. 22.
69 Sul rapporto tra l’intellettuale Giulio Africano e la dinastia dei Severi cf. Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, capitoli 1-2 e 6. Utile pure Adler, Sextus Julius Africanus, pp. 548-550. Per il significato della fondazione di Aelia Capitolina nella regione : B. Lifshitz, Jérusalem sous la domination romaine. Histoire
laura mecella · umberto roberto114
Fino almeno all’autunno 221, Africano visse nell’Oriente romano, viaggiando tra Caria ed Egitto, soggiornando a lungo a Edessa, presso Abgar IX e suo figlio, il pasgriba Ma‘nu, e lungo i confini tra impero romano e regno dei Parti. Queste sue esperienze si riflettono nell’opera storica a noi giunta in frammenti, le Chronogra-phiae, terminate, secondo l’esatta indicazione dell’autore, nel terzo anno di Elaga-balo, sotto il consolato di C. Vettio Grato Sabiniano e M. Flavio Vitellio Seleuco, 221 d.C. La giustificazione politica, culturale e religiosa del rifiuto dell’ ijsotimiva tra Romani e Persiani si trova già in quest’opera che, come noto, rappresenta la prima cronaca universale cristiana, una sintesi potente tra storiografia e cronogra-fia ellenistico-romane e tradizione storiografica giudeo-ellenistica. 70
Nell’interpretazione della storia universale di Africano, uno dei problemi fon-damentali è quello di conciliare l’egemonia mondiale di Roma, e la sua tensio-ne ecumenica (potentemente accentuata da Caracalla, che è l’imperatore sotto il quale furono composte le Chronographiae), con la visione cristiana della storia. Gli studiosi della questione, da Santo Mazzarino a William Frend, da Marta Sordi a William Adler, hanno riconosciuto in Giulio Africano un esponente di spicco di quella parte del cristianesimo che, nell’età tra Commodo e Severo Alessandro, aspirava ad una riconciliazione con l’autorità imperiale ed esprimeva il suo lea-lismo e la sua adesione al programma monarchico dei Severi, in forme coerenti con la fede cristiana. Secondo W. Frend, si tratta di una massa maggioritaria di cristiani, che ben conosciamo attraverso le critiche di esponenti più rigoristi come Tertulliano o Ippolito. 71
Per giustificare in chiave cristiana l’impero romano, Africano ricorre in primo luogo ad uno dei concetti condivisi dalla cultura ellenistico-romana e da quel-
de la ville depuis la conquête de Pompée jusqu’à Constantin (63 a.C. - 325 p.C.), « anrw », ii.8, Berlin-New York, 1977, pp. 444-489 ; B. Isaac, Roman Colonies in Judaea : The Foundation of Aelia Capitolina, in Id., The Near East under Roman Rule. Selected Papers, Leiden-New York-Köln, 1998, pp. 87-111 ; F. Millar, The Roman Coloniae of the Near East : a study of Cultural relations, in H. Solin, M. Kajava (ed. by), Roman Eastern Policy and other Studies in Roman History, Helsinki, 1990, pp. 7-58, poi in Id., Rome, the Greek World, and the East, ed. by H. M. Cotton, G. M. Rogers, Chapel Hill, 2006, pp. 164-222, partic. pp. 188-191 : Millar lamenta la mancanza di notizie sull’identità della comunità ; l’orgoglio di Africano per la sua cittadinanza romana, testimoniato pure dal suo giudizio su Roma e dall’impegno al servizio dei Severi, può essere un significativo indizio del sentimento di appartenenza alla cultura ellenistico-romana che caratterizza i cittadini di Aelia nei primi decenni del iii secolo.
70 Cf. Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, capitoli 3 e 6 ; importanti pure i saggi in Wall- raff (hrsg. von), Julius Africanus und die christliche Weltchronistik. E più recentemente M. Wallraff, The Beginnings of Christian Universal History. From Tatian to Julius Africanus, « zac », 14 (2010), pp. 540-555.
71 Cf. Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, cap. 4. In generale sul tentativo di parte dei cristiani di età severiana di conciliare fede religiosa e lealtà alla dinastia si vd. M. Sordi, I rapporti fra il Cristianesimo e l’impero dai Severi a Gallieno, « anrw », ii.23.1, Berlin-New York, 1979, pp. 340-374, partic. pp. 342-343 e 353-354 ; G. Jossa, Ippolito e la chiesa di Roma, in Storia della società italiana, 3, pp. 705-746, partic. pp. 711-714 ; J. Lehnen, Zwischen Abkehr und Hinwendung. Äußerungen christlicher Autoren des 2. und 3. Jahrhunderts zu Staat und Herrscher, in R. v. Haeling (hrsg. von), Rom und das himmlische Jerusalem, Darmstadt, 2000, pp. 1-28, partic. pp. 15-19. Su Africano come rappresentante di questi gruppi di cristiani disposti alla conciliazio-ne con l’impero cf. W. H. C. Frend, Open Questions Concerning the Christians and the Roman Empire in the Age of the Severi, « JThS », 25 (1974), pp. 333-351, partic. 350-351 ; S. Mazzarino, L’impero romano, ii, Roma-Bari, 19883, p. 486 ; Adler, The Cesti and Sophistic Culture in the Severan Age, pp. 9-10 ; Roberto, Le Chronogra-phiae di Sesto Giulio Africano, pp. 223-229.
isotimia tra roma e la persia 115
la giudeo-cristiana, l’idea di translatio imperii. Lo sforzo di sintesi che è alla base delle Chronographiae si esprime sovente nell’uso di sincronismi o idee che fanno da ponte tra cultura ellenistico-romana e cristianesimo. L’interpretazione della storia politica, secondo la translatio imperii, scandisce l’esposizione di Africano. 72 Nelle Chronographiae, Roma è il quinto e ultimo impero dopo Assiri, Medi, Persia-ni e Macedoni. Ed è impero al servizio della provvidenza, perché proprio all’inizio della monarciva tw`n Kaisavrwn – e si badi la pregnanza di questa espressione per un autore che scrive sotto Caracalla – il Cristo decise di incarnarsi per svolgere la sua missione di salvezza. Il ruolo di Roma nella storia, secondo l’idea di translatio imperii, trova una giustificazione provvidenziale, dunque religiosa, attraverso il fondamentale sincronismo tra l’inizio della monarchia dei Cesari e l’Epifania del Cristo. Si veda al riguardo il frammento 15, probabilmente proveniente dal pro-emio del primo o del secondo libro delle Chronographiae. Nel presentare la cor-rispondenza metodologica e culturale tra la storiografia degli Ebrei, conservata nella Sacra scrittura, e la historia ellenistico-romana, Africano (F15, 10-14 Wallraff-Roberto) afferma :
ejk touvtwn ga;r ∆Ioudai`oi to; ajnevkaqen gegonovte~ ajpo; ∆Abraa;m ajrxavmenoi ajtufovterovn te kai; ajnqrwpivnw~ meta; tou ajlhqou`~ dia; tou Mwusevw~ pneuvmato~ didacqevnte~, e[k te tw`n loipw`n ÔEbrai>kw`n iJstoriw`n, ajriqmo;n ejtw`n pentakiscilivwn pentakosivwn eij~ th;n ejpifavneian tou Sw-thrivou Lovgou th;n ejpi; th`~ monarciva~ tw`n Kaisavrwn khrussomevnhn paradedwvkasin. 73Gli Ebrei, che traggono origine dai Caldei attraverso Abramo, istruiti senza superbia, se-condo l’umana misura e con verità dallo spirito di Mosè, e dalle altre storie ebraiche, han-no tramandato un numero di 5500 anni fino alla Epifania del Logos salvatore, annunciata sotto la monarchia dei Cesari.
È bene sottolineare il messaggio politico. Il sincronismo tra l’egemonia mondiale di Roma e l’Epifania del Cristo sulla terra si realizza quando a Roma termina il regime repubblicano e si insedia la monarciva tw`n Kaisavrwn. Non possediamo purtroppo le Chronographiae per intero, ma altri frammenti confermano questo giudizio di Africano. La sua posizione politica rispetto alla monarciva si unisce con significativa sintonia a idee già diffuse da Melitone di Sardi, Ireneo di Lione, Ori-gene. Africano evidenzia la sua identità di cristiano leale verso Roma e disposto all’intesa con l’impero ; allo stesso tempo, riconosce le aspirazioni della dinastia severiana ad una monarciva forte e garante dell’ordine terreno, perché legittimata dalla provvidenza divina. Si può escludere che Africano fosse un monarchianista ; ma certamente il suo cristianesimo è segnato da una profonda volontà di concilia-zione con il regime dei Severi.
Tenendo presente il giudizio su Roma nelle Chronographiae, terminate nel 221,
72 Cf. Giulio Africano, Chron. T6 ; F89, 53-57 ; F73, 1-7 Wallraff-Roberto. Cf. pure Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, cap. 4.
73 Fondato sull’indicazione del Vangelo di Luca 2.1, il sincronismo tra la fondazione dell’egemonia universale di Roma sotto Augusto e l’incarnazione del Cristo è ben attestato già a partire da Melitone di Sardi (si vd. Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica iv, 26.7) ; e in anni molto vicini ad Africano torna in Ippolito, Commentario a Daniele iv, 9. Cf. in generale Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, pp. 123-124.
laura mecella · umberto roberto116
torniamo ora ai Kestoiv, che furono composti tra il 227 e il 231. 74 Abbiamo visto che le rivendicazioni dei Persiani all’ ijsotimiva con i Romani trovano un fermo rifiuto. Nella sua durezza, Africano è coerente con il pensiero storico delle Chronographiae e con l’interpretazione cristiana del ruolo di Roma come impero della Provvi-denza. In particolare, la scelta del Cristo di incarnarsi in sincronia con l’impero augusteo offre opportuna giustificazione storica al dominio universale che i Ro-mani conquistano dopo il trionfo sui Tolemei (Giulio Africano, Chron. F89, 53-57 e T6 Wallraff-Roberto). Naturalmente, in una visione cristiana della storia nulla è lasciato alla coincidenza fortuita. Già prima delle Chronographiae, la riflessione di alcuni pensatori cristiani esalta il dominio universale di Roma come strumento provvidenziale per l’evangelizzazione. È la pace di Roma che garantisce al nascen-te cristianesimo di propagarsi rapidamente per il bacino del Mediterraneo. Anche se questa idea non è presente nei frammenti superstiti delle Chronographiae, il giudizio fortemente positivo su Roma consente di ipotizzare che Africano condi-videsse questa visione. D’altra parte, in anni vicini alle Chronographiae, Origene ribadisce che la stessa provvidenza ha favorito l’egemonia romana per agevolare la diffusione del Vangelo a tutte le genti unite sotto l’impero (Contra Celsum ii, 30). L’intima connessione tra la diffusione del cristianesimo e la posizione egemonica di Roma esclude, sul piano dell’interpretazione religiosa della storia, che qualsiasi altra potenza possa aspirare ad una condizione di ijsotimiva con l’impero romano.
D’altra parte, la posizione esclusiva di Roma come impero universale si spiega anche in una prospettiva apocalittica della storia. Si tratta di una dimensione in-terpretativa di grande importanza per comprendere non solo un problema assai dibattuto in età severiana, ma pure la genesi stessa delle Chronographiae. In breve, Africano scrive per dimostrare che la fine del mondo è più lontana di quanto con angoscia temessero gruppi diversi dell’Oriente romano, dai seguaci alessandrini del cronografo Giuda (Eusebio, Storia ecclesiastica vi, 7) alle masse che aderivano al montanismo. La riflessione di Africano si allinea in piena sintonia con l’inter-pretazione della fine dei tempi svolta da Ippolito qualche anno prima. C’è piena corrispondenza tra i due per quanto riguarda la definizione cronografica della questione. Diverso è invece il giudizio sul ruolo dell’impero romano in una pro-spettiva apocalittica. Punto di partenza per Ippolito è l’esegesi di un difficile passo paolino in ii Tessalonicesi 2.7. Paolo esorta i suoi lettori spaventati a non considera-re imminente la fine del mondo. C’è qualcosa che trattiene – un katéchon, appunto –, che impedisce la venuta dell’Anticristo. Ippolito riflette sulla questione nel De Christo et Antichristo (25.1 ; 28 ; 33 ; 63) ; e, soprattutto, nel Commento a Daniele iv. Siamo nei primi anni del terzo secolo, tra il 200 e il 202-203. L’immagine di Roma in Ippolito è fortemente negativa. Poiché l’impero perseguita i cristiani, Ippolito lo considera la quarta bestia della visione di Daniele 7 (iv, 5.1 e 7.4) ; e afferma chia-ramente che l’impero romano rappresenta il katéchon : trattiene la venuta dell’An-ticristo, ma ad un prezzo altissimo. I Romani, infatti, fanno soffrire terribilmente
74 Per la datazione dei Kestoiv al periodo 227-231 cf. Vieillefond, Les ‘Cestes’, pp. 60-64 ; Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, p. 186 ; Wallraff et al., Iulius Africanus. Cesti, p. xix.
isotimia tra roma e la persia 117
i popoli loro sottomessi. La questione della fine del mondo è centrale pure nel-le Chronographiae di Africano, che ricorda di aver composto un Peri; eJbdomavdwn, un trattato sul Libro di Daniele propedeutico alla sua opera storica (F93, 102-103 Wallraff-Roberto). Purtroppo, anche in questo caso, non possediamo frammenti sull’interpretazione del katéchon nelle Chronographiae. E tuttavia, è significativo osservare come il pensiero di Africano su Roma, tanto nelle Chronographiae, quan-to nel passo dei Kestoiv in esame rovesci completamente la negatività dell’impero romano descritta da Ippolito. E tanto più emblematico è il rovesciamento se si considera il passo in Comm. in Dan. iv, 8.4-7. Ippolito si domanda infatti per quale ragione il profeta indichi chiaramente la corrispondenza tra la prima bestia e l’im-pero babilonese, la seconda bestia e l’impero persiano, la terza bestia e l’impero degli eredi di Alessandro ; e per quale ragione taccia invece sull’identità della quar-ta bestia. Nessuno, a suo giudizio, può dubitare che la quarta bestia sia Roma. Secondo Ippolito, la spiegazione del silenzio del profeta è piuttosto evidente : i primi tre imperi erano compagini culturalmente e politicamente unitarie ; l’impe-ro romano è invece un’entità priva di unità e di identità :
La bestia che ora governa, invece, non è un unico popolo ; raduna al contrario per sé e prepara alla guerra un esercito da tutte le lingue e da uomini di ogni stirpe. Tutti insieme sono chiamati Romani, pur non provenendo tutti dalla stessa terra (iv, 8.7 : oiJ pavnte~ me;n ÔRwmai`oi kalouvmenoi, mh; o[nte~ de; pavnte~ ejk mia`~ cwvra~. Si vd. pure iv, 9.2-3).
I ‘Romani’ rappresentano dunque una commistione di popoli tenuti insieme dalla brutale coercizione di Roma. Per questo il passo di Daniele non li ha descritti con una precisa indicazione etnica, come invece avviene riguardo ai Persiani : « Allo stesso modo anche i Persiani sono un’unica stirpe, sordida ma con una medesima lingua ; per questa ragione li ha associati ad un orso (iv, 8.5) ». Come suggestivo contrappunto al pensiero di Ippolito, la riflessione di Africano su Roma respinge questa esegesi del silenzio di Daniele. E il passo dei Kestoiv ne è un frammento fondamentale. Roma è l’unico impero universale, unito e compatto, al quale si contrappongono popolazioni divise e disomogenee. In questo senso si spiega la contrapposizione pregnante tra hJmei`~ (cioè i Romani, anche quelli di fede cristia-na) e ta; a[nw th`~ ∆Asiva~ e[qnh (dunque i Persiani). Si conferma in questo modo l’assurdità di ijsotimiva tra Roma e Persia, in quanto contraria all’interpretazione religiosa del dominio universale romano. 75
5.
Oltre ai presupposti religiosi, vi sono altri fattori di carattere politico e culturale che spiegano il rifiuto di Africano all’ ijsotimiva. Per uno storico che accetta la
75 Per il testo dei passi analizzati, con commento, cf. L’Anticristo, vol. i. Il nemico dei tempi finali. Testi dal ii al iv secolo, a cura di G. L. Potestà e M. Rizzi, Milano, 2005, partic. pp. 189-231 e 516-529. Sul passo di Ippolito si vd. pure Mazzarino, L’impero romano, ii, pp. 470-490. L’identificazione del katéchon con l’impero romano è pure in Tertulliano, De resurrectione mortuorum 24, 18 : iam enim arcanum iniquitatis agitatur : tantum qui nunc tenet teneat, donec de medio fiat – quis, nisi Romanus status, cuius abscessio in decem reges dispersa Antichristum superducet ? : cf. L’Anticristo, pp. 90-92 e commento a pp. 487-488. L’opera di Tertulliano è da collocare verso la fine del primo decennio del iii secolo.
laura mecella · umberto roberto118
translatio imperii, la stessa dinamica di alternanza tra egemonie esclude le pretese dei Sasanidi. In un preciso periodo della storia universale, gli Achemenidi hanno avuto spazio per il loro dominio sull’ecumene. Alla fine dell’impero multicultu-rale persiano, abbattuto da Alessandro, segue la supremazia degli Stati ellenistici. Dopo la sconfitta di Cleopatra, Roma eredita nell’ecumene mondiale il ruolo dei Macedoni (Giulio Africano, Chron. F89, 53-57 Wallraff-Roberto). La posizione di Africano è dunque netta : dopo Azio Roma non ha rivali nel dominio del mondo. Accettare, come aveva fatto in età augustea Pompeo Trogo (xli, 1.1), la possibi-lità di un dominio congiunto e paritario sull’ecumene da parte di Roma e della Persia – e dunque l’ ijsotimiva – è visione in inconciliabile contrasto con l’idea di translatio imperii. E, per il lealista Africano, andava a scontrarsi con la supremazia dell’impero di Roma, fondata su radici religiose. L’idea di una ijsotimiva tra Roma e un’altra potenza, il regno dei Parti o la Persia, poteva perfino indicare una mode-rata opposizione all’egemonia romana. Per Africano, l’ipotesi di un bipolarismo romano-persiano è dunque impossibile e da respingere. 76
V’è ancora un altro aspetto che la lettura del brano suggerisce. Nel rifiuto dell’ ijsotimiva ai Persiani confluiscono anche i temi del confronto tra Occidente e Oriente che definisce da secoli il rapporto tra Greci, in quanto ”Ellhne~, e Per-siani. In primo luogo, Africano contrappone all’unità dell’impero romano (hJmei`~) la frammentazione degli e[qnh dell’Asia che non costituiscono un’unità politica e non hanno un’identità culturale pari a quella occidentale. Sul versante culturale la disparità tende ad amplificarsi. I Persiani, infatti, non sono inclini alla ejleuqeriva ; nella visione ellenistico-romana sono piuttosto schiavi, vittime di uno sfrenato dispotismo che li pone in condizione d’inferiorità rispetto agli Occidentali. 77 E il giudizio si esprime ancor più chiaramente quando, come abbiamo visto sopra,
76 Le sconfitte inflitte dai Persiani all’impero, soprattutto l’umiliazione di Valeriano, costringeranno i Romani a superare il loro senso di superiorità, così drasticamente espresso da Africano ; e porteranno a recuperare la visione, già presente in Pompeo Trogo, di due imperi di uguale potenza e dignità. Ne ab-biamo una significativa testimonianza nel resoconto di Pietro Patrizio, frammento 13 Müller, sugli accordi di pace tra Galerio, Cesare vittorioso, e i delegati del re Narsete nel 298. Il passo di Pietro Patrizio esprime l’equilibrio tra le due potenze attraverso la suggestiva immagine di Roma e la Persia come i « due occhi » del mondo ; e indica una certa deferenza nei confronti dello Stato persiano che è tipica di diversi autori dell’età giustinianea. Ve ne sono evidenti tracce anche in Procopio, Menandro, Pseudo-Maurizio ; oltre che nel trattato De scientia politica attribuito a Menodoro (i, 63-68). Si tratta di un giudizio che, a differenza di quanto espresso da Africano, esclude i Persiani dal novero dei barbari ; e ne esalta le virtù di civiltà speculare a quella ellenistico-romana. Si veda pure Giovanni Lido, De magistratibus iii, 34, che equipara l’impero sasanide alla repubblica romana prima di Mario. L’immagine di Roma e la Persia come i due occhi del mondo torna anche in Teofilatto Simocatta iv, 11.1 a testimonianza della forte vicinanza tra le potenze, anche nei rapporti tra le rispettive famiglie regnanti. In generale sulla teoria dei due lumi : P. Lerza, L’immagine delle due potenze = due occhi/luci nelle testimonianze antiche, « Maia », 34 (1982), pp. 219-225 ; sul passo di Pietro Patrizio cf. A. Martolini, I frammenti dell’Anonymus post Dionem/Pietro Patrizio nell’ambito della storiografia tardoantica e bizantina, in U. Roberto, L. Mecella (a cura di), Dalla storiografia ellenistica alla storiografia tardoantica : aspetti, problemi, prospettive, Soveria Mannelli, 2010, pp. 209-237, partic. pp. 235-236.
77 Sull’incapacità dei barbari di governarsi secondo principi di libertà e la loro sfrenata inclinazione al dispotismo cf. U. Roberto, Immagini del dispotismo : la Persia sassanide nella rappresentazione della cultura ellenistico-romana da Costantino a Eraclio, in D. Felice (a cura di), Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico, Napoli, 2001, pp. 25-61.
isotimia tra roma e la persia 119
si confrontano tattiche e organizzazione militare : ormai Africano parla esplici-tamente dei Persiani come bavrbaroi che contendono ai Romani, difensori della civiltà ellenistico-romana, la supremazia militare. 78 I Persiani sono bavrbaroi : non bisogna trascurare la forza di questi pregiudizi nel valutare le parole di Africano. Ed essi appaiono tanto più significativi, se si considera che nella sua ricostruzione dell’origine e della trasmissione del sapere Africano considera l’Oriente, e in par-ticolare i territori abitati dai popoli sotto il dominio dei Sasanidi, come culla della civiltà. Questa idea che l’impero persiano fosse depositario di una sapienza arcaica e superiore condiziona la visione positiva della Persia in alcuni ambiti culturali tardoantichi ; ma è drasticamente respinta da Africano su basi politiche, religio-se, culturali. 79 Nel passo dei Kestoiv, infatti, c’è una significativa integrazione tra la giustificazione politico-culturale della superiorità dei Romani, fondata su una visione provvidenziale della storia ; e i suggerimenti di carattere tecnico-empirico che Africano offre per realizzare questa superiorità anche sul campo di battaglia. Speculazione teorica e sfoggio di erudizione tecnico-scientifica : un accostamento ‘identificativo’ di Africano, che già nelle Chronographiae fonda il suo tentativo di trovare un punto di conciliazione tra visione cristiana della storia e civiltà ellenisti-co-romana nell’uso della scienza cronografica come chiave di lettura dell’azione della Provvidenza. 80
La riconquista della libertà – e, senza dubbio, questo tema era sottolineato nei dispacci che giungevano dai Sasanidi alla corte di Severo Alessandro – induce, secondo Africano, i popoli d’Oriente all’insolenza tipica dei barbari. Da qui la richiesta assurda di ijsotimiva, perché fondata su una falsa pretesa di uguaglianza con Roma. Sta all’imperatore, che porta il nome di Alessandro, respingere con la forza una rivendicazione che turba l’ordine delle cose. Agli occhi del cristiano Africano, l’incontro provvidenziale tra Roma e il cristianesimo emerge in tutta la sua attualità pure al cospetto delle richieste insolenti dei Persiani.
78 Cf. Giulio Africano, Cest. F12, 1, 61-79 Wallraff et al. (i 1, 68-88 [108-111] Vieillefond) citato sopra e Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, cap. 3.
79 Gli autori di iii secolo recuperano l’immagine di grandezza della Persia sasanide emula della Persia achemenide : Cassio Dione lxxx, 4.1-2 ; Erodiano vi, 2.1-2 ; Zonara xii, 15. La presunta superiorità cul-turale dei Sasanidi è ancora riflessa nel giudizio dei filosofi neoplatonici convinti che la società persiana fosse più aperta e tollerante di quella romana. Dopo le drastiche misure antipagane del 529, alcuni intel-lettuali decisero di rifugiarsi in Persia ; ma furono presto delusi e cercarono di far ritorno nel mondo ro-mano. Sull’atteggiamento di deferenza verso i Persiani e sulla posizione di Agazia (in particolare ii, 27.6-8 Keydell), che cercò di reagire a questo atteggiamento, cf. S. McDonough, Were the Sasanians Barbarians ? Roman Writers on the ‘Empire of the Persians’, in R. Mathisen, D. Shanzer (ed. by), Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World, Farnham, 2011, pp. 55-65. Significativo, per esempio, un passo di Procopio (Bellum Persicum i, 2.1-10), forse da Prisco, secondo il quale Arcadio affidò la tutela del piccolo Teodosio ii a Yazdgerd i. In certi casi l’ammirazione verso i Persiani prendeva perfino forma di Persophilia. Sulla rappresentazione del mondo persiano in epoca tardoantica, tra realtà, topoi e sentimenti di superio-rità, cf. J. W. Drijvers, A Roman Image of the ‘Barbarian’ Sasanians, in Mathisen, Shanzer (ed. by), Romans, Barbarians, and the Transformations of the Roman World, pp. 67-76.
80 Roberto, Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano, cap. 3.
Tutte le riviste Online e le pubblicazioni delle nostre case editrici(riviste, collane, varia, ecc.) possono essere ricercate bibliograficamente e richieste
(sottoscrizioni di abbonamenti, ordini di volumi, ecc.) presso il sito Internet :
www.libraweb.net
Per ricevere, tramite E-mail, periodicamente, la nostra newsletter/alert con l’elencodelle novità e delle opere in preparazione, Vi invitiamo a sottoscriverla presso il nostro sito
Internet o a trasmettere i Vostri dati (Nominativo e indirizzo E-mail) all’indirizzo :
*
Computerized search operations allow bibliographical retrieval of the Publishers’ works(Online journals, journals subscriptions, orders for individual issues, series, books, etc.)
through the Internet website :
www.libraweb.net
If you wish to receive, by E-mail, our newsletter/alert with periodic informationon the list of new and forthcoming publications, you are kindly invited to subscribe it at our
web-site or to send your details (Name and E-mail address) to the following address :
composto in carattere dante monotype dalla
fabriz io serra editore, p i sa · roma.
stampato e r ilegato nella
tipografia di agnano, agnano p i sano (p i sa) .
*Giugno 2013
(cz 2 · fg 3)