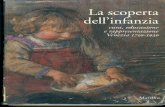Il bambino nella storia della lettura: dalla biblioteca dell'oralità al catalogo delle letture
E. Tatasciore, Letture da “Mediterranee” di Umberto Saba, «Soglie», a. XVI, n. 1, Aprile 2014,...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of E. Tatasciore, Letture da “Mediterranee” di Umberto Saba, «Soglie», a. XVI, n. 1, Aprile 2014,...
Soglierivista quadrimestrale di poesia e critica letteraria
comitato direttivo
Alberto Armellin, Giancarlo Bachini, Fausto Ciompi, Sauro Damiani, Pierangiolo Fabrini, Marzia Minutelli, Helle Nyberg, Elena Salibra.
redazione
Alberto Armellin [con la collaborazione di Lionella Carpita].
comitato scientifico/international advisory Board
Miguel Casado (Toledo)Robert Hampson (Royal Holloway, University of London)
Michael H. Hoffmann (University of Florida)Chris Mann (Rhodes University)
Jean-Michel Maulpoix (Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense)Carles Miralles (Universidad de Barcelona)
Franco Musarra (Katholieke Universiteit Leuven) Jesús María Ponce Cárdenas (Universidad Complutense de Madrid)
Jean-François Puff (Université Jean Monnet, Saint Etienne) Clara Rowland (Universidade de Lisboa)
Ulla Schroeder (Radboud Universiteit Nijmegen)Emmanuela Tandello (Christ Church, University of Oxford)
Giona Tuccini (University of Cape Town)Alexis Ziras (Atene)
Soglie è una rivista blind peer reviewed a cura di studiosi di Università italiane e straniere. Pubblica testi poetici inediti, saggi, articoli, recensioni e interviste concernenti la poesia, specialmente contemporanea, scritta in tutte le lingue.
edizione online: www. torrossa.it.
La rivista è indicizzata dai seguenti organismi:Database e cataloghi internazionali: MLA International Bibliography, OCLC e Deutsche Bibliotek.Discovery Services: Summon Proquest e Primo Central di ExLibris, Ebsco Discovery Services. Link Resolvers: AtoZ, Serials Solutions, SFX.
ISSN 2283-3218
Soglierivista quadrimestrale di poesia e critica letteraria
TesTi poeTiciFreschi di stampa: Valerio Magrelli, La curva 3Jean-Paul BadeT, Guy BaudinaT, La notte decide (a cura di Rosa Galli Pellegrini) 5Umberto piersanTi, Da Nel folto dei sentieri 13
saggiEnrico TaTasciore, Letture da Mediterranee di Saba (Ebbri canti, Il ratto di Ganimede, Entello, Ulisse) 21Marzia MinuTelli, Introduzione a Nordiche di Elena Salibra 41
inTervisTaTiziano rossi, Brùscoli da niente, loro si fanno forza (a cura di Elena Salibra), 57 Recita (prosa lirica inedita)
recensioni 63Silvia MoroTTi, Di questo mondo di Daniela AttanasioSauro daMiani, Datura di Patrizia CavalliSilvia MoroTTi, L’ombra della salute di Alberto Pellegatta
preMio ‘anTica Badia di s. savino’ XXXv edizione: Umberto Vicaretti, Bernardo Pacini, Patrizia Santi, Renzo Francescotti 77
Nuova serie
Anno XV,I n. 1 - Aprile 2014
21Soglie, anno XVI, n. 1, Aprile 2014, pp. 21-39
enrico TaTasciore
Letture da Mediterranee di Saba(Ebbri canti, Il ratto di Ganimede, Entello, Ulisse)
Abstract
The paper focuses on Mediterranee (1946) by Umberto Saba. After a survey of some of the most important issues in Saba’s poetry, the relationships between Mediterranee and Scorcia-toie e raccontini (written in the same years) are duly analyzed with particular reference to four poems: Ebbri canti, Il ratto di Ganimede, Entello, Ulisse, all strictly related to figures and motifs of the classical tradition.
Key-words: Umberto Saba, Mediterranee, Classical Tradition, Greek and Latin Literature
Mediterranee è la prima raccolta di poesie che Saba pubblica nel dopoguer-ra, nel dicembre del 1946, un anno dopo l’edizione Einaudi del Canzoniere uscita a Roma nel novembre del ’45. Se dietro le ventisette poesie sta dunque il vastissimo continente del Canzoniere (che le avrebbe assorbite nel ’48 con la seconda edizione Einaudi), coeve sono le Scorciatoie e le riflessioni me-tapoetiche della Storia e cronistoria del “Canzoniere”.1 Nella Conclusione della Storia e cronistoria, anzi, proprio Amai di Mediterranee è chiamata a descrivere l’atteggiamento primo del poeta di fronte alla tecnica poetica e alla tradizione, strumenti che non ad altro dovrebbero servire, dice Saba, che ad esprimere la “verità interiore”: “Amai trite parole che non uno/ osava…”.2 Non si può quindi parlare di Mediterranee senza gettare almeno un sguardo alla lunga attività che lo precede, o senza far cenno ai dintorni, così immedia-ti, della prosa in forma di ‘scorciatoia’.
1 u. saBa, Mediterranee, Milano, Mondadori, 1946; quindi in u. saBa, Il canzoniere (1900-1947), Torino, Einaudi, 1948, e successive edizioni. Si cita da u. saBa, Tutte le poe-sie, a cura di A. Stara, introduzione di M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 1988 (= TPO); e da u. saBa, Tutte le prose, a cura di A. Stara, con un saggio introduttivo di M. Lavagetto, Milano, Mondadori, 2001 (= TPR). Soltanto per le prose si darà il riferimento di pagina. La “Cronistoria del Canzoniere e del Canzoniere apocrifo” in TPO, e la “Cronologia” in TPR, entrambe a cura di Arrigo Stara, verranno citate abbreviando in Cronistoria e Cronologia.
2 TPR, p. 329.
22
Enrico Tatasciore
Si cercherà tuttavia di seguire non più che un filo, uno dei tanti possibili, per giungere a Mediterranee riunendo durante il percorso temi e strumenti d’analisi ormai consolidati, per volgerli al caso particolare di questa raccolta. Saranno osservati da vicino alcuni testi particolarmente rappresentativi della rilettura cui Saba sottopone figure o luoghi letterari della tradizione classica: Ebbri canti, Il ratto di Ganimede, Entello, Ulisse (secondo l’ordine argo-mentativo, non quello seriale della raccolta). Molto, è evidente, resta fuori: Narciso per esempio, cui è dedicata, dopo Il ratto di Ganimede, la seconda delle Due antiche favole, Narciso al fonte. Le soluzioni di lettura proposte in-tendono tuttavia suggerire, oltre il singolo testo, le linee di un’interpretazione complessiva della raccolta. Quanto rimane sullo sfondo potrà in futuro venire alla ribalta, sollecitare l’attenzione del lettore, anche a partire di qui.
1. Verso Mediterranee
Una fra le più note poesie di Saba, Trieste, inizia con questo verso: “Ho attra-versata tutta la città”. Non c’è forse libro di poesia, nella letteratura italiana, che più di Trieste e una donna restituisca l’immagine così precisa, diramata, di una città che si attraversa, che si misura e si osserva dal suo margine o da luoghi privilegiati dell’interno. E per città non intendiamo soltanto le vie, gli scorci, la disposizione degli spazi, ma la vita degli uomini. Chi vi lavora, chi sta sfaccendato, chi attende per l’imbarco il mercantile, la gente che rincasa, l’osteria, il lupanare: la città è cantata e amata, dirà Saba in Storia e cronisto-ria del “Canzoniere”, per ciò che ha “di proprio e di inconfondibile”.3
Occorrerà partire di qui per collocare, nello spazio e nel tempo, una rac-colta come Mediterranee, che Saba scriverà, come vedremo, da luoghi lontani dalla sua città. Si pensi per esempio a Città vecchia, sempre di Trieste e una donna: la città e gli spazi che la delimitano – campagna e mare – sono l’at-mosfera che risponde, per accensioni o contrasti, ma sempre con segni con-creti, a un io poetico che la interroga a ogni occhiata. Se Trieste si chiude sul “cantuccio” del poeta (“la mia città che in ogni parte è viva,/ ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita/ pensosa e schiva”; ed è correlativo, il “cantuccio”, di una condizione esistenziale fermata, ai primi del Novecento, già da Pascoli ne L’ora di Barga), Città vecchia ci porta, con movimento speculare, nel cuore del teatro di Saba, accanto a figure di “umili” rilevate a metà fra il reale dell’esistenza e la sua acquisizione mentale (il “pensiero” dell’ultima strofa:
3 TPR, p. 151.
23
Letture da Mediterranee di Saba
“Qui degli umili sento in compagnia/ il mio pensiero farsi/ più puro dove più turpe è la via”).
A Trieste si ambienta, anche, il dramma familiare: il distacco provvisorio, il ‘tradimento’ della moglie Lina cui nel 1909 era dedicato il testo di chiu-sura delle Poesie, A mia moglie. È Lina, si sa, la “donna” del titolo Trieste e una donna, in stretta relazione con la città. Si dovrà anzi leggere per intero quella formula di Carimandrei evocata per Trieste, dell’oggetto di canto che è cantato per quanto ha di “proprio” e di “inconfondibile”, poiché essa si ap-plica anche, contemporaneamente, all’altro polo della raccolta, la donna: “È accaduto per Trieste come per Lina. Nel libro che stiamo esaminando, la città e la donna assumono, per la prima volta, i loro inconfondibili aspetti; e sono amate appunto per quello che hanno di proprio e di inconfondibile”.4 E quel verbo “attraversare” del primo verso di Trieste lo incontriamo di nuovo in Più soli, dove, se la città è ancora coinvolta come spazio materico dell’esistenza, al fianco del soggetto poetico figura stavolta il personaggio femminile:
Giungemmo dove si ritrova il mare, con spiagge solitarie, onde turchine. Dai due arsenali, da tante officine,da Trieste che amiamo attraversare
tutta al ritorno, sempre più lontani, e più nostri, in più deserta riviera.[…]
L’importanza del verbo sta nel fatto che esso descrive con assoluta ele-mentarità un modo dell’esperienza dell’io poetico e dei suoi comprimari. Pos-siamo così ricavare alcuni dati essenziali della poesia di Saba: la spazialità concreta, ‘percorsa’ dall’io; la relazionalità di quest’io, per cui l’ambienta-zione realistica dei rapporti si interiorizza, diventa, come è stato scritto, “un piccolo teatro privato”;5 e, corollario della ricerca di relazioni, l’esigenza di coralità della voce poetica, che, molto vicina al postulato d’universalità in-dividuato da Kant per il giudizio sul bello, ha a che fare con la situazione del poeta nel mondo, e, sul piano pratico, con il suo rapporto col pubblico.
Relazione significa tanto amore, attrazione, quanto attrito e incompren-sione. Tale disposizione ambivalente si proietta in Saba non solo sui perso-
4 Ibidem.5 n. palMieri, “Introduzione” a u. saBa, Il Canzoniere (1900-1954), Torino, Einaudi,
2004, p. XiX. Di “potenziale teatralità” della poesia di Saba parla anche p. v. Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Milano, Mondadori, 1978, p. 193.
24
Enrico Tatasciore
naggi e le immagini che la poesia stacca da sé, ma anche sul suo stesso oriz-zonte di ricezione. Come l’attaccamento alla propria terra è così tipico della sua poesia, così l’immaginazione di un pubblico è costante. Con le parole di Mengaldo: “Quella collettività alla cui vita il poeta aspira a fondersi gli si presenta necessariamente come massa omogenea d’ascolto, pubblico vasto e concorde”.6 Possiamo aggiungere che, se c’è una componente sovrastorica e universalizzante della poesia di Saba per cui quel pubblico può essere inteso come entità generale, c’è d’altro canto un impulso alla individuazione spazio-temporale dell’uditorio che lo conduce a incarnare di fatto quel Pubblico in un pubblico italiano storicamente determinato, un pubblico come non mai ‘del proprio tempo’: da quello ‘colto’, effettivamente fruitore, nella realtà, della sua poesia, a quello ‘popolare’ che ne è il fruitore ideale. È anzi esigen-za di Saba che la componente ideale ‘popolare’ sia proprio nel lettore colto perché questi possa “sentire”, dice Saba, e “capire” la sua poesia.7
Il problema riguarda, in parallelo, le condizioni e i modi del fare poesia, riguarda cioè la poetica. E nasce, nella riflessione di Saba, proprio così, se pensiamo al ‘manifesto’ che egli nel 1911 inviò alla redazione della Voce, e che si apriva con questa frase: “Ai poeti resta da fare la poesia onesta” (Quello che resta da fare ai poeti).8 Erano anni in cui la cultura italiana d’avanguardia cercava nuovi mezzi espressivi per uno scavo morale sofferto e sincero, dopo e contro le forme ormai cristallizzate del dannunzianesimo e del pascolismo. Lo scritto fu allora respinto. Non importano qui le ragioni contingenti, ma certo la sua proposta si scontrava contro schemi mentali diffusi. L’“onestà letteraria”, per Saba, è “reazione, durante il lavoro, alla pigrizia intellettuale che impedisce allo scandaglio di toccare il fondo; reazione alla dolcezza di lasciarsi prender la mano dal ritmo, dalla rima, da quello che volgarmente si chiama vena”.9
C’è così un’esigenza prima che coinvolge il lavoro poetico più di quanto non faccia l’esigenza del bel verso. Bello è, per Saba, ciò che nasce sincero, che si dispone cioè in un rapporto di sincerità con il poeta: ciò che nasce “one-sto”. È significativo quel verbo “resta” nel titolo e nella dichiarazione iniziale del saggio: “ai poeti resta da fare la poesia onesta”. La proposta di Saba, vale a dire, si pone in una relazione storica con quanto la poesia italiana ha appena fatto (i crepuscolari), continua a fare (Pascoli e d’Annunzio) o sta facendo
6 P. V. Mengaldo, op. cit., p. 193.7 I due verbi sono impiegati in una lettera a Contini: “Non si tratta di capire, ma di sen-
tire: o meglio di sentire prima e di capire poi” (lettera citata in Cronistoria, TPO, p. 1064).8 Fu stampato postumo nel 1959. La citazione da TPR, p. 674.9 TPR, p. 676.
25
Letture da Mediterranee di Saba
(il futurismo, le cui risonanze, a partire dal marinettiano Manifesto del 1909, erano tutt’altro che estinte): sono le propaggini dell’estetismo, ancora diffuse nella cultura italiana, e con esse la brama del nuovo, dell’originalità a ogni costo, che Saba intende capovolgere in poesia onesta.10
Si poteva davvero estirpare l’estetismo? Aveva senso una battaglia del genere? o la lotta con l’ars, col senso acuto della forma e del mestiere, non è essa stessa un addensato di senso da scavare? Della coscienza sempre più netta che Saba ha di tale aspetto capitale del lavoro poetico è traccia negli scritti saggistici più maturi, dalle Scorciatoie e Raccontini (che egli defini-va le sue Operette morali) alla Storia e cronistoria del “Canzoniere”. Il fatto è che il ‘piacere’ dell’arte, di cui d’Annunzio aveva offerto una sorta di modello supremo, resta componente necessaria della poesia quanto più quello “scandaglio” la conduce nel profondo. Quella vita che Saba sente, dirà Mengaldo, “eroticamente”, è anche rapporto d’amore con l’arte come mezzo di cui il poeta ha competenza gelosa.11 I termini si complicano. La lettura di Nietzsche, che Saba ha affrontato precocemente e non sulle orme del supe-ruomo dannunziano, si conferma e si sviluppa in quella di Freud. Nietzsche e Freud costituiscono per lui, scrive Mengaldo, “un asse consequenziale, deci-sivo per la sua scienza della vita”.12
Il rapporto fra arte e vita va inteso pertanto, alla luce dell’asse Nietzsche-Freud, come una polarità i cui elementi si condizionano a vicenda. Ciò che vela, insegna Freud, rivela. C’è un rapporto tra il profondo e la superficie, per cui l’una si fa rivestimento segnaletico dei contenuti dell’altro, talvolta quan-to più sembri allontanarsene. In termini freudiani, faremmo meglio a dire inconscio e coscienza; ma in Saba – che del resto segue, in questo, percorsi di ricerca aperti dallo stesso Freud – l’analisi dei processi interiori dell’io si
10 Quanto a d’Annunzio e Pascoli, non va dimenticato che essi erano ancora attivi al tempo di Quello che resta da fare ai poeti. Fra l’11 e il ’12 d’Annunzio pubblica sul Corriere della Sera le Canzoni delle gesta d’oltremare, mentre sempre nell’11 Pascoli (che sarebbe morto l’anno successivo) riunisce in un unico volume i Poemi italici e le Canzoni di re Enzio, e pronuncia il famoso discorso La grande proletaria si è mossa, subito ripreso dalla Tribuna e pubblicato da Zanichelli.
11 P. V. Mengaldo, op. cit., p. 191. Scriveva Debenedetti: “Per Saba far poesia è un adat-tare il destino ai gusti di una sensualità onesta e contenuta. E quando si parla di sensualità, qualunque sia poi per esserne la natura, si taglia la strada a tutte le riflesse distinzioni: nel nostro caso a quella tra moralità e poesia” (g. deBenedeTTi, Saggi critici. Prima serie, a cura di C. Garboli, Milano, Il Saggiatore, 1969, p. 114).
12 P. V. Mengaldo, op. cit., p. 188. Numerosi i riscontri nelle Scorciatoie: la 150, per esempio, intitolata Nietzsche-Freud (TPR, p. 71), o l’ultima, Genealogia di Scorciatoie: “Nietzsche – Freud// – S…” (TPR, p. 79).
26
Enrico Tatasciore
fa anche strumento di analisi della civiltà, e della civiltà italiana in partico-lare. Dall’angolatura privilegiata di questa formazione, del tutto atipica per la cultura italiana del tempo, Saba osserva l’Italia – i movimenti culturali, le inclinazioni del costume, la politica – con sguardo lucido, quasi radiografico, capace di giungere all’essenziale attraverso il capovolgimento dei comuni schemi di pensiero. Nascono così quelle Scorciatoie già più volte evocate, saggi di scrittura aforistica cui si affianca da subito la misura più lunga, ma non meno tagliente, dei Raccontini.
Se torniamo, con queste indicazioni, al problema dell’estetismo, capiamo che l’“amor sensuale della parola” tanto conclamato in d’Annunzio, e con nuove vesti ancora caratteristico della letteratura italiana (si pensi alla prosa d’arte della Ronda; ma non vi sfugge nemmeno l’ermetismo), lungi dal poter essere rimosso, forma lo strato che il poeta deve necessariamente attraversare per portare a coscienza i motivi profondi della psiche e della vita relazionale. Uno strato tipico, per giunta, della cultura italiana, come Saba sa benissimo. “La tradizione italiana sette-ottocentesca, tra Parini Foscolo Leopardi, il me-lodramma e i veristi minori”;13 ma anche il Pascoli di certe Myricae o di certi Canti di Castelvecchio (si rammenti ancora il legame fra Trieste e L’ora di Barga), o il d’Annunzio del Poema paradisiaco (l’ammirata poesia Alla nu-trice, di cui Saba parla anche in Ernesto, è il fantasma lirico che le numerose poesie alla balia hanno presente, con certi onirici ‘ritorni’ pascoliani, accanto ai ricordi e alle esperienze reali): è questo l’alveo di una cultura un po’ rétro, distante dai centri dell’avanguardia italiana, cui Saba attinge più scoperta-mente.14
13 P. V. Mengaldo, op. cit., p. 18714 Alla Nutrice è citata in Ernesto come Alla mia nutrice: “L’è assai bela” (Ernesto sta
parlando all’“uomo”), “o almeno a mi la me gà piasso assai, la gò quasi imparada a memo-ria” (TPR, p. 551; cfr. anche Storia e cronistoria del “Canzoniere”, TPR, p. 299). Un paio di casi a esemplificare le relazioni con la poesia di Pascoli e di d’Annunzio. O immaginata a lungo come un mito… (prima delle tre poesie della Casa della mia nutrice in Cuor morituro) ‘riscrive’ Casa mia di Pascoli (del Ritorno a San Mauro) con una vena tutta sabiana di lucida individuazione del movente psichico, di gioco a carte scoperte. Oppure, delle Tre poesie alla mia balia, la terza (…Un grido…): qui il motivo dannunziano, del ritorno alla nutrice come a un asilo che purifica, che rifà nuovi dalle brutture del mondo, si condensa attorno all’io biografico del poeta, immediatamente coinvolto, però, in una trasposizione epicizzante (nella Storia e cronistoria del “Canzoniere”, TPR, p. 267, Saba dirà che, con quell’“esperto/ di molti beni e molti mali” dei vv. 6-7, pensava a Ulisse: e chi legge penserà a un altro Ulisse della tradizione italiana, quello di Foscolo “bello di fama e di sventura”). Eppure non sfugge, dietro l’intreccio, la fabula psichica originaria, dal primo trauma (l’abbandono del piccolo dalla madre alla nutrice: “Si frange/ per sempre un cuore in quel momento”) alla senile con-sapevolezza dell’Edipo (“è un caro a lui conforto/ regolarlo in suo luogo”). Le relazioni fra
27
Letture da Mediterranee di Saba
Il cammino poetico di Saba, dunque, non rinnega le sue origini, ma ne fa elemento di forza e mezzo consapevole di scarto stilistico, veicolo di una po-sizione ‘inattuale’ – quante volte s’è ricorso, e con ragione, a questo aggettivo nietzschiano – rispetto alla contemporanea cultura italiana. La lettura contra-stiva del proprio tempo, con l’elaborazione del messaggio letterario che ne segue, esigerà anche, se occorre, di compiere un apparente passo indietro ri-spetto alla modernità. Ancora Mengaldo scrive che il centro degli interessi di Saba è “il senso del dispiegarsi dell’esperienza individuale come ripetizione di un’esperienza già vissuta, individualmente nel proprio passato, archetipi-camente nelle vicende dell’Uomo di sempre”, e che “la sua visione della vita è, ancor più che in tanti contemporanei, decisamente antistoricistica”.15 Ma guarda poi Saba davvero fuori della storia? A questo punto possiamo dire che per Saba non esiste un ‘fuori’ della storia, se non nella forma di uno sguardo superiore, levato alto su di essa – magari con la rapidità di una ‘scorciatoia’ – ma comunque ad essa magneticamente legato: ché anzi ciò che storia non è, ossia quell’esperienza individuale-archetipica ripetibile, egli potrà trovarlo e, vorremmo dire, isolarlo, solo dentro la storia.
Con lo strumento della psicoanalisi, con la sua logica, col suo modo di vedere e di interpretare i fatti dell’esistenza e della storia, Saba sembra dun-que cercare non un Eden dove l’esperienza umana si dia allo stato di purezza immemore, ma anzi il luogo in cui quella si dichiari più aderente alle vere ragioni del suo essere: il punto in cui l’io giunga a conoscersi senza sovra-strutture o finzioni. L’accettazione di questa verità – dolorosa, perché ci trova disarmati di fronte a un destino che scopriamo già avvenuto, inestirpabile dalla nostra storia – procura tuttavia un sollievo, una liberazione. La psicoa-nalisi è lo strumento teorico di questa ricerca: uno strumento scoperto da Saba non subito, e affinato negli anni con le letture e l’esperienza personale della terapia; affinato a tal punto, relativamente all’esperienza artistica, da implica-re una sorta di estetismo di ritorno, risultato della consapevolezza del mezzo come unica via all’espressione di contenuti profondi.
Il ritrarsi dello sguardo fuori della storia, per smascherare dietro apparen-ze, finzioni o disoneste interpretazioni i meccanismi profondi della vita del singolo e della società, è operazione tipica soprattutto dell’“atteggiamento diagnostico” – come l’ha definito Lavagetto – delle Scorciatoie, in cui uno
mito e psiche, con particolare attenzione alla figura di Ulisse (veramente dominante nell’ope-ra in versi e in prosa di Saba) e a quella di Oreste, sono indagate in a. cinquegrani, “Umberto Saba. ‘Io sono il matricida Oreste’”, in M. canTelMo (a cura di), Il mito nella letteratura italiana. iv. L’età contemporanea, Brescia, Morcelliana, 2007, pp. 243-62.
15 P. V. Mengaldo, op. cit., p. 190.
28
Enrico Tatasciore
“sguardo freudiano” si posa sulle “‘cose’ della realtà quotidiana, della lettera-tura, della storia, della politica, del costume”.16 Sono intuizioni fulminee che rivelano tutta l’arretratezza con cui la cultura italiana si presentava alla metà del secolo, o entrano nel vivo di situazioni storicamente drammatiche come il genocidio degli ebrei o il confuso dopofascismo italiano. ‘Scorciatoia’ in-fatti è per Saba, prima che un modo di esprimersi, un modo di pensare. E noi rileggeremo, fra le tante, questa, che parla dell’arte e del suo rapporto con la storia – calandoci peraltro negli anni di Mediterranee, poiché fu pubblicata sulla Nuova Europa del 18 marzo 1945:
L’ARTE nasce attraverso la forma; vive, e muore, per il contenuto. Il verso “Nel ciel dell’umiltate ov’è Maria” non ci dice più oggi quello che ci avrebbe detto seicento anni fa. Eppure il verso è sempre lo stesso. Ma – per tacere il resto – anche l’azzurra parola cielo ha, dopo che la solcano aeroplani e ne piovono bombe, un altro significa-to. Crea altre associazioni.17
Le Scorciatoie, è il caso di ricordarlo avvicinandoci a Mediterranee, ven-gono pubblicate, coi Raccontini, in rivista fra il marzo e il luglio del 1945, per poi uscire in volume nel gennaio del 1946.18 La congiuntura storica è travagliatissima. Da Firenze, dove aveva riparato fra il 1943 e il 1945, Saba si sposta a Roma. Vi risiede per tutto il 1945, trasferendosi sul finire dell’anno a Milano. Sono i mesi che portano alla Liberazione e alla fine della seconda guerra mondiale, periodo punteggiato, nell’attività di Saba, di interventi in forma di scorciatoia: egli fu tra i primi, ad esempio, a parlare dei Lager e commentò a caldo le reazioni del popolo alla morte di Mussolini, fucilato dai partigiani il 28 aprile.
Né va dimenticata la storia particolare di Trieste, che ovviamente Saba seguiva da Roma o da Milano, non senza un tentativo di ritorno nell’estate del ’45, quando fece un viaggio nell’alto Adriatico tra Venezia e Trieste. Sem-pre fra l’aprile e il maggio del ’45 i partigiani di Tito liberano la Jugoslavia, precedendo di poco a Trieste l’avanguardia degli Alleati (1º maggio). La città fu retta dall’esercito jugoslavo per un mese, per poi passare agli Alleati. Nel 1947 sarebbe nato il Territorio Libero di Trieste, diviso in due zone governate dagli angloamericani e dalla Jugoslavia.
16 M. lavageTTo, L’altro Saba, in Tpr, p. XXvii. 17 TPR, p. 11.18 Ma le prime Scorciatoie risalgono al 1934-35: sono ora raccolte, con annotazioni sto-
rico-critiche di Arrigo Stara, in TPR.
29
Letture da Mediterranee di Saba
2. “Qui pure è Mediterraneo” (Ebbri canti)
Mesi confusi, dunque. Mediterranee nasce appunto con questo senso di lon-tananza da Trieste sconvolta.19 Saba la osserva però – è un dato da non trascu-rare – dal centro dell’Italia e dell’Europa mediterranea, da Roma: “un bril-lante che manda luce da tutte le parti”, scrive alla moglie Lina nel febbraio del ’45, a un mese dal suo arrivo.20 E della città, che era stata liberata il 4 giugno dell’anno precedente, potrà cantare: “Materna calma imprendibile è Roma…”.
È un verso di Ebbri canti, quindicesima poesia di Mediterranee:
Ebbri canti si levano e bestemmie nell’osteria suburbana. Qui pure– penso – è Mediterraneo. E il mio pensiero all’azzurro s’inebbria di quel nome.
Materna calma imprendibile è Roma.S’innamora la Grecia alle sue spondecome un’adolescenza. Oscura il mondo e lo rinnova la Giudea. Non altroa me vecchio sorride sotto il sole.
Antico mare perduto… Pur vuolela Musa che da te nacque, ch’io dica di te, col buio alle porte, parole.
19 Fanno riferimento alla realtà storica, nel suo rapporto col mito, le letture di r. caval-luzzi, “Mediterranee: ancora ‘della vita il doloroso amore’”, in g. Baroni (a cura di), Saba extravagante. Atti del convegno internazionale di studi, Milano, 14-16 novembre 2007, Ri-vista di Letteratura Italiana, XXVI, 2-3, 2008, pp. 363-67; e di d. o’ grady, “Da Milano al mito: acqua e mare in Mediterranee di Umberto Saba”, ivi, pp. 449-52. Lo stesso fascicolo ospita anche, sempre su Mediterranee, g. BàrBeri squaroTTi, “Entello e Ulisse”, ivi, pp. 69-76, che si citerà più avanti (il saggio è anche compreso in g. BàrBeri squaroTTi, Entel-lo, Ulisse, la matrona e la fanciulla. Saggi su Saba e Campana, Sestri Levante, Gammarò, 2011). Utili riflessioni sulla struttura della raccolta e sui suoi motivi dominanti si trovano in B. van den Bossche, “‘Antico mare perduto…’. Gli spazi del mito in Mediterranee”, in g. Baroni (a cura di), “Si pesa dopo morto”. Atti del convegno internazionale di studi per il cinquantenario della scomparsa di Umberto Saba e di Virgilio Giotti, Trieste, 26-27 ottobre 2007, Rivista di Letteratura italiana, XXVI, 1, 2008, pp. 169-73. Attento alla dimensione dello scambio culturale è M. lollini, “Trieste e l’antico mare perduto di Umberto Saba”, Annali d’Italianistica, 24, 2006, pp. 275-94.
20 Si era trasferito nella capitale, da Firenze, “nei primi giorni di gennaio” (A. sTara, in Cronistoria, TPO, p. 1063). La lettera a Lina è citata in Cronologia, TPR, p. lXiX.
30
Enrico Tatasciore
L’immagine di una Roma millenaria occupa qui la strofa centrale. In pochi, essenziali versi Saba ripercorre le tappe della civiltà mediterranea (come l’aveva vista già Dante nel VI canto del Paradiso) in una succes-sione di luce e di ombra: si noti ad esempio il forte contrasto provocato, al centro della strofa, dall’accostamento delle parole “adolescenza” e “oscu-ra”. Ma aggiunge l’ormai immancabile prospettiva della sua vecchiaia, con-traddicendo la famosa sentenza che rintocca nell’Ecclesiaste, nihil sub sole novum. “A me vecchio”: lo sguardo di Saba si è ormai velato di questo sapienziale senso di senilità, quasi di ‘postumità’. Di qui in avanti, le poesie che egli pubblica sono sempre una deroga alla dichiarazione di ‘non scri-vere più’: e tale dichiarazione è – lo si capisce dal modo in cui è ribadita, da come si insinua nelle poesie – uno stato esistenziale della sua più tarda scrittura poetica.
Questo di Roma è solo il centro della poesia. Le strofe di apertura e di chiusura, che ne formano la cornice, ci riportano in realtà a Trieste. “Ebbri canti”, “bestemmie” Saba udiva nella sua Trieste, nei suburbi in cui riusciva a sentirsi solo e in compagnia allo stesso tempo, sul greto della vita come in Città vecchia. Ora egli scrive, però, da “qui”, anche se “qui pure [...] è Me-diterraneo”. Roma non è Trieste, eppure… Il Mediterraneo, simbolo nuovo per la poesia di Saba, è figura di unione. È quel mare che riunisce e acco-muna le più diverse sponde. “In fondo all’Adriatico selvaggio/ si apriva un porto alla tua infanzia” esordisce la seconda delle Tre poesie a Linuccia, con una citazione dannunziana così scoperta, così vicina al popolare ‘ri-cordo di scuola’, che il luogo poetato appare da subito ricoperto del manto caldo e confortante d’una tradizione. Tale uso disarmato e schietto della dizione poetica addensata su luoghi e cose – sia essa antica o recente – crea l’ambiente familiare di risonanza dove il nuovo si avvicina con naturalezza all’antico. Non solo: nei versi appena letti il senso di lontananza spaziale (“in fondo”) si combina con la profondità in un tempo remoto (“si apriva”), ed ecco quindi la terza componente fondamentale di queste Mediterranee, il tempo, dopo il senso della vecchiaia e quello della distanza dal luogo dell’origine. L’ultima strofa di Ebbri canti introduce nella poesia la coordi-nata di questa origine remota, perduta, di fronte alla quale il poeta, che ha fatto dello scavo una ragione della propria poesia, non tace, ma è sospinto ancora alla ricerca e alla parola.
La “Musa” è solo uno dei nomi mitologici, o epici, che si trovano nella raccolta. Il nome – era già il caso di “Mediterraneo” – agisce come figu-ra, o, se vogliamo, ha valore di ‘scorciatoia’. Quando Saba nomina Ulisse, Telemaco, Ganimede, Narciso, intende evocare le situazioni archetipiche
31
Letture da Mediterranee di Saba
condensate in quei nomi. Può bastare il nome, affidato al solo titolo, come nelle Tre poesie a Telemaco o in Ulisse, poesia che chiude la raccolta: i testi, poi, parleranno di Saba, del rapporto, misto di affetto paterno ed erotismo, con un giovanissimo amico, o di una vita che, come quella dell’Ulisse dantesco, ancora affronta il mare aperto spinta dal proprio “non domato spirito”. Tali poesie non ripercorrono né la storia di Telemaco né quella di suo padre Ulisse: eppure, accompagnate nel titolo da quei nomi antichi e a tutti noti, restano come ombreggiate del sovrasenso archetipico evocato da quelle figure.
Non deve ingannare, quindi, l’addensamento di nomi antichi in Medi-terranee, per quanto esso risulti nuovo, a dir la verità, per la poesia di Saba. Esso non segna né l’adesione a un improbabile neoclassicismo, né un tar-divo allineamento alla ricerca di ermetismo e dintorni sulle figure del mito, ponti verso un senso collocato fuori del tempo (si pensi all’Ungaretti di Sentimento del Tempo, o al Luzi di Avvento notturno). La via di trasmissio-ne delle ‘favole antiche’ è stata certamente, per Saba, quella dei grandi tra-duttori, da Annibal Caro a Monti e a Pindemonte (nell’Ernesto si legge che il giovane aveva letto “con rapimento l’Iliade di Omero nella traduzione di Monti”).21 Tuttavia, quando Saba scrive Mediterranee, la ‘sua’ mitologia ha fondamenti teorici ben saldi, che fanno capo ancora alla linea Nietzsche-Freud: dalla Nascita della tragedia, dunque, fino alle ‘figure’ (Edipo, Narci-so…) in cui Freud riconosce la traccia di stati e processi psichici da sempre presenti nell’uomo.
Poco prima dell’uscita di Mediterranee Saba scrive a Contini: “Non posso impedire che in quello che scrivo (poesia o prosa) circoli la vita: e gli italiani ‘hanno paura’ della vita. Essi l’accettano nella forma mummificata di una, più o meno abile, letteratura”.22 Anche quella di Mediterranee è letteratura, e al suo più alto grado, se ricorre al patrimonio degli antichi miti. Ma, tutt’al-tro che mummificata, essa esprime proprio la “vita” di cui gli italiani – quel pubblico culturalmente e sociologicamente determinato che Saba ha sempre presente – “hanno paura”. L’uso della tradizione classica acquista, in questa luce, un senso sottilmente ironico. Lo mostra, soprattutto, un ulteriore affi-narsi di quello strumento di scavo nel profondo che è per Saba la letteratura, complesso di istituti, di convenzioni, perfino di clichés, attraverso i quali la vita può scorrere lieve, se l’abilità del poeta sa trovarle una via.
21 TPR, p. 546.22 Lettera da Milano del 1946, citata in Cronistoria, TPO, p. 1064.
32
Enrico Tatasciore
3. Un adolescente (Il ratto di Ganimede)
Quest’uso del classico trova l’esempio forse più riuscito nelle Due antiche favole, dedicate l’una a Ganimede, il bellissimo fanciullo amato da Zeus e da questi rapito in cielo, dove sarà coppiere degli dei, l’altra a Narciso, il giovane che, specchiandosi nelle acque di una fonte, s’innamora della propria imma-gine, e resta a guardarla per ore fino a morire di consunzione. Ne leggiamo la prima, Il ratto di Ganimede:
Era un giorno fra i giorni. Era sereno l’Ida; le capre brucavano in pace,date in guardia a pastore adolescente. Solo il cane qua e là vagava inquieto.
Sul volto del fanciullo ombre passavano.Forse troppo severo il re suo padre.Forse anelava ai compagni – sull’Idaerano molti della stessa età, che tutti delle stesse gare amanti, per il bacio di un serto, violentisi abbracciavano a un coro d’alte grida. – Bianche in cielo correvano le nubi.
Sempre il cane su e giù fiutava all’erta, ed il gregge più unito in sé stringevasi. Ai presagi insensibile, il pastore,oblioso al suo compito, sognava.
Fulminava dal cielo aquila fosca. Si sbandavano greggi, si sgolava il cane. Già dell’azzurro il fanciullo bagnava un’ultima volta la terra.
Sono cinque quartine, ma dai contorni estremamente mossi. Il discorso travalica, a un certo punto, da una strofa all’altra, in coincidenza con l’am-pliarsi dello sguardo ai giochi dei “compagni” (è l’inserto fra trattini, sotto-lineato dalla rima “Ida”: “grida”). I versi si spezzano in due casi a formare un ‘gradino’, là dove il racconto impone un brusco cambio di prospettiva: prima quando entrano in scena i compagni (“Forse anelava ai compagni/ – sull’Ida…”), poi quando il fanciullo Ganimede, ghermito dall’aquila (cioè
33
Letture da Mediterranee di Saba
da Giove), è già lontano nel cielo (“…si sgolava/ il cane./ Già dell’azzurro il fanciullo…”). È insomma il racconto, con le sue pause, le distensioni, gli av-venimenti improvvisi, a disegnare sullo schema metrico una forma individua-ta.23 Allo stesso modo il rapporto tra verso e frase – da cui un poeta può trarre effetti di grande espressività – si mantiene stabile fintanto che nella scena solo serpeggi un inquieto presagio, col ragazzo immerso in pensieri e gli animali unici ad avvertire che qualcosa sta per accadere; ma si altera quando inter-viene lo scompiglio, e Ganimede è già rapito e il gregge si sbanda e il cane abbaia inutilmente. Allora la frase si tende in enjambement e l’endecasillabo si spezza. Anche l’enjambement della ‘scena nella scena’ (i compagni che “violenti/ si abbracciavano”) ha funzione dinamica, mentre la prima inarcatu-ra, “era sereno/ l’Ida”, assolutizza l’aggettivo “sereno”, primissima indicazio-ne d’ambiente, mettendolo in forte contrasto con “inquieto” in fine di strofa.
Si noterà poi che i verbi sono tutti all’imperfetto. Sebbene proprio l’imper-fetto sia il tempo del racconto, avvertiamo tale insistenza quasi come innaturale. Un passato remoto segnerebbe l’accadere d’un evento e scaricherebbe la ten-sione accumulata dal continuum degli imperfetti, ciò che non avviene nella nar-razione che abbiamo sotto gli occhi. Occorre dunque soffermarsi su quest’uso esclusivo del tempo imperfetto, veicolo d’una tensione vagamente ossessiva e agente primo della innegabile atmosfera di inquietudine del racconto. Si osser-verà intanto che i verbi – e cioè gli imperfetti – oscillano tra la sfumatura epica, dovuta alle anastrofi, agli iperbati e a soluzioni morfologiche aulicizzanti (“Sul volto del fanciullo ombre passavano”, “Bianche in cielo correvano le nubi”, “Fulminava dal cielo aquila fosca”, “stringevasi”) e la più semplice forma non marcata del discorso quotidiano (“era un giorno fra i giorni”, “le capre brucava-no in pace”). Anzi il racconto, avviato su questo registro (si veda la prima stro-fa, solo increspata in senso aulico dall’uso assoluto di “pastore adolescente”), si sposta lentamente sull’epico, facendo di questo livello ‘in tensione’ il più adatto a esprimere la straordinarietà dell’evento. Sono in fondo secoli di storia stilisti-ca a permettere a Saba un uso così nuovo di quella tensione, proprio in quanto essa è collaudata, satura, paradossalmente pronta a ricevere nuova energia.
Se si guarda ai personaggi, anch’essi hanno uno statuto incerto fra l’epos e il racconto di stampo realistico. Ganimede, che per tutti i libri di mitologia è ‘il coppiere degli dei’, qui è semplicemente un ragazzo: sente forse come una punizione l’ordine del “re suo padre” di badare al gregge mentre i suoi
23 Come scrive Bàrberi Squarotti, “tutta la parte iniziale della narrazione mitica è la diva-gante premessa dell’esperienza del ragazzo”; le stesse gare di lotta ne sono “il preannuncio”, e la discesa dell’aquila di Giove sarà “attuazione” del “vago desiderio del fanciullo” (G. BàrBeri squaroTTi, op. cit., p. 74).
34
Enrico Tatasciore
compagni giocano (ce lo mostra, nella seconda strofa, un’appena accennata focalizzazione interna); si perde in pensieri, il suo viso ha le ombre non si sa se del risentimento o delle nubi che attraversano il cielo. Lo circondano animali umili, del tutto a casa nel Canzoniere: le capre, il cane. In tale quadro affatto realistico e naturale, l’“aquila fosca” di Giove piombata sul ragazzo è l’evento soprannaturale, l’inaudito che crea contrasto e straniamento. Il me-raviglioso del racconto irrompe con sensibile scarto stilistico (da “le capre” e “il cane” al più elevato “aquila fosca”, senza articolo) e ha funzione tutt’altro che ornamentale. Vi si esprime l’evento nuovo e sorprendente, veramente un’improvvisa scossa per la vita del ragazzo: l’esperienza del primo rapporto sessuale con un uomo. Si addensa nell’espressione “già dell’azzurro” il senso di ciò che per sempre cambia una vita, che la rapisce in qualcosa di sconvol-gente. È ciò che in Ernesto Saba chiamerà “l’irreparabile”, quando il ragazzo, tremante di paura e di desiderio, ha il suo primo rapporto: “‘Sono perduto’, pensò tra sé, in un lampo; ma senza nessun rammarico, nessun desiderio di tornare indietro”.24 Qui, nel Ratto di Ganimede, forme e modi di tensione stilistica che la tradizione offre come strumenti familiari e duttili sono piegati all’espressione di una tensione psichica ed emotiva affatto nuova.
Narrato da Omero, da Virgilio, da Ovidio, e poi ancora da Stazio, com-mentato da Platone e da Senofonte, dipinto dal Correggio e da Michelangelo, quello di Ganimede è un topos che Saba riprende con rinnovata e fedele atten-zione al particolare: ambienta ancora la scena, con esattezza, sul monte Ida, ci dice che il fanciullo è figlio di re, non tralascia il motivo, sempre presente nella tradizione (anche iconografica), del cane che abbaia al ragazzo rapito. Non nomina, è vero, i custodi del giovane (i custodes dell’Eneide, “vecchi cu-stodi” nel Caro).25 E i “compagni” (che sono per esempio in Stazio) li fa lon-tani, desiderati nei sogni del ragazzo. Ma le scelte mostrano, anche qui, che il racconto di Saba punta alla ‘verità’ del topos. Davanti alla nuova esperienza il suo Ganimede è realisticamente solo; la natura soltanto, e non a caso proprio lei, sembra percepire quello che sta accadendo, e unicamente da lei – il cane, le greggi – Saba prende il ‘commento’ drammatico alla sua scena.26 La favola
24 TPR, pp. 528-9. 25 virgilio, Aeneis, 5, 257; a. caro, L’Eneide di Virgilio, 5, 368.26 Una coincidenza stilistica fra il Ratto di Ganimede e Entello (che si leggerà più avanti)
è spia d’un comune assetto di valori connotativi. Si confronti il verso del Ratto di Ganimede “Bianche in cielo correvano le nubi” con questi di Entello: “Bianche si rincorrevano sull’onde/ schiume che in alto mare eran Sirene”. In entrambi i casi il dato naturalistico volge al mitico: solo, in Entello in maniera esplicita, nel Ratto di Ganimede in maniera implicita, per dissemina-zione di suggerimenti narrativi (e, si direbbe, proprio per questo con effetto di tensione).
35
Letture da Mediterranee di Saba
antica, narrata ancora una volta e proprio come tale, diventa così il velo che protegge “la verità che giace al fondo” (Amai): un segreto che si rivela per il diaframma trasparente della parola satura di letterarietà, e che in Saba non si separa mai dal sentimento fermo di una necessaria tutela, quasi di una gelosia della forma, nei confronti del ‘contenuto di vita’.
4. I fortunosi giochi della poesia (Entello, Ulisse)
La cultura classica entra nel testo, in Mediterranee, anche nei modi confi-denziali del dialogo interiore: le associazioni mentali dell’io ritrovano figu-re di eroi che forse avevano stregato il lettore giovanissimo, Ernesto, che quando leggeva Virgilio per la prima volta “ne era incantato”.27 Su verbi come ‘pensare’, ‘ripensare’, ‘ricordare’, le associazioni del vecchio poeta evocano tanto il passato e il presente dell’esperienza, quanto, sullo stesso piano, figure del mito, in cui quell’esperienza si determina, trova forme, quasi si traveste. Ecco Mediterranea: “Penso un mare lontano, un porto, ascose/ vie di quel porto; […] penso cupa sirena/ – baci ebbrezza delirio –;
27 S’è già accennato alle letture di Ernesto. È il caso di insistervi un momento poiché ad esse s’intrecciano con evidenza, nel romanzo, le esperienze più intense della sua vita. Ad esempio, più di una pagina è dedicata alle Mille e una notte, vera lettura magica dell’infan-zia del ragazzo, fatta a tredici anni nella “più deliziosa estate della sua vita”, estate “felice”, “memorabile” (TPR, pp. 581 e 583). Quando il ragazzo ormai adolescente ha la percezione, piena di sgomento, della fine della fanciullezza, a materializzare tale presa di coscienza è il ricordo, per contrasto, di “quella irripetibile estate” (TPR, p. 604). Ancora: se all’uomo con cui avrà il primo rapporto sessuale racconta di essere stato a vedere i Masnadieri di Schil-ler (TPR, p. 519), il narratore aggiungerà poi, con uno di quegli incisi che schiariscono la coscienza ancora torbida del giovane protagonista: “Più tardi, quando lesse con rapimento l’Iliade di Omero nella traduzione del Monti, doveva dare alla figura fisica di Ulisse i tratti fisici dell’uomo” (TPR, p. 546). Scopriamo così che quell’Ulisse tanto importante per la poesia di Saba appartiene agli strati più antichi e controversi del suo immaginario (ma perché Saba ricorda, in quel passo, l’Iliade e non, come sarebbe più naturale, l’Odissea?). Infine, per fare il nome dell’altro grande poeta epico, ecco che troviamo, nell’ultimo capitolo del libro, il ragazzo affascinato dall’Eneide di Virgilio, ed è anche qui una “prima volta” che Saba descri-ve: Ernesto “leggeva, per la prima volta, Virgilio, e ne era incantato” (TPR, p. 622; ma andrà considerata la piega tutta comica della scena). Sarebbe il caso di indagare tali referti di letture ‘originarie’ (dettagli apparentemente secondari lasciati cadere dal narratore in punti strategici del racconto) nelle loro relazioni di funzionalità con gli stati della coscienza e dell’esperien-za del personaggio, tenendo conto del rapporto con la cornice fortemente intenzionale della voce narrante. Si avrebbe così non un semplice catalogo documentario delle prime letture di Saba, ma una loro mappa psichica diacronicamente distesa sui due ‘io’ di Umberto, il giovane (protagonista di quelle letture) e il vecchio (creatore del mito di quelle letture).
36
Enrico Tatasciore
penso Ulisse/ che si leva laggiù da un triste letto”. Oppure Entello, la poesia di apertura, che leggiamo intera:
Per una donna lontana e un ragazzo che mi ascolta, celeste,ho scritte, io vecchio, queste poesie. Ricordo,come in me lieto le ripenso, anticopugile. Entello era il suo nome. Vinse l’ultima volta ai fortunosi giochid’Enea, lungo le amenespiagge della Sicilia, ospite Anceste.Bianche si rincorrevano sull’ondeschiume che in alto mare eran Sirene.Era un cuore gagliardo ed era un saggio.“Qui – disse – i cesti, e qui l’arte depongo”.
Chiaramente la poesia ha valore proemiale. Le farà eco, a chiusura del li-bro, Ulisse: ma mentre in questa, come s’è detto, la memoria dell’antico eroe si raccoglie nel solo titolo (tocca al lettore scoprire ‘che tipo’ di Ulisse è il Saba di cui ci parla la poesia), in Entello l’identificazione, colta quasi casualmente nei pensieri in bilico fra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ del libro, prende piede fino a restituire intera la figura del vecchio pugile virgiliano, il paesaggio, la situazione. La frase incisa nel finale – la stessa che Entello pronuncia nel quinto libro dell’Eneide – che rende l’iniziale controfigura dell’io un personaggio autonomo e in rilie-vo. Questo Entello è nel teatro della mente, ma non come ombra o proiezione dell’io: ha tutte le sue dimensioni, è un individuo che il poeta ha richiamato e che ha un suo ‘passato’ e, nella letteratura, una sua ‘vita’. Anche a prescindere dalla sua nuova chiamata in causa, qui, nelle riflessioni del poeta nuovo.
Ma chi era Entello, e quali sono i “fortunosi giochi di Enea”? In Sicilia, a Drepano, muore il vecchio padre di Enea, Anchise. Lasciata Cartagine alla volta dell’Italia, Enea fa scalo proprio lì a un anno dalla morte del padre. Per onorarne la memoria indìce dei giochi, ai quali partecipano i troiani della sua flotta e i siciliani del luogo, di cui è re Aceste, antico amico di Anchise. Aceste è l’“ospite” di cui parla Saba. Ma è strano che egli scriva “Anceste”, e non corregga mai l’errore nelle successive edizioni di Mediterranee. Per Mario Geymonat Saba avrebbe “fuso insieme”, scrivendo “Anceste”, “i nomi di Aceste e di Anchise”.28 Un lapsus, insomma, che rivela un legame effetti-
28 M. geyMonaT, “Aceste e Anchise nella memoria poetica di Umberto Saba”, in Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco, Palermo, Università, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Filologia Greca, Istituto di Filologia Latina, 4 voll., 1991, vol. 4, pp. 1809-12, p. 1812.
37
Letture da Mediterranee di Saba
vamente istituibile, nel testo virgiliano, tra le due figure, il padre morto e l’a-mico del padre ospite dei giochi (che Enea, osserva Geymonat, chiama pure pater, epiteto altrimenti riservato – oltre che ad Anchise – alle sole divinità). Di tale nesso profondo, scrive Geymonat, “conscia o inconscia, la soluzione onomastica di Saba sembra offrire una singolare conferma”.29
Spinto proprio da Aceste, Entello, vecchio pugile glorioso, combatterà un’ultima volta, riportando la sua ultima vittoria: “Era un cuore gagliardo ed era un saggio”, dice Saba. In Entello il desiderio di combattere contrasta con la percezione della sua debolezza fisica. Il pugile sa dove fermarsi, conosce il proprio limite, e pronuncia la frase, divenuta proverbiale, che Saba sceglie a epigrafe della propria attività di poeta: hic victor caestus artemque repono (Caro, che Saba certamente aveva nell’orecchio, traduce: “qui ’l cesto appen-do, e qui l’arte ripongo”).30
L’io che in Mediterranee dice “penso”,31 o “ricordo”, medita dunque fi-gure attorno alla propria esperienza: si immerge in sé, tocca il segno di cose, luoghi, persone della propria vita, lo trascende oggettivandosi in maschere la cui autonomia identitaria è assicurata dalla loro appartenenza a un patrimonio culturale antichissimo. Maschere, dunque, ma viventi al di fuori dello spazio e del tempo dell’io. Questo trapasso del soggetto poetico in altro da sé sembra appartenere alla particolare capacità ormai sviluppata da Saba, capacità da un
29 Ibidem.30 virgilio, Aen., 5, 484; caro, L’Eneide di Virgilio, 5, 691. Andrebbe approfondito il
ruolo di mediazione della traduzione di Caro, argomento su cui non conosco studi particolari. Un buon punto di partenza è comunque il saggio citato di Geymonat, che rileva intanto, con giusta misura, la consistenza e i modi del rapporto con Virgilio (condivisibile per esempio, con alla mano non solo l’originale ma anche la traduzione di Caro, quanto vi si legge a pro-posito del Ratto di Ganimede: che qui “gli echi del quinto libro virgiliano – da Geymonat indicati in nota – sono così profondamente rielaborati ed assimilati da risultare quasi imper-cettibili”: M. geyMonaT, op. cit., pp. 1180-81). Quanto al simbolo, è interessante l’interpreta-zione di Bàrberi Squarotti, per cui i “cesti” non sono solo emblema dell’ars, ma “rimandano alle lotte amorose, alle metaforiche battaglie del rapporto sessuale”, battaglie quietatesi, così parrebbe dire Entello, nell’“armonia fra l’amore lontano […] della donna e quello attuale del ragazzo”. Ma soprattutto è da condividere l’indicazione formulata da Bàrberi Squarotti di una tematizzazione d’autocoscienza storico-letteraria nel testo della poesia: “Entello è il poe-ta che anche nell’immediato dopoguerra, quando la poesia sembra avere scelto una strada ben lontana da quella che pure egli ha perseguito fin dall’adolescenza, ha vinto la sua battaglia” (G. BàrBeri squaroTTi, op. cit., p. 70).
31 E non solo in Mediterranee. Si veda per esempio Solo, di Ultime cose: “e penso/ che vedrò questa sera te che amo.// Penso quanto nel sole/ che rileva, nell’ombra che nasconde,/ ho fatto, errato, a dirmi in pace alcune/ parole”; oppure, più indietro, Canzonetta nuova di Cuor morituro: “Penso indefesse/ cure d’amore,/ ed il rossore/ d’un caro viso”.
38
Enrico Tatasciore
lato di pensare, percepire, sentire di lontano (rispetto a Trieste, per esempio), dall’altro di astrarre dai dati concreti dell’analisi, per capovolgerne i rapporti, per scoprirne il lato nascosto, come avviene nelle Scorciatoie (di cui Saba rammenta, proprio sulla soglia di Mediterranee, che “sono nate dall’incontro fra un poeta al declino degli anni ed una disciplina quanto mai esatta e preci-sa [la psicoanalisi]”).32 È insomma una disposizione mentale che quei verbi, “penso”, “ricordo”, coinvolgono. E saranno significative alcune coincidenze stilistiche, riscontrabili proprio con le Scorciatoie, per esempio nel ritratto di Freud della scorciatoia 150, in cui si legge: “Ma era un uomo onesto, uno sguardo profondo e diritto; e dovette – caso confermando caso – arrendersi, riluttante fino all’ultimo, all’evidenza”.33 Lo stile (spezzature, pause, incisi, ma segmenti di frase sempre precisi e limpidi; e poi l’uso dell’imperfetto) è analogo a quello con cui, in Entello, la figura e le parole del pugile sono messe epigrammaticamente in rilievo: “Era un cuore gagliardo ed era un saggio…”.
Caestus artemque repono: infine, che cosa fece Saba? L’ultima poesia di Mediterranee capovolge, inaspettatamente, la parola di Entello. Eccola, Ulisse:
Nella mia giovanezza ho navigato lungo le coste dalmate. Isolottia fior d’onda emergevano, ove raro un uccello sostava intento a prede, coperti d’alghe, scivolosi, al solebelli come smeraldi. Quando l’alta marea e la notte li annullava, velesottovento sbandavano più al largo,per fuggirne l’insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il portoaccende ad altri i suoi lumi; me al largo sospinge ancora il non domato spirito e della vita il doloroso amore.
Memore del suo primo ingresso nella vita – il mare, gli scogli smeraldini sono quelli conosciuti dal giovane Saba quando era mozzo su un mercanti-le – l’“Ulisse al declino” (Ulisse, in Parole), vecchio, in un certo senso già postumo a se stesso, non rinuncia ad ascoltare la sirena che sempre lo chiama a riprendere il mare. La poesia, e con essa Mediterranee, si chiude così riba-dendo, su note vicine al canto (c’è un’eco dell’aria Il lacerato spirito dell’a-mato Verdi), l’idea ormai centrale della poesia di Saba: che arte della vita e
32 Lettera all’editore, TPR, p. 1131. Cfr. TPO, pp. 1084-6.33 TPR, p. 71.
39
Letture da Mediterranee di Saba
arte della parola si rispecchiano a vicenda, e, quasi incalzandosi, a vicenda si rinnovano. Come si gioca il rapporto fra Ulisse e Entello? Sappiamo che sono in real-tà le Variazioni sulla rosa l’ultimo testo scritto da Saba per Mediterranee.34 È di poco rilievo, tuttavia, la questione cronologica di fronte alla domanda suscitata dalla collocazione di due poesie come Entello e Ulisse agli estremi del libro. Una raccolta ha un suo tempo interno: a contare in essa è il tempo della finzione stabilito dai testi, presi a sé e nelle loro relazioni reciproche (persino i dati espliciti di cronologia reale, quando vi siano, risultano assorbiti da tale tempo interno). Se da un lato Entello ci viene incontro sulla soglia del libro come ‘ultima parola’, quasi a sigillare la raccolta già chiusa, proemio e consuntivo a un tempo, dall’altro Ulisse, all’altro capo del libro, e cioè al momento del congedo, si esprime con identica forza, una forza, anzi, eguale e contraria. Abbiamo così come due propositi, conviventi in una tensione che solo un ulteriore atto del poeta può risolvere. Da un lato un ‘deporre le armi’, che trae tutto il risalto dalla sede formale e dal contenuto dichiarato (“ho scrit-te, io vecchio, queste/ poesie”); dall’altro un riprenderle, quelle armi, in una nuova apertura alla sfida – e qui la forza dell’enunciazione viene dalla col-locazione in chiusa e, seppure in altri termini, ancora una volta dai modi del bilancio personale. Due interpretazioni diverse, insomma, e coesistenti, d’un valore di ‘ultimità’ esprimibile dalla poesia (con tutte le sue apparecchiature retoriche) e dalla stessa forma-libro. A ben vedere, però, il compromesso, lo scioglimento, serpeggia già fra le parole, di Entello soprattutto. Ed è quel-lo sguardo superiore, inclusivo, di congiunzioni profonde, che già prima di Freud e di Nietzsche la Frühromantik tedesca aveva chiamato – con parola antica – ironia. Questo nuovo Entello avrà così anche i tratti di Ulisse: è il suo con-traddirsi l’atto che rinnova. E se la vita aggiunge sé a sé, il poeta che ne ac-cetti il ‘gioco’ non potrà che scrivere non l’ultima, ma ancora una poesia.
34 Cfr. Cronistoria, TPO, pp. 1064-1065. Ulisse compare nel “sommario” del libro an-nunciato a Quarantotti Gambini in una lettera del 20 maggio 1946; altre poesie, fra cui Entel-lo, furono composte in quel mese, quando la raccolta era già in parte strutturata; Variazioni sulla rosa, l’ultima, è scritta in giugno. Il libro sarebbe uscito nel mese di dicembre.