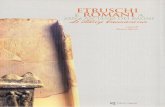VEIO : PIAZZA D’ARMI MATERIALI CERAMICI DEL VII E VI SEC. A.C.
Materiali didattici Culture Romanze Mediterranee. - 3. Sicilia
Transcript of Materiali didattici Culture Romanze Mediterranee. - 3. Sicilia
IL PROBLEMA DEL GRECISMO
IN SICILIA La tesi ‘bizantinista’
La tesi della continuità con la Magna Grecia
Come arrivano gli arabo-islamici in Sicilia?
La Sicilia è bizantina fino all’827.
La dirimpettaia Ifriqyya, attuale Tunisia,
appartiene al califfato degli Abbassidi di
Bagdad, che la governano tramite la dinastia
locale degli Aghlabiti.
Nell’827 un governatore locale bizantino,
Eufemio, si rivolta contro Bisanzio, chiedendo
protezione agli Abbassidi di Baghdad, i quali a
loro volta girano la richiesta agli Aghlabiti
d’Africa, loro ‘agenti’ locali.
Gli Aghlabiti conquistano la Sicilia, prevalendo
più facilmente in Sicilia occidentale, e
enfatizzando il ruolo di Palermo araba contro
Siracusa bizantina.
Siracusa cade nell’878.
Nel 909 una nuova dinastia scalza il potere califfale degli Abbassidi in
Ifriqyya, i Fatimidi.
Di conseguenza al nuovo scenario, i Fatimidi (che hanno base al Cairo)
tentano di imporre i loro agenti locali, i Kalbiti.
La Sicilia resterà kalbita sino all’arrivo dei Normanni.
Gli Abbassidi e gli Aghlabiti sono sunniti, invece i Fatimidi d’Egitto e i
Kalbiti sono sciiti.
Sicilia ebraica
• Ampia presenza di comunità ebraiche
• Catania
• Palermo
• Siracusa
• Iscrizioni giudaiche di Sicilia: la più significativa appare quella bilingue ebraico-latina di Catania, datata 383 d.C., la quale inizia con una acclamazione rituale in lingua e scrittura ebraica, un versetto del Salmo 124, 5, ("Pace a Israel, Amen, Amen, pace Samuel"), per proseguire in latino con un’epigrafe commemorativa della moglie di un Aurelio Samule: «ego Aurelius Samohil / conparabi memoriam mi et oxsoris mei maee » (Jewish Inscriptions of Western Europe, Vol. 1, Italy, excluding the city of Rome, p. 187, foto in Libertini 1929, p.186)
• Un codice arabo in caratteri ebraici si trova a Trapani (G. Mandalà, Un codice arabo in caratteri ebraici dalla Trapani degli Abbate (Vat. Ebr. 358), in “Sefarad”, 71 (2001), pp. 7-24)
Sicilia
• Il mozarabo siciliano è un arabo cristiano,
• …. ma di rito greco
• Complessità mozarabica:
• Corleone, 1182: soggetti esplicitamente cristiani ma con
nomi indistinguibili da nomi assolutamente arabi
• Palermo: Christodoulos, figlio di Bousetou (adattamento
di Abu-l-Sayyd ?)
• Constanza, figlia di Abu-l-Fadl
• Bresc: La presenza di un nome cristiano o greco
all’interno di una struttura onomastica araba è segno di
‘mozarabismo’, NON di conversione, come sosteneva
Amari
• Un ism greco può rinviare
• 1) a un mozarabo di origine greca (greco arabizzato)
• 2) a un neo-convertito di origine musulmana (musulmano
cristianizzato)
La conversione all’islam
implica il cambio di nome
• Cat Stevens > Yusuf Islam
• Cassius Clay > Muhammad Ali
Che lingue si parlavano in
Sicilia? Tre comunità…
• 1) comunità monolingue di parlanti latino o protoromanzo o greco monolingui, distribuiti sul territorio a macchia di leopardo, i Greci prevalentemente nel triangolo est della Sicilia
• 2) comunità diglottica, composta da Arabi, Berberi e Siculo-islamici (ex cristiani che avevano abbracciato lo stile di vita e i valori dell’Islam, che in Spagna chiameremmo mozarabi), tutti aventi in comune il registro alto, dato dall’arabo coranico classico, ma aventi un registro basso diversificato
• 3) comunità di Siculo cristiani, di madrelingua protoromanza ma acculturati in arabo, parlanti un arabo dapprima pidginizzato e poi creolizzato in terza generazione, dunque con una situazione di bilinguismo Romanzo / Arabo-Siculo pidginizzato e creolizzato
Testi arabi prodotti in Sicilia
• Cronaca di Cambridge
• Al-Tanqīb ‘alā mā fī al-Maqāmāt min al-Ġarīb, raccolta e commento di parole rare utilizzate nelle Maqāmāt d’al-Ḥarīrī e copiate da Ibn Ẓafar al-Ṣiqillī.
• Taṯqīf al-lisān di ’Ibn Makkī in realtà non dà indicazioni in tal senso. E’ un’opera cosiddetta laḥn al-ʿāmm, dedicata agli errori dell’arabo coranico, e nulla dice del siciliano.
• In ambito siciliano non sopravvivono testi romanzi in caratteri arabi, come nella letteratura alamjado-morisca, né testi come le (ipotetiche) khargiat.
• Ma … sopravvive un testo in volgare siciliano in caratteri ebraici: Alfabetin
• … sopravvivono testi in volgare siciliano in caratteri greci: ricette e scongiuri
• …. sopravvive un testo di lingua araba in caratteri greci. L’arabo sopravvive nella toponomastica, questa sì abbondante, e nell’onomastica (abbondante e quasi mai citata), e in qualche elemento lessicale agricolo.
• Scarica una carta stradale ad alta definzione (ad es.
http://xnikox.altervista.org/Immagini/Sicilia.jpg)
• e prova a identificare la toponomastica di origine araba.
• Cosa osservi? Ci sono zone in cui è particolarmente
concentrata oppure no? Ci sono aree che paiono indenni
da presenze arabe?
• Viaggiatori arabi
• Ibn Hawqal, mercante, geografo e viaggiatore arabo.
• Visse la sua giovinezza a Baghdad. A causa di un’ingente perdita patrimoniale iniziò nel 943, un viaggio trentennale nelle regioni dell'Islam.
• Nel 973 visitò la Sicilia.
• Ritornato a Baghdad nel 976, raccolse le sue impressioni di viaggio nell'opera Kitāb al-masālik wa l-mamālik (Libro delle vie e dei reami), edita a Leida da M. J. de Goeje nel 1873 per la Bibliotheca Geographorum Arabicorum (BGA), ispirata in parte all'omonimo lavoro geografico di Istakhrī.
•
• Michele Amari, traduzione di Ibn Hawqal:
• In Biblioteca Arabo Sicula, trad. ital. Torino-Roma, 1 vol. p. 10-27
• La Sicilia è un’ isola di sette giornate di cammino in lunghezza sopra quattro di larghezza; essa è coperta di monti e castelli, e di fortezze, abitata e coltivata dovunque. Palermo, la città più popolosa e più rinomata di quest’isola, è altresì sua metropoli. Situata sulle sponde del mare dal lato settentrionale, Palermo di divide in cinque quartieri distinti fra loro, quantunque poco lungi l’uno dall’altro. Il primo è la città circondata da un muro di pietra elevato e formidabile. La pianta oggi presenta un rettangolo situato sulla spiaggia del mare; in tempi assai remoti, il mare penetrava in questo luogo per mezzo di una laguna divisa in due rami (Fiumi Papireto e Kemonia). La città greco-fenicia fu fabbricata sulla lingua di terra compresa tra i due rami, il margine che rimaneva verso scirocco offri il sito ad un novello quartiere, ch’esisteva di già al tempo della prima guerra punica, la Khalessah o la Kalsa o Gausa d’oggidì. La città vecchia, la Paleapoli, fu chiamata El-Kassar, il castello o palazzo; è questo il centro dell’attuale città. La strada principale, che divide la città in due parti uguali, chiamasi ognora il Cassaro. Questo quartiere è i soggiorno de’ mercanti. Vi si ritrova la gran moschea del venerdì, altra volta chiesa de’ cristiani. La Khalessah che ha pure le sue muraglia costruite in pietra, è il soggiorno del sultano e del suo seguito; non vi si vedono né mercanti, ne magazzini di mercanzie; ma bagni, una moschea del venerdì di mezzana grandezza, la prigione del sultano, l’arsenale, e gli uffici delle amministrazioni.
• Michele Amari, traduzione di Ibn Hawqal:
• In Biblioteca Arabo Sicula, trad. ital. Torino-Roma, 1 vol. p. 10-27
Questa città ha quattro porte dal lato di mezzodì; e dal lato di levante di settentrione e di ponente, il mare
ed una muraglia senza porte. Il quartiere detto Sacalibah (quartiere degli schiavoni) è i più popolato e più
considerevole delle due città, di cui ho fatto parola. Qui è il porto marettimo. Il quartiere della Moschea,
che prende il suo nome dalla moschea detta d’Ibn-Saclab, è del pari notevole. I corsi d’acqua vi mancano
affatto, e gli abitanti bevono acqua de’ pozzi (secondo Michele Amari dietro la chiesa di San Tolentino,
dove si riscontra il toponimo moschitta o meschita). A settentrione della città scaturisce una riviera
nominata Oued-Abbas, gran riviera, sulla si rinvengono molti molini, verzieri e giardini di delizia che non
danno alcun prodotto (si parla della costa che va verso il fiume oreto). Il quartiere Sacalibah non è
circondato da alcuna muraglia. I più grandi mercati, non che quello di tutti i venditori d’olio, trovansi fra la
moschea d’Ibn-Saclab ed il quartiere El-Jadid (attuale Albergheria ove si trova il mercato di Ballarò). Nella
città si rinviene un immenso numero di moschee, la più parte delle quali sono frequentate e ritte coi loro
tetti, le loro mura e le loro porte, sorpassano il numero di 300. esse servono di radunanza agli uomini per
comunicarsi i loro lumi ed accrescerli. Al di fuori, tutto lo spazio che la circonda e che ne forma la
continuazione, spazio compreso fra le torri e i giardini, è occupato da mehall (Mehall può significare vie,
paesaggi, luoghi di delizia e padiglioni sicuramente tutto quello che in periodo normanno viene chiamato
Genoardo). Un altra linea di abitazioni si prolunga sino al luogo detto Baida. Un villaggio che s’innalza al
di sopra della città. (Toponimo di Baida ancora oggi utilizzato per la frazione sopra il borgo nuovo. A
Baida, bianca in arabo, vi si trova una terra bianchissima che è un misto di carbonato di calcio, di
magnesio, ossido di ferro e allume). Circa al Kassar, esso è Palermo propriamente detto, o la città vecchia.
La più celebre delle sue porte è la Bab-el-Bahr (porta del mare). La città è circondata da parecchi ruscelli
che scorrono da ponente a levante, e che danno forza di far girare due macine da molino. I margini di questi
sono circondati da terreni paludosi, ove cresce la canna persiana, non sono malsani ne stagni ne luoghi
asciutti. Nel centro del paese vi ha una valle coperta, i gran parte di papiri, che si impiega per la carta del
sultano (luogo oggi detto Papireto).
Michele Amari, traduzione di Ibn Hawqal:
In Biblioteca Arabo Sicula, trad. ital. Torino-Roma, 1 vol. p. 10-27
Miti arabi di Sicilia
• Tomba di Porfirio (dentro l’Etna),
• Tomba di Aristotele (vicino Palermo)
• Tomba di Socrate
• Tomba di Galeno
Ibn Ğubayr, Viaggio in Sicilia e in altri paesi del Mediterraneo,
Introduzione di Francesco Gabrieli, Sellerio, Palermo 1981, pp.
71-2
«In quanto concerne il Re di questo popolo, egli è ammirevole per la sua buona condotta e per il suo valersi dell’opera dei Musulmani, e per il fatto di tenere a servizio dei giovani eunuchi i quali tutti, o [almeno] la maggior parte, mantengono in segreto la loro credenza, e restano devoti alla legge dell’Islam. Ripone molta fiducia nei Musulmani e gli si affida nelle sue faccende personali e nelle cose più importanti, al punto che il soprintendente della cucina è un musulmano. Dispone di un corpo di schiavi neri musulmani, retti da un qaid (comandante) scelto fra loro stessi. Fanno da visir e da ciambellani i paggi suoi di cui ha un numero grande; costoro sono i pubblici ufficiali del regno ed hanno il titolo di cortigiani. Dal loro aspetto si comprende lo splendore del reame, a tal punto fanno sfoggio di vesti ricche e di cavalli agili. Non c’è alcuno di loro che non abbia un ampio seguito di famigli e clienti.
Questo Re possiede palazzi eccelsi, giardini ameni, specialmente nella capitale del regno, la detta al-Madinah. In Messina ha un palazzo bianco come una colomba, il quale domina la costa del mare. Tiene a suo servizio molti paggi ed ancelle, e non c’è regno nella cristianità dove il Re conduca una vita più molle, più deliziosa e più comoda di lui. Rassomiglia ai Musulmani per il vivere immerso nei godimenti del regnare, per l’ordinamento legislativo, per il cerimoniale, per la distribuzione dei gradi nei suoi cortigiani, per il rispetto alla maestà del regno e la pompa sua manifesta. Il suo dominio è molto esteso. Ha medici ed astrologhi a cui prodiga ogni attenzione, ed è sì interessato a questo tipo di persone che se viene a sapere che alcuno di loro è di passaggio nei suoi dominii, lo fa trattenere e lo provvede largamente del necessario onde fargli dimenticare il proprio paese. — Dio colla sua bontà preservi i Musulmani da siffatta tentazione. — Questo Re ha circa trenta anni. — Faccia Iddio che non si mostri nemico dei Musulmani o cerchi di estendersi a [loro danno].»
«Fra le cose notevoli che di lui si raccontano c’è che sa leggere e scrivere l’arabo.
Uno dei servi suoi personali ci disse che la sua ʿalāmah è: « La lode a Dio quale gli è
dovuta », e quella di suo padre era: « La lode a Dio per gratitudine ai suoi benefizi ». Le
ancelle e le concubine che tiene a palazzo sono tutte musulmane. Tra le cose più
singolari che ci raccontò lo stesso servo anzidetto, il cui nome e YaliyA (Giovanni) ibn
Fityn, il ricamatore, il quale ricama in oro nella fabbrica reale dei broccati, è che le
donne cristiane di nazionalità franca che capitano a corte si fanno musulmane,
convertite dalle dette ancelle, e tutto questo ad insaputa del Re. Sul bene fatto da queste
ancelle [si raccontano] cose sorprendenti.
Ci fu pure detto che avvennero nell’isola dei terremoti fortissimi e che questo [Re]
politeista, preso da paura, andava qua e là guardando per il palazzo e non sentiva se non
le voci delle donne e dei paggi che invocavano Dio ed il suo Profeta. Al vedere il Re
restavano spesso confusi, ond’egli per calmarli diceva loro: ognuno di voi invochi
lEssere che egli adora ed in cui crede. In quanto ai paggi, i quali sono i grandi del regno
ed i suoi ministri, essi sono musulmani; tutti, senza eccezione, compiono il digiuno
volontario e meritorio nei mesi [a ciò consigliati], fanno l’elemosina per propiziarsi
Iddio ed avvicinarsi a Lui. Riscattano e beneficano i prigionieri, allevando quelli di loro
che sono piccini e [più tardi] accasandoli; insomma compiono opere buone il più che
possono. Tutto questo è un favore di Dio grande e possente verso i Musulmani
dell’isola, ed una delle cure arcane che Egli si prende di loro.»
Lapide trilingue in memoria di Drogo, padre di Grisanto, oggi Galleria
Regionale della Sicilia, Palazzo Abatellis, Palermo
Lapide quadrilingue in memoria di Anna, madre di Grisanto, 1149,
chiesa di S. Michele de Indulciis, oggi al Castello della Zisa, Palermo
Prima colonna del portico sud della Cattedrale di Palermo, che riporta
il versetto 54 della sura 7 del Corano, detta "del Limbo",
La finzione dell’arabo
• […] pochi tra coloro che videro le iscrizioni arabe nel palazzo di Ruggero, compresi il re stesso e molti tra i suoi ministri e cortigiani erano in grado di leggerle e comprenderne il contenuto letterario. Per quanto chi non sapeva leggere l’arabo non prestasse attenzione a queste iscrizioni, ne avrebbe potuto leggere solo la forma, non il contenuto. Questo non solo perché in pochi avevano una padronanza della lingua e della epigrafia araba sufficiente a decifrare i testi, ma anche perché la maggior parte delle iscrizioni non era facile da leggere nemmeno per chi sapesse l’arabo. […]
•
• Per esempio le iscrizioni in opus sectile provenienti dalla Cappella Palatina […] comprendevano righe di testo sia orizzontali sia verticali che potevano scorrere
• dall'alto in basso o dal basso in alto, cossì che persino un letterato avrebbe dovuto capirne l'orientamento prima di poteme leggere il contenuto. E anche quando ci fosse riuscito, l’accostamento di versi dalla metrica differente creava una serie di ostacoli interni che avrebbe dovuto superare prima di poterne riuscire a comprendere il significato. Non è semplice farlo oggi, seduti indisturbati a un tavolo con i testi ben stesidavanti; si pensi a quanto poteva essere ancora più complicato per un membro della corte, a disagio per essere al cospetto del re.
•
• La forma di queste iscrizioni operava indipendenteemente dal loto contenuto per fornire a un pubblico variegato un complicato intreccio di messaggi sulla natura della monarchia normana; questo vale anche per la pseudo-epigrafia che decorava i palazzi regi perché, sebbene non abbia alcun contenuto verbale, trasmette molti di quegli stessi messaggi attraverso l’imitazione della forma delle vere iscrizioni arabe. L’uso dell’arabo in queste iscrizioni regali voleva far intendere come prima, e più importante nozione che il re padroneggiava la lingua araba. In realtà è quasi certo che Ruggero non fosse in grado di leggere o scrivere in arabo e che fosse solamente l’uso dell’arabo su monete, documenti e iscrizioni a creare l’illusione che sapesse farlo”,
• Johns, «Iscrizioni arabe», pp. 353-54
Salimbene de Adam, Cronica, nuova edizione critica
a cura di Giuseppe Scalia, Laterza, Bari 1966, p. 00.
• «Volebat [Federicus II] enim cognoscere, utrum Hebream
linguam haberent, que prima fuerat, an Grecam vel
Latinam vel Arabicam aut certe linguam parentum
suorum, ex quibus nati fuissent».
Età fridericiana
ma….
Diminuizione di atti privati
redatti in arabo tra contraenti
arabofoni
> progressivo assottigliamento
della popolazione arabofona
«Non disponiamo, dunque, di sufficienti elementi
per supporre l’esistenza di una sezione araba della
cancelleria di Federico II, dal momento che non
produsse documenti in arabo e che in essa non
lavorarono conoscitori della lingua araba. Del
resto, a partire dagli ultimi anni del XII secolo, gli
arabi di Sicilia persero di importanza anche nella
vita culturale e, dopo la loro deportazione a
Lucera, non vi fu più neppure letteratura araba e la
stessa lingua fu rapidamente dimenticata»,
F. Delle Donne, Lo stile della cancelleria di
Federico II, p. 164