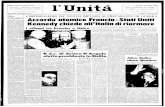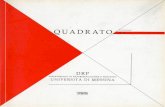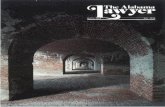La Sicilia al Bar di Spiro Scimone
-
Upload
univ-lorraine -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La Sicilia al Bar di Spiro Scimone
CENTRO DI STUDI FILOLOGICI E LINGUISTICI SICILIANIPresidente del Consiglio Direttivo: GIOVANNI RUFFINO
B O L L E T T I N O
Rivista annuale
Iscrizione in data 9 marzo 1955 al n. 3 del Registro Periodici del Tribunale di Palermo
Direzione e redazione: Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Dipartimento diScienze umanistiche dell’Università di Palermo, Viale delle Scienze, ed. 12, 90128 Palermo,Tel. +39 091 23899213 - Fax +39 091 23860661, e-mail: [email protected], sito web www.csfls.it;Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania, Piazza Dante, 24, 95124 Catania,Tel. +39 095 7102705 - Fax +39 095 7102710
COMITATO SCIENTIFICO
Roberto Antonelli, Henri Bresc, Francesco Bruni, Rosario Coluccia, Mari D’Agostino,Mario Giacomarra, Adam Ledgeway, Franco Lo Piparo, Antonino Pennisi, MaxPfister, Natale Tedesco, Alberto Varvaro
COMITATO DI DIREZIONE
Margherita Spampinato, Gabriella Alfieri, Luisa Amenta, Marcello Barbato,Marina Castiglione, Costanzo Di Girolamo, Mario Pagano, Salvatore ClaudioSgroi, Salvatore C. Trovato
COMITATO REDAZIONALE
Salvatore Arcidiacono, Michele Burgio, Tiziana Emmi, Aldo Fichera, SalvatoreMenza, Daria Motta, Pasquale Musso, Iride Valenti
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
© 2012 CENTRO DI STUDI FILOLOGICI E LINGUISTICI SICILIANI - PALERMO
I singoli contributi sono peer reviewed da un comitato di lettura costituito daalmeno due valutatori esterni
ISSN 0577-277X
Volume pubblicato con il contributo dell’Assessorato Regionale dei BeniCulturali e dell’Identità Siciliana
LA SICILIA AL BAR DI SPIRO SCIMONE
Indagare, qui per “scritto”, “nero su bianco”, la scrittura teatrale diSpiro Scimone non può dare purtroppo che una pallida immagine della bel-lezza della parola recitata, condivisa, ascoltata a teatro, il ricamo di voce esilenzi, il contrappunto di sguardi, gesti, oggetti spostati, toccati, salvati.
È dunque con grande umiltà e immenso piacere che mi accingo afarlo, qui, in terra “straniera”, in Francia, dove mi trovo a vivere, andandoindietro con la mente all’eco di quelle parole, ascoltate appunto al Teatrodelle Rocce di Gavorrano nel 2009.
1. Storia e storie1
Due i personaggi, Nino e Petru, amici d’infanzia, desertica la scenarappresentata (di Valerio Binasco): il retro di un bar, pochi gli oggetti –
a mio padre
Tutte le voci e i pianti e le sommesse parolesi raccolgono qui, nel tubo del palazzo
cui sovrasta la vetrata di lucequi si raccolgono i nostri aliti vaganti.
[…]Rocco Scotellaro, da Tutte le voci.
1 «Bar» di Spiro Scimone (Quattro scene. Personaggi: Nino, Petru). Testo in Scimone(2000). Prima rappresentazione assoluta: Taormina Arte, Palazzo dei Congressi, 9 gennaio 1997,con Francesco Sframeli e Spiro Scimone. Regia Valerio Binasco. Scene e costumi Titina Maselli.Assistente regia Leonardo Pischedda. Direttore tecnico Santo Pinizzotto. Amministrazione Gio-vanni Scimone. Organizzazione Cadmo Associazione. Produzione Compagnia Scimone Sframeli.Premio UBU 1997 Nuovo Autore a Spiro Scimone. Premio UBU 1997 Nuovo Attore a Fran-cesco Sframeli.
Annalisa Comes226
2 In Tomasello (2009: 53 e segg.).3 Regia di Carlo Cecchi. Premio IDI Autori Nuovi 1994 e Medaglia d’oro IDI per la
drammaturgia 1995.
una radio, una scala, alcune sedie ammucchiate, un contenitore per l’im-mondizia –; uno spazio “ristretto” costituito da un muro fucsia contro cuisi addossano i due attori.
Il barista, Nino – interpretato da Francesco Sframeli –, sogna di pos-sedere un giorno un locale tutto suo dove «poter fare gli aperitivi» e sfog-giare le «giacchette» che a ogni compleanno la madre – di cui è succube– gli regala. L’altro, Petru – alias Spiro Scimone –, povero disoccupato epadre di famiglia, impegna e rivende i gioielli della moglie, un vecchioorologio del padre, alla mercé di un misterioso e losco personaggio, Gianni«l’animali», che gli promette lavoro a condizione di trattenere per sé i pri-mi tre mesi di stipendio. Petru sogna un lavoro stabile, che possa redimereil suo vivere di espedienti: per ottenerlo dà a Gianni tutti i suoi beni, tuttele notti gioca a carte a insaputa della moglie, che lo crede al lavoro. Pro-prio in una partita a carte con «l’animali», vissuta dai due amici comel’occasione della vita, i due si fanno sbancare; subito dopo Gianni “mi-steriosamente” sparisce, e due ombre minacciose compaiono sotto la fine-stra del locale a indagare una morte sospetta.
Nel retro del bar claustrofobico e quasi monacale, i due intreccianouna serie di dialoghi serrati e percussivi, da cui lo spettatore ricostruisceper strati successivi, vari, il carattere, le ossessioni, le manie, particolaridell’infanzia, e infine le difficoltà del loro vivere quotidiano. Uno spazioin cui non “succede” granché e dove perfino gli echi della vita esterna ar-rivano attutiti, smorzati, dalla piccola finestra nera. La vita spiata fuoridalla porta del bar è minacciosa e inquieta, proietta lunghe ombre ango-scianti e deformate, e tuttavia il suo “racconto”, la “storia” narrata è ri-dotta a un’esile trama, evita percorsi naturalistici, utilizzando invece unadrammaturgia ben solida, costituita da un intreccio “fisico”, un corpo acorpo di domande e risposte, e assecondata da una regia sapiente.
2. A partire dalla voce
A rendere la storia “vera” – nel senso teatrale del termine –, esperi-bile, funzionante dunque dal punto di vista scenico, l’impiego del dialettomessinese2, altra lente solo superficialmente deformante (in più occasioniScimone ha dichiarato il suo intento di «deformare la realtà per essere piùcomunicativi»). Non è la prima volta per Spiro Scimone, che già nel 1994– quindi tre anni prima di Bar – con Nunzio3 aveva felicemente sperimen-
La Sicilia al Bar di Spiro Scimone 227
4 Chiappori (2003). E ancora: «Sono convinto, che nel teatro ci sia una sola lingua: lalingua teatrale, che si può creare con le parole di tutte le lingue del mondo: italiane, francesi,inglesi, siciliane. L’abilità o l’originalità di un autore, nel creare la lingua teatrale, consiste nelriuscire a mettere insieme le parole, che i corpi dei personaggi gli suggeriscono, mantenendosempre viva la solita relazione tra autore, attore, spettatore. Le parole dovrebbero essere messeinsieme pensando al loro significato e alla loro musicalità. Il ritmo e la musicalità dei dialoghisono indispensabili per creare la giusta atmosfera dell’opera. A volte, scrivere una parola in piùo in meno, non cambia il senso della frase, ma modifica il suono. La sonorità contribuisce acreare gli stati d’animo dei personaggi, dell’attore e dello spettatore» (Scimone 2009: 3-4).
5 Interessanti le parole di Scimone: «Il punto di partenza della mia drammaturgia, comel’interpretazione dell’attore, è la ricerca del corpo dei personaggi. Se trovo il loro corpo, troveròle loro parole, i loro silenzi, i loro pensieri, le loro azioni. Il mio primo testo teatrale Nunzio,scritto in messinese, nacque proprio così. Il protagonista, attraverso il suo corpo e la sua fisicità,mi suggerì le prime parole del testo: “Cori di Gesù, ti pregu. Fammi passari ‘sta tussi, sùbbutusùbbutu. (Tossisce di nuovo) Puru dumani si ti veni mègghiu… Ma ti pregu fammìllapassari.” Se non avessi trovato il corpo del personaggio, con la sua malattia, la sua tosse, le sueazioni, probabilmente Nunzio non l’avrei mai potuto scrivere. Trovare il corpo dei personaggi,non è semplice, essi non hanno un corpo astratto e non hanno nemmeno un corpo naturale. Ilcorpo dei personaggi è un corpo teatrale che vive con la rappresentazione, attraverso il corpodell’attore; rappresentazione in cui è indispensabile la presenza dello spettatore. Senza spettatorenon c’è rappresentazione, l’attore non può fare esistere i suoi personaggi e se non esistono ipersonaggi non esiste nemmeno l’autore» (Scimone 2009: 1).
tato un dialetto che diviene koiné a tutti gli effetti, che si costituisce so-prattutto di musica e ritmo, che nel ritratto del microcosmo dei due amiciperde la sua connotazione realistica, o “soggettiva”, per assurgere a unadimensione cosmica: lingua del teatro tout court. Nelle parole di Scimonein un’intervista al quotidiano «la Repubblica» del gennaio 2003:
Cerchiamo di dare voce a coloro che spesso nella vita sono costretti al si-lenzio. Grazie al teatro, riusciamo a farli parlare, a far ascoltare il loro grido.In questo il ricorso al messinese è stato fondamentale. Non solo perché èla lingua della mia infanzia, ma perché è perfetta per rendere quel mondodi esclusi. Anche se non si tratta del dialetto quotidiano, non è un tentativodi imitazione della realtà. È una lingua pensata per la scena, costruita suuna sorta di partitura musicale, ma che resta sempre qualcosa di incompiutofino a quando non prende corpo, energia, vita grazie all’attore4.
L’assunto, più volte sottolineato, anche in numerose interviste (che èpossibile ascoltare in internet), è che il teatro debba comunicare emozioni– sola condizione per diventare universale –, ed è universale quando si farespiro, carne, quando è innestato nei comportamenti, nelle parole, nei si-lenzi, nelle pause, nel corpo, nei gesti degli attori5.
Anche attraverso gli oggetti, alcuni presenti fisicamente sulla scena,altri solo evocati – ma non per questo, vedremo, meno “reali” –, Scimonetrascende il particolarismo: come non pensare al correlativo oggettivo à laMontale? L’orologio, il bicchierino di vino, le mosche e gli scarafaggi, lagiacchetta, le mutande, la sveglia…
Il comico (ma si dovrebbe dire il ‘teatro’) nasce da questo attrito di
Annalisa Comes228
6 Ancora le parole di Scimone: «Il teatro è scambio. È conflitto. È relazione tra gli op-posti. Far convivere elementi opposti, in teatro, è uno degli obiettivi più importanti da raggiun-gere. […] La mia drammaturgia è caratterizzata, proprio dalla ricerca di mantenere l’equilibriotra dramma e comicità.» (Scimone 2009: 2).
7 Cfr. il saggio «L’umorismo» del 1908.8 In Calamai (2005:27). Sulla lingua di Scimone cfr. anche Sica (2007: 303-330).
opposti, da quest’equilibrio sempre in fieri, sempre affannosamente cercatoe mai offerto come già preconfezionato6. È un comico dal sapore amaroquello che sprigiona dalle scene di Spiro Scimone e Francesco Sframeli.Dietro e/o dopo la risata, c’è la riflessione e la riflessione ci avvicina aldramma, ce lo fa ascoltare, comprendere. Oltre le ben note vicinanze –sottolineate a più riprese – con il teatro dell’assurdo e dunque Beckett,Pinter, Brook, questo straniato e straniante “neonaturalismo” strizza l’oc-chio, a mio avviso, a un altro geniale isolano, Pirandello, con il suo «sen-timento del contrario», con il suo imprevedibile umorismo7.
Il teatro che si sviluppa dunque in questo modo, nella sua fisica te-matica è reso formalmente dal martellamento ora veloce, ora riposato, dibotta e risposta, brevi, ossessive, dalla varietà delle anafore – in un anda-mento potremmo dire a “coblas capfinidas” –, da ripetizioni che sfocianospesso nell’assurdo, anche e soprattutto quando si tratta di grandi temi:l’amore filiale, la giustizia, la violenza, e così via. Proprio a livello dellaretorica, la struttura dialogica espone al massimo livello la forza struttu-rante della vis comica (e tragica insieme), come ha evidenziato chiaramenteSilvia Calamai:
… il dialogo è nella maggior parte rappresentato da battute brevi, brevis-sime, dal ritmo martellante e ossessivo ottenuto, nelle strutture domanda-ri-sposta, mediante la ripetizione della domanda in forma assertiva. Queste ri-sposte, che potremmo definire ‘risposte-eco’ sostituiscono nella maggior partedei casi battute olofrastiche del tipo SI/NO (che pure ci sono, in alternativa,a costituire una sapiente partitura) … In altre risposte viene parzialmenteriutilizzato il materiale lessicale presente nelle domande (una sorta di ‘ripe-tizione-differente’)8.
Così in alcuni tratti della Scena I:
Nino: Jo non ci dava cchiù di trentanni.Petru: Tutti non ci dannu cchiù di trentanni. (…)***Nino: Ci dicisti di véniri ccà?Petru: Iddu vosi véniri ccà.Nino: Ccà non putìti giucari ‘e catti!Petru: Non giucamu ‘e catti!***Petru: Sì. Dammi un bicchierinu, Nino.Nino: ‘N àutru?
La Sicilia al Bar di Spiro Scimone 229
Petru: L’ùttumu.Nino: Nni bivisti assai.Petru: L’ùttumu e basta.Nino: L’ùttumu e basta, però.Petru: L’ùttumu e basta.***Nino: Quantu siti chi giucati?Petru: Quattru.Nino: Sulo quattru?Petru: Quattru.***Nino: A unni giucati?Petru: A casa di Gianni.Nino: Sempre a casa di Gianni?***Petru: Puru dumani?Nino: Puru dumani.Petru: Sicuru?Nino: Sicuru.
per arrivare all’esilarante chiusura della scena:
Petru: To’ matri usa ‘a mutanna di Sara?Nino: Sì.Petru: Ti pari giustu?Nino: M’insigni a giucari chi catti francisi?Petru: Ti pari giustu?Nino: Non mi pari giustu.Petru: È mancanza di rispettu.Nino: Ma Sara n’o sapi…Petru: Sulu pi’ Sara è mancanza di rispettu?Nino: M’insigni a giucari chi catti francisi?Petru: Nino, to’ matri usa ‘a mutanna di Sara.Nino: Sì.Petru: Ti pari giustu?Nino: M’insigni a giucari chi catti francisi?Petru: Ti pari giustu?Nino: Non mi pari giustu.Petru: È mancanza di rispettu.Nino: Ma Sara n’o sapi…Petru: Sulu pi’ Sara è mancanza di rispettu? Sulu pi’ Sara è mancanza dirispettu?Nino: N’o sàcciu!Petru: Sulu pi’ Sara to’ matri non avi rispettu?Nino: Basta, Petru!Petru: Sulu pi’ Sara!Nino: Basta! Basta!Petru: Sulu pi’ Sara! Sulu pi’ Sara!
Annalisa Comes230
3. Il mondo femminile
Proprio la figura sopra evocata di Sara, ci fa aprire un altro capitolonel libro del teatro di Spiro Scimone e Francesco Sframeli… Dire che ilmondo femminile è assente nella pièce solo perché non ci sono personaggifemminili in campo, è in effetti grossolano e del tutto sbagliato. Il mondofemminile è presente nel testo attraverso la rievocazione di due donne daiconnotati contrapposti, e dunque due figure tragicomiche: Sara, l’amica diNino che “lavora” sul marciapiede di fronte, e la madre di Petru. Sonodue veri e propri personaggi vivi, “presenti” sulla scena tramite gli oggettireali, insistiti, minuziosamente, ossessivamente insistiti: la «mutanna» perSara (scena I); la «giacchetta», ma soprattutto la sveglia, per la mamma.
Nel passaggio della scena III:
[…] Silenzio
Petru: Tutti i matini, apri u bar a ‘st’ura?Nino: Sì.Petru: Così prestu?Nino: Sì.Petru: Comu fai mi ti svigghi così prestu?Nino: Mi svigghia me’ mamma.Petru: Non ll’hai ‘a sveglia?Nino: Ll’haiu.Petru: E picchì non ti punti ‘a sveglia?Nino: Picchì mi svigghia me’ mamma.Petru: Ma si tu punti ‘a sveglia non c’è bisognu chi ti svigghia to’ mamma.Nino: Jo a punto a sveglia. Ma mi svigghia me’ mamma.Petru: N’a senti sunari?Nino: Chi?Petru: A sveglia.Nino: No.Petru: Hai u sonnu pisanti?Nino: Non hàiu u sonnu pisanti.Petru: E picchì n’a senti sunari?Nino: A stacca me’ mamma! Avi cchiù di vintanni chi me’ mamma mi staccaa sveglia. I primi voti ‘a staccava ‘e setti. Jo, tutti i siri, puntava ‘a sveglia‘e setti, ma n’a sintìa mai sunari, pinsava: ‘sta sveglia non funziona e nnicomprava ‘n autra, ‘a puntava e setti, ma puru chista n’a sintìa mai sunari…Pinsava: puru ‘sta sveglia non funziona e nni comprava ‘n autra, ‘a puntavae setti, ma puru chista n’a sintìa mai sunari… Pinsava: puru ‘sta sveglia nonfunziona e nni comprava ‘n’autra…Petru: Quantu svegli comprasti?Nino: Assai! Dopu sei misi capìa chi non era ‘a sveglia ma era me’ mammachi si svigghiava deci minuti prima di setti e ‘a staccava. Allura ‘na sira pun-tai ‘a sveglia ‘e sei e menza, ma puru dda vota me’ mamma si svigghiau deciminuti prima. Allura puntai ‘a sveglia ‘e sei, ma puru dda vota me’ mammasi svigghiau deci minuti prima…
La Sicilia al Bar di Spiro Scimone 231
Petru: Ma picchì to’ mamma si svigghiava sempri deci minuti prima da sve-glia?Nino: P’u café! Così mi puttava ‘nto lettu u café! (Pausa)Petru: Ma si ti voi svigghiari c’a sveglia basta chi chiudi a chiavi a stanza aunni dommi tu, così to’ mamma non po’ ‘ntràsiri.Nino: Si chiudu a chiavi ‘a stanza a unni dommu jo, me’ mamma non po’cchiù nésciri.Petru: Da quantu tempu dommi cu’ to’ mamma?Nino: Da picciriddu. (Pausa) Ti fazzu u café?
Attraverso gli oggetti riconosciamo Sara come “vittima”, una poveraragazzetta in mano a Gianni l’«animali» che la prende a bastonate; e ri-conosciamo la madre come «carnefice», che attrae a sé Nino, vittima diinconscia e comica leggerezza.
4. Lingua/e
Dal punto di vista della morfologia (e morfosintassi), funzionale e ca-ratterizzante appare la presenza di alterati: i diminutivi, fondamentali perlo sviluppo della vis comica, come ad es. il «bicchierinu» (scena I, 2 vol-te; scena II, 1 v.; scena IV, 1 v.), definito sempre «l’ùttumu», che, presentefin dalla prima scena, conclude – suggerito e innominato – la pièce (dasottolineare che altrove, come per es. nel caso dell’«animali» Gianni, iltermine utilizzato è «bicchieri») :
Nino: Nni voi?Petru: Nni bivemmu assai.Nino: L’ùttumu e basta.Petru: L’ùttumu e basta, però.Nino: L’ùttumu e basta.
Buio.
Sipario.
O come il diminutivo «picciriddu», che innesca tutta una serie di ri-cordi, tragicomici, a partire dalla scena I:
Petru: Da quantu tempu fai u barista?Nino: Da vintanni.Petru: Prima chi facivi?Nino: Era picciriddu.Petru: Annavi a scola?Nino: Sapìa léggiri e scrìviri.Petru: Chi sapìi scrìviri?Nino: U me’ nomi.
Annalisa Comes232
9 Cfr. De Matteis (2004: 210).10 Cfr. Calamai (2005: 1-38).11 Scimone (2006: 3).
Il termine è ripetuto poi 7 volte nella scena II, due nella III. In unacontrapposizione tra il sentimento della parola nei due amici (che lo usanocon sapore nostalgico) e nello spettatore, dà vita a una grande comicitàmista a disgusto (per poi condurre a pena e tristezza), rievocando giochidi mosche e scarafaggi: da bambini i due protagonisti venivano assoldatidai proprietari dei negozi per catturare vive o morte mosche escarafaggi che dovevano poi essere rilasciati nei negozi dei concorrenti.
Infine la «giacchetta», anzi le giacchette, dato che sono almeno tre(fatte fare dal sarto), dono della mamma al figlio Nino per i vari comple-anni: c’è quella per i «ventiseianni»; quella «janca» per i «ventinovanni»,«di rasu, chi buttuni dorati»; l’altra per i «trentanni», «… sempre di rasu,chi buttuni dorati, pero .. russa chi bordi niri.. ». Il termine è ripetutoaddirittura 15 volte nella scena II (e poi un’ultima volta nella scena III),ma, di nuovo, come nel caso dell’alternanza bicchierinu/bicchieri, anche quitroviamo «giacca» all’inizio della scena IV, proprio perché non in riferi-mento a Nino. La giacchetta è il sogno “congiunto”, potremmo dire, diNino e della madre, delle “grandi speranze”, di arrivare ad avere un barproprio dove finalmente poter fare gli aperitivi con un bel sottofondo dimusica americana…
Nell’ambito del lessico (e della semantica) abbiamo già sottolineatola funzione del dialetto, che evidenzia ancora una volta come molte vocirimandino al registro informale e familiare, tipico dell’oralità, come peresempio: «mi fa schifu» (ripetuto 2 volte nella scena II) o «gente chi cun-ta» (scena IV), e altre appartenenti al registro substandard e volgare, come«cessu» (ripetuto 4 volte nella scena I) e «cazzu» (1 occorrenza nella scenaII). Nello stesso modo, seguendo appunto l’ambito sociale dei due, vedia-mo predominare il sistema della paratassi sull’ipotassi. Le frasi sono spessobrevi, brevissime; frasi nominali, con strutture ellittiche di vario tipo (cosìcome anche risulta dagli studi di De Matteis9 e Calamai10), da mettere inrelazione – sul piano della scrittura scenica – alla presenza insistita di di-dascalie di pause e silenzio. Con queste parole Scimone ne indica la va-lenza:
Nella drammaturgia, il silenzio è fondamentale. Non è facile scrivere il si-lenzio, ma quando si riesce a farlo è come aver scritto un numero infinitodi parole11.
Sono 4 nella Scena I (a cui si aggiunge un «fuori scena»); 5 nellascena II (inoltre inizio nel silenzio); addirittura 11 nella scena III (e inizio
La Sicilia al Bar di Spiro Scimone 233
12 Alla domanda «Citando Eduardo hai rievocato l’attualità della questione della lingua,non intesa soltanto in ciò che può significare “italiano” o “dialetto», Spiro Scimone risponde:«C’è un teatro di testo e ci sono gli attori che parlano. Si devono trasmettere le emozioni, sidevono creare relazioni. Ho iniziato a scrivere in messinese e ultimamente uso l’italiano, ma nonfaccio distinzioni. Esiste solo una lingua, quella teatrale. Il siciliano possiede delle sonorità cheè possibile ricreare anche con l’italiano. Il messinese che si legge nei miei testi non è quelloche parlano i miei conterranei. È lo studio sulla parola e sui dialoghi ad essere teatrale, perchési relazionano con gli oggetti, lo spazio, gli spettatori. Io compongo studiando i silenzi e le pau-se, ciò che sta tra una parola e un’altra, per trovare una parola “forte” prima del silenzio. Ciòconsente uno studio attento della parola, che poi genera una situazione, la creazione di un’at-mosfera»: «Giovani a Teatro’s Blog », 17 gennaio 2011.
13 Spettacoli sono stati rappresentati in Francia, Belgio, Inghilterra, Germania, Spagna,Canada, Argentina, Portogallo, Olanda, Croazia, Grecia, Svezia e nei festival europei più pre-stigiosi e significativi (tra i quali il Festival d’Automne a Parigi, il Kunsten Festival des Arts diBruxelles, il Festival de Otoño a Madrid, Il Festival internazionale di Rotterdam, il Festival deAlmada–Portogallo, il Festival Inernacional de Teatro Mercosur Cordoba, ecc.). I testi di SpiroScimone sono tradotti in francese, inglese, tedesco, greco, spagnolo, portoghese, norvegese, croa-to, sloveno, danese e messi in scena in Francia, Germania, Portogallo, Scozia, Grecia, Croazia,Slovenia, Svizzera, Belgio, Norvegia, Danimarca, Brasile, Cile, Venezuela (pubblicati in Franciadall’Arche tradotti da Jean Paul Manganaro e Valeria Tasca, in Spagna dal Teatro del Astillero,traduzione di Carla Matteini, in Portogallo da Artistas Unidos).
nel silenzio). Unitamente, sul piano della grafia, si evidenzia l’uso insistitodei punti di sospensione, utilizzati, in ordine decrescente: 16 volte nellascena I, ben 34 v. nella scena II, 16 v. nella scena III e 4 v. nella scenaIV.
Il successo del teatro di Spiro Scimone e Francesco Sframeli, in Italiae all’estero, ci fa ben sperare per il futuro. Il teatro è un’arte viva e quan-do il pubblico se lo trova davanti, lo riconosce, riesce ad apprezzarlo,riesce ancora a ridere, ad ascoltare, a riflettere: le lingue allora si fanno“lingua”12, e un assolato triangolo d’Italia sembra portare luce ai quattroangoli cardinali13.
Versailles ANNALISA COMES
BIBLIOGRAFIA
Arvers, Fabienne, 2001. «Spiro Scimone et Francesco Sframeli - Hic et nunc», in LesInrock(http://www.lesinrocks.com/2001/11/06/musique/concerts/spiro-scimone-et-francesco-sframeli-hic-et-nunc-11217875), 11 giugno.
Calamai, Silvia, 2005. «Lingue da palcoscenico. Il teatro dell’anno 2004», in Quaderni del La-boratorio di Linguistica, 5, anno 2004/2005, pp. 1-38 (numerazione dell’estratto).
Capitta, Gianfranco, 1998. «A Messina giovani affacciati sul nulla», in il Manifesto, 15 maggio.Chiappori, Sara, 2003. «Confessioni al Bar/Spiro Scimone ‘La mia Sicilia degli esclusi’», in la
Repubblica, 8 gennaio.Compagnia Scimone Sframeli (http://www.scimonesframeli.org)De Matteis, Tiberia, 2004. «Spiro Scimone e i rituali del disagio», in Autori in scena. Sei dram-
maturgie italiane contemporanee, Roma, Bulzoni, pp. 199-213.Di Giammarco, Rodolfo, 2000. «Cinquanta minuti di Bar splendidi e tragicomici», in la Repub-
blica, domenica 27 gennaio.
Annalisa Comes234
Doninelli, Luca, 2003. «Nel ‘Bar’ di Scimone e Sframeli il teatro mischia dolore e bellezza», inAvvenire, 14 gennaio.
Giacobbe, Gigi, 1997. «Tra Beckett, Linus e Andy Capp - Si consuma cosi la solitudine nelretro del bar di Spiro Scimone», in Giornale di Sicilia, 11 gennaio.
Guerrieri, Osvaldo, 1997. «Carlo Cecchi: Il mio Pinter di sarcasmo e dissoluzione», in “La Stam-pa”, 8 febbraio.
La Ruina, Saverio, 2011. «Il teatro dell’asolto di Scimone e Sframeli», in Giovani a Teatro’s Blog,17 gennaio (http://giovaniateatro.wordpress.com/2011/01/17/il-teatro-dellascolto-di-scimone-e-sframeli/).
Novelli, Laura, 2000. «Annega in un dialogo da ‘Bar’ il fallimento dell’uomo del Sud», in IlGiornale, 11 marzo.
Quadri, Franco, 2003. «Chinotti e risate, quanto è bella la vita del Bar», in la Repubblica, 22gennaio.
Savioli, Aggeo, 1997. «Mezzogiorno sul palcoscenico fra niente e Pinocchi napoletani», in l’Unità,1 giugno.
Scimone, Spiro, 2000. Teatro, Nunzio Bar La festa, Introduzione di Ettore Capriolo, ubulibri,Milano.
–, 2006. «In teatro la lingua bisogna inventarsela», in Neri Binazzi – Silvia Calamai (a cura di),Lingua e dialetto nel teatro contemporaneo. Atti della Giornata di Studio, (Prato, 12 marzo2004), Firenze, Unipress pp. 1-6 (numerazione dell’estratto).
–, 2009. «Il corpo nella scrittura teatrale», in Varietà dell’italiano nel teatro contemporaneo. Attidella Giornata di Studio, (Strumenti), Scuola Normale Superiore, Pisa, pp. 1-7 (numera-zione dell’estratto).
Sica, Anna, 2007. «La drammaturgia degli emarginati nella recente scena siciliana», in PaoloPuppa (a cura di), Lingua e lingue nel teatro italiano, Roma, Bulzoni, pp. 303-330.
Tomasello, Dario, 2009. Un assurdo isolano. Il teatro di Spiro Scimone e Francesco Sframeli, Roma,Editoria & Spettacolo.
Giuseppe Brincat, Il siciliano dei documenti di Malta (1350-1550).Documenti della Universitas conservati nell’archivio della Catte-drale di Mdina . . . . . . . . . . pag 5
Giuseppina Brunetti, Il viaggio della grammatica di Francesco daButi da Pisa alla Sicilia: considerazioni sul MS. Città del Vatica-no, BAV, Ottoboniano Lat. 1193 . . . . . . . » 13
Rosario Coluccia, Il glossario dei poeti della Scuola Siciliana . . » 25
Fabrizio Franceschini, Il lessico della cultura materiale (lavori, pian-te, aniali) nelle redazioni siciliane delle «Regule» di Francescoda Buti (Fine XIV-XV secolo) . . . . . . . » 43
Gabriella Macciocca, Schede siciliane di Guidernone . . . . » 95
Mario Pagano, Appunti sparsi per un vocabolario del siciliano me-dievale . . . . . . . . . . . » 113
Pasquale Caratù, Concordanze lessicali Sicilia-Italia meridionale nellinguaggio marinaresco . . . . . . . . » 139
Nicola De Blasi, Francesco Montuori, Storia di parole tra la Siciliae Napoli . . . . . . . . . . . » 165
Alessandro De Angelis, Percorsi del significato: considerazioni sul sic.Sciara . . . . . . . . . . . » 185
Salvatore Claudio Sgroi, Lessico(grafia) e Wortbildung a Palermo . » 203
Fiorenzo Toso, Il lessico storico delle tonnare: alcune riflessioni . » 211
Annalisa Comes, La Sicilia al Bar di Spiro Scimone . . . . » 225
Sergio Lubello, Sicilianismi e lingua d’autore: da Capuana a Piran-dello . . . . . . . . . . . » 235
Francesco Marchegiani, Sondaggi lessicali nelle lettere della fami-glia Verga . . . . . . . . . . . » 247
Tavola rotonda, La lessicografia dialettale oggi. Alcune prospettivedi lavoro . . . . . . . . . . . » 267
. . . . . . . . . . .
La diffusione del Bollettinoè curata dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani
Sito web: www.csfls.it