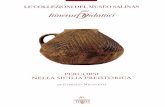La selvicoltura in Sicilia: problemi e prospettive
Transcript of La selvicoltura in Sicilia: problemi e prospettive
- 828 -
F. MAETZKE (*) - G. BARBERA (*) - S. CULLOTTA (*) - T. LA MANTIA (*) D.S. LA MELA VECA (*) - G.M. PIZZURRO (*)
LA SELVICOLTURA IN SICILIA: PROBLEMI E PROSPETTIVE
(*) Dipartimento di Colture Arboree, Università di Palermo
Le formazioni forestali siciliane, pur ridotte in termini di superficie, presentano una forte eteroge-neità dovuta alle pressioni ambientali e antropiche subite. I numerosi rimboschimenti, realizzati dalla metà del secolo scorso, presentano situazioni estremamente diversificate per le specie utilizzate ma anche per la carenza di adeguate cure colturali. Questo è stato determinato dalla mancanza di una po-litica forestale con indirizzi chiari e continuità nel tempo.
Su questa situazione grava l’attuale vuoto della pianificazione esecutiva ed inoltre pochissimi piani di assestamento sono stati redatti, ben poco applicati. Di fronte a così gravi carenze, è utile individua-re opportune linee guida di gestione per ciascun tipo forestale che possano consentire di colmare, per ambiti omogenei, l’assenza di strumenti di pianificazione di dettaglio.
Il rinnovato interesse e attenzione verso il bosco, visto come risorsa ambientale e turistico-ricreativa nonché come opportunità economica - sensu lato - oggi tradotto anche in disposizioni nor-mative comunitari e nazionali, richiede un momento gestionale e di conseguenza di pianificazione non più procrastinabile. Alcune formazioni possono rivestire interesse economico più specifico. Lo studio riporta gli indirizzi di intervento per ciascuna categoria forestale identificata. Parole chiave: pianificazione forestale, gestione forestale sostenibile, rimboschimenti, Sicilia. Key words: forest planning, sustainable forest management, reafforestation, Sicily. Mot clés: planification des forets, gestion soutenable des forets, reforestation, Sicile.
1. IL PATRIMONIO FORESTALE IN SICILIA
Secondo i dati dell’ultimo Inventario Nazionale delle Fo-reste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (2007) la superfi-cie forestale della Sicilia ammonta a 338.171 ettari ripartita fra Boschi e Altre terre boscate. Nonostante sia più che raddoppiata rispetto a quella del 1947 (140.678,00 ettari) (Cavarretta e Saporito, 1998), il coefficiente indicativo del-le risorse forestali (boschi e aree pre-forestali) regionale, pari al 13,1%, è comunque notevolmente più basso rispetto al corrispondente valore nazionale (34,7%). Nella categoria “Boschi” rientrano i boschi alti, gli impianti di arboricoltu-ra da legno e le aree temporaneamente prive di soprassuo-lo, mentre in quella “Altre terre boscate” rientrano i boschi bassi, i boschi radi, le boscaglie, gli arbusteti, le macchie-garighe.
Ciascuna categoria inventariale è suddivisa in categorie forestali indicate sulla base della specie o del gruppo di specie prevalente, per evitare categorie di tipo misto.
Le categorie forestali dei Boschi alti presenti nel territo-rio regionale siciliano sono riportate in tabella 1.
In Sicilia i boschi naturali ammontano a circa 146.000 ettari (elaborazioni su dati INFC 2007) e sono rappresenta-ti, in ordine decrescente, da boschi di roverella (molti dei quali in formazioni miste) (52.161 ettari), cerrete (20.000 ettari), leccete, sugherete, faggete, castagneti, pinete di pi-no marittimo, pinete di pino laricio (4.000 ettari), rovereti (1.516 ettari), pinete di pino d’Aleppo (800 ettari) e betule-ti (758 ettari).
I querceti caducifogli più estesi, le cerrete, sono localiz-zati sui Nebrodi; seguono i querceti di roverella, soprattutto nei rilievi del Nord-est, ma in maniera frammentata su tutta l’isola.
Le sugherete sono localizzate prevalentemente lungo i versanti settentrionali dei Nebrodi e delle Madonie. Nuclei
più ridotti si rinvengono sui Monti di Palermo, sugli Iblei e nella Sicilia Sud-orientale.
Le leccete più estese e meglio conservate si trovano sull’Etna e sulle Madonie. Altrove, senza mai formare veri e propri complessi monospecifici ampi, il leccio impronta il paesaggio forestale di molti siti del siracusano, degli Iblei, dei Nebrodi e delle Isole minori. Sui Peloritani, spesso, esso costituisce la vegetazione sommitale, su suoli primitivi.
La distribuzione delle faggete è strettamente legata ai maggiori complessi montuosi dell’Isola e rientrano quasi esclusivamente all’interno dei Parchi regionali dei Nebro-di, dell’Etna e delle Madonie occupando, ad eccezione dell’Etna, la fascia più elevata in corrispondenza del limite della vegetazione arborea.
I castagneti più estesi ricadono sui Nebrodi orientali, sui Peloritani e sull’Etna.
Tra le formazioni minori, le pinete di pino marittimo, le pinete di pino laricio e i betuleti si distribuiscono in manie-ra esclusiva rispettivamente nell’Isola di Pantelleria e sull’Etna, mentre i rovereti relitti sono prevalentemente presenti sulle Madonie e sui Nebrodi.
Alla metà del novecento, a seguito delle guerre e il con-seguente degrado sociale e ambientale, la Sicilia appariva praticamente quasi priva di copertura forestale, ridotta a poco più di 90.000 ettari sugli oltre 2,5 milioni di superfi-cie totale, delineando uno scenario disastroso.
Nel periodo compreso fra il secondo dopoguerra e gli anni settanta il patrimonio forestale della Sicilia è notevolmente aumentato grazie ad una graduale e vasta opera di rimbo-schimento, realizzata soprattutto con conifere, che ha contri-buito a modificare il paesaggio (La Mantia, 2002) e ha inci-so, spesso in maniera rilevante, sull’economia del territorio.
Ad oggi in Sicilia i boschi artificiali ammontano a circa 70.000 ettari (elaborazioni su dati INFC 2007) e sono stati realizzati prevalentemente dall’Azienda Regionale Foreste
- 829 -
Demaniali, dall’E.S.A (Ente Sviluppo Agricolo), dalla SICILFOR, dai Consorzi di Bonifica e, in piccola parte, dai privati e dai Comuni. Essi si distribuiscono principalmente nella Sicilia Centro occidentale, con le superfici più estese presenti in provincia di Palermo e Agrigento (popolamenti a prevalenza di conifere mediterranee), Enna e Caltanisset-ta (eucalitteti puri e misti a conifere mediterranee). Consi-stenti sono anche le superfici forestali in provincia di Mes-sina e Catania, costituite rispettivamente con conifere me-diterranee ed eucalipti e con pino laricio, e i rimboschi-menti puri e misti di pino nero e cedro dell’Atlante ubicati sui Monti Sicani e sulle Madonie.
In particolare, tra le specie utilizzate nel piano basale fi-gurano i pini mediterranei (pino d’Aleppo, pino domestico e pino marittimo, in ordine di frequenza), il cipresso co-mune e il cipresso dell’Arizona mentre alle quote più ele-vate, il pino nero d’Austria, il pino laricio, il cedro dell’Atlante (Saporito, 1995; Cavarretta e Saporito, 1998; La Mela Veca e Saporito, 2000). Tra le latifoglie sono state impiegate, in purezza o in consociazione alle conifere, l’orniello, l’ontano napoletano, il frassino minore, il casta-gno, l’acero campestre, l’olmo campestre, la roverella. Largo impiego hanno trovato anche la robinia, sia pure in ambienti particolari quali scarpate, corsi d’acqua, zone in frana (La Mantia et al.,1999), e gli eucalitti.
Alcune immagini relative a periodi diversi (1947 e 2005) testimoniano quanto imponente sia stata l’opera di rimbo-schimento in Sicilia (Fig. 1).
2. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI IN SICILIA
La selvicoltura su vaste aree è dipendente
dall’applicazione di una coerente politica forestale. La rea-lizzazione della politica forestale, impostata dal quadro na-zionale e resa cogente dalle norme e dai piani regionali, è demandata alla redazione e applicazione degli strumenti di pianificazione a livello territoriale e locale (Cullotta e Mae-tzke, 2008a, 2008b). Storicamente lo strumento fondamen-tale adottato in Italia è il piano di assestamento forestale, redatto a livello aziendale. Le norme vigenti lo confermano e in Sicilia già le prime norme specifiche (LR 11/89) ri-chiamavano l’obbligatorietà dei piani di assestamento, così come nelle recenti leggi forestali regionali (LR 16/96 e successive modifiche e integrazioni) è costante il concetto che la gestione dei boschi pubblici e privati è “di norma, ...[effettuata]...sulla base di piani di gestione forestale so-stenibile“. Ciononostante, le norme sono rimaste “sostan-zialmente inattuate”. In Sicilia infatti sono stati redatti e approvati solo tre piani di assestamento e i loro dettati, a loro volta, non sono mai stati di fatto applicati o aggiornati alla loro scadenza.
Inoltre, nonostante l’esistenza di una normativa regiona-le, fino ad ora lo strumento pubblico di tutela in campo fo-restale si riduce all’applicazione delle Prescrizioni di Mas-sima e Polizia Forestale (P.M.P.F.). A livello nazionale le P.M.P.F. sono state sostituite recentemente dai regolamenti provinciali, dalle norme tecniche di attuazione o piani di gestione nei territori protetti. Tuttavia, anche questi ultimi hanno carattere generale e spesso sono poco specifici nelle norme tecniche. In Sicilia, il governo regionale ha aggior-nato, secondo le rettifiche del D.A. n. 13 del 20 Gennaio
2006, le preesistenti P.M.P.F. valevoli per le diverse pro-vince. Inoltre, alcuni enti gestori di aree protette (Ente Parco dei Nebrodi e delle Madonie, Azienda Regionale Foreste Demaniali) hanno redatto delle proprie specifiche normative e disciplinari delle attività selvicolturali e/o dei divieti ope-ranti o delle Linee Guida per la redazione dei piani di ge-stione delle riserve naturali, in particolare quelle orientate “Sughereta di Niscemi” e “Bosco della Ficuzza, Rocca Bu-sambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago” (AA.VV., 2005; La Mela Veca et al., 2007). Altri strumenti interni sono stati nel tempo emessi dall’Assessorato Territo-rio e Ambiente tra cui la Circolare n. 822 del 22 gennaio 1998 per la zona A di riserva che fissa i contenuti del piano di sistemazione della riserva naturale.
In tale contesto, è opportuno sottolineare come la legisla-zione regionale e nazionale è stata influenzata dal mutato quadro normativo e dall’atteggiamento culturale nei riguardi delle foreste in campo internazionale ed europeo, proponen-do modalità sostenibili degli interventi di sfruttamento delle risorse forestali e facendo emergere il concetto di gestione forestale sostenibile (Ciancio et al., 1998 e 2002).
Il Piano Forestale Regionale, attualmente in corso di e-manazione, costituisce, insieme alle già diffuse Linee Gui-da del Piano Forestale Regionale, il primo strumento orga-nico in grado di svolgere più funzioni quali, in primo luo-go, coordinare le diverse azioni previste dal Piano di Svi-luppo Rurale del prossimo periodo 2008 - 2013 e, succes-sivamente, indicare le priorità negli interventi di amplia-mento della superficie forestale regionale (Maetzke et al., 2008), fornire gli indirizzi tecnici per la realizzazione dei rimboschimenti e degli impianti di arboricoltura, nonché numerose altre indicazioni tecniche e programmatiche.
Si delinea così uno scenario che conferma la necessità di strumenti regionali e locali armonici in grado di rendere gli indirizzi politici una realtà funzionale e organizzata.
Il piano di assestamento rimane comunque lo strumento di base per la gestione aziendale. Tuttavia, di fronte al qua-dro tracciato e alla luce delle considerazioni su esposte, emerge la necessità di superare la logica produttiva per rendere questo dispositivo meno rigido, in grado di lasciare più spazio alle necessità colturali dei soprassuoli interpre-tandone le dinamiche. Inoltre, occorre comprendere che è necessario un cambiamento di approccio e di mentalità nel-la gestione del patrimonio forestale regionale, pubblico e privato, comprendendo che la pianificazione e la pro-grammazione non sono limitazioni, ma sono opportunità di sviluppo e di conservazione del bene, di sviluppo sociale e culturale per l’intera comunità che convive con il bosco.
Poiché, dunque, è mancata nella recente storia forestale siciliana la continuità di intenti esecutivi per la realizzazio-ne degli indirizzi, che pure la politica regionale aveva re-cepito da quelli nazionali e fatti propri, ne deriva conse-guentemente che la selvicoltura applicata è stata limitata alle pratiche consuete, adottate da tempo, spesso episodi-che e comunque prive di continuità in una programmazio-ne sia regionale sia locale.
Si consideri che, viceversa, la sia pur limitata estensione della superficie forestale ha caratteristiche tali da richiedere un’attenzione particolare. Le ragioni sono da ricercarsi, infatti, nella notevole diversità biologica, a partire da quella specifica, unica nel bacino del Mediterraneo, che caratte-rizza le formazioni naturali e nella necessità di eseguire
- 830 -
urgenti interventi colturali a carico sia delle formazioni fo-restali naturali sia di quelle artificiali realizzate nella vasta opera di rimboschimento del secolo scorso.
La selvicoltura applicata è stata comunque influenzata dall’evoluzione del pensiero forestale, in parte fatta propria dal complesso normativo, che ha determinato un cambia-mento nelle modalità di gestione forestale del patrimonio forestale regionale avvenuto in diverse fasi. Nella prima fase, che va dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni ‘70, i problemi forestali sono stati legati alla protezio-ne del suolo, all’aumento della superficie boscata, all’occupazione della manodopera.
Gli interventi hanno riguardato principalmente la realiz-zazione di rimboschimenti in aree demaniali. Questi, in ge-nere, sono stati realizzati con coerenza tecnica utilizzando gli schemi della selvicoltura classica, con una visione del bosco che oggi viene definita di tipo lineare, e non in un quadro di pianificazione a livello regionale, risultando quindi anch’essi episodici. Per contro, le formazioni natu-rali, già degradate, sono state trascurate e non oggetto di interventi. Nel successivo ventennio, nel panorama foresta-le furono evidenziate le problematiche legate alla conser-vazione della natura e si diffusero i concetti di preservazio-ne e di conservazione a livello monospecifico (come nel caso dell’Abies nebrodensis) e un atteggiamento critico circa l’impiego delle specie esotiche.
A livello gestionale, si iniziò a fare riferimento agli schemi della selvicoltura classica di tipo naturalistico ponendo l’attenzione sulla rinaturalizzazione dei rimboschimenti fino ad allora realizzati. Nell’ultima fase, dalla fine degli anni ‘90 ad oggi, i temi di riferimento sono stati quelli legati allo svi-luppo sostenibile: cambiamenti climatici e immobilizzazione del carbonio, conservazione della biodiversità, lotta alla deser-tificazione, ecocertificazione forestale. A livello gestionale è andata affermandosi la selvicoltura sistemica come forma di gestione innovativa delle risorse forestali.
Nonostante questa evoluzione del pensiero forestale, di fatto in Sicilia la selvicoltura si è limitata: - all’esecuzione di interventi sporadici e limitati nello spazio, in assenza di una programmazione tecnica e talora senza un chiaro obiettivo colturale, quali a) la ceduazione nei cedui quercini a regime, b) la pratica di alcuni tagli di avviamento al governo a fustaia nei cedui di faggio, c) l’esecuzione di diradamenti episodici nei rimboschimenti di conifere; - alla realizzazione d’impianti di rimboschimento e di arboricoltura da legno, questi ultimi supportati da finanziamenti comunitari, anch’essi per la maggior parte realizzati in modo incoerente con gli obiettivi produttivi auspicati.
Per contro, i boschi e i rimboschimenti siciliani sono og-gi interessati da emergenze gestionali che derivano da di-verse e gravi problematiche.
In dettaglio, è possibile fare una distinzione sui problemi di gestione tra le formazioni naturali ed i rimboschimenti. Si osserva ad esempio che le fustaie di origine naturale, molto rare, frammentate e di piccola estensione, versano in uno stato prevalente di abbandono colturale.
Riguardo ai cedui si rileva una ridotta colturalità in quan-to utilizzati con turni brevi e stressanti per i soprassuoli o con modalità ad alto impatto ambientale, anche a causa
della scarsa e inadeguata meccanizzazione dei lavori fore-stali. Si rileva anche la frequente e talora errata esecuzione degli interventi di avviamento alla fustaia in alcuni casi con-dotti con pratiche discutibili e con prelievi troppo intensi. In altri casi si presentano oggi sotto forma di cedui abbandonati ed oltre turno e con strutture molto irregolari e complesse, in cui sarebbe auspicabile intervenire per accelerare e migliorare l’assetto strutturale e quindi il momento funzionale (Fig. 2).
Ad aggravare questo stato precario dei sistemi forestali autoctoni si aggiungono azioni di stress d’origine antropica diffusi quali il pascolo brado in bosco, troppo intenso e in-controllato nonostante i limiti posti nelle “fide di pascolo”, gli incendi, che spesso ricorrendo sulle stesse superfici de-terminano oltre ad un’azione distruttrice anche un limite alle possibilità di evoluzione post incendio dei soprassuoli forestali e pre-forestali.
Limitatamente ai soprassuoli artificiali realizzati preva-lentemente con conifere ed eucalipti, allo stato attuale l’età degli impianti varia dai 30 ai 60 anni con valori più fre-quenti compresi tra 40 e 50 anni e con densità generalmen-te molto elevata. Laddove i soprassuoli sono stati interessa-ti da episodici interventi di diradamento, sono stati osserva-ti processi di rinnovazione naturale delle stesse specie del soprassuolo principale e fenomeni di rinaturalizzazione sotto copertura da parte di specie arboree ed arbustive au-toctone. Tali processi sono maggiormente evidenti negli impianti di pino d’Aleppo e di pino domestico (Cullotta et al., 2003). Gli eucalitteti, realizzati con finalità produttive ed in molti casi in situazioni difficili per caratteristiche pe-doclimatiche, e gli impianti di arboricoltura da legno gene-ralmente non hanno dato i risultati attesi.
Nonostante le problematiche gestionali che investono le formazioni forestali siciliane, gli interventi di rimboschi-mento realizzati nel secolo scorso hanno dato vita ad un immenso laboratorio forestale in ambiente mediterraneo. Infatti, se oggi si guarda, anche con giusta critica, alle su-perfici rimboschite e agli interventi che hanno interessato sia i soprassuoli naturali sia quelli artificiali, l’esperienza maturata consente di valutarne i risultati e disporre da un lato di casi di studio diversificati su vaste superfici e dall’altro di una base di conoscenze specifiche indispensa-bili per la formulazione di indirizzi selvicolturali valevoli per le diverse tipologie forestali presenti in Sicilia.
3. INDIRIZZI SELVICOLTURALI
In base a queste considerazioni, di seguito si evidenziano
alcuni aspetti importanti, al fine di fornire indirizzi selvi-colturali di valenza generale a livello di categoria e tipo forestale: 1) Pascolo in bosco: a differenza di molte altre regioni italiane, in cui l’abbandono del sistema ceduo ha portato ad aumenti di naturalità e della biodiversità per reingresso del-le specie originarie, l’abbandono delle tradizionali pratiche selvicolturali nei cedui della Sicilia ha avuto effetti diffe-renti, in quanto è aumentata decisamente la pressione del pascolo brado in bosco e degli incendi. Allevamenti bradi sono oggi presenti all’interno delle coperture forestali per molti mesi all’anno, creando forti alterazioni agli equilibri del sistema bosco: modifiche pedologiche, mancanza o ri-duzione dei processi di rinnovazione, diverse alterazioni meccaniche sull’assetto della struttura in relazione all’età
- 831 -
del soprassuolo, ecc.. L’eccessiva presenza del pascolo in-teressa, di fatto, quasi tutti i soprassuoli forestali, comprese molte aree di alto livello di protezione ricadenti all’interno di aree protette (parchi e riserve). 2) Incendi: l’emergenza di questi eventi, quasi tutti di natura dolosa, che ogni anno porta alla distruzione di in-genti porzioni dell’esiguo patrimonio forestale, rappresenta uno dei freni maggiori all’ampliamento della auspicata su-perficie boscata regionale. Considerata poi l’ampia porzio-ne dei soprassuoli artificiali di conifere nel panorama delle risorse forestali della regione, si evidenzia la particolare vulnerabilità di tale patrimonio nei confronti di questo fat-tore antropico. 3) Rinaturalizzazione dei popolamenti artificiali: al note-vole sforzo di rimboschimento, infatti, non è sempre segui-ta l’applicazione di cure colturali adeguate, nonostante la sperimentazione abbia dimostrato l’utilità di una gestione attiva. Nei boschi di proprietà pubblica, dove in genere le finalità sono multiple e l’impiego di manodopera svolge anche un ruolo sociale, sono state eseguite per lo più insuf-ficienti ripuliture e diradamenti di grado debole; spesso nessun tipo di intervento. Per tali considerazioni, la rinatu-ralizzazione assume oggi un carattere prioritario in tutte quelle situazioni in cui si ritiene necessario ottenere popo-lamenti più stabili, a più alta efficienza ecologica e con maggiore capacità ad assolvere le funzioni protettive, pae-saggistiche, ricreative e naturalistiche. 4) Copertura forestale: in molti settori collinari dell’Isola, nella fattispecie nel settore sud (province di Ragusa, Sira-cusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani), la copertu-ra forestale è assente o ridotta ad alcuni popolamenti artifi-ciali di conifere. Ciò determina diffusi fenomeni erosivi e una riduzione della biodiversità e delle aree naturali.
Nella tabella 2 sono riportate con un livello di dettaglio maggiore le linee guida di gestione forestale per le princi-pali categorie e tipi forestali presenti in Sicilia.
4. CONCLUSIONI
Il quadro tracciato evidenzia punti di forza e di debolez-
za del sistema forestale dell’Isola. La notevole estensione dei rimboschimenti ha consentito non solo la ricostituzione di una parte sostanziale della copertura ma ha anche inne-scato, sia pur localmente, fenomeni di progressione positi-va per un ulteriore incremento naturale delle superfici bo-scate. L’elevata diversificazione delle formazioni naturali,
unica nel bacino del mediterraneo, costituisce un patrimo-nio di valore inestimabile.
D’altra parte è anche evidente la mancanza di indirizzi tecnici operativi corretti, univoci e continui necessari per la coltivazione di sistemi con cicli così lunghi come quelli forestali.
Le soluzioni tecniche sono chiare e la ricerca e la speri-mentazione in corso, l’osservazione e lo studio dei feno-meni in atto, naturali e indotti dall’uomo, nel laboratorio mediterraneo costituito dalle formazioni presenti, consen-tono di delineare i principali indirizzi necessari e spesso urgenti per il miglioramento e la salvaguardia del patrimo-nio forestale dell’Isola.
L’ingente estensione di rimboschimenti realizzati spesso con specie alloctone richiede la guida e la protezione dei fenomeni di naturalizzazione in atto e, in alcuni casi, come negli eucalitteti, la sostituzione di specie.
Le vaste estensioni di bosco ceduo, specialmente nei trat-ti montani, devono essere avviate con interventi corretti e non impattanti verso il governo a fustaia, mantenendo il regime solamente dove le condizioni stazionali idonee permetteranno di garantire ancora una funzione produttiva con la conservazione del paesaggio forestale tradizionale.
La salvaguardia del patrimonio di diversità richiede una più efficace conservazione delle cenosi forestali relitte ed endemiche di particolare importanza ecologica e biogeo-grafia (molte di queste già ricadenti all’interno di diverse tipologie di aree protette).
Infine è auspicabile un ulteriore ampliamento della su-perficie forestale regionale con imboschimenti basati sull’impiego di specie legnose (arboree e arbustive) autoc-tone ed ecologicamente coerenti con le stazioni di impiego.
Gli effetti positivi a cascata generati dall’applicazione di una corretta gestione delle formazioni forestali sarebbero molteplici, come del resto già comprovato dalle opere del passato: contrasto dei fenomeni di desertificazione, imple-mentazione della rete ecologica, aumento dell’articolazione dell’eco-mosaico paesaggistico, creazione di nuovi habitat e nicchie ecologiche, ricadute sociali dirette e indirette.
Tutto ciò richiede una politica forestale condotta con co-erenza e continuità dal livello programmatico a quello della pianificazione e dell’operatività pratica. E questo anche in considerazione dei motivi di sostegno sociale che la coltura del bosco in Sicilia ha mantenuto nel tempo e che consente a sua volta di limitare l’esodo dalla montagna.
- 832 -
Figura 1. Area dei Monti Sicani sottoposta ad interventi di rimboschimento a distanza di un cinquantennio (A.S.F.D., 1959). Figure 1. Sicani mountains area subject to reforestation activities during last half century (A.S.F.D., 1959). Figure 1. Une zone del montagnes Sicani soumis a l’intervention de reboisement à distance de 50 ans (A.S.F.D., 1959).
Figura 2. Esempio di ceduo oltre turno nel bosco di Ficuzza (PA). Figure 2. Example of beyond turn coppice in Ficuzza forest (PA). Figure 2. Exemple de ceduo au-delà de roulement dans le bosco de Ficuzza (PA).
Categorie forestali dei Boschi alti Superficie re-gionale (ha)
Superficie na-zionale (ha)
% su dato nazionale
% su superficie forestale regionale
% su totale Boschi alti
Boschi a rovere, roverella e farnia 62.016 1.084.247 5,7 18,3 24,4 Pinete di pini mediterranei 41.168 226.101 18,2 12,1 16,2 Altri boschi di latifoglie sempreverdi 29.849 84.712 35,2 8,8 11,7 Cerrete, boschi di farnetto, fragno, vallonea 24.227 1.010.986 2,3 7,1 9,5 Leccete 18.195 620.318 2,9 5,3 7,1 Altri boschi caducifogli 15.509 994.777 1,5 4,5 6,1
(segue)
- 833 -
(segue Tabella 1) Sugherete 15.541 168.602 9,2 4,5 6,1 Faggete 15.162 1.035.103 1,4 4,4 5,9 Castagneti 9.476 788.408 1,2 2,8 3,7 Pinete di pino nero, laricio e loricato 7.170 236.467 3 2,1 2,8 Boschi igrofili 6.444 229.054 2,8 1,9 2,5 Altri boschi di conifere, puri o misti 6.065 63.407 9,5 1,7 2,3 Ostrieti, carpineti 2.884 852.202 0,3 0,8 1,1 Totale Boschi alti 253.708 8.582.968 2,9 75 100
Tabella 1. Estensione delle categorie forestali dei Boschi alti in Sicilia (INFC, 2007). Table 1. Extension of hight woods forest categories inventory in Sicily (INFC, 2007). Tableau 1. Extension des catégories des forêts haut en Sicile (INFC, 2007).
Linee Guida di Gestione forestale Principali categorie (in grassetto) e tipi Forestali della Sicilia (Cullotta, 2003; Cullotta e Marchetti, 2007)
Monitoraggio e miglioramento dei boschi naturali (soprattutto conversio-ne dei cedui): Sistema di diradamenti graduali e continui verso i soprassuoli transitori, con rimodulazione dell’intervento in relazione alle risposte dei sopras-suoli; evitare prelievi troppo intensi. Monitoraggio ed interventi graduali di riduzione della copertura arborea nelle aree in cui i soprassuoli sono pronti alla rinnovazione. Gli interventi devono assicurare la rinnovazione naturale ed il mantenimento del grado di mescolanza, laddove presente. Sospensione del pascolo fino all’affermazione della rinnovazione natura-le e ad un sufficiente sviluppo del soprassuolo.
Faggete Faggete tipiche dei substrati calcarei Faggete tipiche dei substrati silicei Faggete dell’Etna Faggete aperte cacuminale e su pareti rocciose
Conservazione del paesaggio Miglioramento dei boschi naturali: In alcune aree, rinaturalizzazione e sostituzione graduale del soprassuolo, stimolando i processi di diffusione degli arbusti e delle latifoglie arboree autoctone (querce caducifoglie, faggio). Ove il grado di copertura è elevato e la rinnovazione è assente o insuffi-ciente, intervenire con tagli a raso a piccoli gruppi. Nelle aree ove la rinnovazione è presente, uniformemente o a gruppi, intervenire con diradamenti graduali sul soprassuolo principale. Sospensione del pascolo fino all’affermazione della rinnovazione natura-le e ad un sufficiente sviluppo del novellame.
Pinete di pino laricio Pinete mature di pino laricio Popolamenti pionieri di pino laricio
Nessun intervento - Monitoraggio dell’evoluzione naturale Betuleti Popolamenti pionieri di betulla dell’Etna Formazioni pioniere di pioppo tremulo
Monitoraggio e miglioramento dei boschi naturali (soprattutto fustaie): Monitoraggio; sporadicamente, interventi graduali di riduzione della co-pertura arborea nelle aree in cui i soprassuoli sono pronti alla rinnovazio-ne. Sospensione del pascolo fino all’affermazione della rinnovazione natura-le e ad un sufficiente sviluppo del soprassuolo.
Rovereti Querceti di rovere ed agrifoglio Popolamenti di agrifoglio
Mantenimento del bosco ceduo: cedui matricinati con matricinatura me-dio-alta.
Castagneti Castagneti degli ambienti mesici Castagneti degli ambienti mesici e xerici della Sicilia settentrentrionale Cerrete Cerrete montane Querceti di Quercus gussonei Querceti caducifogli puri e misti di roverella s.l. Querceti caducifogli misti di Quercus pubescens s.l. Querceti caducifogli misti con leccio, acero montano e campestre, or-niello e tiglio
Monitoraggio e miglioramento dei boschi naturali (soprattutto conversio-ne dei cedui): Sistema di diradamenti graduali e continui verso i soprassuoli transitori, con rimodulazione dell’intervento in relazione alle risposte dei sopras-suoli; evitare prelievi troppo intensi. Monitoraggio ed interventi graduali di riduzione della copertura arborea nelle aree in cui i soprassuoli sono pronti alla rinnovazione. Gli interventi devono assicurare la rinnovazione naturale ed il mantenimento del grado di mescolanza, laddove presente. Sospensione del pascolo fino all’affermazione della rinnovazione natura-le e ad un sufficiente sviluppo del soprassuolo. Mantenimento del bosco ceduo: mantenimento del governo a ceduo, laddove è ecologicamente ed eco-nomicamente giustificabile, tramite matricinatura medio-alta e/o il ricor-so al ceduo composto.
Leccete Leccete su pareti rocciose Leccete pure (paucispecifiche) Leccete con orniello e/o carpino nero Leccete di transizione verso i boschi di caducifoglie
(segue)
- 834 -
(segue Tabella 2) Monitoraggio e miglioramento dei boschi naturali: Monitoraggio ed interventi graduali di riduzione della copertura arborea nelle aree in cui il soprassuolo è pronto alla rinnovazione. Regolamentazione degli interventi di decortica e relativa regolarizzazio-ne dei turni. Sospensione del pascolo fino all’affermazione della rinnovazione natura-le e ad un sufficiente sviluppo del novellame.
Sugherete Sugherete pure di ambienti moderatamente mesici Sugherete degli ambienti xerici Sugherete con querce caducifoglie
Nessun intervento - Monitoraggio dell’evoluzione naturale
Pinete naturali o formazioni di Pinus sp. pl. naturalizzati Pinete di pino marittimo Pinete collinari di pino domestico, eriche e cisti Pinete di pino d’Aleppo
Nessun intervento - Monitoraggio dell’evoluzione naturale
Fruticeti altomontani e arbusteti montani Formazioni di Astragalus siculus Fruticeti di Astragalus nebrodensis e Prunus sp. pl., e Juniperus hemi-phaerica Formazioni pioniere di Genista aetnensis
Nessun intervento - Monitoraggio dell’evoluzione naturale
Macchie e garighe degli ambienti mesici e/o caldo-aridi Consorzi di mantello Macchie di leccio Macchie di alberi ed arbusti sclerofillici dei substrati acidofili Macchie di olivastro (Olea europaea var. sylvestris) Macchie di quercia spinosa Macchie di ginepro spp. Garighe di palma nana
Nessun intervento - Monitoraggio dell’evoluzione naturale
Formazioni riparie Formazioni di Tamarix africana tipiche (paucispecifiche) Formazioni di Tamarix sp. pl., Nerium oleander e popolamenti di Ul-mus minor Formazioni di Salix e Populus Formazioni riparie di Platanus orientalis dei canyon siciliani
Rinaturalizzazione e miglioramento dei boschi artificiali: Rinaturalizzazione graduale dei soprassuoli, stimolando i processi di dif-fusione degli arbusti e delle latifoglie arboree autoctone. Ove il grado di copertura è elevato e la rinnovazione è assente o insuffi-ciente, intervenire rispettivamente con un regime di diradamenti graduali e/o semine e piantagioni integrative, facendo ricorso alle specie locali già spontaneamente insediatesi e comunque appartenenti alla medesima fa-scia di vegetazione. Nelle aree ove la rinnovazione è presente, uniformemente o a gruppi, intervenire con diradamenti graduali sul soprassuolo principale, da mo-dulare in relazione alla risposta al primo diradamento. Sospensione del pascolo fino all’affermazione della rinnovazione natura-le e ad un sufficiente sviluppo del novellame.
Boschi artificiali di conifere Cedrete di Cedrus atlantica e C. deodara Boschi misti di Pinus nigra, Cedrus sp. pl., Abies cephalonica, Pseudo-tsuga menziesii Pinete di pino domestico Pinete di pino d’Aleppo Pinete miste con Cupressus sp. Cipressete
Nessun intervento - Monitoraggio dell’evoluzione naturale
Formazioni arboree seminaturali Noccioleti in coltura Pistacchieti in coltura Frassineti da manna Uliveti naturalizzati
Rinaturalizzazione e miglioramento dei boschi artificiali: diradamento graduale dell’eucalipteto per agevolarne la sostituzione con specie arboreo-arbustive autoctone anche attraverso interventi di imbo-schimento e difesa della rinnovazione naturale dal pascolo.
Eucalipteti Eucalipteti di E. globulus Eucalipteti di E. camaldulensis Eucalipteti misti Impianti di Acacia sp. pl. e Myoporum insulare
Rinaturalizzazione e miglioramento dei boschi artificiali: diradamento graduale del soprassuolo artificialeper agevolarne la sostitu-zione con specie arboreo-arbustive autoctone anche attraverso interventi di imboschimento e difesa della rinnovazione naturale dal pascolo.
Robinieti, Ailanteti e Pioppeti artificiali Formazioni pure di Robinia pseudoacacia Formazioni pure di Ailanthus altissima Pioppeti artificiali
Tabella 2. Linee guida di gestione forestale per principali categorie forestali presenti in Sicilia. Table 2. Management forest guidelines for each forest type of Sicily. Tableau 2. Les adresses d’intervention pour chaque type de forêt de la Sicile.
SUMMARY
SILVICULTURE IN SICILY: PROBLEMS AND PROSPECTS
In spite of their little surface, natural sicilian forests and
reafforestation are strongly heterogeneous due to environmental factors and anthropic activities. In Sicily
forest surface was enriched by afforestation activities that have been largely widespreaded in the last century, planting various species in order to cope land abandonment and desertification processes. However, forestry practices had not ever technically correct and continuous addressed because of lack of forestry policy during the time. For example, operative forest planning was deficient and very little plans have been drawn up. According to EU and
- 835 -
national legislation, forest may be seen not only such as an economic opportunity but also as an environmental resource. Renewed interest and attention for woods requires urgent forest planning and sustainable forest management. Moreover, some woods may have economic specific interest. Thus, in this paper with the aim to produce useful tools for forest planning, appropriate guidelines for management of sicilian forest type were identified. The study shows management forest guidelines for each forest type of Sicily with forestry homogeneous character.
RÉSUMÉ
LA SYLVICULTURE EN SICILE: PROBLEMES ET PERSPECTIVES
Les forêts de la Sicile, bien que petit en termes de
superficie, sont caractérisées par une forte hétérogénéité en raison des facteurs environnementaux multiples et des diverses formes d’exploitation. La diversité des forêts naturelles a été enrichie par les nombreux reboisements effectués à partir de la moitié du dernier siècle. Ces reboisements sont extrêmement diversifiés pour les espèces utilisées et pour les cultures de soins effectués, pas toujours respectés en raison de l’absence d’une politique forestière avec des lignes directrices claires et continues dans le temps.
Cette situation a été agravée par l’actuelle absence de planification d’exécution et en outre in Sicile très peu de plans d’ajustement ont été établis et appliquées. Pour remédier à ces lacunes, il est utile identifier des lignes directrices appropriées pour la gestion forestrière de chaque type de forêt qui pourrait permettre de combler, pour des zones homogènes, l’absence de moyens de planification de détail.
Les rénovés intérêt et attention vers les bois, vus comme une ressource de l’environnement, touristique-récréatif et économique, aujourd’hui traduit en dispositions normatives communautaires et nationales, demandent une gestion et planification forestière très urgent. Certaines formations peuvent présenter un intérêt économique plus spécifique. L’étude montre les adresses d’intervention pour chaque type de forêt de la Sicile qui présente caractéristiques foresterie homogènes.
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., 2005 - Ricerche per la redazione del piano di
gestione della R.N.O. Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago (Pa). Dipartimento di Colture Arboree, Università di Palermo.
A.S.F.D., 1959 - L’azienda di Stato per le foreste demaniali. Volume 1, tomo 11 - Società A.B.E.T.E., Roma.
Cavarretta D., Saporito L., 1998 - Boschi artificiali della Sicilia. Aspetti selvicolturali e problematiche gestionali. in “Atti del secondo congresso di selvicoltura: Conservazione e miglioramento dei boschi in Sicilia”. Palermo, Regione Siciliana, Azienda Foreste Demaniali, 57-101.
Ciancio O., Iovino F., Menguzzato G., Nicolaci A., 1998 -
Concerning cutting periods for holm oak coppices. Annali ISSA. Anno 1996. Special ISSUE MEDCOP, 27: 89-95.
Ciancio O., Clerici E., Iovino F., Menguzzato G., Nocentini S., Pettenella D., 2002 - I cedui quercini: aspetti selvicolturali e gestionali. In: Ciancio O., Nocentini S. (a cura di), Il bosco ceduo in Italia. Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze, p. 165-197.
Cullotta S., 2003 - Forest and Pre-forest Types of Sicily (Italy): classification system, nomenclature, distribution, ecology and management. Ph.D. Thesis, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic. pp. 382.
Cullotta S., Pizzurro G.M., Garfì G., La Mantia T., 2003 - Analisi dei processi di rinaturalizzazione nelle pinete artificiali mediterranee dei monti di Palermo (Sicilia Nord-occidentale). SISEF Atti 3: 457-466.
Cullotta S., Marchetti M., 2007 - Forest Types for Biodiversity Assessment at regional level: the case study of Sicily (Italy). European J Forest Research, 126 (3): 431-447 DOI 10.1007/s10342-006-0166-y [Published online: 11 January 2007].
Cullotta S., Maetzke F., 2008a - La pianificazione forestale ai diversi livelli in Italia. Parte I: Struttura generale e pianificazione a livello nazionale e regionale. L’Italia Forestale e Montana, Anno LXIII (1): 29-47.
Cullotta S., Maetzke F., 2008b - La pianificazione forestale ai diversi livelli in Italia. Parte II: La pianificazione territoriale e aziendale. L’Italia Forestale e Montana, Anno LXIII (2): 91-108
INFC, 2007 - Le stime di superficie 2005 - Prima parte. Autori G. Tabacchi, F. De Natale, L. Di Cosmo, A. Floris, C. Gagliano, P. Gasparini, L. Genchi, G. Scrinzi, V. Tosi. Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio. MiPAF - Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale, CRA -ISAFA, Trento. [on line] URL: http://www.infc.it.
La Mantia T., 2002 - L’arboricoltura da legno nel paesaggio siciliano. Rimboschimenti e piantagioni nelle trasformazioni del paesaggio. Quaderni IAED, 15: 135-153.
La Mantia T., Cullotta S., La Mela Veca D.S., 1999 - Analisi degli accrescimenti di Robinia pseudoacacia L. sui Monti Peloritani (ME). Atti del secondo Congresso S.I.S.E.F. - Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, “Applicazioni e prospettive per la Ricerca Forestale Italiana”, Bologna 20-22 ottobre, Ed. Avenue media, Bologna, p. 77-79.
La Mela Veca D.S., Saporito L., 2000 - La gestione dei rimboschimenti in Sicilia: produzione legnosa e prospettive di rinaturalizzazione. Atti della Tavola Rotonda su: Selvicoltura ed Arboricoltura da legno: quale gestione? - Palermo 25 Marzo - Collana Sicilia Foreste, 7: 53-61. Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste, Direzione Azienda Foreste Demaniali.
La Mela Veca D.S., Maetzke F., Pasta S. (a cura di), 2007 - La gestione forestale sostenibile nelle aree protette: il caso studio della Riserva Naturale Orientata “Sughereta di Niscemi” (CL). Collana Sicilia Foreste, 31, pp. 215. Dipartimento Azienda Foreste Demaniali, Assessorato Agricoltura e Foreste, Regione Siciliana.
Maetzke F, Cullotta S., La Mantia T, La Mela Veca D.S, Pizzurro G.M., 2008 - Individuazione di aree
- 836 -
ecologicamente omogenee e di un sistema di aree a priorità di intervento per l’ampliamento della superficie forestale in Sicilia. Forest@ (on line). vol. 5, pp. 280-295 ISSN: 1824-0119. doi:10.3832/efor0543-0050280 [online: 2008-10-10] URL: http://www.sisef.it/forest@/.
Regione Siciliana, 2004 - Piano Forestale Regionale, Linee Guida. Suppl. Ord. G.U.R.S. n. 50 del 19-11-2004.
Regione Siciliana, 2008 - Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007 - Agricoltura e Foreste.
Saporito L., 1995 - Aspetti Selvicolturali delle pinete di pino domestico in Sicilia. Sviluppo Agricolo, 7/8: 36-43.
Saporito L., 1998 - Stato attuale e problematiche selvicolturali dei rimboschimenti di eucalipto in Sicilia. Sherwood, 38: 23-30.