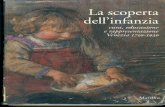La biblioteca privata di Tito Vignoli. Letture di un antropologo evoluzionista
Transcript of La biblioteca privata di Tito Vignoli. Letture di un antropologo evoluzionista
Storia in Lombardia, anno XXX, n. 3, 2010
Ricerche
LA BIBLIOTECA PRIVATA DI TITO VIGNOLI. LETTURE DI UN ANTROPOLOGO EVOLUZIONISTA
di Elena Canadelli
«Uno dei modi migliori per far rivivere
il pensiero d’un uomo: ricostituire la sua biblioteca» M. Yourcenar, Memorie di Adriano
Cronaca di un ritrovamento
Testimonianza affascinante e complessa, la biblioteca privata di uno studioso
costituisce una preziosa chiave d’accesso al suo pensiero e alla sua opera. Frut-to di stratificazioni e personali percorsi di ricerca, da essa, così come dalle car-te d’archivio, si ottengono numerosi indizi e informazioni sulla persona che, li-bro su libro, l’ha costruita. Le raccolte librarie private non rivelano solo qual-cosa del proprietario, della sua personalità, dei suoi interessi o del suo lavoro. Esse permettono anche di guardare a una particolare stagione della storia intel-lettuale con gli occhi di un contemporaneo, al di là delle etichette storiografi-che1. Queste biblioteche delimitano infatti lo spazio della memoria di un indi-viduo e di una generazione, configurandosi come microcosmi culturali. Rara-mente, però, sopravvivono intatte. Spesso ci si trova di fronte a corpus librari irrimediabilmente perduti. In alcuni casi più fortunati si tratta solo di oblio. Donati di rado a istituzioni pubbliche, di frequente rimangono ai familiari, e-sposti al pericolo di traslochi, dispersioni, vendite e smembramenti. Se alcune biblioteche diventano pubbliche per volontà degli eredi o del loro stesso pro-prietario (esemplare in questo senso è il caso dello storico della cultura Aby
1. Per il recente dibattito sulle biblioteche private cfr. Biblioteche filosofiche private in età moderna
e contemporanea, a cura della redazione del sito Biblioteche dei filosofi, picus.sns.it, Scuola normale superiore di Pisa e Università di Cagliari, 2008; Le biblioteche private come paradigma bibliografico. Atti del convegno internazionale, Roma, 10-12 ottobre 2007, a cura di F. Sabba, Roma, Bulzoni, 2008; Biblioteche private in età moderna e contemporanea. Atti del convegno internazionale, Udine, 18-20 ot-tobre 2004, a cura di A. Nuovo, Milano, Sylvestre Bonnard, 2005; Bibliothecae selectae. Da Cusano a Leopardi, a cura di E. Canone, Firenze, Olschki, 1993. Su due casi specifici cfr. La biblioteca di Carlo Cattaneo, a cura di C.G. Lacaita, R. Gobbo, A. Turiel, Bellinzona, Casagrande, 2003 e Le carte e la bi-blioteca di Paolo Mantegazza. Inventario e catalogo, a cura di M.E. Frati, Milano, Bibliografica, 1991.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
6
Warburg2), altre volte invece sono destinate a restare sommerse, uscendo di scena con la morte di chi le ha costruite. In questi casi, per farle riemergere, sono necessarie complicate ricostruzioni di alberi genealogici, passaggi d’eredità, trame familiari.
La storia della biblioteca di scienze umane di Tito Vignoli, antropologo e psicologo evoluzionista di origini toscane che costruì la sua carriera a Milano nel corso della seconda metà dell’Ottocento, è proprio una di queste. La biblio-teca è segnalata un’ultima volta nel 1914, come collocata nella sua casa di Cor-so Venezia 44. Proprio quell’anno, infatti, il Circolo filologico pubblicò l’utile repertorio Le biblioteche milanesi, in cui si dava spazio anche alle raccolte li-brarie private. Tra queste era menzionata quella di Vignoli, che a detta del compilatore raccoglieva «non solo libri di scienze naturali e di antropologia ma anche una serie di volumi intorno alla storia delle religioni»3.
Con la scomparsa di Vignoli il 5 dicembre 1914, la biblioteca si eclissò. Al-meno fino al 2006, quando nel corso delle mie ricerche di dottorato è stata rin-tracciata in un castello in provincia di Trento4: Castel Campo, dove i suoi libri approdarono con ogni probabilità all’inizio degli anni venti, dopo la morte di Vignoli e della moglie Francesca Pedrali nel 1919. Il castello fu acquistato nel 1920 dall’imprenditore milanese Cesare Rasini, suocero della scultrice Thea Casalbore, una delle quattro nipoti di Vignoli. Nel corso degli anni trenta Thea vi trascorse periodi sempre più lunghi, ospitando personalità rilevanti della cul-tura italiana del tempo come la poetessa Ada Negri e assecondando la propria vocazione religiosa con la nomina a terziaria francescana nel vicino convento di Campo Lomaso5. Nonostante i numerosi incarichi nelle istituzioni culturali e
2. Cfr. S. Settis, Warburg continuatus. Descrizione di una biblioteca, in «Quaderni storici», 1985, n.
58, pp. 5-38 e K.W. Forster, K. Mazzucco, Introduzione ad Aby Warburg e all’Atlante della memoria, Milano, Bruno Mondadori, 2002.
3. Le biblioteche milanesi, Milano, Cogliati, 1914, p. 400. 4. La tesi di dottorato, «Più positivo dei positivisti». Tito Vignoli (1824-1914): evoluzionismo, psico-
logia e antropologia, svolta sotto la guida del prof. Giulio Barsanti (Università di Firenze), è stata di-scussa nel 2009 nell’ambito del dottorato toscano in Storia della scienza, Università di Pisa.
5. Thea non fu l’unica nipote di Vignoli. Un’altra figlia di Vignoli, Enrica, sposata con Alberto Ca-salbore e morta nel 1912, ebbe infatti quattro figlie, indicate come le eredi naturali nel testamento del 6 agosto 1917 della vedova di Vignoli, Francesca Pedrali: oltre Teresa (detta Thea), sposata con Giovanni Rasini, sono menzionate Carla Gabriella, che sposò Antonio Cipollini, Albertina, che sposò un Valenti, e Francesca che morì poco dopo di spagnola, non lasciando eredi. Cfr. Tribunale di Milano, Indice ge-nerale delle disposizioni di ultime volontà, 1902-1924, testamento di Francesca Pedrali, 6 agosto 1917, notaio Pietro Bermond. I tre rami di eredi – Cipollini, Rasini e Valenti – conservano ancora oggi parti diverse dell’archivio Vignoli, solo parzialmente donato al Museo civico di storia naturale di Milano ne-gli anni novanta del secolo scorso. Al Museo sono comunque conservate le riproduzioni del materiale in possesso degli eredi. È inoltre in corso il progetto di riunificazione digitale e messa on line dell’intero Fondo Vignoli sul sito Aspi-Archivio storico della psicologia italiana, centro interdipartimentale dell’Università di Milano-Bicocca, www.archiviapsychologica.org. Per una ricostruzione più analitica
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
7
scolastiche di Milano, tra cui il Circolo filologico, l’Accademia scientifico-letteraria e il Museo civico di storia naturale, stranamente Vignoli non ha dona-to loro il suo consistente fondo librario, che ha seguito quindi un percorso sot-terraneo, che lo ha condotto, insieme a parte delle sue carte, in Trentino, protet-to dai bastioni e dall’ampio fossato di Castel Campo, nella torre più antica, ac-canto alle sculture, ai gessi preparatori e ai libri a tema per lo più religioso e devozionale di Thea, e a quelli di contenuto storico e artistico del marito Gio-vanni Rasini.
Lo spazio della biblioteca come la conosciamo oggi, quindi, non è quello vissuto in prima persona da Vignoli. Sull’originale organizzazione e sulla scel-ta dell’ordine, anche fisico, da lui impresso ai volumi rimaniamo all’oscuro; un dato che sarebbe stato invece interessante, nel caso egli avesse seguito un crite-rio particolare, tanto più che per lavoro Vignoli si confrontò in diverse occa-sioni, su scala più ampia, con la gestione e l’ordinamento di alcune biblioteche d’istituzioni culturali e scientifiche di Milano, per esempio in qualità di con-servatore della biblioteca dell’Istituto lombardo-Accademia di scienze e lettere per la classe di lettere, o di direttore amministrativo del Museo civico di storia naturale per la riorganizzazione della biblioteca, tra il 1896 e il 1898, dopo il trasferimento nel nuovo edificio ai Giardini pubblici6.
Per quanto riguarda il lavoro effettuato a Castel Campo tra il 2006 e il 2010, innanzitutto è stato necessario identificare e separare i libri di Vignoli da quelli di Thea e Giovanni Rasini, segnalati dalla presenza dei loro ex-libris. In questa operazione d’identificazione, laddove mancava la firma di possesso di Vignoli sul frontespizio, si è utilizzato un criterio tematico, di data di pubblicazione o di appartenenza a determinate collane editoriali in suo possesso. In secondo luogo, poiché non esisteva alcun inventario, si è compilato un catalogo dei libri in formato Excel7. Nella lista sono stati inseriti anche quei pochi volumi che
di queste vicende, cfr. E. Canadelli, Tito Vignoli, un filosofo alla direzione del Museo Civico di Storia Naturale. Un percorso nella Milano di fine Ottocento, in «Natura», 2010, n. 1, pp. 15-18 e Il fondo Tito Vignoli, nella sezione Archivi del sito Aspi. Ringrazio la famiglia Rasini di Castel Campo per la cortese ospitalità e per aver messo a disposizione la biblioteca.
6. Cfr. Vignoli Tito, in A. De Gubernatis, Dictionnaire international des écrivains du monde latin, Roma-Firenze, Società tipografica fiorentina, 1905, p. 1458; Museo civico storia naturale di Milano (d’ora in poi MSNM), Archivio amministrativo, b. 48, doc. 15/2, Esercizio economico e scientifico del Museo civico di storia naturale nell’anno 1896, e b. 49, doc. 77/1, Regolamento della biblioteca appro-vato dalla Giunta municipale nella seduta del 30 giugno 1898.
7. Il catalogo della biblioteca di Vignoli sarà a breve disponibile sul sito www.milanocittadelle scienze.it, coordinato dal prof. Pietro Redondi, docente di storia della scienza presso l’Università di Mi-lano-Bicocca, finanziato tra gli altri da Fondazione Cariplo. Nel file Excel sono riportati: autore, titolo, casa editrice, luogo e anno di edizione, traduttore, collana di appartenenza, eventuali annotazioni di Vi-gnoli e dediche a lui indirizzate. Ringrazio la dott.ssa Paola Livi, responsabile della biblioteca del Mu-
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
8
portano sul frontespizio firme diverse, in qualche modo collegate a Vignoli: da quelli appartenuti ai suoi familiari, come la figlia Enrica o i parenti della mo-glie, a quelli di Carlo D’Adda, presso cui lavorò come precettore, o di Antonio Stoppani, l’abate geologo che precedette Vignoli alla guida del Museo civico di storia naturale durante gli anni ottanta dell’Ottocento, con alcuni opuscoli di argomento geologico e paletnologico.
A distanza di quasi un secolo dall’ultima segnalazione, la raccolta ammonta oggi a circa 1.000 titoli, spesso formati da più volumi, in maggioranza in fran-cese e in italiano, di argomento storico, linguistico, filosofico, antropologico, psicologico, etnografico e naturalistico, poche serie spurie di periodici, tra cui le più consistenti sono la «Revue des deux mondes» (1866-90), «Cosmos» (1860-1868), la «Revue des cours littéraires de la France et de l’étranger» e la «Revue des cours scientifique de la France et de l’étranger» (1864-67)8, e un esiguo fondo antico di testi storici, letterari e filosofici del Cinquecento e Set-tecento in particolare.
In generale, sono pochi i libri annotati da Vignoli o con glosse a margine. Significativo è il caso della copia dei Principj di scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni di Giambattista Vico, nell’edizione del 1848 dell’editore milanese Silvestri, preceduta da una biografia del filosofo parteno-peo scritta da Niccolò Tommaseo. Particolarmente annotati sono i passi del primo e del secondo libro in cui Vico discute della mente umana, della sua ten-denza a proiettarsi all’esterno e degli universali fantastici, concezioni fonda-mentali per l’elaborazione della teoria vignoliana del mito, come riconosciuto in alcuni scritti dallo stesso Vignoli9. Oltre a Vico, sono sottolineati e compul-sati anche altri studi, a firma di alcuni autori di riferimento di quegli anni, che molto contribuirono alla formazione delle sue teorie. Si spazia dalla biologia, psicologia e fisiologia – con Charles Darwin (De la variation des animaux et des plantes sous l’action de la domestication, 1868), Herbert Spencer (Princi-
seo civico di storia naturale di Milano, per il fondamentale aiuto durante le ricerche e per la cataloga-zione della biblioteca di Castel Campo.
8. Tra i periodici più numerosi segnalo inoltre le «Memorie dell’Istituto lombardo di scienze e lette-re» (1868-1905) e «L’Esploratore» (1879-82). Di altri, come lo «Zeitschrift für Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft», «L’Année biologique», la «Rivista delle tradizioni popolari italiane», la «Revue de linguistique et de philologie comparée», la «Revue de l’histoire des religions», la «Rivista di studi psichici», la «Rivista di filosofia scientifica» e la «Revue d’archéologie», è rimasto solo qualche fasci-colo sparso.
9. Cfr. Biblioteca MSNM, Fondo Vignoli, b. 3, fasc. 1/1, Quaderno con traduzione dal francese del Discorso sopra il sistema di Vico del Michelet, 1842. Per i riferimenti a Vico nelle opere a stampa cfr. T. Vignoli, Di una dottrina razionale del progresso, in «Il Politecnico», 1864, n. 95-96, pp. 129-172, pp. 257-312; Mito e scienza, Milano, Dumolard, 1879; Del mito nella interpretazione scientifica della natura e della storia, in «Il Pensiero italiano», 1892, n. 24, pp. 548-563.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
9
pes de biologie, 1877-78), Théodule Ribot (La psychologie allemande contem-poraine, 1879), Giuseppe Sergi (Teoria fisiologica della percezione, 1881), Charlton Bastian (Le cerveau organe de la pensée chez l’homme et chez les animaux, 1882), George John Romanes (L’évolution mentale chez les animaux, 1884), Alfred Binet (La psychologie du raisonnement: recherches experimen-tales par l’hypnotisme, 1886) – alla linguistica, antropologia e storia delle reli-gioni – con David-Frédéric Strauss (Vie de Jésus, 1856), Karl Wilhelm Ludwig Heyse (Sistema della scienza delle lingue, 1864), Athanase Coquerel (Des premières transformations historiques du christianisme, 1866), John Lubbock (Les origines de la civilisation: état primitif de l’homme et moeurs des sauva-ges modernes, 1873), Edward B. Tylor (La civilisation primitive, 1876-78), Gi-rard de Rialle (La mythologie comparée, 1878)10.
In generale la biblioteca non si contraddistingue per la rarità dei volumi, né per la presenza di esemplari particolarmente pregiati. Alcuni di questi, anzi, ci sono arrivati deteriorati, spaginati, sbriciolati dal tempo. A volte, a testimoniare la presenza di un titolo, è rimasta solo la copertina. L’attuale fondo librario non è certamente completo: accanto alle “fisiologiche” dispersioni, qualche titolo può essere rimasto nelle biblioteche degli istituti da lui diretti, come il Museo civico di storia naturale, dove in effetti non è raro incrociare estratti e volumi inviati all’allora direttore. Considerata la sua precoce adesione alla teoria dell’evoluzione – come emerge in alcuni appunti inediti risalenti al 1860-61, dove Vignoli citava Darwin a proposito del «gran combat de la vie»11, e poi pubblicamente all’inizio degli anni sessanta sulle pagine della rivista cattanea-na «Il Politecnico» – una delle mancanze più significative è quella dell’Origine delle specie, assente sia nella prima edizione inglese del 1859, sia nella tradu-zione francese del 1862 o in quella italiana del 1864, sia in altre successive. Nonostante alcune assenze eccellenti, nel complesso, da questa eterogenea bi-blioteca di scienze umane da poco ritrovata, emerge un quadro coerente delle stratificate letture e dei diversi percorsi di uno dei protagonisti oggi poco ricor-dati della stagione positivista italiana e milanese in particolare, permettendo di evidenziare alcune specificità.
10. Le opere della biblioteca di Vignoli sono citate nella lingua e nell’edizione presenti a Castel
Campo. 11. Biblioteca MSNM, Fondo Vignoli, b. 3, fasc. 1/6, Quaderno di appunti di Vignoli, Vita e morte
[1860].
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
10
Per un profilo biografico di Vignoli
I modi con cui si è sviluppata la biblioteca sono intimamente legati allo stile della persona che l’ha creata nell’arco di più di cinquant’anni. Nato nel 1824 a Rosignano Marittimo, durante gli anni quaranta Vignoli studiò legge all’Università di Pisa, dove insegnavano anche l’elettrofisiologo Carlo Mat-teucci e lo zoologo Paolo Savi, che lo introdussero a studi naturalistici. Al con-tempo si dedicava con assiduità alla filosofia sotto la guida dell’eclettico poeta e docente di storia della filosofia Silvestro Centofanti, di cui frequentava il sa-lotto pisano, animato da esponenti della nobiltà toscana e da professori e gio-vani studenti dell’Università. Grazie a Centofanti si avvicinò al circolo fioren-tino d’intellettuali cattolici e moderati come Gino Capponi, Giovan Pietro Vieusseux, Niccolò Tommaseo e Raffaele Lambruschini, i quali, come dimo-stra la sua biblioteca, diventarono anche i suoi primi riferimenti teorici.
Nel 1851, dopo aver passato indenne i violenti scontri del ’48 ed essersi lau-reato, Vignoli lasciò il Granducato e si trasferì controvoglia a Milano, dove, perseguitato da difficoltà finanziarie, accettò l’impiego d’istitutore privato. Nel corso degli anni cinquanta lavorò per alcuni degli uomini economicamente e politicamente più influenti di Milano, dal duca Uberto Visconti di Modrone al marchese Carlo D’Adda. I panni dell’istitutore gli stavano stretti, ma gli con-sentirono di mantenersi, continuare a studiare, venire in contatto con importanti personalità del tempo tra serate galanti e lunghe villeggiature sul lago Maggio-re, viaggiando frequentemente in Italia, in particolare a Genova, Torino e Ve-nezia, e in tutta Europa, soprattutto in Svizzera e in Francia. Durante alcuni dei suoi viaggi a Parigi, per esempio, conobbe il linguista Gaspare Gorresio, tra-duttore in italiano del poema indiano Rāmāyana, mentre rimasero senza suc-cesso i suoi tentativi di contattare il filosofo-linguista Ernest Renan e il filosofo Vincenzo Gioberti, entrambi presenti in forze nella sua biblioteca.
Della Milano degli anni cinquanta, del ritorno degli austriaci e della partenza di Carlo Cattaneo per la Svizzera, non frequentò il gruppo stretto intorno al «Crepuscolo» di Carlo Tenca, da lui relegato tra i «letterati mestieranti»12, e del suo collaboratore, il linguista Gabriele Rosa, che pure trattavano temi vicini ai suoi interessi. A loro preferiva la compagnia del medico e letterato Paolo Ma-spero, traduttore dell’Odissea, del linguista Pietro Giuseppe Maggi, esperto di
12. Archivio di Stato di Pisa (d’ora in poi ASP), Carteggio Centofanti, b. 32/3b, doc. 54, Lettera di Vignoli a Centofanti, Milano 19 maggio 1856. Per una biografia e bibliografia su e di Vignoli, cfr. E. Canadelli, Appendice bio-bibliografica, in T. Vignoli, Mito e scienza e Saggio di una dottrina razionale del progresso, a cura di E. Canadelli e L. Steardo, Pisa, Ets, 2010, pp. 455-459 e la scheda a lui dedicata sul sito Aspi.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
11
sanscrito e cultura indiana, del poeta Felice Bellotti, traduttore di Sofocle, del medico-antropologo Paolo Marzolo, impegnato in quegli anni nella stesura dei Monumenti storici rivelati per l’analisi della parola (1851), una sorta di storia naturale del linguaggio, e del glottologo goriziano Graziadio Isaia Ascoli, «il-lustre e venerato maestro»13, che Vignoli contattò per la prima volta nel 1854. Tutti e cinque sono presenti a Castel Campo con alcuni lavori, anche se, consi-derata la lunga amicizia con Ascoli, mi aspettavo una presenza più consistente dei suoi scritti, probabilmente perduti.
All’indomani dell’Unità d’Italia Vignoli trascorse lunghi periodi a Torino al seguito di Carlo D’Adda, nominato governatore della prefettura della capitale. Qui conobbe il ministro degli interni Marco Minghetti e il grande scrittore A-lessandro Manzoni, a Torino per giurare al Senato e votare la cessione di Nizza alla Francia; e qui seguì le discussioni in Parlamento, dove disponeva di «un posto riservato nella comoda ringhiera degli ambasciatori»14, vivendo in prima persona il drammatico annuncio della morte di Cavour in una Torino parata a lutto. In anni politicamente complicati Vignoli abbracciò gli ideali risorgimen-tali, ma non sui campi di battaglia. Liberale moderato, parteggiava per il fronte monarchico, al fianco di Cavour e Napoleone III, contro l’Austria e la «setta mazziniana»15, il «partito pseudo-garibaldino, o repubblicano con Mazzini, Cattaneo, Bertoni, Guerrazzi e altri testicoli a guide»16. Cristiano animato da un profondo spirito laico, si schierò contro la «tirannide temporale dei Papi» e il loro «sozzo»17 Stato.
Nel 1864 si aprì per lui una nuova fase: quarantenne, sposò Francesca Pedrali, nipote dell’esploratore Manfredo Camperio e dei patrioti Giacomo e Filippo Cia-ni, esuli a Lugano, a cui Vignoli dedicò nel 1877 il libro Della legge fondamen-tale dell’intelligenza nel regno animale. Saggio di psicologia comparata18. Pro-
13. Biblioteca Accademia dei Lincei, Roma, (d’ora in poi BAL), Carte Ascoli, doc. 6/95, Lettera di
Vignoli ad Ascoli, Como-Borgovico 26 agosto [1900]. 14. ASP, Carteggio Centofanti, b. 32/3d, doc. 137, Lettera di Vignoli a Centofanti, Torino 6 aprile
1861. 15. Ivi, doc. 132, Lettera di Vignoli a Centofanti, Torino 8 gennaio 1861. 16. Ivi, b. 32/3c, doc. 131, Lettera di Vignoli a Centofanti, Milano 28 dicembre 1860. 17. Ivi, b. 32/3d, doc. 135, Lettera di Vignoli a Centofanti, Torino 10 marzo 1861. 18. Vignoli era molto legato alla famiglia della moglie, figlia dell’ingegnere Giuseppe Pedrali e di
Enrichetta Camperio, una delle sei sorelle dell’esploratore Manfredo Camperio e imparentata con le fa-miglie Simonetta, Besana, Prinetti, Dall’Acqua e Gabrini. Di questi legami è rimasta traccia nel carteg-gio di Vignoli, nelle poche lettere ritrovate tra i libri di Castel Campo, nelle commemorazioni tenute da Vignoli su Filippo Camperio e Francesca Ciani e in alcune dediche sui suoi libri che Vignoli regalò alla «sua cara nonna Francesca Ciani-Camperio», all’«ottimo mio zio ed amico, chiaro e dotto geografo Manfredo Camperio», al «mio carissimo zio Pippo», oggi conservati a Villasanta, vicino Monza, nell’Archivio della famiglia Camperio. Cfr. T. Vignoli, Commemorazione di Filippo Camperio, Milano, Tip. Bellini, 1882 e Fanny Ciani ved. Camperio, [s.l.], [s.n.], [1886]; P. Zocchi, L’Archivio della fami-
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
12
prio Filippo Ciani nel 1868 gli lasciò in eredità le rendite provenienti dal fondo terriero di Monzoro19, alle porte di Milano, dandogli la possibilità d’interrompere l’istruzione dei figli dell’industriale Andrea Ponti per dedicarsi a tempo pieno a-gli studi che lo imporranno sulla scena culturale ed editoriale degli anni settanta. Fino a quel momento, infatti, Vignoli aveva pubblicato solo i due saggi Dell’insegnamento elementare della filosofia nei licei dello Stato (1863) e Di una dottrina razionale del progresso (1864) apparsi sulla terza serie del «Poli-tecnico» di Cattaneo, che con l’autore intrattenne un breve scambio epistolare nel 1863 relativo al primo dei due lavori. Il giudizio di Cattaneo, oggi presente a Ca-stel Campo solo con il volume Scritti storici-letterari-linguistici-economici del 1900 a cura di Carlo Romussi, è contrastante. Se trovava buona la concezione di una filosofia che è scienza e che non si perde in vuote controversie, aprendosi al-le «idee capitali di Cosmologia e d’Etnografia», negativo invece era il suo giudi-zio sullo stile à la Gioberti, «di sacrestia» e «studiato per confondere le idee»20, di Vignoli, che in quegli anni leggeva in effetti numerosi lavori del sacerdote e filosofo italiano. Sebbene le fonti per chiarire quale fu il reale rapporto tra Vi-gnoli e Cattaneo siano al momento ancora insufficienti e nonostante le loro diffe-renze di stile e prese di posizione su alcune questioni, per esempio politiche, tra i due si delineano comunque affinità teoriche, dettate dalle tematiche vichiane svi-luppate da entrambi21.
Partendo dai classici della filosofia, dall’erudizione letteraria, dalla linguisti-ca romantica e dalla filosofia della storia di Vico, apprezzato già ai tempi dell’università, Vignoli si aprì ai nuovi sviluppi delle scienze umane della se-conda metà dell’Ottocento, interrogandosi su temi quali l’origine dell’uomo, il funzionamento della sua intelligenza rispetto al resto del regno animale e la ra-dice “psicologica” che sta alla base della scienza, dell’arte e della religione di popoli e civiltà diverse. Nato filosofo, nel corso della sua lunga carriera diven-
glia Camperio, in Manfredo Camperio. Tra politica, esplorazioni e commercio, a cura di M. Fugazza, A. Gigli Marchetti, Milano, FrancoAngeli, 2002, pp. 199-203.
19. Le carte relative a questo fondo terriero sono conservate a Milano presso la famiglia Valenti. 20. Lettera di Cattaneo a Vignoli, [1863], in Epistolario di Carlo Cattaneo, vol. 4, a cura di R. Cad-
deo, Firenze, Barbera, 1956, p. 115. La minuta si trova in Civiche raccolte storiche – Museo del Risor-gimento (d’ora in poi CRSM), Carteggio di Carlo Cattaneo, b. 3, plico 30, doc. 170. Nella biblioteca di Cattaneo è conservato il saggio Di una dottrina razionale del progresso, cfr. La biblioteca di Carlo Cat-taneo, cit., p. 335. Si vedano anche “Il Politecnico” di Carlo Cattaneo. La vicenda editoriale, i collabo-ratori, gli indici, a cura di C.G. Lacaita, R. Gobbo, E. Laforgia, M. Priano, Bellinzona, Casagrande, 2005; M. Fugazza, Carlo Cattaneo. Scienza e società 1850-1868, Milano, FrancoAngeli, 1989.
21. Cfr. G. De Liguori, Introduzione, in C. Cattaneo, Psicologia delle menti associate, Roma, Editori Riuniti, 2000, pp. 7-36; N. Badaloni, Tito Vignoli tra evoluzionismo e neovichismo ottocentesco, in «Studi storici», 1990, n. 2, pp. 525-546. Vignoli riconobbe l’importanza degli studi di Cattaneo in I mi-gliori libri italiani consigliati da cento illustri contemporanei, Milano, Hoepli, 1892, pp. 164-167.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
13
tò antropologo e psicologo, passando attraverso l’incontro fondamentale con la linguistica comparata da una parte e il darwinismo dall’altra. In quest’ottica, la sua fama è legata a due libri pubblicati negli anni settanta nella collana Biblio-teca scientifica internazionale della casa editrice milanese Dumolard. Vignoli era in catalogo insieme ad autori di punta del positivismo italiano, come il cri-minologo Cesare Lombroso con Pensiero e meteore. Note di un alienista (1878) o il medico psichiatra Enrico Morselli con Il suicidio (1879). Se Della legge fondamentale dell’intelligenza nel regno animale del 1877, tradotto in tedesco due anni dopo, lo consacrò come l’iniziatore della psicologia compara-ta in Italia, Mito e scienza, del 1879, tradotto tra il 1880 e il 1882 sia in tedesco che in inglese, lo caratterizzò come antropologo interessato al problema del mi-to, anche fuori dai confini nazionali, dove i suoi lavori furono segnalati e re-censiti su riviste come la «Revue philosophique», il «Journal des savants», la «Deutsche Litteraturzeitung» o il «Popular Science Monthly», o citati nei loro lavori dal filosofo-psicologo francese Alfred Espinas, dallo psicologo evolu-zionista inglese George John Romanes, dall’evoluzionista tedesco Ernst Hae-ckel, dallo psicologo dell’École des hautes études di Parigi Jules Soury e dallo storico delle religioni Hermann Usener. Proprio attraverso Usener Mito e scienza arrivò ad Aby Warburg, al tempo uno dei suoi allievi più brillanti, tra-mite il quale è giunto al filosofo Ernst Cassirer. Questi, ormai lontano dal clima tardo ottocentesco, ne giudicò positivamente le tesi nella sua Filosofia delle forme simboliche22, traghettando così l’analisi “psicologica” del mito di Vigno-li nel vivace dibattito novecentesco su queste tematiche.
Oltre ai due volumi citati, sempre con Dumolard Vignoli pubblicò due studi di carattere storico-politico, Delle condizioni morali e civili d’Italia (1876) e Delle condizioni intellettuali d’Italia (1877), mentre negli anni novanta per Hoepli uscirono due raccolte di saggi già editi, Peregrinazioni psicologiche (1895) e Peregrinazioni antropologiche e fisiche (1898). Autore prolifico e ben inserito nel panorama culturale della seconda metà dell’Ottocento, nel corso della sua lunga carriera, pubblicò numerosi articoli, che toccavano temi di psi-cologia comparata, psicofisica, biologia, antropologia, estetica, pedagogia e scienze naturali, apparsi su riviste diverse: dai «Rendiconti del Reale Istituto
22. Cfr. E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche, Firenze, La Nuova Italia, 1964, vol. 2, p. 31; 1966, vol. 3, tomo 1, pp. 100-102. Per le recensioni, cfr. A. Espinas, Études nouvelles de psychologie comparée, in «Revue philosophique», janvier-juin 1878, pp. 600-617; Mito e scienza, in «Journal des savants», novembre 1879, p. 724; H. Usener, T. Vignoli, Mythus und Wissenschaft, in «Deutsche Litte-raturzeitung», 1881, n. 27, pp. 1065-1067; Myth and Science, in «Popular Science Monthly», June 1882, p. 271. Sul rapporto tra Vignoli e Warburg cfr. E. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intel-lettuale, Milano, Feltrinelli, 2003; B. Villhauer, Aby Warburgs Theorie der Kultur, Berlin, Akademie Verlag, 2002. Sul mito cfr. H. Blumenberg, Elaborazione dl mito, Bologna, il Mulino, 1991.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
14
lombardo di scienze e lettere», di cui fu socio dal 1869, alla «Rivista di filoso-fia scientifica», edita da Dumolard e diretta da Morselli, da «Il Pensiero italia-no» alla «Rivista di scienze biologiche», fondata dal biologo Paolo Celesia in-sieme a Morselli, da «L’Esploratore», il periodico promosso dallo zio della moglie Manfredo Camperio, agli «Atti della Società italiana di scienze naturali e del Museo civico di storia naturale di Milano».
Pubblicista e conferenziere apprezzato, fu membro di numerose società e as-sociazioni nazionali e locali, che si occupavano di scienza, cultura, istruzione e beneficenza. Segretario della Società promotrice di esplorazioni scientifiche, fu membro dell’Accademia fisio-medico-statistica, della Società dantesca italiana, della Società promotrice dei ricreatori laici, dell’Opera Pia della cura climatica, dell’Associazione d’incoraggiamento all’intelligenza e della Società interna-zionale per la pace promossa dall’amico e premio Nobel Ernesto Moneta. Si-gnificativo fu il suo contributo alla fondazione nel 1882 della Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria e artistica (attuale Siae) e alle attività della Commissione conservatrice dei monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità della provincia di Milano. Ispettore scolastico, partecipò ai consigli direttivi di alcuni istituti d’istruzione secondaria della città, come la Scuola su-periore d’arte applicata all’industria, la Scuola tecnico letteraria femminile, il Collegio Calchi Taeggi e il Convitto nazionale Longone.
Deluse ben presto le aspettative di entrare in pianta stabile nel mondo uni-versitario italiano, Vignoli iniziò una lunga gavetta nel 1874, quando su propo-sta dell’amico Graziadio Ascoli, al tempo preside dell’Accademia scientifico-letteraria, tenne un corso libero e gratuito di antropologia, le cui lezioni, «mo-vendo dagli studi sullo sviluppo degli organismi e delle specie, e dando largo spazio agli sperimenti della psicologia comparata», dovevano costituire, «nel loro complesso, una compiuta introduzione alla etnologia generale e all’etnografia storica»23. Questa esperienza fu ripetuta saltuariamente nel 1875 e nel 1878, interrompendosi nel 1879 per riprendere dieci anni dopo con la li-bera docenza in psicologia. La nomina a professore incaricato arrivò solo nel 1894 e terminò con il pensionamento nel 1911. Sullo scorcio della Milano fin de siècle, Vignoli insegnò antropologia e psicologia con un taglio peculiare proprio delle scienza della cultura di quegli anni, distante sia da quello filosofi-co e pedagogico tradizionale sia da quello sperimentale del fondatore dell’Università Cattolica, padre Agostino Gemelli, che tanta fortuna avrà nella
23. Archivio centrale dello Stato (d’ora in poi ACS), Ministero della pubblica istruzione, Professori
universitari (1860-80), fascicolo personale Tito Vignoli, Lettera di Ascoli al ministro dell’istruzione pubblica, Milano 23 dicembre 1873.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
15
Milano del Novecento. Oltre a questo, i suoi incarichi più impegnativi furono le direzioni, dal 1885 al 1894, del Circolo filologico, e poi, dal 1893 al 1911, del Museo civico di storia naturale. Per il primo organizzò corsi di lingue stra-niere e conferenze, chiamando personalità della cultura da tutta Italia, del se-condo invece contribuì a disegnare il nuovo assetto istituzionale, sovrainten-dendo al trasloco nel nuovo edificio ai Giardini pubblici e all’attivazione della Stazione di biologia e idrobiologia applicata presso l’Acquario civico.
Politicamente vicino al fronte liberale conservatore e monarchico, sul finire del secolo Vignoli dialogò con l’emergente sponda del socialismo milanese di Filippo Turati – che sulle riviste «Cuore e critica» e «Critica sociale» ne segna-lava le prolusioni ai corsi dell’Accademia scientifico-letteraria – e di Anna Ku-liscioff, invitata nel 1890 al Circolo filologico a tenere la conferenza Il mono-polio dell’uomo.
Tra i «propugnatori delle dottrine positiviste»24, Vignoli è dunque un intellet-tuale laico dalle molte anime e dalla formazione poliedrica. Diviso tra cultura umanistica e scientifica, egli sperimentò in prima persona il passaggio dalla ge-nerazione dei Tommaseo, Gioberti e Lambruschini a quella postunitaria dei Lombroso, Morselli e Mantegazza. Questa complessità di pensiero, interessi, a-micizie e ruoli rivive nello spirito che anima la sua biblioteca come corpus unita-rio, così come emerge nelle dediche sui libri ed estratti che gli furono inviati. Sfogliandoli, di volta in volta ci si trova di fronte al collega, al maestro, all’antropologo, allo psicologo, all’evoluzionista, al libero pensatore, o sempli-cemente all’amico. C’è chi, come Lombroso, sulla copia dell’Uomo delinquente (1897), lo definiva «fratello di armi e maestro»; chi, come il giornalista-geografo Arcangelo Ghisleri, sulla copia di Dalla fede alla scienza (1887), si rivolgeva a lui come a un «illustre combattente per la scienza e per la vita»; o addirittura chi, come l’amico e astronomo della Specola di Brera, Giovanni Schiaparelli, sulla copia della terza Memoria sulle osservazioni di Marte del 1886 gli dedicava un lungo componimento in latino. Se per il sociologo Alessandro Groppali dei Saggi di sociologia (1899) Vignoli era un «illustre e carissimo amico», per l’antropologo Ettore Regalia di Vi ha una coscienza e un soggetto cosciente? (1898) egli era un «illustre psicologo e antropologo», mentre per il filosofo Adol-fo Padovan delle Origini del genio (1909) era «amico e maestro».
24. L. Previti, Della decadenza del pensiero italiano, Firenze, Tip. Ricci, 1884, p. 67.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
16
Tra scienze umane e scienze naturali: stratificazioni disciplinari
Una descrizione di come doveva apparire la biblioteca prima di arrivare a Castel Campo, con un Vignoli all’apice della carriera, la fornì nel 1884 il gior-nalista Giovanni Gavazzi Spech, il quale raccontava: «Lo studio è in diretta comunicazione con l’anticamera. È lungo, e poco illuminato. Una parete è oc-cupata da una vasta biblioteca aperta, nella quale ci sono volumi di scienza in diverse lingue. Di contro, il caminetto. Alla finestra una vasta scrivania piena di carte e volumi. Poco, del resto, qui dentro, di interessante pel curioso; qual-che ritratto di famiglia e una fotografia di Darwin con dedica cortese»25.
All’epoca Vignoli abitava al primo piano di palazzo Trotti in via Filodramma-tici. Presto si sarebbe trasferito in Corso Venezia 44, dove fu segnalata per l’ultima volta anche la biblioteca. Lo studio è descritto come un luogo austero, lasciato nella penombra. Su tutto, accanto ai ritratti dei cari, domina la fotografia di Darwin che Vignoli si fece mandare dai familiari nel 1882, all’indomani della morte del naturalista inglese, per tenerla «sacra, e sempre dinanzi a me»26. La bi-blioteca è vasta, con numerosi volumi in diverse lingue, un dato confermato an-cora oggi dalla rilevante presenza a Castel Campo di libri in francese, lingua in cui leggeva i maggiori autori stranieri, inglesi e tedeschi in particolare.
Testimonianza di particolari interessi personali, questa raccolta libraria ben rappresenta gli sviluppi delle scienze umane della seconda metà dell’Ottocento, coniugando la filosofia romantica di Ernest Renan e Victor Cousin con quella positivista di Herbert Spencer ed Émile Littré, uno dei maggiori discepoli di Comte. Essa è caratterizzata da una commistione d’interessi e discipline che tro-vano un terreno d’incontro nell’indagine sull’uomo, sulla sua natura, le sue ori-gini e la sua storia, secondo un’impostazione che caratterizza anche il lavoro più noto di Vignoli, Mito e scienza. Tra gli scaffali si spazia dalla filosofia classica e “scientifica” alla linguistica comparata, dalla storia delle religioni all’etnografia, dall’antropologia alla psicologia, dalla biologia evoluzionista alla geologia, dalla storia alla paletnologia, dalla fisiologia alla pedagogia, dalla nascente psichiatria alla sociologia. I temi più trattati riguardano i fenomeni della percezione, l’intelligenza, il cervello, la coscienza, i sensi, l’istinto, il rapporto corpo/mente, le alterazioni della psiche, l’evoluzione, l’umanità primitiva, le religioni, le lin-gue e la cultura in generale di popoli e civiltà diverse. A Castel Campo mito, ma-gia, follia, religione e scienza incrociano così il loro cammino.
25. G. Gavazzi Spech, È in casa? (Le visite di John), Roma, A. Sommaruga e C., 1884, p. 222. 26. Cambridge University, Darwin Archive, CUL-DAR215.10u, Lettera di Vignoli alla famiglia di
Darwin, Lugano 4 maggio 1882.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
17
Nonostante l’eterogeneità, il corpus librario di Vignoli traccia un percorso coerente e rappresentativo della sua opera e del suo lavoro. Un dato interessan-te viene dal fatto che il suo avvicinamento alla teoria dell’evoluzione è passato attraverso il dibattito linguistico e storico-filosofico sulle origini dell’uomo e sull’“incivilimento delle genti”, per approdare ai nuovi sviluppi delle scienze umane della seconda metà del secolo, in primis della psicologia e dell’antropologia, e della storia della cultura, con un taglio etnografico e di sto-ria delle religioni, alla luce del darwinismo e della biologia. È dunque in quest’ottica “mista” di erudizione e approccio filosofico, di scienze umane e scienze naturali, che si deve guardare alla sua biblioteca, in cui è da segnalare un consistente nucleo di linguistica, etnografia e storia delle religioni, con un picco nel periodo in cui Vignoli lavorò come precettore a Milano, tra gli anni cinquanta e sessanta. Come scrisse all’amico e maestro Silvestro Centofanti, fu in questa fase che, partendo da Vico e da figure come lo scrittore francese An-toine Fabre d’Olivet, di cui possedeva l’Histoire philosophique du genre hu-main (1824), Vignoli si confrontò con la «storia etnica del genere umano»27 e con l’annoso problema antropologico dell’origine delle “razze” umane, come testimonia la presenza a Castel Campo di volumi importanti dell’epoca, dall’Histoire naturelle de l’homme dell’etnologo inglese James Cowles Pri-chard (1843) all’Études des races humaines del medico-zoologo francese Mi-chel-Hyacinthe Deschamps (1857), da De la pluralité des races humaines dell’anatomo comparato Georges Pouchet (1858) all’Unité de l’espèce humai-ne dello zoologo Armand de Quatrefages (1861). E fu sempre in questi anni che, accanto alla filosofia di Gioberti e Rosmini, alle Confessioni di Terenzio Mamiani, ai manuali e ai saggi di storia della filosofia di Henry Ritter (Histoire de la philosophie, 1835), Victor Cousin (Cours de l’histoire de la philosophie, 1840), Kuno Fischer (Geschichte der neuern Philosophie, 1855), Jean Félix Nourrisson (Histoire et philosophie, 1860), o ai classici, letti per lo più in fran-cese, come Kant, Fichte, Schlegel, Bruno, Platone, Cartesio, Bacone e Leibniz, la sua attenzione si rivolse alla linguistica comparata di scuola francese e so-prattutto tedesca. Proprio alla Germania, infatti, egli guardava in questi anni come a una «fucina di studi»28 da prendere a modello.
27. ASP, Carteggio Centofanti, b. 32/3a, doc. 32, Lettera di Vignoli a Centofanti, Milano 21 aprile
1855. 28. Ivi, b. 32/3b, doc. 58, Lettera di Vignoli a Centofanti, Milano 11 agosto 1856. Cfr. S. Timpanaro,
Sulla linguistica dell’Ottocento, Bologna, il Mulino, 2005; A. Morpurgo Davies, La linguistica dell’Ottocento, Bologna, il Mulino, 1996; P. Desmet, La linguistique naturaliste en France (1867-1922), Leuven, Peeters, 1996; G. Landucci, Sull’origine del linguaggio. Note e documenti, in «Critica storica», 1981, n. 2, pp. 223-263.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
18
Ispirandosi al metodo e ai risultati di geologia, paleontologia e anatomia com-parata, la linguistica di questi anni dialogava con l’etnografia, la storia delle reli-gioni, la psicologia dei popoli, l’antropologia, l’archeologia, interrogandosi sull’origine del linguaggio e lo sviluppo della civiltà. Lo studio comparato di lin-gue, dialetti ed etimologie si confrontava quindi con il mistero del passato anti-chissimo dell’umanità. E fu proprio in quest’ottica che Vignoli si procurò, accan-to ai libri di Ernest Renan (De l’origine du langage, 1858 e De la part des peu-ples sémitiques dans l’histoire de la civilisation, 1862), alcune pietre miliari di questo settore, che costituisce una sezione quantitativamente significativa della biblioteca, a firma dei principali autori del tempo: dal linguista svizzero Adolphe Pictet (De l’affinité des langues celtiques avec le sanscrit, 1837) all’egittologo tedesco Richard Lepsius (Briefe aus Aegypten, Aethiopien und der Halbinsel des Sinai, 1852); dall’indologo norvegese Christian Lassen (Indische Alterthumskun-de, 1855) al glottologo torinese Giovanni Flechia (Grammatica sanscrita, 1856); dal filologo tedesco Georg Curtius (Grundzüge der griechischen Etymologie, 1858) al linguista tedesco August Schleicher (Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, 1861); dall’antropologo Max Mül-ler (Letture sopra la scienza del linguaggio, 1861) allo storico francese Louis Benloew (De quelques caractères du langage primitif, 1863); dal linguista fran-cese Michel Bréal (Hercule et Cacus: étude de mythologie comparée, 1863) al linguista tedesco Heymann Steinthal (Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern mit besonderer Rücksicht auf die Logik, 1863); dal filolo-go tedesco Karl Wilhelm Ludwig Heyse (Sistema della scienza delle lingue, 1864) al linguista François Bopp (Grammaire comparée des langues indo-européennes, 1864-74). La sezione di linguistica è arricchita da vocabolari, grammatiche e manuali di lingue morte o parlate, tra cui illirico, greco, inglese, ebraico, caldaico, cinese, latino, russo, spagnolo, polinesiano, italiano, basco, sanscrito, turco, persiano.
Accanto ai testi classici dell’archeologo Jacques Champollion (Égypte an-cienne, 1839), dello storico e numismatico Theodor Mommsen (Storia romana, 1857-65), dell’antropologo Theodor Waitz (Anthropologie der Naturvölker, 1859-72), di Ariosto (Orlando furioso, 1854), Shakespeare (The Dramatic Works, 1824) e Byron (Opere complete, 1852-53), in questa fase trovano posto numerosi volumi di storia delle religioni, tra cui quelli del teologo Heinrich Klee (Storia dei dogmi, 1843), del filosofo Henry Ritter (Histoire de la philo-sophie chrétienne, 1843-44), dell’ebraista Jean Baptiste Glaire (Archeologia biblica, 1850), del linguista Louis-Ferdinand Alfred Maury (Histoire des reli-gions de la Grèce antique, 1857-59), del filosofo ed economista Pierre Leroux
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
19
(De l’humanité, 1865) e del filosofo francese Elme Marie Caro (L’idée de Dieu et ses nouveaux critiques, 1864), in cui si discuteva con accenti critici la teoria di Darwin. La biblioteca di Castel Campo conferma inoltre l’interesse che Vi-gnoli nutriva in questi anni per una filosofia che si confronta con le questioni aperte dell’antropologia, della psicologia, della fisiologia, dell’evoluzionismo. Da un lato, infatti, troviamo volumi di medici come Charles e Hector Jantet (De la vie et de son interprétation dans les différents âges de l’humanité, 1860), Eugène Bouchut (La vie et ses attributs, 1862), Louis François Lélut (Physiologie de la pensée, 1862), di filosofi come Emilé Nerva (Introduction a la philosophie des sciences naturelles a la philosophie de l’histoire et a l’étude des littératures comparées, 1860), Joseph Tissot (La vie dans l’homme, 1861), Auguste Laugel (con la trilogia Les problèmes de la nature, 1864, Les problè-mes de la vie, 1867, Les problèmes de l’âme, 1868), Henri Joly (L’instinct, 1869), di etnologi come Adolf Bastian (Das Beständige in den Menschenras-sen und die Spielweite ihrer Veränderlichkeit, 1868) o di antropologi come Charles Letourneau (Physiologie des passions, 1868); dall’altro, Vignoli dialo-gava in maniera diretta o mediata con i maestri della filosofia positivista e ma-terialista europea, leggendo filosofi come Paul Janet (Le matérialisme contem-porain en Allemagne: examen du système du docteur Büchner, 1864), Hippo-lyte Taine (Le positivisme anglais: étude sur Stuart Mill, 1864), Émile Littré (Auguste Comte et la philosophie positive, 1864) e John Stuart Mill (Auguste Comte et le positivisme, 1868).
L’incontro con l’opera di Darwin all’inizio degli anni sessanta offrì a Vigno-li, come a molti dei suoi contemporanei, una cornice teorica precisa in cui inse-rire le questioni trattate. Da quel momento, fino alla morte, nella sua biblioteca entrarono autori che hanno fatto la storia del darwinismo ottocentesco e primo novecentesco, dallo stesso Darwin (De la variation des animaux et des plantes sous l’action de la domestication, 1868; The Descent of Man, 1871) al geologo Charles Lyell (The Geological Evidences of the Antiquity of Man, 1863), dal naturalista Jean-Baptiste Lamarck (Philosophie zoologique, ou Exposition des considérations relatives à l’histoire naturelle des animaux, 1809) al linguista August Schleicher (La théorie de Darwin et la science du langage, 1868), dallo zoologo Ernest Haeckel (Histoire de la création naturelle, 1874) al botanico Alphonse de Candolle (Darwin considéré au point de vue des causes de son succès et de l’importance de ses travaux, 1882), dallo psicologo George John Romanes (L’évolution mentale chez les animaux, 1884) all’anarchico russo Petr Kropotkin (L’entraide. Un facteur de l’évolution, 1906). La biblioteca conferma che dopo l’iniziale entusiasmo per l’opera di Darwin, a cui Vignoli
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
20
guardava come a un baluardo di scientificità e libero pensiero, egli non smise di interrogarsi sui fattori dell’evoluzione, anche quando il darwinismo iniziò a eclissarsi all’inizio del nuovo secolo. Per questo la letteratura pro o contro la teoria evoluzionistica è numerosa, e spazia da volumi in italiano, come quelli di Achille Quadri (Note alla teoria darwiniana, 1869) e Carlo Fenizia (Storia della evoluzione, 1901), a volumi in francese, come quelli del fisiologo antie-voluzionista Pierre Flourens (Examen du livre de M. Darwin sur l’origine des espèces, 1864), del filosofo Léon Dumont (Haeckel et la théorie de l’évolution en Allemagne, 1873) o dello zoologo tedesco Oscar Schmidt (Descendance et darwinisme, 1874).
Significativo è che a partire dagli anni settanta, in coincidenza con il suo in-gresso sulla scena editoriale, Vignoli si sia procurato numerosi studi in cui l’evoluzionismo era applicato alle scienze umane e sociali, in linea con certa produzione positivista ben rappresentata dal catalogo di alcuni editori del tem-po. Lo dimostra la presenza rilevante di quasi tutti i lavori di Herbert Spencer, letto prevalentemente in francese, e di filosofi e biologi, per la maggior parte francesi, come Louis Gumplowicz (La lutte des races: recherches sociologi-ques, 1893), Charles-Jean-Marie Letourneau (L’évolution littéraire dans les di-verses races humaines, 1894), Jean-Louis de Lanessan (La lutte pour l’existence et l’évolution des sociétés, 1903), René Worms (Les principes bio-logiques de l’évolution sociale (1910) e Félix Le Dantec (L’égoïsme seule base de toute société, 1911). Questi autori dedicavano i loro lavori a un’interpretazione evoluzionistica della società, insistendo su concetti quali la lotta per l’esistenza, l’evoluzione o la regressione sociale. In questa direzione, molti dei libri della biblioteca, stampati nella seconda metà dell’Ottocento, da-vano voce a certa produzione di filosofia antimetafisica, “positiva”, “evoluzio-nista”, “scientifica” e “materialista”, con qualche apertura verso il marxismo sul finire del secolo. In questa fase, mentre diminuiscono i testi di filosofia classica, aumentano infatti quelli di autori emergenti, quali i filosofi Hippolyte Taine (De l’intelligence, 1870) e Émile Littré (La science au point de vue phi-losophique, 1873), il pedagogo e filosofo scozzese Alexander Bain (L’esprit et le corps, 1873), il filosofo-scienziato John William Draper (Les conflits de la science et de la religion, 1875), il filosofo materialista Friedrich Albert Lange (Histoire du matérialisme et critique de son importance a notre époque, 1877-79), il filosofo-psicologo Alfred Espinas (La philosophie expérimentale en Ita-lie, 1880), lo psicologo Jules Soury (Philosophie naturelle, 1882), il biologo Jean-Louis de Lanessan (Le transformisme: évolution de la matière et des êtres vivants, 1883), il sociologo russo Eugène de Roberty (L’éthique. Le psychisme
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
21
social, 1897), i filosofi Georges Sorel (Saggi di critica del marxismo, 1903) ed Eugenio Rignano (La sociologia nel corso di filosofia positiva d’Augusto Com-te, 1904).
Al contempo, Vignoli continuava a coltivare la sua antica passione per la storia delle religioni, la mitologia, l’etnografia, la linguistica e l’antropologia. Accanto a un sottobosco di titoli minori sugli argomenti più diversi, nella bi-blioteca troviamo alcuni importanti lavori pubblicati nel corso della seconda metà dell’Ottocento, che confermano la rilevanza che queste tematiche rivesti-vano ai suoi occhi. Sugli scaffali di Castel Campo sono conservati alcuni autori classici del settore, come gli orientalisti Émile Burnouf (La légende athénien-ne: étude de mythologie comparée, 1872) e Theodor Nöldeke (Histoire littérai-re de l’Ancien Testament, 1873), gli antropologi John Lubbock (Les origines de la civilisation, 1873), Max Müller (La science de la religion, 1873) ed E-dward B. Tylor (La civilisation primitive, 1876-78), i linguisti William Dwight Whitney (La vie du langage, 1875), Girard de Rialle (La mythologie comparée, 1878) e Abel Hovelacque (La linguistique, 1876), i filosofi Eugène Véron (Hi-stoire naturelle des religions, 1883) e Baldassare Labanca (Della religione e della filosofia cristiana, 1888), il medico-criminologo francese Alexandre La-cassagne (Les tatouages: étude anthropologique et médico-légale, 1881) e l’etnologo belga Élie Reclus (Les primitifs: études d’ethnologie comparée, 1883). Si aggiungono, sempre a partire da questi anni, numerosi lavori, di ta-glio più o meno specialistico abbastanza diffusi, concernenti la paleontologia umana e l’archeologia preistorica, tra cui quelli del divulgatore francese Louis Figuier (L’Homme primitif, 1870), dell’antropologo Ernest Théodore Hamy (Précis de paléontologie humaine, 1870), di Gabriel de Mortillet e Abel Hove-lacque (Notes sur le précurseur de l’homme, 1873), del paleontologo francese Jean-Albert Gaudry (Les ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques, 1888), dei linguisti Isaac Taylor (L’origine des Aryens et l’homme préhistori-que, 1895) ed Emmanuel Denoy (Descendons-nous du singe?, 1901).
Tra gli anni ottanta e novanta aumenta la presenza della produzione italiana, testimonianza del suo ruolo e di una fase matura del suo lavoro, legato agli svi-luppi del positivismo italiano e alla cultura e alla scienza del tempo. Da una parte troviamo numerosi estratti e volumi, che spesso gli venivano inviati dai nomi più in vista del panorama delle scienze umane di fine Ottocento, tra cui molti collaboratori della «Rivista di filosofia scientifica»: da Enrico Morselli a Cesare Lombroso, dagli antropologi Giuseppe Sergi, Paolo Mantegazza e Giu-seppe Marina agli psicologi Gabriele Buccola, Eugenio Tanzi, Roberto Ardigò, Angelo Brofferio e Guido Villa; dai filosofi Andrea Angiulli, Pietro Siciliani,
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
22
Icilio Vanni, Giovanni Cesca, Francesco De Sarlo ed Eugenio Rignano ai so-ciologi Napoleone Colajanni, Angelo Vaccaro, Alessandro Groppali e Achille Loria. Dall’altra, invece, sono presenti i lavori di letterati di stampo più tradi-zionale come Carlo Cantoni, Ruggero Bonghi, Pietro Ceretti, Mario Pilo, An-tonio Fogazzaro, storici della letteratura come Ugo Angelo Canello, politici e uomini delle istituzioni come Carlo Cadorna e Luigi Credaro; naturalisti e scienziati italiani, come Enrico Hyller Giglioli, Leopoldo Maggi, Giovanni Ca-nestrini, Camillo Golgi, Giovanni Battista Grassi, Mario Cermenati, Daniele Rosa, o personalità in vista di Milano, in relazione alle sue amicizie e cariche pubbliche, come il banchiere Cimone Weill Schott, l’architetto Luca Beltrami, lo psichiatra Andrea Verga, i letterati Lodovico Corio e Carlo Baravalle, il filo-sofo Giuseppe Zuccante e i naturalisti del Museo civico di storia naturale, da Emilio Cornalia ad Antonio Stoppani, da Angelo Andres a Ettore Artini. Nel complesso questa parte della biblioteca restituisce un affresco preciso della cul-tura e della scienza italiana e milanese fin de siècle.
In linea con i diversi interessi di Vignoli, accanto alla sociologia, alla peda-gogia e all’antropologia, a partire dagli anni settanta, spicca la sezione dedicata alla psicologia sperimentale e comparata, in stretto rapporto con studi di fisio-logia e nascente psichiatria. Dopo l’adesione alla teoria dell’evoluzione, Vi-gnoli dedicò gran parte dell’attività proprio a studi di psicologia comparata, psicofisica e teoria della percezione, come mostrano i numerosi articoli da lui pubblicati sui «Rendiconti del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere» ri-guardanti l’intelligenza degli animali, la psicologia fisiologica o fenomeni per-cettivi come l’audizione colorata e la falsa memoria. Anche in questo caso, tra numerosi volumi, particolarmente rappresentata è la scuola francese, con autori di punta come Alfred Espinas (Des sociétés animales: étude de psychologie comparée, 1877), Henri Joly (L’imagination: étude psychologique, 1877), É-douard Fournié (Essai de psychologie. La bête et l’homme, 1877), Théodule Ribot (L’hérédité psychologique, 1882)29, Charles Richet (L’homme et l’intelligence: fragments de physiologie et de psychologie, 1884), Alfred Binet (La psychologie du raisonnement, 1886), Jules Soury (Les fonctions du cer-veau, 1891). Accanto a questi, troviamo i lavori di psicologi e fisiologi inglesi e tedeschi che hanno fatto la storia della disciplina in questi anni: da Hermann Lotze (Principes généraux de psychologie physiologique, 1876) a Émile Léon Poincaré (Le système nerveux périphérique au point de vue normal et patholo-gique, 1876), da Ludwig Büchner (La vie psychique des bêtes, 1881) a Henry
29. Cfr. S. Nicolas, L’hérédité psychologique d’après Théodule Ribot (1873): la première thèse
française de psychologie scientifique, in «L’Année psychologique», 1999, n. 2, pp. 295-348.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
23
Charlton Bastian (Le cerveau organe de la pensée chez l’homme et chez les animaux, 1882), da Henry Maudsley (La pathologie de l’esprit, 1883) a George John Romanes (L’évolution mentale chez les animaux, 1884), da Jac-ques Loeb (Fisiologia comparata del cervello e psicologia comparata, 1907) a William James (Philosophie de l’experience, 1910).
A fronte di una presenza significativa di libri di psicologia, antropologia, linguistica e storia delle religioni, risulta inferiore il numero dei volumi di scienze, nel complesso funzionali ai suoi interessi antropologici e alle sue in-dagini psicologiche. Se matematica, fisica, astronomia e chimica sono pratica-mente assenti, più rappresentate sono invece la geologia, la fisiologia, l’anatomia, la biologia e le scienze naturali. Al di là di alcuni classici del pen-siero scientifico, come Galileo (Le opere, 1842-56) e Francesco Redi (Opuscoli di storia naturale, 1858), di qualche manuale, come il Dizionario compendiato di geologia e mineralogia di Giovanni Aschieri (1855), l’Introduzione alla sto-ria naturale di Leonardo Doveri (1859) o il Corso di geologia di Antonio Stoppani (1873), degli studi sulla teoria dell’evoluzione e dei lavori dei natura-listi con cui è in contatto per la direzione del Museo di storia naturale, a Castel Campo sono conservati i testi di alcuni autori di riferimento della cultura scien-tifica ottocentesca, quali Goethe (Il saggio sulla metamorfosi delle piante, 1842), il fisiologo tedesco Johannes Müller (Manuel de physiologie, 1845), il geologo danese Frederik Klee (Le déluge, 1847), lo zoologo antievoluzionista Louis Agassiz (De l’espèce et de la classification en zoologie, 1869), l’anatomista tedesco Carl Gegenbaur (Manuel d’anatomie comparée, 1874), l’evoluzionista inglese Thomas Henry Huxley (Manuale dell’anatomia degli animali vertebrati, 1874), lo zoologo tedesco Carl Vogt (Leçons sur les ani-maux utiles et nuisibles, 1875), il fisico francese Lucien Poincaré (La physique moderne: son évolution, 1906) e il chimico tedesco Wilhelm Ostwald (L’énergie, 1911).
L’editoria scientifica tra Francia e Italia Al di là di uno specifico approfondimento su Vignoli, l’analisi di questa bi-
blioteca permette di seguire un certo tipo di produzione editoriale ottocentesca e primo novecentesca, francese e italiana in particolare, grazie alla presenza pressoché completa di alcune collane editoriali che hanno segnato la storia dell’editoria scientifica di quegli anni. La maggior parte dei libri e degli autori finora citati, infatti, traccia un percorso culturale ben circoscrivibile. Significa-
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
24
tiva in primo luogo è la presenza della Francia, i cui libri erano di frequente acquistati da Vignoli nella centralissima libreria dei Dumolard, punto di riferi-mento in città per l’acquisto di volumi francesi30. Gli editori più rappresentati sono Gustave Germer Baillière e Félix Alcan, che si associò a Baillière nel 1875 rilevandone dal 1883 il catalogo, con le collane Bibliothèque de philoso-phie contemporaine, avviata nel 1864, e Bibliothèque scientifique internationa-le, iniziata nel 187331. Le due collane di Baillière, editore di stampo accademi-co attento al sorgere di nuove scienze come la psicologia e la psichiatria, ri-specchiano gli interessi di Vignoli. La prima collana, sensibile a quanto stava succedendo in quegli anni in campo filosofico e psicologico, vanta nel suo ca-talogo autori come Henri Bergson, Charles Richet, Ludwig Büchner, Jakob Moleschott, John Stuart Mill, Louis Agassiz, Max Müller, Alexander Bain, Al-fred Espinas, Théodule Ribot, Alfred Binet e Hermann Lotze. I temi trattati spaziano dal materialismo tedesco alla filosofia della religione, dalla psicologia alla fisiologia, dall’arte all’etica, fino alla psichiatria. La seconda collana, inve-ce, propone autori come Herbert Spencer, Armand de Quatrefages, Thomas Henry Huxley, John Lubbock, Étienne-Jules Marey, Alfred Binet e Félix Le Dantec, con una progressiva “francesizzazione” del catalogo a partire dalla ge-stione Alcan, a fronte di un’iniziale preponderanza di lavori inglesi. In questo caso la protagonista è una filosofia che dialoga con le scienze biologiche e le emergenti discipline psicologiche e sociali, con una predilezione per medicina, zoologia e psicologia. Sempre di Baillière, a Castel Campo è presente qualche volume della Bibliothèque scientifique contemporaine, come L’archéologie préhistorique di Joseph de Baye (1888) e Les cavernes et leurs habitants di Ju-lien Fraipont (1896), e qualche titolo della Bibliothèque utile, come Histoire de l’eau di Émile Bouant (1882), insieme ad alcuni libri fuori collana, in partico-lare le opere principali di Spencer tradotte in francese nel corso degli anni set-tanta, da Les premiers principes ai Principes de sociologie, de biologie e de psychologie.
Un’altra presenza significativa nella biblioteca di Vignoli è quella della casa editrice parigina Carl Reinwald, confluita nel 1897 in quella dei fratelli Schlei-cher. Reinwald contribuì in maniera sostanziale alla diffusione del darwinismo e del materialismo scientifico in Francia, traducendo in francese alcuni testi fondamentali, presenti a Castel Campo, di evoluzionisti come Darwin, Roma-
30. Cfr. M. Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaurazione, Torino, Einaudi, 1980, pp. 73-74; M. Raicich, Editori d’Oltralpe nell’Italia unita, in «La Bibliofilia», 1987, n. 1, pp. 29-65.
31. Cfr. di V. Tesnière, Le quadrige, un siècle d’édition universitaire 1860-1960, Paris, Puf, 2001; Diffuser la science, in Le Livre et l’Historien, Geneve, Droz, 1997, pp. 779-793; Le livre de science en France au XIXe siècle, in «Romantisme», 1993, n. 80, pp. 67-77.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
25
nes e Haeckel, medici e zoologi come Büchner, Gegenbaur e Vogt, o antropo-logi come Tylor32. Numerosi sono i titoli che rientrano nella Bibliothèque des sciences contemporaines, avviata da Reinwald nel 1876. Si tratta di testi dall’ambizione enciclopedica dedicati a singole discipline, non solo scientifi-che, con una significativa presenza di biologia ed etnografia, per lo più firmati da autori francesi, tra cui pubblicisti, medici e insegnanti dell’École d’anthropologie di Parigi diretta da Paul Broca. A Castel Campo troviamo quelli che hanno più attinenza con i suoi studi, scritti da Abel Hovelacque (La linguistique, 1876), Charles-Jean-Marie Letourneau (La biologie, 1876), Paul Topinard (L’anthropologie, 1876), Eugène Véron (L’esthétique, 1878), André Lefèvre (La philosophie, 1878) e Jean-Louis de Lanessan (La sociologie, d’après l’ethnographie, 1880).
Oltre alle collane di Reinwald e Baillière-Alcan, la biblioteca conserva alcuni volumi della Bibliothèque des merveilles di Hachette, come Les métamorphoses des insectes di Maurice Girard (1867) e L’intelligence des animaux di Ernest Me-nault (1868), testi di carattere divulgativo da cui Vignoli traeva numerose informa-zioni utilizzate come esempi nelle sue pubblicazioni. Più in generale, Hachette è ben rappresentata anche con libri di filosofia e psicologia di autori come Littré, Taine e Joly, di scienza, con Quatrefages, Figuier e Kropotkin, oppure di linguisti-ca, con Michel Bréal. Dagli anni ottanta è presente la Bibliothèque matérialiste di Doin, con i volumi Les débuts de l’humanité di Hovelacque, Le transformisme di Jean-Louis de Lanessan e l’Histoire naturelle des religions di Véron, mentre dall’inizio del Novecento compare anche Flammarion, in particolare con l’interessante collana Bibliothèque de philosophie scientifique, avviata nel 1902 sul modello della Bibliothèque scientifique internationale di Baillière-Alcan33. Sotto la direzione dello psicologo e sociologo francese Gustave Le Bon la collana vanta au-tori di punta dell’accademia francese, proponendo anche traduzioni di noti autori stranieri con particolare attenzione alla psicologia. A Castel Campo sono conserva-ti i lavori di Le Dantec sull’egoismo nella società o di William James sulla filosofia dell’esperienza. Per la produzione ottocentesca, sono presenti anche gli editori Di-dier e Didot per saggi a carattere filosofico, psicologico, storico, linguistico ed et-nografico, Charpentier e Ladrange per le edizioni di classici e saggi di filosofia, Franck per la linguistica, i fratelli Garnier per storia e filosofia darwiniana, Guil-laumin per sociologia ed economia, Levy per storia delle religioni, Masson per testi
32. Cfr. H. Jeanblanc, La librairie Carl Reinwald et la diffusion du matérialisme scientifique en
France dans la seconde moitié du XIXe siècle, in «Cahiers d’études germaniques», 1987, n. 13, pp. 119-141; V. Tesnière, Diffuser la science, cit.
33. Cfr. É. Parinet, La librairie Flammarion 1875-1914, Paris, Imec, 1992.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
26
medici e filosofici, tra cui il Traité de phénomènes électro physiologiques des ani-maux (1844) dei suoi maestri pisani, Carlo Matteucci e Paolo Savi.
Se la produzione francese è rilevante, sporadica, invece, è la presenza di testi in tedesco e in inglese, con titoli legati soprattutto a determinati interessi di Vi-gnoli. In tedesco, per esempio, troviamo alcuni lavori di linguistica, etnografia e antropologia, risalenti per lo più agli anni cinquanta e sessanta, quando Vi-gnoli seguiva con attenzione la scuola tedesca, oppure qualche volume che gli fu inviato da personalità con cui era in contatto, come lo zoologo Haeckel che gli spedì i suoi Über unsere gegenwärtige Kenntiss vom Ursprung des Men-schen (1898) e Die Welträthsel (1899)34. In inglese, tra i pochissimi titoli pre-senti, si segnalano i volumi di Darwin (The Descent of Man) e Lyell (The Geo-logical Evidences of the Antiquity of Man), entrambi stampati dall’editore lon-dinese John Murray, mentre sul versante filosofico e storico-religioso troviamo alcune edizioni, per lo più risalenti agli anni trenta e quaranta, di case editrici di Bruxelles, come la Société belge de librairie che editò i lavori filosofici di Victor Cousin.
Passando all’Italia, i volumi della biblioteca stampati tra gli anni quaranta e sessanta si occupano soprattutto di storia, filosofia, lettere varie con autori clas-sici come Romagnosi, Muratori, Luigi Pulci e Gasparo Gozzi. Di editori diver-si, spesso tipografi-librai di Milano quali Niccolò Bettoni, Pirotta e Ubicini, per questa sezione della biblioteca troviamo soprattutto titoli slegati da collane, a eccezione della Nuova biblioteca popolare dei Cugini Pomba di Torino, di cui Vignoli possedeva per esempio Platone in Italia di Vincenzo Cuoco (1852), Il primo e il nuovo galateo di Melchiorre Gioja (1853) o le Istorie fiorentine di Macchiavelli (1853). Negli anni cinquanta, consistente è la presenza di libri a tema storico, letterario e naturalistico dell’editore fiorentino Le Monnier, ben rappresentato anche negli anni successivi, con lavori di Cesare Balbo (Storia d’Italia sotto i barbari, 1856), Paolo Lioy (Lo studio della storia naturale, 1857), Gioberti e Tommaseo.
Ma è dagli anni settanta che la produzione editoriale italiana diventò signifi-cativa e sintomatica di nuovi indirizzi culturali. A Castel Campo dominano la scena due case editrici di Milano, con cui Vignoli pubblicò tra l’altro i suoi la-vori più importanti: l’editore “positivo” Dumolard e l’editore “enciclopedico” Ulrico Hoepli. Nella biblioteca, infatti, sono conservati numerosi volumi della Biblioteca scientifica internazionale, avviata da Dumolard nel 1875 in sinergia con l’iniziativa di editori anglo-americani, tedeschi e del francese Baillière-
34. Cfr. E. Canadelli, Tito Vignoli ed Ernst Haeckel. Dal carteggio di un direttore dimenticato, in «Atti
della Società italiana di scienze naturali, Museo civico di storia naturale. Milano», 2006, n. 2, pp. 239-266.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
27
Alcan. Di questa collana è presente il primo volume sui principi dell’acustica, a firma del fisico Pietro Blaserna, insieme ai lavori di figure di punta del positi-vismo e del mondo accademico italiano, da Morselli a Lombroso, da Sergi a Siciliani, e a traduzioni di libri di Spencer, Bain o de Candolle. Della Dumo-lard si trovano inoltre alcuni libri fuori collana come La specie dell’esperienza di Brofferio o il volume collettaneo a cura di Morselli, Carlo Darwin e il dar-winismo nelle scienze biologiche e sociali. Di Hoepli, invece, è pressoché completa la serie dei Manuali, spesso inviatigli in omaggio dall’editore o dai singoli autori, spaziando in egual misura dai titoli tecnici a quelli di scienze na-turali e di nuove scienze umane. Sempre di Hoepli, ben rappresentata è la Bi-blioteca scientifico-letteraria, nella cui serie nel 1895 uscì anche il suo Pere-grinazioni psicologiche35. Nell’arco della seconda metà dell’Ottocento, se le edizioni Treves, Utet e Zanichelli sono praticamente inesistenti, fatta eccezione per il Viaggio di un naturalista intorno al mondo di Darwin (1872) per Utet e i volumi che gli inviò Pietro Siciliani per Zanichelli, abbastanza rappresentati sono invece editori come Sonzogno, con la Biblioteca classica economica, di cui possedeva alcuni classici come Galileo, Cattaneo, Aristotele e Vico, Loe-scher per testi di storia delle religioni e filosofia, Paravia per titoli di linguisti-ca, e Barbera per lavori di storia, letteratura e scienze naturali. Numerosi sono alcuni titoli editi da Vallardi nell’ambito del progetto a dispense L’Italia sotto l’aspetto fisico, storico, letterario, artistico e statistico con speciale riguardo all’industria ed al commercio, affidato a numerosi collaboratori, oltre a una gran quantità di tipografi-stampatori milanesi, come Agnelli, Bernardoni e Re-beschini, Civelli e Cogliati, con cui pubblicavano personaggi illustri e in vista della Milano fin de siècle, da Luca Beltrami ad Antonio Stoppani.
Dai primi del Novecento è presente un discreto numero di volumi della Pic-cola biblioteca di scienze moderne dei Fratelli Bocca di Torino, che insieme ad autori italiani proponeva traduzioni di stranieri con significative aperture al so-
35. Cfr. P. Redondi, Il catalogo Hoepli come classificazione del mondo, in Tecnica e bellezza Hoepli tra
arte e architettura 1890-1950, Lugano-Milano, Edizioni Città di Lugano-Hoepli, 2008; Editori italiani dell’Ottocento, a cura di A. Gigli Marchetti, M. Infelise, L. Mascilli Migliorini, M.I. Palazzolo, G. Turi, Milano, FrancoAngeli, 2004; P. Govoni, Un pubblico per la scienza, Roma, Carocci, 2002; N. Tranfaglia, A. Vittoria, Storia degli editori italiani, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 63-131; il numero monografico di «Ricerche storiche», 1999, n. 2, con i saggi di G. Tortorelli, La produzione scientifica della casa editrice Zanichelli, pp. 229-256, e M. Nani, Editoria e culture scientifiche nell’Italia postunitaria appunti sulle edi-zioni Dumolard, pp. 257-298; A. Gigli-Marchetti, Le nuove dimensioni dell’impresa editoriale, in Storia dell’editoria nell’Italia contemporanea, a cura di G. Turi, Firenze, Giunti, 1997, pp. 113-164; E. Scarpelli-ni, Editoria e cultura tecnico-scientifica nella Milano del secondo Ottocento: la Ulrico Hoepli, in Innova-zione e modernizzazione in Italia fra Otto e Novecento, a cura di E. Decleva, C.G. Lacaita, A. Ventura, Mi-lano, FrancoAngeli, 1996, pp. 578-632; Un secolo di Manuali Hoepli. 1875-1971, a cura di A. Assirelli, Milano, Hoepli, 1992.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
La biblioteca privata di Tito Vignoli
28
cialismo, alla psicologia e alla storia delle religioni, cercando di colmare il vuoto lasciato nel frattempo dalle edizioni Dumolard36. Oltre ai volumi in col-lana del gesuita Viktor Cathrein (Il socialismo, 1898), del grande fisico e filo-sofo austriaco Ernst Mach (Letture scientifico-popolari, 1900), di Giuseppe Sergi (Psiche nei fenomeni della vita, 1901) e Baldassare Labanca (Gesù Cri-sto nella letteratura contemporanea straniera e italiana, 1903) e del sociologo statunitense William Isaac Thomas (Sesso e società, 1911), editi da Bocca sono anche i volumi di Lombroso (L’uomo delinquente, 1897) e dello psicologo Guido Villa (La psicologia comparata, 1899), entrambi regalati a Vignoli dai due autori. Accanto all’editore torinese, anche il palermitano Remo Sandron all’inizio del Novecento proponeva alcuni titoli di taglio simile, presenti a Ca-stel Campo, come Saggi di critica del marxismo a cura di Vittorio Racca (1903), La sociologia nel corso di filosofia positiva d’Augusto Comte di Euge-nio Rignano (1904) e Fisiologia comparata del cervello e psicologia compara-ta di Jacques Loeb (1907)37.
Sulla base di questa biblioteca si possono fare alcune considerazioni interes-santi. Vignoli si è avvicinato all’evoluzionismo passando dalle scienze umane, che costituiscono, anche dopo l’incontro con Darwin, l’obiettivo primario delle sue ricerche. I libri da lui posseduti mostrano come la filosofia, la storia delle religioni e la linguistica abbiano avuto un ruolo di primo piano nella sua for-mazione e come il suo evoluzionismo sia stato mediato dalla cultura francese, in quegli anni più vicina al trasformismo di Lamarck e a concetti quali uso e disuso degli organi, che alla teoria di Darwin38. In prevalenza francesi sono sta-ti anche i suoi canali di aggiornamento e studio, con la presenza rilevante delle collane promosse da case editrici parigine come Baillière-Alcan e Reinwald, sensibili a certa produzione “positiva” e artefici di numerose traduzioni di auto-ri emergenti del mondo anglosassone e tedesco come Spencer, Lubbock o Hae-ckel. L’interesse di Vignoli non è rivolto solo alla psicologia comparata ma an-che alla psicofisica e alla fisiologia, oltre che alla geologia e paletnologia, col-tivate in parallelo a ricerche etnografiche e antropologiche sull’umanità primi-tiva. Se non per il valore degli esemplari, la ricchezza di questo fondo librario privato, considerato come un unicum, restituisce quindi un quadro coerente dei suoi studi e di certa produzione di scienze umane ottocentesca e primo nove-
36. Cfr. L’illustrazione nelle collezioni filosofico-scientifiche dei Fratelli Bocca, in «Quaderni uti-
nensi», 1996, n. 15-16, pp. 47-63. 37. Cfr. M.I. Palazzolo, Tra positivismo e attualismo: le edizioni Sandron di Palermo, in M.I. Palazzolo,
I tre occhi dell’editore. Saggi di storia dell’editoria, Roma, Archivio Guido Izzi, 1990, pp. 157-260. 38. Cfr. G. Barsanti, Una lunga pazienza cieca, Torino, Einaudi, 2005; Y. Conry, L’introduction du
darwinisme en France au XIX siècle, Paris, Vrin, 1974.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
E. Canadelli
29
centesca, in un momento decisivo della loro storia. In presenza di poche fonti primarie39, esso ha contribuito a ricostruire le fasi della sua formazione, i suoi percorsi, le sue vicende familiari, i suoi interessi, i legami con i personaggi del-la cultura di quegli anni.
Ibrido di scienze naturali, umane e storiche, la biblioteca di Vignoli, che un tempo si trovava a Milano, si articola intorno a un unico, fondamentale proble-ma, guardato attraverso diverse discipline: l’uomo, la sua storia, le sue origini; un sapere stratificato che trova la sua espressione più alta in Mito e scienza, il volu-me che, come notava Cassirer, nonostante un indirizzo «rigorosamente empiristi-co» e «una gnoseologia puramente positivistica»40, lo rende ancora oggi stimo-lante. I suoi circa 1000 titoli restituiscono la fotografia di una generazione che at-traversa l’Ottocento, passando dalla stagione risorgimentale all’organizzazione dello Stato unitario d’età liberale, dalla filosofia di un Tommaseo o di un Giober-ti all’antropologia di un Lombroso o di un Mantegazza, dalla psicologia di un Cantoni a quella sperimentale di un Ribot. Al di là dell’intrinseco valore docu-mentario, emerge un coté culturale in evoluzione, caratterizzato da contamina-zioni tra discipline diverse, alcune giovani e in ascesa, in un momento in cui la filosofia e la storia virano in una più ampia e stratificata storia della cultura, in una filosofia scientifica che guarda alla biologia evoluzionista e ai nuovi sviluppi delle scienze umane e sociali. Grazie alla biblioteca si accede così al dietro le quinte del percorso intellettuale di un antropologo e psicologo evoluzionista, uno dei pochi della Milano di quegli anni.
39. Le fonti primarie più consistenti sono il suo carteggio conservato al Museo di storia naturale di
Milano, sotto forma di fotocopia e in originale presso la famiglia Cipollini, a Milano, le lettere inviate a Centofanti all’Archivio di Stato di Pisa, per il periodo giovanile, e quelle inviate agli astronomi Schia-parelli e Giovanni Celoria all’archivio storico dell’Osservatorio astronomico di Milano, per la fase della maturità a partire dagli anni novanta.
40. E. Cassirer, La filosofia delle forme simboliche, cit., vol. 2, p. 31; vol. 3, tomo 1, p. 100.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.