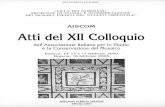In tema di metodo di interpretazione degli atti negoziali e di titolarità dei rapporti di lavoro...
Transcript of In tema di metodo di interpretazione degli atti negoziali e di titolarità dei rapporti di lavoro...
LA NUOVAGIURISPRUDENZA
CIVILECOMMENTATA
MAURIZIO FALSONE
In tema di metodo di interpretazione degli atti negoziali e di titolarità dei rapporti di lavoro
nell’ambito di un gruppo societario
Estratto:
ISSN 1593-7305RIVISTA MENSILEde Le Nuove Leggi Civili Commentate
CASS. CIV., sez. lav., 29.11.2011, n. 25270Conferma App. Torino, 11.7.2007
Contratto - Interpretazione - Crite-ri legali di interpretazione - Priori-tà del criterio letterale - Sussisten-za (cod. civ., artt. 1362-1371) (a)
Lavoro (rapporto) - Gruppo di socie-tà - Assunzione formale in societàcontrollata - Gestione concreta delrapporto in capo alla società capo-gruppo - Fattispecie interpositoria -Sussistenza - Conseguenze - Imputa-zione del rapporto alla società capo-gruppo (cod. civ., art. 2094) (b)
(a) Poiché i canoni legali di ermeneuticacontrattuale sono governati da un princi-pio di gerarchia, il criterio fondato sul si-gnificato letterale delle parole (art. 1362,comma 1o, cod. civ.) prevale non solo suquelli cc.dd. interpretativi-integrativi (artt.1366-1371 cod. civ.) ma anche sugli altricanoni strettamente interpretativi (artt.1362-1365 cod. civ.). Pertanto, quando ilcriterio letterale è sufficiente, l’operazioneermeneutica deve ritenersi conclusa, men-tre in caso contrario il giudice può ricorre-re gradatamente e in via sussidiaria agli al-tri canoni interpretativi (tale principio im-pedisce di ritenere transatta ogni pretesaconnessa all’intero svolgimento del rap-porto di lavoro nel caso in cui l’accordotransattivo intercorso fra lavoratore e da-tore di lavoro effettivo abbia ad oggetto«l’intercorso rapporto di lavoro a contenu-to dirigenziale»).(massima non ufficiale)
(b) Una società capogruppo che gestisceconcretamente il rapporto di lavoro di undipendente formalmente assunto da unasocietà controllata riguardo ad aspetti de-cisivi quali la determinazione della retri-buzione, la posizione previdenziale, gliobiettivi, i risultati della prestazione el’inserimento di quest’ultimo in un’orga-nizzazione produttiva diversa da quelladella società che lo aveva assunto, assu-me la qualità di datore di lavoro in quan-
to effettiva utilizzatrice della prestazione.(massima non ufficiale)
[Massima ufficiale: In presenza di ungruppo di società, la concreta ingerenza del-la società capogruppo nella gestione del rap-porto di lavoro dei dipendenti delle societàdel gruppo, che ecceda il ruolo di direzione ecoordinamento generale alla stessa spettan-te sul complesso delle attività delle societàcontrollate, determina l’assunzione in capoalla società capogruppo della qualità di dato-re di lavoro, in quanto soggetto effettiva-mente utilizzatore della prestazione e titola-re dell’organizzazione produttiva nella qua-le l’attività lavorativa si è inserita con carat-tere di subordinazione.]
dal testo:
Il fatto. Con sentenza in data 7.6/11.7.2007la Corte di appello di Torino, in riforma delladecisione di primo grado, dichiarava sussisterefra B.R., la Fiat Group Automobiles spa (giàFiat Auto spa) e la Fiat partecipazioni spa unrapporto di lavoro subordinato con riferimen-to al periodo 1.8.1982/31.3.1987.
Osservava in sintesi la Corte territoriale che,in tale periodo, la Fiat Auto aveva in concretogestito l’attività lavorativa del B., sia sottol’aspetto organizzativo, che gerarchico ed eco-nomico, ed aveva usufruito delle relative pre-stazioni, assumendo nei confronti dello stessola veste di effettivo datore di lavoro, in luogodella società controllata estera (la Fiat of Au-stralia pty limited) che lo aveva formalmenteassunto. Per la cassazione della sentenza pro-pongono ricorso la Fiat Group Automobilesspa (già Fiat Auto spa) e la Fiat partecipazionispa con due motivi. Resiste con controricorsoB.R. Entrambe le parti hanno depositato me-morie.
I motivi. 1. Con il primo motivo, svolto aisensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, le società ricor-renti lamentano violazione degli artt. 1362 e1363 c.c., osservando che fra le parti era inter-venuto un accordo transattivo (“al fine di pre-venire l’insorgere di ... controversie connesse
Cass., 29.11.2011, n. 25270 Contratto / Lavoro (rapporto)
384 NGCC 2012 - Parte prima
c
all’intercorso rapporto di lavoro a contenutodirigenziale...”) e che una corretta lettura di ta-le testo contrattuale avrebbe dovuto indurre laCorte a considerare che con lo stesso le partiavevano inteso definire ogni pretesa retribuivae risarcitoria connessa all’intera carriera pro-fessionale del dipendente, e non solo al perio-do in cui lo stesso aveva svolto funzioni diri-genziali.
Con il secondo motivo, prospettando viola-zione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazioneagli artt. 2697 e 2094 c.c., e alla L. n. 1369 del1960, art. 1) e vizio di motivazione, osservanoche la corte territoriale aveva ritenuto comesintomatici della sussistenza della fattispecieinterpositoria elementi che, in realtà, nulla pro-vavano in merito all’assoggettamento del lavo-ratore al potere organizzativo e gerarchico del-la Fiat Auto, dal momento che i documentipresi in considerazione attestavano solo l’inte-resse dell’azienda alla prestazione del lavorato-re; interesse connaturale al ruolo di coordina-mento e di direzione strategica svolto dalla FiatAuto nell’ambito della struttura di gruppo e ta-le da rendere del tutto fisiologica “l’ingerenza”della stessa nella vita delle società consociate.
2. Il primo motivo è procedibile, avendo lesocietà ricorrenti provveduto a trascrivere il te-sto dell’atto transattivo contestato e a indicarlonella sua esatta collocazione nell’ambito dei fa-scicoli di causa, così soddisfacendo l’onere im-posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novel-lato dal D.L. n. 40 del 2006, che, oltre a richie-dere l’indicazione degli atti, dei documenti edei contratti o accordi collettivi posti a fonda-mento del ricorso (e, quindi, la descrizionespecifica di tali atti secondo il canone dell’au-tosufficienza del ricorso per cassazione: cfr. ades. Cass. n. 18854/2010), esige, altresì, che siaspecificato in quale sede processuale il docu-mento risulti prodotto; tale prescrizione vacorrelata all’ulteriore requisito di procedibilitàdi cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cuideve ritenersi, in particolare, soddisfatta, qua-lora il documento sia stato prodotto, nella fasedi merito, dallo stesso ricorrente e si trovi nelfascicolo dello stesso, mediante la produzionedel fascicolo, purché nel ricorso si specifichiche il fascicolo è stato prodotto e la sede in cuiil documento è rinvenibile; ovvero, qualora ildocumento sia stato prodotto dalla contropar-
te, mediante indicazione che il documento èprodotto nel fascicolo del giudizio di merito ditale parte (cfr. SU (ord.) n. 7161/2010).
E risulta, altresì, ammissibile, con riferimen-to al tema di indagine relativo al rispetto deicanoni di ermeneutica legale, tenuto conto delcontenuto stresso della sentenza impugnata,che, al fine di escludere la rilevanza dell’attotransattivo, ha dato ingresso ad un profilo di-verso da quello preso in considerazione daigiudici di primo grado, che le società ricorrentihanno in conseguenza censurato.
3. Nel merito, tuttavia, il motivo è infonda-to.
Giova, al riguardo, premettere, in conformi-tà al consolidato indirizzo della giurisprudenzadi legittimità, che l’interpretazione degli attinegoziali implica un accertamento di fatto ri-servato al giudice di merito, che, come tale,può essere denunciato, in sede di legittimità,solo per violazione dei canoni legali di erme-neutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c. in rela-zione all’art. 360 c.p.c., n. 3) ovvero per viziodi motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), fermol’onere del ricorrente di indicare specificamen-te il modo in cui l’interpretazione si discostidai canoni di ermeneutica o la motivazione re-lativa risulti obiettivamente carente o logica-mente contraddittoria, non potendosi, invece,limitare a contrapporre interpretazioni o argo-mentazioni alternative o, comunque, diverse ri-spetto a quelle proposte dal giudice di merito,non potendo il controllo di logicità del giudi-zio di fatto risolversi in una revisione del ragio-namento decisorio, ossia dell’opzione che hacondotto il giudice di merito ad una determi-nata soluzione della questione esaminata.
In tal contesto, poi, i canoni legali di erme-neutica contrattuale sono governati da un prin-cipio di gerarchia, in forza del quale i canonistrettamente interpretativi (artt. 1362 e 1365c.c.) prevalgono su quelli interpretativi - inte-grativi (artt. 1366 e 1371 c.c.) e ne escludono laconcreta operatività, quando l’applicazione de-gli stretti canoni interpretativi risulti, da sola,sufficiente per rendere palese la comune inten-zione delle parti stipulanti.
Nell’ambito, poi, dei canoni strettamente in-terpretativi, risulta prioritario il canone fonda-to sul significato letterale delle parole (art.1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che,
Cass., 29.11.2011, n. 25270 Contratto / Lavoro (rapporto)
NGCC 2012 - Parte prima 385
quando quest’ultimo risulti sufficiente, l’opera-zione ermeneutica deve ritenersi utilmenteconclusa, mentre, in caso contrario, il giudicepuò, in via sussidiaria e gradatamente, ricorre-re agli altri, al fine di identificare, nel caso con-creto, la comune intenzione delle parti con-traenti (v. ex plurimis ad es. Cass. n. 23273/2007; Cass. n. 20660/2005; Cass. n. 7548/2003).
Di tali principi la sentenza impugnata ha fat-to corretta applicazione, avendo individuatonel testuale e ripetuto riferimento all’“intercor-so rapporto di lavoro a contenuto dirigenzia-le”, quale oggetto dell’accordo transattivo,l’impossibilità di ritenere transatta ogni pretesaconnessa all’intero svolgimento del rapporto dilavoro. L’interpretazione cui è pervenuta lacorte territoriale, sulla base del significato let-terale delle parole del testo negoziale, sonocontestate dalle ricorrenti (allegando che lacorte di merito avrebbe “trascurato totalmen-te” nella motivazione il riferimento all’“inter-corso” per focalizzare l’attenzione sulla partesuccessiva della frase che richiama il “contenu-to dirigenziale”) sul presupposto che, in realtà,il riferimento sarebbe al “vissuto lavorativo”complessivo del dipendente (“... comprensivopertanto del periodo anteriore al 1995 in cui ...ha lavorato in categorie sub dirigenziali”), masenza specificare sotto quale aspetto l’utilizza-zione del prioritario criterio dell’interpretazio-ne letterale risulti illogica o contraddittoria oincompatibile con i canoni legali che presiedo-no all’interpretazione dei contratti. Con la con-seguenza che il ricorso, in quanto volto solo aprefigurare una diversa opzione interpretativa,senza sminuire, tuttavia, la adeguatezza logicae normativa di quella adottata dai giudici dimerito, non risulta, pertanto, idoneo a contra-stare l’accertamento da questi ultimi operato.
4. Anche il secondo motivo (sebbene am-missibile, per denunciare le società ricorrentil’adeguatezza degli elementi sintomatici presiin considerazione, e puntualmente descritti,dai giudici di merito ai fini della ricostruzionedella fattispecie interpositoria, e non preclusoda alcuna autonoma statuizione, rimasta privadi impugnazione) è, nel merito, infondato.
5. Ravvisato lo snodo decisivo della causanella individuazione del soggetto destinatariodelle prestazioni, la corte di merito ha accerta-
to, in punto di fatto, che la Fiat Auto, conferitaal B. la posizione di direttore generale del SudEst Asia, aveva richiesto alla Fiat of Australiadi “emettere una lettera” (funzionale al conse-guimento del suo permesso di soggiorno a Sin-gapore), in cui si attestava che sarebbe statoiscritto nei libri paga della Fiat of Australia eche gli sarebbe stato corrisposto da quest’ulti-ma il salario mensile, con successivo addebitoall’ufficio di Sidney della Fiat Auto; che erastata la Fiat Auto a determinare il trattamentoeconomico del B. e a provvedere ai relativi ade-guamenti (al pari di quanto avveniva per i di-pendenti della Fiat Auto distaccati all’estero eche operavano nella stessa area del B.); che erastata la Fiat Auto a determinare gli “obiettivifondamentali della posizione” del dipendente,individuato, in una nota a firma del “valutatoreItalo Matteucci”, con “la posizione e la qualifi-ca di Area manager - Singapore”, “appartenen-te all’Ente Direzione vendite Area Extra Euro-pa”; che la Fiat Auto si era fatta carico puredella sua posizione contributiva, provvedendoal pagamento annuale di 5.000,00 dollari, “daattingere dai fondi di funzionamento”; ed an-cora che la Fiat of Australia sì occupava di trat-tori e macchine agricole, laddove il B. (per co-me risultava dal documento con il quale la FiatAuto fissava gli obiettivi per il 1986) era statoincaricato di “promuovere tutte quelle attivitàche consentano una ripresa delle nostre attivitàin Tailandia, Indonesia, Malesia, Singapore eHong Kong sulla linea Fiat che Lancia”, e,quindi, di promuovere una tipologia merceolo-gica affatto distinta da quella dell’impresa chelo aveva formalmente assunto.
Dal complesso di tali dati di fatto, corretta-mente valutati dai giudici di merito, e, pertan-to, insindacabili in questa sede di legittimità, lacorte piemontese ha dedotto che, in tale perio-do, la Fiat Auto aveva in concreto gestito l’atti-vità lavorativa del B., sia sotto l’aspetto orga-nizzativo, che gerarchico ed economico, edaveva usufruito delle relative prestazioni, assu-mendo nei confronti dello stesso la veste di ef-fettivo datore di lavoro, in luogo della societàcontrollata estera che lo aveva formalmente as-sunto.
Le contrarie valutazioni delle società ricor-renti, fondate essenzialmente sulla considera-zione che “l’interessamento e l’ingerenza della
Cass., 29.11.2011, n. 25270 Contratto / Lavoro (rapporto)
386 NGCC 2012 - Parte prima
Fiat Auto nella vita delle società collegate econsociate” dovevano considerarsi del tutto“fisiologiche”, oltre che coerenti “col ruolo didirezione strategica unitaria rivestito dalla FiatAuto nell’ambito dell’assetto strutturale delgruppo” e non risultavano, pertanto, idonee adevidenziare la sussistenza della fattispecie in-terpositoria, non inficiano la correttezza logicae giuridica del ragionamento della corte terri-toriale.
Ed, al riguardo, merita di essere, innanzi tut-to, ricordato come anche di recente la giuri-sprudenza di questa Suprema Corte abbia ri-badito come costituisca regola generale dell’or-dinamento lavoristico il principio secondo cuiil vero datore di lavoro è quello che effettiva-mente utilizza le prestazioni lavorative, anchese i lavoratori sono stati formalmente assuntida un altro (datore apparente) e prescindendo-si da ogni indagine (che tra l’altro risulterebbeparticolarmente difficoltosa) sull’esistenza diaccordi fraudolenti (fra interponente ed inter-posto) (così SU n. 22910/2006). Regola – giovasoggiungere – che si è correttamente ritenutonon abbia perduto consistenza nemmeno a se-guito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267del 2003, dal momento che le forme di disso-ciazione fra titolarità del rapporto e destinazio-ne effettiva della prestazione ivi previste deb-bono considerarsi come tipologie negoziali ec-cezionali, in deroga al principio che parte dato-riale è solo colui su cui in concreto fa carico ilrischio economico dell’impresa nonché l’orga-nizzazione produttiva nella quale è di fatto in-serito con carattere di subordinazione il lavora-tore, e l’interesse soddisfatto in concreto dalleprestazioni di quest’ultimo, con la conseguen-za che chi utilizza tali prestazioni deve adem-piere tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo de-rivanti dal rapporto di lavoro medesimo (giur.Cit.; v. anche, con riferimento alla disciplinacomunitaria dei licenziamenti, Corte Giust.10.9.2009, causa C-44/08 per l’affermazioneche per la realizzazione dell’“effetto utile” deidiritti collettivi di tipo procedimentale, il grup-po non rileva al fine di escludere la responsabi-lità del “diretto” datore di lavoro).
Se, pertanto, la giurisprudenza conferma larilevanza che, in ambito lavoristico, assume ilconcetto di impresa e di datore di lavoro, indi-viduabile, sulla base di una “concezione reali-
stica”, nel soggetto che effettivamente utilizzala prestazione di lavoro ed è titolare dell’orga-nizzazione produttiva in cui la prestazione stes-sa è destinata ad inserirsi, non vi è dubbio chetale direttiva, con riferimento al fenomeno deigruppi di società, impone una attenta valuta-zione degli indici utilizzabili al fine di distin-guere fra la fisiologia e la patologia del fenome-no delle imprese a struttura complessa.
Ed, infatti, la direzione ed il coordinamentoche compete alla società capogruppo, e chequalifica, ora anche in sede normativa (art.2497 ss. c.c.), il fenomeno dell’integrazione so-cietaria, può evolversi in forme molteplici, chepossono riflettere una ingerenza talmente per-vasiva da annullare l’autonomia organizzativadelle singole società operative (accreditandoun uso puramente strumentale o, in altri termi-ni, puramente “opportunistico” della strutturadi gruppo), ovvero un rilevante, ma fisiologico,livello di integrazione (che può costituire ilpresupposto per una valutazione differenziatache la rilevanza dell’“interesse unitario digruppo” manifesta rispetto all’adempimentodelle obbligazioni che risultano funzionali allarealizzazione di tale interesse).
In questo contesto, e con specifico riferi-mento alle problematiche lavoristiche, del tut-to decisivo appare il riferimento alle forme diutilizzazione del personale dipendente, poten-do l’ingerenza della società dominante nellagestione del rapporto di lavoro spingersi sinoal punto di determinare una utilizzazione deltutto indistinta e promiscua della forza lavoroall’interno del gruppo (accreditando una situa-zione di “confusione contrattuale”, tale da farconstatare, in realtà, l’esistenza di una impresaunitaria, solo apparentemente organizzata informa di gruppo: v. per tutte Cass. n. 6707/2004); ovvero, in presenza di gruppi genuini,ma fortemente integrati, determinare la desti-nazione della prestazione di lavoro al comples-so delle società operative, secondo le note for-me della prestazione cumulativa o alternativa;oppure riguardare solo la determinazione ge-nerale degli obiettivi strategici delle singole so-cietà operative, anche per ciò che riguarda lepolitiche del personale, ma senza alcuna inci-denza sulla concreta gestione del personale esulla destinazione della prestazione alla societàche assume la veste di datore di lavoro. Con ri-
Cass., 29.11.2011, n. 25270 Contratto / Lavoro (rapporto)
NGCC 2012 - Parte prima 387
ferimento a tali molteplici fattispecie, ha avutomodo la giurisprudenza di legittimità di preci-sare (per citare solo alcune esempi, indicatividelle situazioni evidenziate), da un lato, come“il collegamento economico funzionale tra im-prese appartenenti ad un medesimo grupposocietario non è di per sé sufficiente a far rite-nere che gli obblighi inerenti ad un rapporto dilavoro subordinato, intercorso fra una di esseed il lavoratore, debbano estendersi anche al-l’altra, e che, tuttavia, in presenza di una socie-tà capogruppo, formalmente estranea al rap-porto di lavoro, che si comporti come effettivodominus, decidendo il distacco del lavoratorepresso altra società del gruppo e la data del suolicenziamento anche per ragioni organizzative,va ravvisato un fenomeno di illecita interposi-zione di manodopera con la conseguente im-putazione del rapporto di lavoro alla capo-gruppo” (cfr. Cass. n. 19931/2010); ma anche,che “è giuridicamente possibile concepireun’impresa unitaria che alimenta varie attivitàformalmente affidate a soggetti diversi, il chenon comporta sempre la necessità di superarelo schermo della persona giuridica, né di nega-re la pluralità di quei soggetti, ben potendo esi-stere un rapporto di lavoro che veda nella po-sizione del lavoratore un’unica persona e nellaposizione del datore di lavoro più persone,rendendo così solidale l’obbligazione del dato-re di lavoro” (così Cass. n. 4274/2003). Nel ca-so in esame, sulla base degli accertamenti svoltidalla corte di merito, deve ritenersi che l’inte-resse della Fiat Auto “alla destinazione e al ri-sultato dell’attività lavorativa del B.” (così nelricorso) non fosse solo riflesso del ruolo dicoordinamento e di direzione strategica unita-ria dalla stessa rivestito nell’ambito dell’assettostrutturale del gruppo, ma determinasse unaconcreta incidenza nella gestione del rapportodi lavoro del dipendente (per aspetti decisivi equalificanti, quali la determinazione della retri-buzione, la previsione degli obiettivi e la valu-tazione dei risultati della prestazione, la sop-portazione dei costi relativi alla posizione pre-videnziale) e l’inserimento di quest’ultimo (benevidenziato anche dalla tipologia dell’attivitàproduttiva della società controllata, a frontedei ben diversi compiti assegnati al lavoratore)nell’organizzazione produttiva di una impresadiversa da quella che lo aveva formalmente as-
sunto, al pari di altri dipendenti della Fiat Au-to distaccati all’estero e che operavano nellastessa area del B. Così convertendosi l’interessedella Fiat Auto al “risultato dell’attività lavora-tiva del B.” in un interesse, non di mero fatto,ma giuridicamente qualificato e tale da deter-minare l’imputazione del rapporto di lavoro alsoggetto che era stato effettivo destinatario edutilizzatore della prestazione.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato e va, al ri-guardo, formulato il seguente principio di di-ritto:
In presenza di un gruppo di società, la con-creta ingerenza della società capogruppo nellagestione del rapporto di lavoro dei dipendentidelle società del gruppo, che ecceda il ruolo didirezione e coordinamento generale alla stessaspettante sul complesso delle attività delle so-cietà controllate, determina l’assunzione in ca-po alla società capogruppo della qualità di da-tore di lavoro, in quanto soggetto effettivamen-te utilizzatore della prestazione e titolare del-l’organizzazione produttiva nella quale l’attivi-tà lavorativa si è inserita con carattere di subor-dinazione. (Omissis)
[Roselli Presidente – Meliadò Estensore – Finoc-chi Ghersi P.M. (concl. parz. diff.). – Fiat Parteci-pazioni s.p.a. (avv. De Luca Tamajo) – B.R. (avv.Cossu)]
Nota di commento: «In tema di metodo di in-terpretazione degli atti negoziali e di titolaritàdei rapporti di lavoro nell’ambito di un grupposocietario» [,]
I. Il caso
La Corte di Cassazione ha affrontato nuovamenteil caso di un lavoratore, formalmente assunto da unasocietà controllata, il cui rapporto di lavoro è statogestito in concreto dalla società capogruppo che haanche usufruito delle relative prestazioni.
Dopo la promozione ad incarichi dirigenziali, illavoratore ha concluso con la società controllanteun accordo transattivo «al fine di prevenire l’insor-gere di controversie connesse all’intercorso rapportodi lavoro a contenuto dirigenziale».
Il lavoratore ha successivamente adito il giudicecompetente per sentire dichiarare la sussistenza di
[,] Contributo pubblicato in base a referee.
Cass., 29.11.2011, n. 25270 - Commento Contratto / Lavoro (rapporto)
388 NGCC 2012 - Parte prima
un rapporto di lavoro subordinato con la societàcapogruppo, relativamente al periodo in cui ha pre-stato lavoro con qualifiche sub dirigenziali. La do-manda è stata rigettata dal Giudice di primo gradoe successivamente accolta in sede di gravame. Conla sentenza che si annota, la Corte di Cassazione haconfermato la decisione dei Giudici di secondogrado.
I Giudici di legittimità hanno affrontato due temiinteressanti, confermando gli orientamenti preva-lenti della giurisprudenza: 1. le modalità di in-terpretazione degli atti negoziali alla luce deicanoni legali di ermeneutica contrattuale , perprecisare preliminarmente il significato da attribuireall’accordo transattivo stipulato dal lavoratore conla società capogruppo; 2. le condizioni e gli in-dici di sussistenza della fattispecie interposi-toria nell ’ambito dei gruppi societari , per in-dividuare, nel caso di specie, la titolarità effettiva delrapporto di lavoro.
II. Le questioni
1. L’interpretazione degli atti negoziali.Prima di affrontare lo snodo sostanziale della causa,i Giudici della Corte hanno risolto una questione er-meneutica relativa all’accordo transattivo intervenu-to fra il lavoratore e la società capogruppo. Parte da-toriale, infatti, enfatizzando il riferimento testualealla parola «intercorso» attribuita al rapporto di la-voro, sosteneva che una lettura corretta del testocontrattuale avrebbe dovuto indurre a consideraredefinita ogni pretesa retributiva e risarcitoria con-nessa all’intera carriera professionale del dipenden-te, mentre i Giudici d’appello, sottolineando la ne-cessità di dare senso e significato all’espressione suc-cessiva «a contenuto dirigenziale», avevano ascrittola transazione solo al periodo in cui il lavoratore ave-va svolto funzioni dirigenziali.
La Corte di Cassazione ha affrontato e risolto laquestione ribadendo che nell’ordinamento italianovige un principio gerarchico che governa l’impiegodei criteri di ermeneutica contrattuale previsti dalcodice civile vigente. Di conseguenza, i criteri«strettamente interpretativi», cioè quello letterale equelli relativi al testo contrattuale e alle intenzioniespresse dalle parti (artt. 1362-1365 cod. civ.), pre-valgono sui canoni «interpretativi-integrativi» (artt.1366-1371 cod. civ.) e nell’ambito dei criteri stretta-mente interpretativi, il canone letterale prevale suglialtri. Il ragionamento, pacificamente accolto da dot-trina e giurisprudenza, si conclude precisando gli ef-fetti di tale struttura gerarchica: quando il canonegerarchicamente superiore «risulta sufficiente, l’ope-razione ermeneutica deve ritenersi conclusa». Sitratta di una massima enunciata in numerosi altri
precedenti, relativi anche all’interpretazione deicontratti collettivi (v. infra, sub 2).
A tal proposito, può essere necessario precisare ilsistema di impiego dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, perché la formula riportata, ormai tra-latizia, ha il pregio di valere come principio ispirato-re generale, ma, in certi casi, potrebbe indurre aqualche eccesso di rigore e di formalismo.
Come è noto, l’art. 1362, comma 1o, cod. civ.non sancisce l’applicazione del criterio letteraletout court, piuttosto impone che nell’interpretazionedel contratto non ci si limiti al senso letterale delleparole ma si indaghi la comune intenzione delleparti. Dal criterio letterale si può dunque sempreprescindere, non solo quando il testo negoziale siaoscuro o ambiguo ma anche quando ulteriori ele-menti, testuali o extra-testuali, documentano me-glio l’assetto contrattuale effettivamente instauratodalle parti, sovrastando i dati testuali oggetto dicontesa, ancorché questi ultimi risultino formal-mente chiari e lineari.
La formula espressa dalla Corte va letta, dunque,precisando il significato da attribuire al criterio –forse sfuggente – della «sufficienza», richiamato dal-la Corte di Cassazione come condizione di perfezio-namento della procedura di interpretazione, in pre-senza della quale non è ammesso un legittimo utiliz-zo di ulteriori criteri ermeneutici.
Alla luce del significato specifico attribuito all’art.1362, comma 1o, cod. civ., possiamo allora precisareche l’applicazione del canone letterale «è sufficien-te» non tanto quando il testo è chiaro e lineare, co-me potrebbe sembrare prima facie, ma quando ilgiudice di merito che lo ha impiegato risolve la que-stione interpretativa controversa con un’analisicompleta del rapporto contrattuale complessivo euna motivazione esauriente (v. Cass., 5.6.2009, n.13083, infra, sez. III).
Ovviamente, però, la parte che chiede la cassazio-ne di una sentenza su tale punto non deve limitarsi adimostrare che esistono diverse legittime opzioni in-terpretative che il giudice non ha voluto applicare,ma deve provare la violazione dei criteri legali di in-terpretazione e del loro ordine gerarchico oppureindicare un vizio di motivazione, poiché l’interpreta-zione degli atti negoziali implica un accertamento difatto riservato ai giudici del merito.
Pare invece che alla Corte di Cassazione non siastata fornita in sede di ricorso alcuna fondata moti-vazione di censura per cassare la sentenza impugna-ta. Nel caso di specie, infatti, nulla lascia supporreche l’esito dell’interpretazione letterale del Giudiced’appello non corrisponda all’effettiva volontà delleparti, tanto che le parti questionano soltanto sul va-lore da attribuire alle singole parole del testo, senzafare alcun riferimento ad ulteriori dati, anche non
Cass., 29.11.2011, n. 25270 - Commento Contratto / Lavoro (rapporto)
NGCC 2012 - Parte prima 389
testuali, che possano dimostrare una volontà diversadei contraenti.
2. L’interposizione di lavoro e i gruppi so-cietari. Sulla questione relativa alla effettiva titola-rità del rapporto di lavoro oggetto della causa, iGiudici della Corte di Cassazione hanno avuto gio-co facile a riconoscere la fattispecie interpositoria eindividuare nella capogruppo la vera società titolaredel rapporto, grazie ad una serie di dati fattuali elen-cati nella sentenza impugnata e difficilmente contro-vertibili: i Giudici di appello avevano constatato in-fatti che a) in sede di assunzione del lavoratore, lasocietà capogruppo e la società estera controllata sierano impegnati, la prima a rimborsare i costi ancheprevidenziali del rapporto instaurato, la seconda ademettere una lettera che attestava l’iscrizione al pro-prio libro paga al solo fine di permettere al lavorato-re assunto di chiedere e ottenere un regolare per-messo di soggiorno, b) la retribuzione, gli obiettivi, irisultati e i premi di produzione erano gestiti dallasocietà capogruppo, c) il lavoratore era risultato ef-fettivamente inserito nell’organizzazione produttivadi una impresa terza diversa da quella che lo avevaformalmente assunto, d) la società controllata for-malmente titolare del rapporto svolgeva una tipolo-gia di attività produttiva del tutto incompatibile coni compiti assegnati al lavoratore.
In uno scenario del genere non ha avuto fortunala tesi di parte datoriale secondo cui l’ingerenza del-la società capogruppo poteva considerarsi fisiologi-ca e coerente col ruolo di direzione strategica daquesta assunto. Secondo questa impostazione taleingerenza non incideva sul rapporto di lavoro, attra-verso l’esercizio diretto del potere direttivo e di ge-stione, ma sulla società consociata e attestava esclu-sivamente il legittimo interesse per la prestazione dilavoro nel contesto del gruppo. La decisione dellaCorte non va comunque interpretata come una stig-matizzazione – che sarebbe oramai démodé – delgruppo societario come sistema organizzativo del-l’impresa. La questione è più complessa, perché siinnesta nell’ambito di un confronto serrato e ancoraaperto: quello fra il sistema economico-produttivofrutto della c.d. globalizzazione e l’ordinamento giu-ridico che tenta di coglierne le novità per metaboliz-zarle e disciplinarle.
Come è noto, la fattispecie del «gruppo» è decli-nabile in numerose sottospecie, nessuna delle qualirisulta sistematicamente disciplinata dal diritto posi-tivo. Da ciò, ha osservato la Corte nella sentenza chesi commenta, discendono diverse possibili soluzionifinalizzate a reagire ad una illegittima elusione delladisciplina lavoristica. L’imputazione del rapportopuò infatti spettare alla sola società capogruppo, co-me accade più spesso, oppure può competere a due
o più società di un gruppo, rendendo così solidali leobbligazioni del datore di lavoro, perché nulla im-pedisce che parte datoriale sia rappresentata da piùsoggetti di diritto (Razzolini, 263, infra, sez. IV).Se le circostanze di fatto lo permettono, inoltre,sembra possibile accertare in capo ad un solo lavo-ratore, la sussistenza di più rapporti contrattuali in-staurati con più società del gruppo, ad esempio rico-noscendo la concomitanza di due contemporaneirapporti di lavoro a tempo parziale (in quest’ultimosenso Lozito, 447, infra, sez. IV).
In dottrina e in giurisprudenza è tradizionalmenteescluso che il gruppo societario possa rilevare comeunità giuridica, sia relativamente alla titolarità delrapporto di lavoro, sia rispetto al computo dei lavo-ratori funzionale all’applicazione di alcune discipli-ne lavoristiche, e in primis della tutela reale. Taleconclusione non è scalfita dai nuovi espliciti maframmentari riferimenti al gruppo societario fattidal legislatore, ad esempio, con l’art. 2847 cod. civ.nella versione recentemente riformata.
Tuttavia negli ultimi tempi è ravvisabile un’evolu-zione della giurisprudenza rispetto al riconoscimen-to del fenomeno del gruppo societario. Si tratta diuna apertura destinata, forse, ad affermarsi nel tem-po.
In precedenza il gruppo veniva giuridicamente ri-conosciuto come soggetto di diritto, solo nel caso incui si fosse trattato di uno pseudo-gruppo o gruppoapparente; di un gruppo, cioè, le cui società affiliateagiscono in stato di «confusione» patrimoniale e/ocontrattuale e con il proposito di mascherare l’im-presa unica per ragioni elusive e di frode alla legge.Ovviamente tale riconoscimento avveniva difficil-mente perché implicava un onere probatorio diffi-cilmente sostenibile. Più recentemente, invece, la ri-levanza giuridica del gruppo societario come sogget-to unico è riconosciuta anche solo in presenza diuna serie di indici creati dalla giurisprudenza, a pre-scindere da una indagine sulla sua natura patologi-ca; tali indici infatti si addicono anche a gruppi so-cietari «genuini».
I sintomi individuati sono a) l’unicità della strut-tura organizzativa e produttiva, b) l’integrazione frale attività esercitate dalle varie imprese del gruppo el’interesse comune, c) il coordinamento tecnico eamministrativo-finanziario di un soggetto unico cheorienta le singole imprese verso uno scopo comune,d) l’utilizzazione contemporanea – nei diversi modipossibili – della prestazione lavorativa da parte didiverse società del gruppo (v. in questi terminiCass., 15.5.2006, n. 11107, infra, sez. III).
Tuttavia quando tali indici sussistono e provanol’esistenza di una impresa unica, le conseguenze giu-ridiche possono essere solo quelle ipotizzate sopra,in virtù del divieto di interposizione nei rapporti di
Cass., 29.11.2011, n. 25270 - Commento Contratto / Lavoro (rapporto)
390 NGCC 2012 - Parte prima
lavoro che, come è noto, vige ancora nel nostro or-dinamento, nonostante l’abrogazione della l. n.1369/1966. Finché il fenomeno del gruppo societa-rio non sarà apertamente riconosciuto e organica-mente disciplinato dal legislatore, le soluzioni dellagiurisprudenza saranno sempre complesse e soloparzialmente soddisfacenti.
Per una migliore soluzione delle controversie re-lative alla prestazione di lavoro nell’ambito di ungruppo, è necessario compiere qualche ulteriorepassaggio teorico attraverso una complessa opera ri-costruttiva della giurisprudenza e della dottrina, masoprattutto attraverso appositi interventi del legisla-tore, volti a permettere al lento apparato giuridicodi riagganciare il galoppante sistema produttivo-fi-nanziario internazionale. Come è stato lucidamentenotato, ad esempio, bisogna prestare attenzione alfatto che ai fini lavoristici «quel che rileva, non ètanto il concetto di persona giuridica» quanto «piut-tosto il concetto di impresa e di datore di lavoro, in-dividuabile sulla base di una concezione realistica»(così Meliadò, 3332, infra, sez. IV, fra l’altro esten-sore della sentenza in commento, che sembra rinvia-re alla tesi precedentemente formulata da Mazzot-ta, 365, infra, sez. IV). D’altronde, infatti, l’art.2094 cod. civ. su cui si fonda il principio stesso deldivieto di rapporti interpositori, si riferisce al lavora-tore che collabora all’impresa.
Il gruppo societario che smette di essere gruppo diimprese e diventa impresa di gruppo, realizza un as-setto organizzativo difficile da disciplinare, ma nonnecessariamente censurabile sul piano degli interessigenerali dell’ordinamento e dei diritti dei lavoratori;pertanto si rende necessario un trattamento specifi-co ad hoc che la giurisprudenza, come si è detto, staperfezionando lentamente nell’attesa, forse, che so-praggiunga un intervento legislativo organico e rigo-roso.
III. I precedenti
1. L’interpretazione degli atti negoziali.Le decisioni più recenti da cui è tratta la massima diprincipio citata nella sentenza che si annota e di-scussa supra, sono: Cass., 8.11.2007, n. 23273, inNotiz. giur. lav., 2008, 166; Cass., 25.10.2005, n.20660, in Mass. Foro it., 2005; Cass., 15.5.2003, n.7548, ined. a quanto consta. I precedenti sul temariguardano spesso anche l’interpretazione dei con-tratti collettivi.
Si vedano inoltre Cass., 28.8.2007, n. 18180, inGiust. civ., 2008, I, 684, secondo cui, in tema di in-terpretazione del contratto «il primo e principalestrumento è rappresentato dal senso letterale delle pa-role e delle espressioni utilizzate» ma «il rilievo da as-segnare alla formulazione letterale va poi verificato al-
la luce dell’intero contesto contrattuale», nonchéCass., 5.6.2009, n. 13083, in Mass. Foro it., 2009,per la quale «ove il giudice di merito (...) abbia risoltoi dubbi posti dal senso letterale delle parole medianteun’analisi adeguata e compiutamente motivata dellacomune intenzione delle parti come risultante dalcomplesso dell’atto, il processo ermeneutico è confor-me ai canoni legislativi e non presenta vizi di motiva-zione».
2. L’interposizione di lavoro e i gruppi so-cietari. Per quanto riguarda la giurisprudenza piùrigorosa che ammette la rilevanza giuridica delgruppo solo in caso di uso fraudolento della fram-mentazione dell’impresa v., ex plurimis: Cass.,8.2.1989, n. 795, in Giur. it., 1989, I, 1, 1123 e Trib.Milano, 10.12.2008, in Orient. giur. lav., 2008, I,923, in materia di computo dei lavoratori ai fini del-l’applicazione della tutela reale.
La giurisprudenza più recente ha mostrato invecemaggior apertura rispetto al riconoscimento del fe-nomeno del gruppo societario elaborando una seriedi indici sintomatici. A tal proposito si veda Cass.,15.5.2006, n. 11107, in Riv. giur. lav., 2007, II, 440;Cass., 21.9.2010, n. 19931, in Foro it., 2010, I, 3325e in Riv. it. dir. lav., 2011, II, 717; Cass., 24.3.2003,n. 4274, ivi, 2003, II, 740, che riconosce la responsa-bilità solidale di due società relativamente ad ununico rapporto di lavoro.
Il fenomeno dei rapporti interpositori è stato og-getto di una recente sentenza delle sezioni unite:Cass., sez. un., 26.10.2006, n. 22910, in Arg. dir.lav., 2007, 1019, con nota di M.T. Carinci.
Il fenomeno dei gruppi societari è attualmenteoggetto di attenzione anche nell’ambito della giuri-sprudenza europea: v. Corte giust. CE, 10.9.2009,causa C-44/08, in Dir. rel. ind., 2010, 541, con notadi Cosio.
IV. La dottrina
1. L’interpretazione degli atti negoziali.Sui criteri di interpretazione degli atti negoziali se-condo la lettura offerta supra, v., più recentemente,Roppo, Il contratto, nel Trattato Iudica-Zatti, Giuf-frè, 2011, 443. Sul rapporto fra il canone letterale el’intenzione effettiva delle parti v.: Perreca, Breviconsiderazioni sui rapporti fra il criterio letterale di in-terpretazione del contratto e la determinazione della«comune intenzione», in Riv. giur. sarda, 2009, 782.
2. L’interposizione di lavoro e i gruppi so-cietari. Il tema del gruppo societario dal punto divista del diritto commerciale è stato trattato recente-mente da Galgano, Direzione e coordinamento disocietà, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 2005; di Majo, La responsabilità per l’atti-
Cass., 29.11.2011, n. 25270 - Commento Contratto / Lavoro (rapporto)
NGCC 2012 - Parte prima 391
vità di direzione e coordinamento nei gruppi di socie-tà, in Giur. comm., 2009, I, 537 e Tombari, Dirittodei gruppi di imprese, Giuffrè, 2010.
Sotto il profilo prettamente lavoristico, i contribu-ti in materia di gruppi societari sono molto numero-si. Senza pretese di esaustività si rinvia a Carabelli,La responsabilità del datore di lavoro nelle organizza-zioni di impresa complesse, in Dir. rel. ind., 2009, 101;Pinto, I gruppi societari nel sistema giuridico del la-voro, Cacucci, 2005, e Nogler, Gruppo di imprese ediritto del lavoro, in Lav. e dir., 1992, 2, 291. Relati-vamente al tema specifico della contitolarità del rap-porto di lavoro v. Razzolini, Contitolarità del rap-porto di lavoro nel gruppo caratterizzato da «unicità diimpresa», in Dir. lav. e rel. ind., 2009, 263.
Sul rilievo da dare alla nozione di impresa più chea quella di persona giuridica ai fini del diritto del la-voro v. Mazzotta, Divide et impera: diritto del la-voro e gruppi di imprese, in Lav. e dir., 1988, 365 eMeliadò, Imprese a struttura complessa, controllo
dei fenomeni di esternalizzazione ed interpretazionigiurisprudenziali, in Foro it., 2010, I, 3329.
L’eventualità di poter accertare in capo ad un so-lo lavoratore, la sussistenza di più rapporti contrat-tuali instaurati con più società del gruppo è suggeri-ta da Lozito, Presunti gruppi di impresa e lavoratorecondiviso, in Riv. giur. lav., 2007, II, 444.
La posizione della Corte di giustizia dell’UE in ma-teria di gruppi è stata approfondita da Zoli, Licenzia-menti collettivi e gruppi di imprese: la procedura di in-formazione e consultazione nella giurisprudenza dellaCorte di Giustizia, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, 524.
Sul tema dell’interposizione nei rapporti di lavorosi rinvia ai classici Mazzotta, Rapporti interpositorie contratto di lavoro, Giuffrè, 1979 e M.T. Carinci,La fornitura di lavoro altrui: interposizione, coman-do, lavoro temporaneo, lavoro negli appalti, nel Com-mentario Schlesinger, Giuffrè, 2000, spec. 113.
Maurizio Falsone
TRIB. ROMA, 27.10.2011
Danni civili - Violazione dei doverigenitoriali - Lesione di diritto fonda-mentale - Danno non patrimoniale -Prova per presunzioni - Necessità (Cost.,artt. 2, 29, 30; cod. civ., artt. 147, 148, 2043 e 2059)
La sottrazione da parte del genitore natu-rale all’assolvimento degli obblighi e deidiritti nei confronti della prole costituisceun contra ius costituzionale suscettibile dicagionare un danno non patrimoniale ri-sarcibile, purché provato o dedotto trami-te presunzioni.
dal testo:
Il fatto. Con atto di citazione notificato indata 22.11.2006, le sorelle XX e YY hanno ci-tato in giudizio, dinanzi questo Tribunale, ZZ,per sentir dichiarare che il convenuto è padrenaturale delle attrici, e per sentirlo condannarealla corresponsione, in favore delle stesse, di
quanto non versato, fin dalla nascita, per il loromantenimento, nonché di un assegno mensile atitolo di alimenti e mantenimento per ciascunadi esse, oltre al risarcimento del danno non pa-trimoniale subito per essersi il Bl. sottratto aipropri obblighi di natura personale e morale,danno da liquidarsi in via equitativa. (Omissis)
I motivi. I risultati delle prove ematologichedisposte dal G.I. nel corso del giudizio, esple-tate dal Ctu con modalità tecniche adeguate econ appropriate competenze, hanno accertatosenza margini di incertezza la paternità del Bl.nei confronti delle attrici (Omissis).
Venendo alla disamina delle richieste a con-tenuto patrimoniale, le attrici articolano tre di-stinte domande; 1. a seguito della sottrazioneda parte del convenuto agli obblighi su di luiincombenti in qualità di genitore sin dalla loronascita, la condanna del medesimo al pagamen-to di una somma di danaro quale contributoper il mantenimento mai corrisposto, sino al-l’introduzione del presente giudizio; 2. stantelo stato di bisogno e l’assenza di reddito, la con-danna del convenuto alla corresponsione di unassegno di natura alimentare o di mantenimen-
Trib. Roma, 27.10.2011 Danni civili
392 NGCC 2012 - Parte prima
c