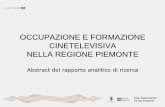Il Piemonte in età moderna. Linee storiografiche e prospettive di ricerca, a cura di P. Bianchi,...
Transcript of Il Piemonte in età moderna. Linee storiografiche e prospettive di ricerca, a cura di P. Bianchi,...
MATERIALI PER LA STORIA DEL PIEMONTE
1
Comitato promotore per l’ISPRE
Istituto per la Storia del Piemonte Regione d’Europa
Comitato promotore per l’ISPRE
Istituto per la Storia del Piemonte Regione d’Europa
Il Piemonte in età modernaLinee storiografiche eprospettive di ricerca
a cura di
PAOLA BIANCHI
Centro Studi PiemontesiCa dë Studi Piemontèis
Centro Studi PiemontesiCa dë Studi Piemontèisvia Ottavio Revel, 1510121 Torino (Italia)tel. (011) 537.486fax (011) 534.777E-mail: [email protected]
© ISPRE 2007
ISBN 978-88-8262-109-4
Comitato promotore per l’ISPREIstituto per la Storia del Piemonte Regione d’EuropaVia Piave, 21Torino
Consiglio Direttivo
GIORGIO LOMBARDIPRESIDENTE
MARCO CARASSI
DARIO DISEGNI
ALBINA MALERBA
GIUSEPPE RICUPERATI
Collegio dei Revisori dei Conti
EUGENIO MARIO BRAJA
FEDERICO DELLA CHIESA
GIUSEPPE FRAGALÀ
Giorgio LombardiPremessa
Paola BianchiPer una nuova storia del Piemonte:tempi e spazi
Saggi
Paola BianchiStoria militare e diplomatica. Il Piemonte nei rapporti congli spazi italiani ed europei
Tomaso Ricardi di NetroStato e amministrazione. Rappresentatività, ordini intermedie burocrazia nel Piemonte d’Antico Regime
Blythe Alice RaviolaTerritori e poteri. Stato e rapporti interstatuali
Andrea MerlottiSocietà e ceti. Le complessità della struttura per ordini nelPiemonte d’Antico Regime
Paolo CozzoStoria religiosa. Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosanel Piemonte di età moderna
Indice dei nomi
Indice
pag. 7
» 15
» 27
» 67
» 91
» 137
» 167
» 217
GIORGIO LOMBARDI
Premessa
Nell’aprire questo volume, mi pare necessario spendere qual-che parola a proposito dell’ISPRE (Istituto per la Storia
del Piemonte, regione europea), istituto di cui esso costituisceinsieme la prima realizzazione e la prima uscita pubblica.
Chi segue la ricerca storica che si svolge nel nostro Paese sache nell’ultimo ventennio la storia degli antichi Stati italiani èstata uno dei filoni più percorsi dagli studiosi. È un po’ comese i grandi dibattiti suscitati negli anni Settanta dalla pubblica-zione della Storia d’Italia Einaudi e dagli Annali della medesimaabbiano spinto gli storici a cercare le risposte ai problemi chequesta sollevava nelle vicende di quegli Stati e signorie territo-riali che per un millennio costituirono il maggior elementoidentitario dalla penisola. Non a caso, un ruolo centrale haavuto la Storia d’Italia UTET, diretta da Giuseppe Galasso, strut-turata proprio in volumi relativi ai singoli Stati. Il volume sulPiemonte, apparso nel 1994 a opera di Giuseppe Ricuperati edi storici formatisi al suo magistero, ha rappresentato in que-sto senso un punto di svolta nella storiografia sullo Stato sa-baudo: esso ha, infatti, consolidato quanto fatto sino ad alloraed ha insieme, se non aperto, almeno suggerito piste che sisono rivelate in seguito feconde. Temi, questi, che ho ritenutoessenziali anche sul versante degli studi giuridici, come hoposto in evidenza nella parte introduttiva della monografia sulPiemonte edita nella collana di studi regionali diretta dal com-pianto presidente Guido Landi 1.
1 Cfr. G. LOMBARDI, La regione Piemonte, Milano, Giuffré, 1986.
Il dibattito storiografico sugli antichi Stati italiani è, peral-tro, coinciso con una fase della storia politica del nostro Paesein cui il valore e la necessità stessa dell’Unità nazionale sonostati posti in discussione. Una crisi dell’identità nazionale cuila parte più consapevole della storiografia italiana ha cercato direagire, evitando di attardarsi su aree di ricerca divenute ormaitanto comode quanto sterili e indagando, invece, con mentalitàe domande nuove, aree spesso da tempo dimenticate. La storiadegli antichi Stati italiani è parsa così un terreno fondamentaleper comprendere l’Italia di oggi, i suoi problemi e le sue debo-lezze così come le sue radici e i suoi punti di forza. In un’im-portante opera apparsa nel 1996, per esempio, Gaetano Grecoe Mario Rosa dichiaravano che tornare a essa era fondamentaleper «affrontare una strada certo difficile, ma non più dilazio-nabile: la ricostruzione della coscienza dell’identità nazionaleitaliana prima della formazione dello Stato unitario» 2.
Nel decennio successivo i problemi posti alla coscienza na-zionale all’inizio degli anni Novanta non hanno certo trovatosoluzione. Nello stesso tempo, l’approssimarsi del 2011, anni-versario dei centocinquanta anni dell’Unità nazionale, pone anoi tutti un’importante occasione di riflessione su temi ormainon più derogabili per un Paese che voglia esser consapevoledelle proprie radici e, quindi, anche forte e sicuro del proprioessere e delle proprie azioni.
Il quadro storico e politico che ho cercato di delineare sinqui è alla base della decisione di dare vita a una nuova storia delPiemonte. Non una semplice opera, sia chiaro, ma un interopercorso di studio che sia in grado, nei prossimi anni, di giun-gere a una sintesi dopo avere realizzato le necessarie ricerche.
Qualcuno potrà forse obiettare che negli anni passati sonogià state scritte storie del Piemonte. Ma esse rispondevano alle
8 giorgio lombardi
2 Storia degli antichi stati italiani, a cura di G. Greco e M. Rosa, Roma-Bari, Laterza,1996, pp. VIII-IX.
premessa 9
domande degli uomini del presente di allora e queste sono di-verse, necessariamente, da quelle degli uomini del nostro pre-sente. La storia, mi sia consentito citare uno dei pensieri piùcelebri di Croce, è sempre storia contemporanea, perché anchequando interroga epoche lontane lo fa con gli occhi del pre-sente, animata dai drammi e dalle esigenze del tempo in cuiviviamo.
In anni così delicati della nostra storia nazionale analizzarela vicenda del Piemonte e dello Stato sabaudo con gli occhialidella contemporaneità è non solo possibile, ma opportuno e,ritengo, necessario. Non una sterile opera di erudizione, maun’opera che parli alla coscienza civile degli italiani.
È da queste riflessioni, sollecitate anche dalle discussionicon un gruppo di giovani e brillanti studiosi alcuni dei qualisono divenuti amici, che è nata in me l’idea di creare un Isti-tuto per la Storia del Piemonte.
La Compagnia di San Paolo, mostrandosi come sempreinterlocutrice attenta e sensibile, ha deciso di accoglierla, ini-ziando con il fondare, nel 2005, un Comitato promotore pertale Istituto. In tale Comitato, che mi onoro di presiedere,sono state coinvolte due istituzioni centrali per la ricerca sto-rica in Piemonte: l’Archivio di Stato di Torino – indispensabilepalestra formativa per chiunque voglia coscientemente prati-care il mestiere dello storico – e il Centro Studi Piemontesi –luogo prezioso per chiunque abbia caro il nome Piemonte eche ha tenuto alta la nostra bandiera in anni in cui era di modastrapparla e gettarla nel fango –. Accanto a tali istituzioni, rap-presentate dai loro direttori, la Compagnia ha chiamato a farparte del Comitato promotore Giuseppe Ricuperati, che haavuto un ruolo centrale nel formare giovani storici, futuro dellamodernistica in Piemonte.
La parola futuro è la parola centrale. Nata dalle esigenzedella nostra contemporaneità, l’azione dell’Istituto dovrà esser
10 giorgio lombardi
svolta per gli italiani di domani, perché anch’essi possano saliresulle nostre spalle, come noi facciamo su quelle di chi ci hapreceduto, e guardare avanti.
Immaginando l’Istituto come un albero, il Comitato pro-motore ne costituisce l’insieme delle radici, stabili perché anti-che, mentre le persone chiamate a studiare, riflettere, scriverene sono i verdi rami, da cui si attendono frutti rigogliosi.
Quando il Comitato promotore ha iniziato a selezionare lepersone cui affidare la realizzazione di un progetto per la sto-ria del Piemonte e le ricerche a essa necessarie non ha avuto nédifficoltà né esitazioni, infatti, a rivolgersi a giovani studiosi,che da anni lavorano su temi legati alla storia dei territorisubalpini. Diversi fra loro hanno compiuto studi importanti,che sono stati accolti con interesse dalla comunità scientifica,la quale ha trovato in essi una visione moderna e innovativadello Stato sabaudo. I loro nomi, che il lettore scorrerà nellepagine che seguono, sono ormai tanto noti e apprezzati da nonrichiedere da parte mia alcuna presentazione.
Il programma di ricerca da loro elaborato è stato articolatoper nuclei tematici e porta ad indicazioni puntuali, se pur nonconclusive. Le riflessioni che seguono mantengono cioè unaforma progettuale, unendo tuttavia elementi e dati che i singoliautori sono in grado di fornire fin da ora allo scopo di realiz-zare una nuova Storia del Piemonte, obiettivo dell’ISPRE. Il volumeva letto, pertanto, nella prospettiva di un lavoro in fieri.
Il Piemonte si configura oggi come uno spazio unitario, cheè però il risultato di un lungo processo evolutivo. Il modoattraverso il quale questo spazio si è andato definendo lo carat-terizza come un ambito in cui le differenze politiche, culturalie sociologiche hanno giocato, nel corso dei secoli, un contri-buto importante. I vari fenomeni di aggregazione sono statiaccompagnati, infatti, da diversi e non lineari processi di iden-tificazione: la dimensione urbana (per la quale si nota unadebolezza istituzionale che fa apparire tendenzialmente reces-
siva la componente che potremmo definire «democratica» erepubblicana dei comuni in paragone con quella feudale, benpiù robusta), quella signorile (che si evolve su quella feudalepiù antica) e infine quella statale (che la conclude), rappresen-tata dapprima dalla compresenza di poteri territorialmentepoco estesi e dispersi (Asti, Ceva, Saluzzo, il Monferrato),riorganizzati in età moderna sotto un governo via via più sta-bile e consolidato. Non bisogna dimenticare che l’egemoniadei Savoia fu estremamente contrastata e di lenta affermazione,visto che ancora nel XIV secolo il primato sabaudo era contesofra Visconti, Angioini, Saluzzo e Paleologhi del Monferrato.
Il discorso politico, che porta lo storico modernista a so-vrapporre il concetto di Piemonte a quello di Stato sabaudo,non senza usare in questo modo semplificazioni poco fondate,non va disgiunto da quello culturale in senso lato. L’idea diPiemonte che si è sviluppata nei secoli, fino a oggi, non è quel-la che nelle diverse epoche storiche ricorreva nelle stanze delpotere, nei vari ambienti sociali, nei disparati ambiti geografici.Politica, società, spazi fisici fortemente antropizzati: questi glielementi da valutare di volta in volta nell’applicare il terminepiemontese a un contesto articolato quale quello oggetto distudio dell’ISPRE. È forse banale ricordare come un novaresestenti ancora oggi a sentirsi un piemontese; eppure Novaraentrò sotto la corona dei Savoia nella prima metà del Sette-cento. Viceversa, terre che parrebbero oggi tradizionalmente eintrinsecamente piemontesi come l’Albese e il Saluzzese furo-no annesse allo Stato sabaudo non prima del XVII secolo. Diquesti aspetti trattano i progetti contenuti nel volume, sugge-rendo percorsi d’indagine volti a incrementare un bagaglio diconoscenze che risulta a tutt’oggi largamente incompleto, a di-spetto di quanto la vulgata faccia apparire.
A proposito di vulgata e di senso storico comune, non pos-so non accennare all’importanza della ripresa di studi scientifi-camente fondati sui temi della storia piemontese. Una storia
premessa 11
che ha patito, non a caso, diverse censure e molti silenzi ingiu-stificati: dalle tendenze di scuola a voler seguire mode storio-grafiche aliene da interessi sabaudo-piemontesi (tendenze, sibadi, mai neutre, tanto meno neutrali) alla rimozione del Pie-monte in quanto terreno di svolte storiche guardate con so-spetto quali il Risorgimento nazionale e successivamente lacontiguità fra monarchia e regime fascista. Perché proiettaresull’età moderna le ombre dei secoli successivi personalizzandola storia di un territorio in quella di una casa regnante, che tral’altro visse, da Carlo Alberto in poi, un vero e proprio cambiodinastico? 3.
Al di là delle valutazioni sugli esiti contemporanei dell’e-sperienza di governo sabauda, quel che preme restituire nelleattività patrocinate dall’ISPRE è un solido impianto di ricerca,dedicato ai secoli XV-XIX, capace di dialogare con la comunitàdegli studiosi italiani e stranieri. Non una nuova Storia del Pie-monte, dunque, che guardi solo ai dibattiti fra gli storici locali,ma un’occasione per ridiscutere il ruolo dei territori subalpini(dei poteri politici, delle strutture sociali, dei climi culturaliche vi si avvicendarono), nel corso dei secoli determinanti del-l’età moderna, nel panorama degli antichi Stati italiani e del-l’Europa. Terra di passi, via di transito fra il continente e lapenisola, il Piemonte ha intessuto, fra Quattro e Ottocento,relazioni importanti con l’area italiana, non solo con quellaeuropea (come più spesso si è portati a pensare sottolineandol’eccezione istituzionale e militare sabauda).
I saggi che seguono giustificano e motivano la scelta di unacronologia ampia, compresa appunto fra XV e XIX secolo,mettendo in discussione cesure tramandate convenzionalmente(dal rientro di Emanuele Filiberto, all’inizio della seconda me-
12 giorgio lombardi
3 Cfr. A. MERLOTTI, I Savoia: una dinastia europea in Italia, in I Savoia. I secoli d’oro di unadinastia europea, a cura di W. Barberis, Torino, Einaudi, 2007, pp. 87-133, in particolarepp. 128-133.
tà del Cinquecento, alla crisi della compagine statale, creata, trafine Settecento e inizio Ottocento, negli anni del governoprovvisorio repubblicano e del regime napoleonico), ma pococonsone per spiegare i processi di continuità e di rottura fratardo Medioevo ed età moderna.
Ne consegue la necessità di uscire da una semplice prospet-tiva di studio interno. Sui singoli temi, individuati dal Comi-tato promotore dell’ISPRE quali nuclei d’indagine principali,vengono compiute l’analisi dello stato dell’arte e una rassegnadei problemi storiografici che restano aperti; ciascun autoreoffre poi una parte propositiva suggerendo elementi e fonti dacui partire per la costruzione della nuova Storia del Piemonte.
I tempi per la realizzazione non possono che essere scanditida fasi preparatorie (raccolta di nuove fonti documentarie, ste-sura di repertori e bibliografie) e da successive fasi di elabora-zione vera e propria. Un Repertorio delle cariche civili e militari (dacostruirsi non solo con un elenco delle cariche e degli organi-grammi dei singoli uffici, ma attraverso un discorso sulle ori-gini e trasformazioni dei vari impieghi, con opportuni con-fronti con casi coevi non piemontesi), un Dizionario biografico deipiemontesi (che si prevede articolato in volumi tematici, nonsemplicemente alfabetici, arricchiti da schede ragionate suiretroterra familiari e sulle relazioni sociali dei singoli perso-naggi) e alcune storie di città sono qui proposti come tappeintermedie, a loro volta non immediate, ma certamente neces-sarie a colmare molte attuali lacune.
Lascio alle pagine seguenti il compito di illustrare al lettorele linee complessive di un piano di lavoro che si costruirà ingran parte in équipe. L’auspicio è che ne nascano scambi e colla-borazioni non solo ravvicinati, ma anche a distanza, forieri dinuovi spunti di studio e, insieme, di rinnovate riflessioni sulruolo della storia locale, regionale e nazionale, che di recentetanto avrebbe bisogno di essere reinterpretata a prescindere da
premessa 13
mode, tendenze, obblighi ideologici condizionati da fattoricontingenti.
Mi sia consentito ora, prima di deporre la penna, spiegare avoi e insieme a me stesso perché ho voluto così fortementeimpegnarmi nel progetto dell’ISPRE.
Innanzitutto per l’amore, che nutro da vecchia data, verso ilmestiere dello storico di professione: un sentimento che mideriva dalla curiosità appassionata per la storia della regione incui vivo e in cui è iniziata la mia formazione. Una formazioneche mi ha portato a operare in ambiti geografici assai più ampirispetto alla dimensione regionale, ma in cui ho sempre volutotrasferire il senso delle mie radici intellettuali e culturali. Unaprima risposta alla domanda formulata sopra potrebbe esseredettata, dunque, da una voce emotiva, che tocca le corde delfattore identitario.
Ma le risposte si giocano, evidentemente, anche su un pianopiù meditato e razionale: sul piano scientifico. E nascono comeeffetto dei miei primi studi dedicati alla definizione di un con-cetto tutt’altro che semplice come quello di Piemonte, intesoin senso non solo geografico, ma politico. Un impegno che hocercato di restituire nella curatela e nella direzione scientificadegli atti di un convegno internazionale che si svolse aMondovì sulla Guerra del sale ed in tanti altri studi che ungiorno spero di riunire e ripubblicare, e nell’indimenticabile,pur se breve, esperienza di responsabile dell’Area istituzioni diquell’importante momento corale costituito dagli Stati generalidel Piemonte, voluti dal Consiglio Regionale.
In conclusione, auguro a me stesso e a voi di poter leggereprossimamente i frutti di indagini capaci di nutrire quell’anticapassione e quella curiositas intellettuale di cui parlavo sopra. Lacollana editoriale inaugurata da questo volume per i tipi delCentro Studi Piemontesi costituisce un primo importante tas-sello, che mi conforta e mi sprona a sostenere l’ideazione el’impostazione della nuova Storia del Piemonte.
14 giorgio lombardi
PAOLA BIANCHI
Per una nuova storia del Piemonte: tempi e spazi
1. I modelli e gli obiettivi
Nodo preliminare che i singoli progetti qui presentati de-vono affrontare è quello di stabilire l’arco temporale
entro cui proporre la realizzazione di una nuova storia delPiemonte.
Ciascuno dei progetti formula riflessioni fondate su ragionimetodologiche proprie, legate al tema specifico. La necessità,tuttavia, di coordinare il discorso in funzione di un’opera che,nella complessità della sua struttura, si presenti in modo coesoe coerente richiede una premessa sui termini della scelta crono-logica.
Occorre precisare che quanto è qui esposto nasce da espe-rienze d’indagini personali, ma si vuole porre anche come oc-casione di discussione e confronto. È infatti inevitabile che unprogetto di lavoro circoscriva il proprio ambito e definisca tem-pi e modi di esecuzione, ma è altrettanto scontato immaginareche, al momento della consegna e strada facendo, lo stesso pro-getto si arricchisca e si articoli, in modo tale da offrire nuovispunti e nuovi parziali elementi di definizione. Ciò giustifical’organizzazione di un prossimo seminario di discussione, stret-tamente legato al progetto ISPRE, in cui saranno presenti espertiin veste di interlocutori.
Queste pagine raccolgono riflessioni che partono dalla for-mulazione delle seguenti domande:
a) Che cosa si deve intendere per storia del Piemonte? Qual è,cioè, l’accezione assegnata a un termine che è oggi comune-mente inteso in senso geografico, ma che è anche portatoredi una stratificazione di significati legati non solo alla storiadella descrizione fisica del territorio, bensì alla sua perce-zione politico-istituzionale?
b) Posto di compiere una scelta in quest’ultimo senso (con unadefinizione dell’ambito disciplinare che sarà giustificata piùsotto dalle varie prospettive), è possibile indicare, se purcon una certa elasticità, le coordinate cronologiche entro lequali operare?
Le risposte a queste domande offrono lo spunto per dotte eampie considerazioni. Ci limiteremo, tuttavia, a formulare lenostre osservazioni nel modo più schematico possibile, inter-pretando questo progetto come un testo da cui ricavare un pia-no operativo, più che non l’occasione per stendere un saggiosecondo i canoni tradizionali. Per questa ragione indicheremoin modo essenziale, in nota, i principali riferimenti bibliografici.
La questione della periodizzazione, oggetto di queste pagi-ne introduttive, potrebbe essere analizzata più ampiamente daisingoli responsabili delle aree tematiche. Si tratterebbe di unapubblicazione preliminare, agile ma densa, volta a rappresen-tare uno strumento propedeutico per le indagini da avviare eun documento sulla filosofia di un nuovo lavoro di ricerca, chesi pone sotto diversi aspetti in dialogo con la storia italiana edeuropea.
È interessante, da questo punto di vista, constatare l’assenzadi riflessioni in questa direzione. Non che all’area subalpinanon siano stati dedicati studi. Si tratta, tuttavia, di indaginiparziali, lontane dalla prospettiva che si è concepita per unastruttura come quella dell’ISPRE, oppure di ricostruzioni com-plessive che usano il concetto di Piemonte per lo più comesinonimo di Ducato sabaudo/Stato sabaudo. È questo il caso
16 paola bianchi16 paola bianchi
del volume Il Piemonte sabaudo (1994) inserito nella collana delleStoria d’Italia diretta da Giuseppe Galasso 1. Il volume si apresenza alcuna premessa che giustifichi non solo l’assunzione deltermine Piemonte nel titolo, ma anche la scelta della periodiz-zazione. Tranne che nelle prime pagine dedicate a un rapidoscorcio sul primo Cinquecento, il volume adotta di fatto lapartizione tradizionale e dinastica: l’età di Emanuele Filiberto,il Seicento, l’età di Vittorio Amedeo II, il Settecento. All’in-terno del volume, poi, la categoria Stato mette in ombra ilconcetto espresso dal sottotitolo, la dialettica cioè tra «Stato eterritori». La parte cinque-secentesca è attenta al rapporto conla rete territoriale dal punto di vista della storia politico-mili-tare o delle principali trasformazioni amministrative avviate dal-la capitale, senza però uno sguardo sulla realtà socio-istituzio-nale preesistente vista nei singoli contesti. Quanto alla sezionededicata al Settecento, essa rispecchia soprattutto l’interesseper un discorso sulle riforme amministrative che progettarono(ma non sempre realizzarono) le trasformazioni decretate dalcentro dello Stato. L’opera costituisce, in altri termini, l’unicomodello abbastanza recente, ma uno strumento privo della com-plessità cui vorrebbe mirare il progetto qui esposto.
Al di là del volume della Utet, esistono, come elementi diconfronto, alcune grandi imprese editoriali, che hanno giusta-mente segnato un’epoca nel modo di fare ricerca storica. Sipensi alla Storia d’Italia della Giulio Einaudi editore. In questoponderoso progetto editoriale non si dedicava al concetto di«Stato territoriale» (quello più vicino all’impostazione che sisuggerisce per un istituto come l’ISPRE) grande attenzione. Ciòera inevitabile per l’impostazione che nel lontano 1972 ave-vano gli studi sul territorio. Là dove l’attenzione era posta ai«quadri ambientali», la prospettiva era più quella della geogra-fia umana che non quella della storia degli antichi Stati e della
per una nuova storia del piemonte: tempi e spazi 17
1 P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, Il Piemonte sabaudo. Stato eterritori in età moderna, Torino, Utet, 1994.
per una nuova storia del piemonte: tempi e spazi 17
loro lenta costruzione sui sedimenti di organizzazioni sociali eamministrative più antiche. Leggere, in questo senso, in paral-lelo il primo volume (I caratteri originali, 1972) della Storia d’ItaliaEinaudi e quello di apertura della collana Utet diretta da Ga-lasso rappresenta un esercizio utile per misurare la mancanzadi un discorso comparativo e complesso sugli spazi sabaudie/o piemontesi 2.
L’Einaudi puntava su volumi tematici dedicati a una storiad’Italia per periodi e per temi (dalla caduta dell’Impero roma-no al XVIII secolo, dal primo Settecento all’Unità, dall’Unitàa oggi, ma anche: dal feudalesimo al capitalismo, scienza e tec-nica, intellettuali e potere, il paesaggio, economia, malattia emedicina, insediamenti e territorio). Erano prevalenti sia il di-scorso socio-economico sia quello culturale in senso lato.Lucio Gambi parlava, in apertura della serie di volumi, non acaso, di «regioni funzionali». La Utet, con la Storia d’Italiadiretta da Galasso, si poneva filologicamente il problema dell’i-talianità. Il lungo saggio che lo stesso Galasso ha premesso aquesta seconda impresa dedicata alle discontinue vicende sto-rico-nazionali era incentrato su una riflessione sul significatodi «italico» / «italiano», partendo dall’antichità greco-romana.
Per ragionare sulle scelte di periodizzazione di una nuovastoria del Piemonte non basta, tuttavia, guardare al panoramaitaliano. Occorre misurarsi anche con le storie d’Europa e conl’attenzione dedicata negli studi stranieri agli spazi piemontesi.Non esiste, tuttavia, una storia d’Europa che tocchi il pro-blema in modo metodologicamente aggiornato e utile per laprospettiva che qui interessa. Esistono, semmai, spunti neilavori di singoli autori, su cui si tornerà più avanti nelle partitematiche che ciascuno di noi ha steso. Prima di motivare lescelte della periodizzazione è bene, in ogni caso, far cenno a
18 paola bianchi
2 Storia d’Italia, vol. I, I caratteri originali, Torino, Einaudi, 1972; G. GALASSO, L’Italiacome problema storiografico, Introduzione alla Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, Torino, Utet,1979.
due opere recenti, da cui è possibile ricavare confronti di pro-spettive.
La prima è L’Europa delle città 3 di Marino Berengo, un libroche ha avuto il merito di riportare all’attenzione di un editorecome Einaudi un lavoro di storia ponderoso e specialistico,fondato su una periodizzazione lunga (Medioevo - età con-temporanea), che poco, in realtà, risponde al discorso sul Pie-monte quale nucleo territoriale e politico. Privilegiando il rap-porto fra città dominanti e suddite, muovendosi cioè nellaricostruzione delle vicende da una prospettiva in cui il pesodello Stato resta in secondo piano, Berengo considera Torinoun’autentica città capitale, rimasta ai margini della grande fio-ritura urbana italiana. Su questo aspetto vorremmo riaprire ladiscussione.
La seconda opera recente su cui vale la pena riflettere consi-ste in un progetto editoriale in corso, in più volumi, per i tipidella casa editrice Laterza4. I volumi, usciti fra 1999 e 2004,rispettivamente su Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia,
per una nuova storia del piemonte: tempi e spazi 19
3 M. BERENGO, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Etàmoderna, Torino, Einaudi, 1999.
4 Storia dell’Abruzzo, a cura di C. Felice, A. Pepe e L. Ponziani, 1. Dalla Preistoriaall’Alto Impero romano, 2. Dal Tardo Impero romano al 1350, 3. Dal 1350 al 1650, 4. Dal 1650al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; Storia dell’Emilia Romagna, a cura di M.Montanari, M. Ridolfi e R. Zangheri, 1. Dalla Preistoria all’Alto Impero romano, 2. Dal TardoImpero romano al 1350, 3. Dal 1350 al 1650, 4. Dal 1650 al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; Storia della Puglia, a cura di A. Massafra e B. Salvemini, 1. DallaPreistoria all’Alto Impero romano, 2. Dal Tardo Impero romano al 1350, 3. Dal 1350 al 1650, 4.Dal 1650 al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999; Storia della Sicilia, a cura di F.Benigno e G. Giarrizzo, 1. Dalla Preistoria all’Alto Impero romano, 2. Dal Tardo Impero romanoal 1350, 3. Dal 1350 al 1650, 4. Dal 1650 al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza,1999; Storia del Molise, a cura di G. Massullo, 1. Dalla Preistoria all’Alto Impero romano, 2. DalTardo Impero romano al 1350, 3. Dal 1350 al 1650, 4. Dal 1650 al 1900, 5. Il Novecento,Roma-Bari, Laterza, 2000; Storia del Veneto, a cura di C. Fumian e A. Ventura, 1. DallaPreistoria all’Alto Impero romano, 2. Dal Tardo Impero romano al 1350, 3. Dal 1350 al 1650, 4.Dal 1650 al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2000; Storia della Calabria, a cura diP. Bevilacqua, 1. Dalla Preistoria all’Alto Impero romano, 2. Dal Tardo Impero romano al 1350, 3.Dal 1350 al 1650, 4. Dal 1650 al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2001; Storiadella Lombardia, a cura di L. Antonielli e G. Chittolini, 1. Dalla Preistoria all’Alto Imperoromano, 2. Dal Tardo Impero romano al 1350, 3. Dal 1350 al 1650, 4. Dal 1650 al 1900, 5.
Molise, Veneto, Calabria, Lombardia, Toscana, Sardegna, sonoospitati (con gli stessi contenuti, presentati solo in forma gra-fica differente) in due collane di destinazione diversa: Storia eSocietà (che ospita la saggistica) e Collezione scolastica - Stati regionali(che accoglie testi didattici). Si tratta di un tentativo di rico-struzione della storia della Penisola in chiave di alta divulga-zione, che piega la storia delle varie realtà italiane alla geografiadelle regioni attuali. L’operazione rivela inevitabilmente alcunesfasature: per esempio la non coincidenza fra il concetto diLombardia e l’estensione dell’ex Ducato di Milano, oppurequella fra Toscana e Stati in essa compresi sino al periodo del-l’unificazione italiana, e così via. Non è forse casuale che tra ivolumi in programma nella stessa collana non compaia ancorail Piemonte, regione storicamente non facile da restituire nellesue intricate vicende di terra a un tempo stanziale e di confine.La soluzione cronologica adottata nei volumi Laterza riper-corre dall’antichità le vicende storiche di aree ritagliate conl’occhio alla geografia politica attuale. Più attinente era stata lacollana avviata a fine anni Settanta da Einaudi, Storia delle regioniitaliane dall’unità a oggi, il cui primo volume, a cura di ValerioCastronovo (1977), trattava del Piemonte appunto dal 1861al 19005.
2. I complessi significati storico-politici del concetto di Piemonte
L’obiettivo al quale auspichiamo l’ISPRE punti è, invece,quello di evitare di restituire la storia dell’attuale Piemonte at-
20 paola bianchi
Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2001; Storia della Toscana, a cura di E. Fasano Guarini, G.Petralia e P. Pezzino, 1. Dalla Preistoria all’Alto Impero romano, 2. Dal Tardo Impero romano al1350, 3. Dal 1350 al 1700, 4. Dal 1700 al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza,2001; Storia della Sardegna, a cura di M. Brigaglia, A. Mastino e G.G. Ortu, 1. DallaPreistoria all’età bizantina, 2. Dal Tardo Impero romano al 1350, 3. Dal 1350 al 1700, 4. Dal1700 al 1900, 5. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2002.
5 V. CASTRONOVO, Il Piemonte, Torino, Einaudi, 1977.
per una nuova storia del piemonte: tempi e spazi 21
traverso tracce sparse, dagli albori della presenza umana in areasubalpina a oggi. Il lavoro che proponiamo è quello di un’ana-lisi storica delle accezioni del termine Piemonte, privilegiandoil campo semantico politico. Il tema è tutt’altro che sempliceda esporre. Ci si limiterà qui a offrire alcune prime coordinate,che confortano nel proporre una periodizzazione relativamentelunga, che ha ragion d’essere anche come punto d’incontro deisingoli approcci tematici oggetto di questo progetto.
La periodizzazione che proponiamo è compresa fra la metàcirca del XV secolo e l’unificazione d’Italia. La scelta di questitermini a quo e ad quem deriva dall’esperienza di studio che ab-biamo maturato nell’occuparci da tempo di storia degli spazisubalpini. La scelta mira cioè sostanzialmente da un lato a su-perare (per il Quattrocento) la mancanza o la scarsità di studiche sarebbero importanti per una corretta impostazione dimolte ricerche dedicate alla storia moderna, dall’altro lato avincere l’imbarazzo (o la non volontà) di spingersi oltre ilcosiddetto triennio giacobino per analizzare gli sviluppi e/o letrasformazioni dell’Antico Regime. Un nodo, quest’ultimo, dirilevante significato e di non gratuita attualità. Le polemiche incorso sul significato da attribuire alla storia piemontese neidestini del Risorgimento nazionale vanno infatti ben al di làdelle diatribe accademiche e specialistiche. Affrontare temi chespesso disinvoltamente, e con scarsa serietà, riempiono le pa-gine dei giornali o le pubblicazioni di larga divulgazione costi-tuisce, in tal senso, anche una risposta doverosa all’impegnoprofessionale.
Consapevoli del fatto che dietro la nozione di Piemonte visia stata per secoli una realtà politico-istituzionale composita,un insieme eterogeneo di territori riuniti da una politica diespansione continuamente oscillante, ci pare di individuare nelQuattrocento l’avvio di un processo di aggregazione che, sepur non lineare, superò autonomie e particolarismi precedenti,segnando la svolta verso quella che gli anglosassoni (riferendosi
in generale alla storia europea del 1450-1750 ca.) chiamanoearly modern age.
Gli studi di Alessandro Barbero 6 e Guido Castelnuovo 7,compiuti tanto sul versante francese quanto su quello italianodei domini sabaudi, confortano in tal senso. In area subalpinail Quattrocento fu, scrive Barbero, un secolo di aggregazione di«patrie», in particolare nel principato d’Acaia a partire dal1418.
Lo stesso secolo assistette, in centri esterni agli spazi pie-montesi, ma con un futuro riflesso anche sull’immagine delPiemonte, al fiorire di una cultura cartografica e corograficadestinata a ridefinire la rappresentazione delle singole aree ter-ritoriali italiane. Il superamento della prima cultura umanisticain età rinascimentale aveva contribuito al maturare delle «de-scrizioni d’Italia», in cui è interessante notare ora l’assenza del«Piemonte» ora una sua identificazione circoscritta. Si pren-dano due autori: per Flavio Biondo (1392-1463) il Piemonteiniziava al confine occidentale del Monferrato, posto lungo lealture presso Moncalieri, e terminava sulle rive della Dora Ri-paria, da dove partiva il Canavese. Leandro Alberti (1479-1553 ca.), autore di una Descrittione d’Italia (ripubblicata in edi-zione anastatica con introduzione critica nel 2003), che avevapur preso a modello Biondo, non parlava di Piemonte, ma delterritorio «piè da monti» compreso fra Torino e le Alpi.
La citazione degli esempi potrebbe continuare con figurecome il noto cartografo Giacomo Gastaldi, nato a Villafranca
22 paola bianchi
6 A. BARBERO, Un’oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento,Roma, Viella, 1995; ID., Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano,Roma-Bari, Laterza, 2002; ID., Da signoria rurale a feudo: i possessi degli Avogadro fra il distrettodel comune di Vercelli, la signoria viscontea e lo stato sabaudo, in Poteri signorili e feudali nelle campagnedell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio, atti delconvegno di studi (Milano, 11-12 aprile 2003) a cura di F. Cengarle, G. Chittolini eG.M. Varanini, «Reti Medievali», V, 2004, 1, on-line nel sito: <http://www.dssg.unifi.it/_rm/rivista/atti/poteri.htm>.
7 G. CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo,Milano, Angeli, 1994; ID., Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà ’200 - fine ’400), inPoteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento cit.
Piemonte, nell’odierna provincia di Torino, ma attivo a Vene-zia, dove morì nel 1566 8. Per l’edizione italiana di Tolomeo,Gastaldi preparò una tavola, intitolata Piamonte, Contea de Ceva,Astesana, Marcha de Incisa, Monferrà, Campagna de la Fraschea, Valdosta,Biblascho, in cui era evidente lo scarto fra rappresentazione diuna regione e realtà politico-amministrativa. Il Marchesato diMonferrato illustrato da Gastaldi e da altri geografi di metàCinquecento restava, per esempio, fortemente condizionato dauna prospettiva umanistica priva di rispondenza alla mutevoleconfigurazione geopolitica. Era, in sostanza, un Monferratonon storico né geografico, bensì letterario, nel quale trovavanoposto anche Moncalieri e Chieri; immagine, tuttavia, che finivaper non risultare sgradita alla dinastia sabauda nel momento incui aveva necessità di inglobare idealmente il piccolo Stato neisuoi possedimenti.
Il tema della coincidenza o meno degli Stati territoriali conla percezione fisico-geografica che veniva trasmessa dai variautori (scrittori, cartografi, trattatisti etc.) è strettamente lega-to a uno dei progetti che seguono (Raviola), ma interessa an-che gli altri. Va precisato che, in relazione all’area subalpina, glistudi compiuti a oggi su questi aspetti sono stati realizzatipressoché esclusivamente da geografi, ma richiederebbero l’in-crocio con la prospettiva offerta da storici del territorio attentinon tanto al fenomeno tecnico-culturale dell’esercizio carto-grafico quanto ai soggetti politici e sociali che producevanocarte e descrizioni.
3. Le ragioni di una periodizzazione ampia (metà XV secolo-1861)
Assumere nei progetti patrocinati dall’ISPRE una periodiz-zazione ampia, dal Quattro all’Ottocento, consente perciò diaffrontare su un piano interdisciplinare i seguenti aspetti:
per una nuova storia del piemonte: tempi e spazi 23
8 Cfr. la voce di D. BUSOLINI, in Dizionario biografico degli italiani, vol. LII, Roma,Istituto dell’Enciclopedia Italiana (Treccani), 1999, pp. 529-532.
a) il problema della genesi dello Stato alla luce di una riletturadel paradigma centro/periferia proposta nell’ultimo decen-nio9, tenendo presente che il ruolo di Torino come capitaleprese forma già nella seconda metà del Quattrocento 10 eche, d’altro canto, nel XV secolo altri centri (Casale, Saluz-zo, ma anche Asti e Mondovì) vissero una stagione di gran-de sviluppo cortigiano e/o urbano;
b) la produzione corografica legata, fra Quattro e Cinquecen-to11, alla cultura di corte e sviluppata da una fase impor-tante come quella secentesca12,
c) il periodo compreso fra Sette e Ottocento, in cui si conso-lidarono veri e propri organi istituzionali e professionalipreposti alla descrizione fisica e politica degli spazi e allarealizzazione di opere ad alto valore tecnico.
Le indagini condotte da alcuni degli autori del presenteprogetto hanno già messo in luce interessanti testi, che segna-rono il superamento della tradizione cronachistica medievaleche era stata diffusa sia alla corte dei Savoia sia presso gliAleramici a Saluzzo e i Paleologhi in Monferrato 13. Nel Cin-
24 paola bianchi
9 Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura diG. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1994; G.G. ORTU, Lo Statomoderno. Profili storici, Roma-Bari, Laterza, 2001.
10 Si veda quanto scrive Alessandro Barbero in Storia di Torino, II, Il basso Medioevo e laprima età moderna (1280-1536), a cura di R. Comba, Torino, Einaudi, 1997.
11 Più di uno Stato territoriale occupava allora gli spazi subalpini restando al mar-gine della grande cultura geografica italiana ed europea.
12 Si trattava di un secolo ancora fortemente intriso di cultura cosmografica, non acaso presente nei piani di studio delle élites, ma culminato anche nell’impresa del Thea-trum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis, opera che rappresentò non solo un’occasione diriformulazione delle conoscenze sul territorio, bensì un momento di confronto politicofra la capitale dello Stato sabaudo e i vari centri che ebbero il compito di eseguire gliordini ducali.
13 P. COZZO, Antichi soldati per nuove battaglie. Guglielmo Baldesano e la riscoperta del culto tebeonelle «valli infette », «Bollettino della Società di Studi valdesi», CXVIII (2001), pp. 1-23;ID., Fra militanza cattolica e propaganda dinastica. La storiografia di Guglielmo Baldessano (1543-1611) nel Piemonte sabaudo, in «Nunc alia tempora, alii mores». Storici e storia in età post-tridentina,
quecento l’occupazione francese dei territori subalpini, l’annes-sione alla Francia del Marchesato di Saluzzo e il passaggio delMonferrato ai Gonzaga avevano interrotto tali tradizioni, favo-rendo una nuova sensibilità per la descrizione degli spazi delpotere. In questa luce si possono leggere le opere di autori, piùo meno noti, come il gesuita carmagnolese Guglielmo Bal-desano o Baldessano (1543-1611), il francescano braidensePaolo Brizio (1597-1665), i savoiardi Emanuele FilibertoPingone (1525-1582) e Pierre Monod (1586-1644), il fossa-nese Emanuele Tesauro (1592-1675), il saluzzese FrancescoAgostino Della Chiesa (1593-1662), il milanese Valeriano Ca-stiglione (1593-1663). Tutti esprimevano le istanze di una sto-riografia di corte che si caratterizzava, anche attraverso lo stru-mento corografico, come ricerca delle ragioni dell’azione poli-tica sul territorio da parte della dinastia regnante. Un di-scorso a sé meriterebbe la figura, più conosciuta, di GiovanniBotero. Nell’edizione del 1601 delle Relazioni universali, trat-tando dell’Italia, Botero descriveva il Piemonte indicando con-fini geografici precisi («Il Piemonte ... si stende dalla Sesia sinal Delfinato, tra l’Appennino e l’Alpi») e aggiornando sulpiano politico l’immagine del territorio. L’autore vi compren-deva infatti ormai anche il Marchesato di Saluzzo («stato atempi nostri unito al Piemonte, e a gli altri Stati suoi da Carlo
per una nuova storia del piemonte: tempi e spazi 25
atti del convegno Torino, 24-27 settembre 2003, Firenze, Olschki, 2006; ID., Chiesa trastoriografia dinastica e patrizia, in Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea, a cura di A.Merlotti, Torino, Zamorani, 2003, pp. 19-56; A. MERLOTTI, Dall’integrazione all’emargina-zione. La nobiltà di Saluzzo e lo Stato sabaudo nel XVII secolo, in L’annessione sabauda del Marchesatodi Saluzzo. Tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica (sec. XVI-XVIII), a cura di M. Fratini,Torino, Claudiana, 2004, pp. 87-116; B.A. RAVIOLA, Le immagini di un territorio. Descri-zioni del Monferrato in età moderna, in Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini inun piccolo Stato italiano tra Medioevo e Ottocento, a cura di B.A. Raviola, atti del convegnoAcqui Terme - Nizza Monferrato - Casale Monferrato (11-13 marzo 2004), Milano,Angeli, 2007, pp. 19-44; P. BIANCHI, «Descrizioni», « corone», « teatri» degli Stati sabaudi. Larappresentazione del territorio ad usum regni (sec. XVI-XVII), in L’Italia dell’Inquisitore. Storia egeografia dell’Italia del Cinquecento nella Descrittione di Leandro Alberti, a cura di M. Donattini,atti del convegno internazionale di studi, Bologna, 27-29 maggio 2004, Bologna,Bononia University Press, 2007, pp. 507-529.
Emanuele duca invittissimo di Savoia»). Il termine Piemonteassumeva così il significato di «tutto ciò che soggiace a’ duchidi Savoia».
Esigenze dinastiche e istanze legate all’appartenenza a unordine o a un istituto religioso 14, cultura municipale e con-fronto fra élites e aree territoriali in ascesa o in declino l’una ri-spetto all’altra: tutti questi nodi si intersecano, toccando tra-sversalmente i nuclei tematici di questo progetto.
In modo coerente rispetto alla scelta cronologica che si èformulata, ciascuno di noi individuerà, nelle pagine che seguo-no, percorsi d’indagine autonomi, non privi di continui reci-proci rimandi. La struttura dei vari contributi mantiene, così,un carattere prevalentemente critico e propositivo, dunque ine-vitabilmente frammentario. La speranza è, tuttavia, quella diessere riusciti, nel complesso, a porre alcuni elementi prelimi-nari sufficientemente fondati e motivati.
26 paola bianchi
14 Va detto che il concetto di provincia usato da alcuni degli autori citati sopra eraespresso in riferimento alla presenza inquisitoriale o degli ordini regolari.
PAOLA BIANCHI
Storia militare e diplomatica.Il Piemonte nei rapporti con gli spazi italianied europei
1. Lo stato dell’arte
Trattare di storia militare e diplomatica del Piemonte in etàmoderna vuol dire impostare i propri studi ben diversa-
mente da quanto accadeva fra Otto e primo Novecento per legrandi scuole storiche nazionali. In questo piano di ricerca sidà per scontato di far cenno allo stato dell’arte delineatosi ne-gli ultimi decenni, senza che si tocchino questioni storiografi-che più antiche 1. Ci sarebbe tuttavia da discutere sul fatto che,in relazione a diversi aspetti e a diverse fasi storiche, autori co-me quelli ottocenteschi e primo novecenteschi continuino a co-stituire l’unica fonte di informazioni. Di qui, appunto, la ne-cessità di ragionare sull’area tematica militare-diplomatica invista di una nuova storia del Piemonte che, sulla base di quantomotivato nella premessa, privilegi un arco temporale compresofra la metà del XV e la metà circa del XIX secolo.
Anche in un Paese come l’Italia, che, per lo meno dal secon-do dopoguerra agli anni Settanta, è stato riluttante verso talitemi, il settore storico-militare, più che quello storico-diplo-matico, ha riconquistato lentamente spazi di ricerca già occu-pati pressoché esclusivamente dai contemporaneisti 2.
1 Sulle opere e gli autori (Pinelli, Ricotti, Brancaccio) che hanno costituito le fontiprevalenti per gli studiosi fino alla prima metà del Novecento, ma che non possonoessere considerati oggi come modelli di metodo, mi permetto di rinviare a P. BIANCHI,Esercito e riforme militari negli Stati sabaudi del Settecento. Un bilancio storiografico, «Società italianadi storia militare», Quaderno 1995 (ma 1997), pp. 7-38.
2 Cfr. Guida alla storia militare italiana, a cura di P. Del Negro, Napoli, Edizioni scien-
Offuscatasi l’immagine del Risorgimento, censurata quelladelle imprese coloniali, fino a pochi decenni fa sopravviveval’interesse per vicende relativamente vicine come quelle dellaGrande guerra e del secondo conflitto mondiale. Non a caso,nei convegni e nelle operazioni editoriali di un certo rilievo de-dicati alla storia militare, comparivano pochi noti storici ita-liani novecentisti, di contro al silenzio quasi totale da parte deimodernisti. Differente la posizione di antichisti e medievisti,per i quali l’aura letteraria ed estetica del tema della guerra haavuto buon gioco nel non recidere bruscamente l’interesse sto-rico.
Al di là dei bilanci sui singoli settori disciplinari, che porte-rebbero lontano dalla traccia di questo progetto, va ricordatoche il panorama storiografico italiano ha iniziato da non più diuna trentina d’anni a manifestare attenzione, se pur con moltecautele, verso le prospettive d’indagine suggerite da alcune scuo-le straniere. In area anglosassone, in Francia, negli Stati tede-schi il rapporto degli storici modernisti con lo studio delleguerre, dei contesti in cui si svolsero e dei loro attori è datempo vissuto in modo molto meno conflittuale. A partiredalla seconda metà del Novecento in quei Paesi è stato anzirivalutato il punto di vista militare per cogliere nodi essenzialinella ricostruzione della storia istituzionale, sociale e culturale.Basti citare i nomi di Corvisier, Parker, Howard, McNeill,Tallet, Gooch e, più di recente, Anderson, Lynn, Parrott, stu-diosi che hanno pubblicato i loro studi fra gli anni Settanta egli anni Novanta con l’impegno dichiarato, al di là dei singolioggetti di ricerca, di rivisitare metodi e oggetti tradizionalmen-te ascritti alla storia militare europea; a tal fine sono state co-niate categorie come «war and society studies», «armées etsociétés», «histoire des militaires», che hanno più o meno po-lemicamente superato la vecchia visuale dell’«histoire bataille».
28 paola bianchi
tifiche italiane, 1997; D. MAFFI, Militari e società civile nell’Europa dell’età moderna (XVI-XVIII secolo). Fatti, documenti, interpretazioni, dattiloscritto distribuito in occasione del attidel convegno internazionale Trento, 13-17 settembre 2004.
Cercando di recuperare la distanza di prospettive rispetto agliinglesi e ai francesi, anche alcuni storici italiani, nel corso degliultimi anni, hanno avviato iniziative nel campo della moderni-stica senza escludere il dialogo con gli studiosi di storia con-temporanea. Ne è testimone un’organizzazione come il Centrointeruniversitario di studi e ricerche storico-militari, nato conl’intento di unire le università di Milano, Padova, Pavia, Pisa eTorino tentando non semplici scambi di ricerca con l’UfficioStorico dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Alcune frale principali riviste storiche nazionali e alcuni dei più presti-giosi centri di studio italiani, originariamente lontani da temidel genere, si sono poi aperti a numeri monografici e a conve-gni dedicati, fra gli altri, ai rapporti fra guerra e pace, alla cre-scita e alla trasformazione dell’organizzazione bellica, ai con-tatti fra militari e società civile nell’Europa dell’età moderna.Penso a riviste come «Studi settecenteschi» o «Ludica» (rivi-ste nate da retroterra storiografici tutt’altro che militareschi),oppure a istituti quali la Fondazione Cini di Venezia el’Istituto storico italo-germanico di Trento. Mi riferisco inoltrealla rivista «Guerra e pace. War and peace. Guerra y pez. Guer-re et paix. Economia, società e istituzioni nel mondo moder-no», patrocinata dal Dipartimento di studi storici, sociali efilosofici dell’Università di Siena sotto la direzione di EnricoStumpo, il cui primo numero è in corso di realizzazione e nelcui comitato scientifico sono lieta di far parte accanto a stu-diosi italiani e stranieri. Nelle iniziative storico-militari recentipromosse in tali sedi era ed è evidente lo sforzo di insistere sulbisogno della comparazione e sullo scambio fra prospettive distudio in Italia e all’estero3.
storia militare e diplomatica 29
3 Sulla storiografia militare dedicata agli antichi Stati italiani è utile l’intervento diDavide Maffi presentato nel seminario che si è svolto a Madrid il 22-24 giugno2006: D. MAFFI, Ejército y sociedad civil en la Europa de la edad moderna. Nuevas perspectivas histo-riográficas, in La nación irlandesa en el Ejército y sociedad hispana (siglos XVI-XVIII), in corso distampa.
L’aspetto interessante e problematico a un tempo, dal puntodi vista della ricerca, nell’affrontare lo studio degli spazi ita-liani e dei territori piemontesi all’interno di essi è la lungacompresenza, durante i secoli dell’età moderna, di Stati territo-riali con caratteristiche proprie. Si trattava tuttavia di aree nonprive di contatti creati per ragioni diverse, non ultime quelle ditipo dinastico, diplomatico, familiare, militare. È evidente co-me questo discorso rappresenti un filo rosso per tutte le inizia-tive suggerite da questo progetto di ricerca.
Scrivere una storia militare dei territori italiani in età mo-derna significa ricomporre le tessere di un mosaico, per com-pletare il quale è prima di tutto necessario liberarsi dell’otticanazionale presente in gran parte della storiografia otto-nove-centesca, che tentava di leggere le vicende degli eserciti del pas-sato accentuando aspetti di coesione e omogeneità lontani dal-la realtà d’Antico Regime. Tornerò su questo punto più avanti,suggerendo, in relazione all’area piemontese, quelle che restanoquestioni ancora aperte e da privilegiarsi in una ricostruzionecomplessa della storia territoriale.
Qui mi preme sottolineare come uno degli sforzi maggioriper lo storico dell’età moderna che si occupi di studio del ter-ritorio in tutte le sue implicazioni (politiche, sociali, economi-che, culturali) sia proprio quello di comprendere una categoriastoriografica non nuova – ma tuttora utilissima – quale il con-cetto di «Stato composito» 4. Nato in riferimento all’eteroge-neo quadro amministrativo dell’Impero asburgico e della mo-narchia spagnola degli Austrias, tale concetto può essere appli-cato, e anzi assunto come corretto punto di partenza, anchenella ricostruzione della storia dei domini sabaudi.
Accolta la scelta di una periodizzazione compresa fra metàQuattrocento e metà Ottocento, una storia militare e diploma-
30 paola bianchi
4 H.G. KOENIGSBERGER, Estates and Revolutions. Essays in Early Modern Europe History,Ithaca-London, Cornell University Press, 1971; J.H. ELLIOTT, A Europe of Composite Mo-narchies, «Past and Present», 137 (1992).
tica degli spazi occupati dai Savoia dovrà inoltre tener conto,per i secoli XV-XVII, della convivenza di più di una realtà sta-tuale. Accanto allo Stato sabaudo, messo in crisi dall’occupa-zione francese nella prima metà del Cinquecento, occorreràconsiderare la situazione nell’Astigiano, nel Saluzzese e in Mon-ferrato prima e dopo l’annessione, nel Pinerolese temporanea-mente ceduto ai francesi, nei territori orientali annessi solo nelcorso del Settecento5.
Non si potrà, poi, ritagliare semplicemente lungo l’arco al-pino il limite occidentale dei territori subalpini; avrebbe pocapertinenza, in questo senso, ignorare quanto accadde, sino al1860, anche nel Nizzardo e in Savoia. All’interno dei dominisabaudi la struttura militare consolidatasi nel corso dell’età mo-derna assisteva infatti a continui movimenti di uomini e ditruppe sui due fronti delle Alpi. Nei progetti dell’ISPRE le duearee di Nizza e della Savoia potranno essere tenute in secondopiano rispetto ai territori subalpini, ma occorrerà stabilire, divolta in volta, i necessari raffronti fra la situazione al di qua eal di là dello spartiacque alpino.
Parlare di storia militare e diplomatica implica trattare, fral’altro, anche di questioni di ordine pubblico, ed è chiaro cheda questo punto di vista la frontiera montana non può essereconsiderata un confine geografico tale da restringere il campod’indagine ai soli territori cisalpini 6. Su tali aspetti ho dedicatoattenzione negli ultimi anni, ma in riferimento soprattutto alSettecento e agli anni napoleonici 7. Giustificherò qui di se-
storia militare e diplomatica 31
5 Non è forse inutile ricordare le date di annessione ai domini dei Savoia deiseguenti territori: Asti nel 1531, Saluzzo nel 1601, benché occupata fin dal 1588, ilMarchesato del Monferrato (Casale e Acqui) nel 1713, Pinerolo divenuta sabauda findal 1220, ma passata alla Francia nel 1630 e tornata sotto il governo sabaudo a fineSeicento, le province orientali di Alessandria, Valenza e della Valsesia (1713), Tortona,Novara e il Basso Novarese (1738), Voghera, Vigevano e l’Alto Novarese (1748).
6 In Antico Regime il controllo dell’ordine pubblico era affidato, com’è noto, all’e-sercito regolare, in assenza di unità equivalenti agli attuali corpi di polizia.
7 P. BIANCHI, Una piazzaforte sabauda: esercito, difesa e controllo sociale ad Asti nel Settecento, inQuando San Secondo diventò giacobino, a cura di G. Ricuperati, atti del convegno di Asti, 12-13 dicembre 1997, Alessandria, dell’Orso, 1999, pp. 127-178; EAD., Concordia discors.
guito la necessità di estendere ai secoli precedenti e ai decennisuccessivi un’indagine di questo tipo, alla luce di quanto hopotuto constatare, insieme con Andrea Merlotti, occupandomidi un’area piemontese specifica, il Cuneese, per il periodo com-preso fra Cinquecento e fine Settecento 8. Il discorso sui con-
32 paola bianchi
Ragioni e debolezze dell’alleanza austro-piemontese contro la Grande Nation, atti del Forum Marengo2000 (Cittadella di Alessandria, 12-17 giugno 2000), «Rivista Napoleonica. RevueNapoléonienne. Napoleonic Review», I (2000), n. 1-2, Immaginario napoleonico e luoghidella memoria, pp. 177-191; EAD., La guerra franco-piemontese e le Valli valdesi (1792-1799), inLa Bibbia, la coccarda e il tricolore. I Valdesi fra due emancipazioni (1798-1848), a cura di G.P.Romagnani, Torino, Claudiana, 2001, pp. 73-117; EAD., Onore e mestiere. Le riforme mili-tari nel Piemonte del Settecento, Torino, Zamorani, 2002, passim; EAD., Guerra e pace nel Sette-cento: alcune riflessioni sul caso sabaudo, «Studi settecenteschi», vol. 22, 2002, pp. 89-102;EAD., Il potere e la frontiera nello Stato sabaudo. Alcune riflessioni sugli spazi alpini nel Settecento,«Società e storia», n. 96, 2002, pp. 221-239; EAD., Verso un esercito-polizia. Il controllo del-l’ordine pubblico nel Piemonte del Settecento, in atti del convegno Corpi armati e ordine pubblico inItalia (XVI-XIX sec.), Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, 10-11 novem-bre 2000, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp.213-39; EAD., Fra carriere militari e diplomazia. La difficile eredità del marchese d’Ormea, in Nobiltàe Stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea, atti del convegno svolto a Torino e Mondovì, 3-5ottobre 2001, a cura di A. Merlotti, Torino, Zamorani, 2003, pp. 323-344; EAD., Spun-ti per una discussione sulle fonti di storia militare in età moderna: i documenti sui governatori nelPiemonte del Settecento, in Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti, atti del convegnodi Messina, 12-13 novembre 1999, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Soveria Man-nelli, Rubbettino, 2004, pp. 77-98; EAD., Saluzzo fra Sei e Settecento. La trasformazione delbaluardo militare dopo l’annessione allo Stato sabaudo, in L’annessione sabauda del Marchesato di Saluzzo.Tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica. Sec. XVI-XVIII, a cura di M. Fratini, atti convegnodi Saluzzo, 1°-2 settembre 2001, Torino, Claudiana, 2004, pp. 119-144; EAD., «Politicae polizia» in una realtà d’antico regime: le sfide contro vecchi e nuovi disordini nello Stato sabaudo fra Seie Settecento, «Bollettino storico bibliografico subalpino», CIII (2005), fasc. I, pp. 473-504; EAD., Militari, banchieri, studenti. Presenze protestanti nella Torino del Settecento, in Valdesi eprotestanti a Torino. XVIII-XX secolo, atti del convegno di Torino, 12-13 dicembre 2003, acura di A. Merlotti, P. Cozzo e F. De Pieri, Torino, Zamorani, 2005, pp. 41-65; EAD.,«Ad meliorem custodiam»: appunti per lo studio delle forme di carcerazione nel Piemonte del Settecento, inCarceri carcerieri carcerati: dall’antico regime al Novecento, atti del convegno di Somma Lom-bardo, 14-15 dicembre 2001, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino,2006, pp. 195-214; EAD., Stato nello Stato? Appunti sull’incompiuta perequazione del Monferrato afine Settecento, in Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini in un piccolo Stato ita-liano tra Medioevo e Ottocento, atti del convegno di Acqui Terme - Nizza Monferrato -Casale Monferrato, 11-13 marzo 2004, a cura di B.A. Raviola, Milano, Angeli, 2007,pp. 221-255; EAD., Protestants, Huguenots and French refugee soldiers in Savoy-Piedmont betweenSeventeenth and Eighteenth Century, in War, Religion and Service. Huguenot soldiering 1685-1713,ed. by M. Glozier and D. Onnekink, Aldershot, Ashgate Academic Publishing, 2007,in corso di stampa.
8 P. BIANCHI - A. MERLOTTI, Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte d’anticoregime, premessa di R. Comba, Milano, Angeli, 2002.
fini, di cui si occupa in particolare il progetto di Alice Raviola,trova analoghi spunti in relazione ad altre zone di frontiera:quella, per esempio, con le terre liguri (sede di antichi conflittifra comunità, oggetto di velleità di conquista da parte sabauda,motivo di lunghe ed estenuanti trattative diplomatiche nel cor-so di tutta l’età moderna) e quella aperta verso i territori lom-bardi 9.
In queste pagine uso il concetto di storia militare e diplo-matica mantenendo volutamente e strettamente legati i due ter-mini. Le vicende dei territori subalpini, quelle politico-istitu-zionali ma non solo, non possono essere comprese se non at-traverso il continuo scambio fra questi due fattori.
Un bilancio storiografico consente di verificare se la produ-zione recente abbia posto dovutamente attenzione a questo bi-nomio. Una prima verifica può riguardare i libri pubblicati acura di istituti, fondazioni e centri di ricerca, oppure uscitipresso le principali case editrici italiane (Einaudi, Laterza, ilMulino, Angeli, Carocci) e presso alcune classiche collane sto-riche straniere (quella di Oxford, di Cambridge, della pariginaPUF). Il secondo tipo di spoglio va eseguito su riviste di am-bito non soltanto piemontese, selezionate sulla base del tagliometodologico, privilegiando quello socio-istituzionale.
Ho circoscritto l’indagine alla bibliografia uscita tra gli anniOttanta e oggi, perché in quegli anni da un lato la monografiadedicata da Geoffrey Symcox al regno di Vittorio Amedeo IIriportava l’attenzione degli storici stranieri – in particolareanglosassoni – sulla storia sabauda legandola alle vicende euro-pee 10, dall’altro lato gli studiosi si riaccostavano alle ricerched’archivio con rinnovata convinzione.
storia militare e diplomatica 33
9 B.A. RAVIOLA, Le immagini di un territorio. Descrizioni del Monferrato in età moderna, intro-duzione a Cartografia del Monferrato cit.; P. BIANCHI, Stato nello Stato? cit.
10 G. SYMCOX, Victor Amadeus II. Absolutism in the Savoyard State, 1675-1730, London,Thames and Hudson, 1983 (ed. it. Vittorio Amedeo II. L’assolutismo sabaudo, 1675-1730,Torino, SEI, 1985).
Più che il libro di Symcox, tuttavia, che riprendeva assuntidella storiografia precedente (Carutti in primis) presentandoli informa accattivante per il lettore di oggi, indicherei alcuni con-tributi di pochi anni precedenti come punti di partenza per l’a-nalisi di nuovi e interessanti temi, non completamente svilup-pati. Mi riferisco ai lavori di Enrico Stumpo 11, che hanno avu-to il merito di superare l’immagine del Seicento sabaudo comepuro secolo di crisi valorizzando lo studio dell’avvio di impor-tanti trasformazioni economiche e amministrative negli anni delducato di Carlo Emanuele II. A Stumpo si deve, inoltre, l’aversottolineato la consistenza degli investimenti nella politica di-fensiva dei Savoia durante il XVII secolo utilizzando precisiconfronti con altre realtà statuali. Sulla scia dei percorsi d’in-dagine aperti da Stumpo si erano posti i lavori di Claudio Ros-so, confluiti nel citato volume del Piemonte sabaudo pubblicatodalla Utet nel 199412; in tema storico-militare, Rosso avevagiustamente attirato l’attenzione su episodi importanti per co-gliere alleanze e tensioni maturate sul territorio in occasione didifficili operazioni militari e diplomatiche: la guerra civile fraprincipisti e madamisti (1638-42) e lo scontro con Genova del1672. Molto resta, peraltro, da lavorare per poter dire di cono-scere in modo approfondito le vicende militari che interessa-rono la frontiera con la Repubblica ligure (non meno impor-tante era stato lo scontro del 1625-34) e le vicende bellichericorrenti nel corso del XVII secolo.
Nuovi elementi sono sicuramente stati posti, dopo i lavoridi Rosso, da Andrea Merlotti nell’ottica di una ricostruzionedi lunga durata del rapporto fra élites sul territorio e governosabaudo fra Seicento e Ottocento13. In scala geografica più
34 paola bianchi
11 E. STUMPO, Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento, Roma, Istituto storicoitaliano per l’età moderna e contemporanea, 1979; ID., Guerra ed economia: spese e guadagnimilitari nel Piemonte del Seicento, «Studi storici», XXVII (1986), pp. 371-395.
12 C. ROSSO, Il Seicento, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI IlPiemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, Torino, Utet, 1994, pp. 127-267.
13 A. MERLOTTI, L’enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento, Firen-ze, Olschki, 2000.
limitata, ho potuto verificare quanto accadde nel Cuneeese, areainteressata sia dalla guerra civile sia dalle ripercussioni delletensioni con Genova14. In generale, sul periodo compreso frametà Quattrocento e metà Ottocento, non si può tuttavia nonconstatare il numero limitato degli studi utili al progetto ISPRE.
Il libro di Walter Barberis ha avuto il merito di riprendere iltema della storia militare del Piemonte sabaudo con l’ambizio-ne di recuperare un lungo arco cronologico: dall’età di Ema-nuele Filiberto a quella di Carlo Alberto 15. In realtà sono so-prattutto il secondo Cinquecento, il secondo Settecento e laprima metà dell’Ottocento a essere toccati da Barberis, che po-ne l’importante questione del rapporto contrattuale fra sovranidi casa Savoia, comunità ed élites utilizzando però fonti pro-dotte pressoché unicamente dal centro dello Stato, uno Statoche il lettore non percepisce tanto nei suoi meccanismi ammi-nistrativi e difensivi quanto nell’elaborazione della propria im-magine e tradizione militare. L’approccio di Barberis non è, inaltri termini, del tutto assimilabile a quello dei «war and so-ciety studies» di cui parlavo sopra. Più che a una storia militareintesa nell’accezione socio-istituzionale, questo studio mira aun interessante approccio culturale giocato sulla valutazione, nellungo periodo, del ruolo assunto dal ceto dirigente sabaudonella storia nazionale.
Gli articoli che Ferrone ha pubblicato contemporaneamentee immediatamente dopo l’uscita del libro di Barberis hannocontribuito a inserire lo Stato sabaudo degli ultimi decenni delSettecento nel contesto culturale europeo delle accademie scien-tifiche, rivalutando le figure di quelli che l’autore definisce«tecnocrati militari»16. Fedele a una storiografia delle idee che
storia militare e diplomatica 35
14 P. BIANCHI - A. MERLOTTI, Cuneo in età moderna cit.15 W. BARBERIS, Le armi del principe. La tradizione militare sabauda, Torino, Einaudi, 1988.16 V. FERRONE, La Nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo
III, Torino, Meynier, 1988. I testi dei saggi raccolti in questo volume sono stati ripresiin altre sedi; la più recente: L’Accademia Reale delle Scienze. Sociabilità culturale e identità del « let-terato» nella Torino dei Lumi di Vittorio Amedeo III, in Storia di Torino, V, Dalla città razionale alla
ha colto nei lumi e nelle riforme la chiave interpretativa dellapolitica degli Stati tardo-settecenteschi, Ferrone non ha toc-cato temi militari e diplomatici dal punto di vista socio-istitu-zionale, né ha affrontato il problema della definizione storicadegli spazi piemontesi. Trattando delle origini e dei progressidelle scuole d’artiglieria di Torino ha giustamente riportato l’at-tenzione sulla raffinata cultura delle armi dotte presente nellacapitale, fondandosi su trattati e regolamenti o su singoli pro-fili biografici d’eccellenza, non su ampie ricostruzioni proso-pografiche dei gruppi sociali.
Diverso il discorso sul libro di Sabina Loriga, che offrespunti nella prospettiva delle indagini su società e istituzioni 17.L’approccio risente, in questo caso, di un’impostazione di ta-glio sociologico applicata a un ricco materiale archivistico cheviene rielaborato in forma statistica restituendo talvolta inter-pretazioni condizionate dalla volontà di rispondere a un mo-dello di tipo neo-foucaultiano. Il libro si apre tuttavia a que-stioni che risultano centrali nella storiografia militare attuale:per esempio il rapporto fra crescita numerica, burocratica eprofessionale dell’organizzazione bellica e la trasformazionedelle ragioni che spingevano all’arruolamento, i contatti frapopolazione civile e militari, la mobilità sociale nei vari corpiarmati. In relazione a un progetto come quello elaborato perl’ISPRE, il limite dell’indagine condotta dalla Loriga è anche illimite del libro da me pubblicato nel 2002: la scelta cronolo-gica ristretta al solo Settecento. Nella ricostruzione che hoofferto delle riforme militari settecentesche avevo cercato di fardialogare il piano istituzionale con quello sociale e culturaleriservando un certo spazio a un discorso comparativo con altrerealtà europee che varrebbe la pena estendere almeno ai duesecoli precedenti e alla prima metà del secolo seguente 18.
36 paola bianchi
crisi dello Stato d’Antico Regime (1730-1798), a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi,2002.
17 S. LORIGA, Soldati. L’istituzione militare nel Piemonte del Settecento, Venezia, Marsilio,1992.
18 P. BIANCHI, Onore e mestiere cit.
L’elemento della comparazione credo debba essere accoltocome fondamentale in ogni futura ricerca promossa dall’ISPRE.È proprio la scarsità dello sguardo comparativo a rendere ne-cessarie nuove indagini, soprattutto sul Quattro-Seicento.
Inserisco, a questo proposito, una sintetica tavola cronolo-gica (che ho distinto in una fase pre-amedeana e in una fasesegnata dalla forte impronta riformistica di Vittorio AmedeoII, che allineò i domini sabaudi alla situazione di diversi Statieuropei) per mostrare come, a partire dal Cinquecento, maforse anche prima a saper indagare più approfonditamente, lostudio delle strutture militari piemontesi debba essere inqua-drato entro coordinate europee oltre che italiane.
1553-1684 19
PIEMONTE (domini sabaudi)1560 Emanuele Filiberto crea le «milizie paesane»1594 Carlo Emanuele I riforma le «milizie paesane» impiegando contingen-
ti di uomini «scelti» (o «quotizzati») e di miliziani «ordinari» (o «ge-nerali»): rispettivamente forze di rincalzo alle truppe mobili e forzeterritoriali
1618 altra riforma delle «milizie» promossa da Carlo Emanuele I1636 richiamandosi alla legislazione dei predecessori, Vittorio Amedeo I or-
dina la levata di corpi di fanteria mobile e territoriale: «milizie ordina-rie» e «scelte»
1644 si iniziano a sperimentare i primi servizi sanitari militari1669 si crea il battaglione di Piemonte, che raccoglie gli elementi migliori,
volontari, della «milizia scelta»1676 nominandolo segretario di Stato e di Finanze (5 novembre), Giovanna
Battista conferisce a Donato Chapel di Saint Laurent anche l’incaricodi segretario di Guerra e di milizia
1677 istituzione dell’Accademia Reale1678 si forma un Consiglio di Fabbriche e Fortificazioni (con presidente e
membri non militari, e con la presenza, se necessario, del primo inge-
storia militare e diplomatica 37
19 La fase cinque-secentesca corrisponde all’avvio di una sempre più chiara politicadi riforma militare. Quella successiva a un maggior impatto istituzionale e organizza-tivo non solo negli spazi sabaudi, ma in quelli italiani ed europei.
gnere ducale); il personale tecnico (misuratori, operai, sovrastanti) vie-ne ripartito presso le principali località fortificate (Torino, Asti, Ver-celli)
AUSTRIA1650 si organizzano (su modello spagnolo) due nuovi Consigli per l’ammi-
nistrazione dell’armata: il Generalkriegskommissariat e l’Hofkriegsrat, Consi-gli che sarebbero stati riformati da Haugwitz nel 1752 (al primo sa-rebbero spettati la distribuzione del soldo e il controllo disciplinare, alsecondo il comando vero e proprio dei soldati)
FRANCIA1555, due ordinanze di Enrico II (parallelamente a quanto si verifica anche in
Spagna) introducono l’ufficio del cappellano delle truppe (aumôneriemilitaire), per ogni «banda» (successivamente per ogni reggimento);tale pratica sarebbe continuata (con il reclutamento di vescovi o dimembri di ordini regolari) in Paesi sia cattolici sia protestanti
1559 nasce la figura del connétable, responsabile di far rispettare la disciplinafra le truppe e capo dell’armata in assenza del re (carica più ammini-strativa che di guerra)
1567 ai commissari si aggiungono alcuni controllori di guerra (cariche tra-sformate da Luigi XIII e Richelieu in quelle degli intendants de provinces eintendants d’armée)
1606 nasce a Sedan, ad opera del duca di Bouillon, l’Académie des Exercices: unodei primi esempi di scuola militare
1620 si ordina per la prima volta di segnalare la presenza di «passavolanti»in occasione delle «mostre»
1623 un regolamento fissa un sistema di «tappe», dando il via a una serie diordini che avrebbero toccato l’assetto territoriale in ragione della di-sponibilità delle risorse contributive
1629 il Code Michau regolamenta i criteri per il rilascio dei congedi e imponeche i «ruoli» includano, accanto al nome proprio del soldato, anche:nome di guerra, luogo di nascita, età, caratteristiche fisiche (un sistemache sarebbe tuttavia stato generalizzato solo a seguito degli interventilegislativi di Louvois)
1635 si creano i reggimenti di cavalleria (24 di cavalleria propriamente detti,1 di carabine e 6 di dragoni); si commina la pena di morte ai disertori(pena che sarebbe stata soppressa nel 1684, e ripristinata nel 1716)
1638 prima ordinanza che proclama un’amnistia per i disertori1660 un’ordinanza stabilisce l’uniformità del trattamento dei soldati (pane,
soldo e utensili)
38 paola bianchi
1558
1618ca.
1661 si sopprime la figura del colonnello generale di fanteria, mentre tutti imastri di campo si vedono assegnare il grado di colonnello; un’ordi-nanza regolamenta precedenze e onori militari in occasione delle visitereali e dei principi di sangue presso le guarnigioni
1663 nasce un reggimento del re (le guardie del corpo)1664 l’ufficio dei commissari di guerra (amministratori civili con responsa-
bilità finanziaria, subordinati all’intendente) diventa una carica venale1665 Luigi XIV crea i Consigli di guerra, tribunali che (convocati dai gene-
rali, dai governatori delle province e dai comandanti dell’armata) giu-dicano i delitti militari; si istituiscono i battaglioni di guarnigione
1667 il corpo di guardia reale (Casa militare) viene subordinato al controllodel segretario di Guerra; un’ordinanza stabilisce la pena di morte per i«passavolanti» e la sospensione degli ufficiali responsabili del diffon-dersi di un tale reato (nel 1676 si sarebbe prescritta, piuttosto, la reci-sione del naso), per quanto continui a godere fortuna la pratica diarruolare nell’esercito malfattori e delinquenti
1669 si compilano i «ruoli» dei corpi di marina: nasce cioè il primo sistemaorganico di reclutamento delle forze di mare
1670 si istituisce il corpo degli invalidi (l’Hôtel Royal des Invalides) e si formanoi primi registres de contrôle
1671 si creano il Dipartimento delle Fortificazioni di Terra e di Mare e uncorpo di artiglieria (reggimento fucilieri del re); la Maison militaire du roiforma un corpo separato dall’armata (corpo che nel 1690 avrebbe as-sunto una struttura definitiva)
1675 Luigi XIV uniforma il principio di promozione degli ufficiali generali1676 un’ordinanza regolamenta il funzionamento degli ospedali delle mag-
giori piazzeforti1680 Louvois pubblica un piano di Vauban per la costruzione di caserme,
una delle prime iniziative di questo tipo; viene introdotto, progressiva-mente, l’uso dell’uniforme (come segno distintivo della condizionemilitare e, a un tempo, elemento per imporre maggior disciplina)
INGHILTERRA1558 uno statuto si appella agli obblighi dei free holders, che devono organiz-
zare milizie di autopolizia e autodifesa (d’origine medievale e territo-riale)
1682 si imita l’istruzione per gli invalidi dell’Hôtel francese del 1670 creandoil Royal Hospital of Chelsea, poi detto Chelsea College
PAESI BASSI1566 primo codice penale militare
storia militare e diplomatica 39
1567 si apre il primo ospedale militare permanente dell’Europa moderna aMechelen (Malines), nel Brabante (ospedale smantellato dopo un soloanno, riaperto poi nel 1585)
SVEZIA1621 Gustavo II Adolfo promulga un codice militare largamente ispirato alle
idee di Grozio (codice che sarebbe rimasto per lo più in vigore fino allariforma di Gustavo IV, alla fine del XVIII secolo)
1647 si crea il Kringsmanhus di Vadstena per l’assistenza agli invalidi1682 l’Indeltnisverket o Indelta (sorta di preannuncio di quello che sarebbe stato
il Kantonsystem prussiano del 1733), per decreto di Carlo XI, ripartisceil territorio in base a un criterio rigorosamente militare
1684-1730
PIEMONTE (domini sabaudi)1685 si raccolgono in un unico ufficio le cariche di veedore, contadore e te-
soriere1688 soppressione della Veedoria1691 disposizioni (ma ancor vaghe) dedicate all’Ufficio generale del Soldo e
a quella che sarebbe diventata la Segreteria di Guerra; i commissari diguerra (i membri del Soldo incaricati di svolgere compiti amministra-tivi e di esercitare anche un certo margine di potere disciplinare) ven-gono ripartiti per dipartimenti
1695 le istruzioni dirette al contadore (obbligato, di qui in avanti, a risiederepresso il palazzo ducale) erodono le prerogative del segretario di Guer-ra in fatto di bilanci
1697 si estendono all’artiglieria, alla stregua degli altri corpi, le pene previstein caso di diserzione
1701 ordine per la consegna generale di tutti gli uomini dai 18 ai 40 anniper formare un corpo di «milizia»
1702 distribuzione della baionetta a ghiera alle truppe1704 divieto ai contadini di uccidere disertori dell’esercito nemico1706 fusione delle «milizie scelte» e «ordinarie» nella «milizia generale»1709 abolizione dei dipartimenti, centralizzazione e riorganizzazione del-
l’Ufficio generale del Soldo (ufficio con funzioni di contabilità, ap-provvigionamento e rivista delle truppe)
1710 istituzione di un controllore generale presso l’ufficio del tesoriere diguerra
1711 si riuniscono (in una sola Azienda) Artiglieria, Fabbriche e Fortifica-
40 paola bianchi
1692
zioni (tre uffici a capo dei quali è l’intendente generale), e si crea ununico Consiglio (le cui riunioni sono presiedute dal gran mastro e dalprimo ingegnere, quando si tratta di «fortificazioni», o dal primo ar-chitetto, con competenza sulle «fabbriche» civili)
1713 scioglimento del battaglione di Piemonte; si formano i reggimenti pro-vinciali; in Sicilia si istituisce un Ufficio del Soldo (subordinandolo alcorrispondente ufficio centrale di Torino) destinato a sopravvivere sinoal 1719
1714 introduzione del giuramento militare; si istituiscono in Sicilia un Con-siglio e un’Azienda d’Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni (che avreb-bero operato, in subordine rispetto agli uffici torinesi, sino al 1718)
1717 riordinamento sia dell’apparato statale (la Segreteria di Stato viene di-visa in tre ministeri: Esteri, Interni, Guerra) sia delle Aziende finanzia-rie (di qui in poi al generale delle Finanze sarebbe toccata la direzionefinanziaria dello Stato, mentre al contadore generale, a capo del Soldo,la direzione dell’amministrazione militare)
1720 si crea per la Sardegna il corrispettivo del Soldo, mettendogli a capo uncommissario
1723 convenzione con la Francia e l’Austria per la reciproca consegna dei di-sertori (convenzione rinnovata, successivamente, nel 1727, 1734 e 1742)
1726 fondazione delle Scuole d’Artiglieria e Ingegneria; norme sul ruolo delgran mastro, del colonnello, del luogotenente colonnello, dell’auditoregenerale, del primo ingegnere e del primo architetto entro il Consigliod’Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni
1730 riforma dell’Accademia Reale (l’insegnamento delle discipline cavalle-resche viene distinto da quello delle materie letterarie); nuove disposi-zioni sul Soldo (in sintonia, per lo più, con quelle del 1709); cessal’attività del Consiglio d’Artiglieria (la gestione economica dell’Azien-da d’Artiglieria, Fabbriche e Fortificazioni è affidata all’intendentegenerale)
AUSTRIA1697 a Vienna si fondano istituzioni a favore degli invalidi (così a Pest nel
1724, e a Praga nel 1728)1719 Carlo VI crea una marina da guerra facendo costruire il primo arsenale
a Trieste
FRANCIA1684 si crea un reggimento di bombardieri1688 mentre si aprono le ostilità di Luigi XIV contro il Palatinato si orga-
nizzano la «milizia reale» (un contingente che, utilizzato di rincalzo e
storia militare e diplomatica 41
come riserva, è reclutato, per estrazione a sorte, dal 1688 al 1697, dal1702 al 1714, divenendo permanente a partire dal 1726; nel 1771 sisarebbe parlato, piuttosto, di «reggimenti provinciali») e quello che(nel 1734) sarebbe stato il Dépot de la Guerre; Vauban presenta un nuovomodello di fucile moschetto, che Louvois fa adottare
1689 ordinanza sull’impiego del fucile e della baionetta in fanteria1690 fusione degli apparati delle Fortificazioni di Guerra e di Marina1690 Luigi XIV organizza: a) 12 Grands gouvernements géneraux (denominati in
base alla provincia), b) governatori di media importanza, c) governa-tori particolari (corrispondenti, per lo più, al numero delle città e deipaesi)
1691 organizzazione del Dipartimento delle Fortificazioni di Terra e di Ma-re (che, da piccolo ministero indipendente, sarebbe via via diventato unorgano direttivo legato alla Segreteria di Stato e di Guerra, e che da in-gegneri semi-civili sarebbe passato nelle mani di militari)
1692 un’ordinanza fissa a 180 il numero dei commissari di guerra1693 i «miliziani» iniziano ad essere sorteggiati tra gli uomini al di sopra
dei 18 anni1696 nasce il corpo degli ingegneri di campo e delle armi del re, e cioè degli
ingegneri geografi, un corpo che sarebbe stato progressivamente milita-rizzato (1761: dipende dalle Fortificazioni e dal Dépôt de Guerre; 1776:gli si ascrive un direttore del genio)
1699 si abbandona l’uso del moschetto1703 nuovo regolamento sull’«ordre de combat»; convenzione con le Pro-
vince Unite, che regolamenta la restituzione dei prigionieri di guerra(nel corso della guerra di Successione spagnola si evolve il concetto di«guerra regolata»)
1710 si assegna una pensione per gli svizzeri di religione riformata, i qualiperaltro non avrebbero potuto entrare nell’Hôtel Royal des Invalides senzaaver prima abiurato
1715 soppressione della «milizia» di rincalzo; si crea un doppio inquadra-mento disciplinare entro l’armata: gestito da un lato dai governatori,dall’altro dagli ispettori
1715 si convocano diversi Consigli di guerra
1716 ordinanza sul reclutamento, che prescrive ai maggiori di tenere un regi-stro per ogni compagnia del loro reggimento (con nome della famigliae di guerra di sergenti, caporali e soldati, luogo di nascita, età, data delreclutamento, di morte, di congedo o di diserzione); nella riorganizza-zione delle truppe in occasione della pace, i reggimenti di cavalleriaperdono l’ufficio dell’aumônerie militaire, che sarebbe stato ristabilito soloin tempo di guerra
42 paola bianchi
1718
1717 nasce il fucile con calibro normalizzato1718 dissoluzione del Consiglio di guerra; regolamento che prescrive la fre-
quenza a corsi d’anatomia e chirurgia presso gli ospedali militari1719 si ristabilisce la milizia di rincalzo1720 i reggimenti Reale Artiglieria e Reale Bombardieri danno origine a 5
battaglioni (si trattava di corpi d’artiglieria che, già costituiti da im-prenditori e specialisti civili, erano stati militarizzati sotto il regno diLuigi XIV)
1721 si ristabilisce la carica di colonnello generale di fanteria; riorganizza-zione delle scuole d’artiglieria
1725 i commissari di guerra sono tenuti a inviare i risultati delle «riviste» intriplice copia: al segretario di Stato per la Guerra, all’intendente dellaprovincia, al tesoriere incaricato del pagamento
1727 i commissari di guerra diventano sempre più una carica militarizzata(assolvono gli stessi obblighi dei capitani di fanteria nel servizio delle«tappe», prima di vestire, a far data dal 1746, l’uniforme e prima diessere assimilati, dal 1772, ai capitani di fanteria)
INGHILTERRA1689 il Parlamento adotta il mutinity act, primo esempio di autentica e orga-
nica legislazione militare1692 agli invalidi del Royal Hospital of Chelsea viene assegnata una pensione1716 con la creazione delle compagnie della Royal Artillery, l’artiglieria diventa
un corpo autonomo
PRUSSIA1707 si istituiscono pensioni a favore degli invalidi
RUSSIA1701 Pietro il Grande crea la scuola del genio1703 nascono le scuole d’artiglieria1707 si apre una scuola di chirurgia militare1709 si inaugura la scuola degli ingegneri militari1722 si organizza un sistema d’assistenza per gli invalidi (prima con l’appog-
gio dei conventi, poi delle città di guarnigione)
SPAGNA1699 nasce, a Barcellona, una scuola d’artiglieria1711 Flamand Verboom opera un’organizzazione complessiva del corpo de-
gli artiglieri1717 nasce un’istituzione nazionale per gli invalidi
storia militare e diplomatica 43
1730
Tornando al bilancio sullo stato dell’arte, i lavori di Pier-paolo Merlin sull’età di Emanuele Filiberto e Carlo EmanueleI 20, gli studi di Claudio Rosso sulle segreterie di Stato e ledinamiche sociali nel corso del XVII secolo21 hanno certa-mente rinnovato l’interesse posto decenni addietro da RomoloQuazza sui fatti politici, militari e diplomatici che coinvolserole corone di Spagna e di Francia nelle relazioni con gli spazipiemontesi. La ricerca documentaria attende, tuttavia, in granparte, l’incrocio delle fonti straniere con quelle sabaude, men-tre sul piano interpretativo occorrerebbe un raffronto aggior-nato con quanto si sta studiando all’estero. Un recente conve-gno internazionale svoltosi a Madrid22 mi ha offerto l’oppor-tunità di raccogliere, intervenendo fra i relatori, una bibliogra-fia dei lavori patrocinati da atenei, fondazioni e istituti iberici.Ho potuto in questo modo confermarmi nell’idea che il dia-logo fra storici dei domini spagnoli in età moderna e storiciche si occupano di spazi subalpini sia pressoché inesistente; edè non meno curioso che anche gli studiosi ispanisti italiani nonsentano in genere il bisogno di trovare contatti con la storio-grafia dedicata alle aree subalpine, pur a lungo condizionatedalla politica di alleanza o di belligeranza con la Spagna.
Sopra accennavo al fatto che, a partire dagli anni Ottanta,alcuni storici stranieri si siano accostati alla storia dello Statosabaudo. L’interesse si è concentrato sul periodo tardo-secente-sco e settecentesco, e cioè sul consolidamento del Ducato sa-baudo in Regno di Sardegna. Per gli stranieri non è tuttaviafacile percepire il significato di un aggettivo come «sabaudo»,che non ha una traduzione corrispondente in inglese e fran-
44 paola bianchi
20 P. MERLIN, Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell’età di Carlo Emanuele I, Torino, SEI,1991; ID., Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l’Europa, Torino, SEI, 1995.
21 C. ROSSO, Una burocrazia di antico regime. I segretari di Stato dei duchi di Savoia, 1559-1637, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1992; ID., Il Seicento cit.
22 Guerra y Sociedad en la Monarquía Hispánica. Política, Estrategia y Cultura en la EuropaModerna. 1500-1700, atti del convegno di Madrid, 9-12 marzo 2005, E. García Her-nán, D. Maffi editores, Madrid, Laberinto-CSIC-Fundación MAPFRE, 2006, 2 voll.
cese, e che viene sostituito da «savoiardo» con uno slittamentosemantico non del tutto appropriato. Non a caso si ricorre alleespressioni «Savoyard State» o «Savoy-Piedmont» senza checi si ponga il problema della trasformazione in senso politicodel concetto di Piemonte come conseguenza di aggregazioniterritoriali avviate dalla prima età moderna.
In relazione alla storia militare e diplomatica, l’unico lavororecente che ha prodotto elementi nuovi, frutto di ricerche diprima mano, è quello di Christopher Storrs, che fornisce ancheun esempio di «new diplomatic history»: «an intricate andsensitive blending of social and international history with thehistory of ideas», allo scopo – scrive Storrs – di « integratediplomacy and foreign policy with domestic politics in a wayolder diplomatic history did not» 23. In questo libro, mentre laparte dedicata alla politica militare risulta per lo più debitricedi studi altrui, il capitolo intitolato Savoyard diplomacy, 1690-1720 inserisce bene i domini di Vittorio Amedeo II nel conte-sto delle alleanze europee mettendo in luce il momento disvolta segnato dalla guerra della Lega d’Augusta, finora ingiu-stamente messa in ombra dalla storiografia che ha esaltato levittorie conseguite dai Savoia durante le guerre di successione.La lettura della politica sabauda nel tardo Seicento compiutada Storrs si differenzia da quella condotta da Robert Oresko,che si muove entro una cronologia più ampia (tutto il Seicentoe il Settecento) restando però legato a un discorso dinastico vi-cino agli schemi di una storia diplomatica concepita come tea-tro delle relazioni fra gruppi parentali di teste coronate 24.
Lo spoglio a campione, sulle annate 2000-2005, degli indi-ci delle riviste fra le più frequentate dagli storici italiani mo-
storia militare e diplomatica 45
23 C. STORRS, War, diplomacy and the rise of Savoy, 1690-1720, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 1999; la citazione da p. 125.
24 R. ORESKO, The House of Savoy in search for a royal crown in the seventeenth century, inRoyal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe: essays in memory of Ragnhild Hatton, edi-ted by R. Oresko, G.C. Gibbs and M. Scott, Cambridge, Cambridge University Press,1997.
dernisti («Quaderni storici», «Rivista storica italiana», «So-cietà e storia», «Storica») mi ha consentito di svolgere unaverifica anche fra i saggi pubblicati al di fuori di volumi tema-tici. Se ne evince una conferma del fatto che gli spazi subalpiniinteragiscono assai poco con il panorama degli studi italiani:scarsi gli articoli su argomenti più o meno direttamente atti-nenti ai progetti dell’ISPRE e invece evidente la predilezione peril secondo Cinquecento e il Settecento. Si tratta, peraltro, diarticoli che colmano lacune rimaste talvolta vistosamente sco-perte.
Il contributo di Allegra sul mercato del lavoro nella Torinodel Settecento, apparso sulla «Rivista storica italiana» nel 2004,si pone idealmente in relazione agli studi di Simona Ceruttisulle corporazioni urbane e le reti parentali nella capitale delSei-Settecento25. Allegra ha il merito di indagare una dimen-sione – quella economica – che la recente Storia di Torino uscitada Einaudi ha lasciato vistosamente scoperta per i secoli del-l’età moderna 26; la sua prospettiva abbraccia tuttavia il soloSettecento, applicando alla capitale un metodo di ricerca giàsperimentato dalla cosiddetta micro-storia.
Alle vicende strettamente istituzionali si riferisce il saggio diAntonello Mattone su assolutismo e tradizione statutaria nelRegno di Sardegna fra 1720 e 1827, apparso pure sulla «Ri-vista storica italiana» nel 200427. L’ambito insulare, che Mat-tone ha privilegiato nei suoi studi, non costituirà per l’ISPRE
oggetto di attività di ricerca diretta; ma in questo articolo èutile notare la gamma di sfumature con cui viene usato il con-
46 paola bianchi
25 Cfr. rispettivamente L. ALLEGRA, Fra norma e deroga. Il mercato del lavoro a Torino nelSettecento, «Rivista storica italiana», CXVI (2004), III p. 872 e sgg.; S. CERUTTI, Mestierie privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino. Secoli XVII-XVIII, Torino, Einaudi, 1992.
26 Storia di Torino, III, Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630),IV, La città fra crisi e ripresa (1630-1730), V, Dalla città razionale alla crisi dello Stato d’anticoregime (1730-1798), a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi, 1998, 2002.
27 A. MATTONE, Assolutismo e tradizione statutaria. Il governo sabaudo e il diritto consuetudina-rio del Regno di Sardegna (1720-1827), «Rivista storica italiana», CXVI (2004), III, p.926 e sgg.
cetto di assolutismo facendo ricorso a una serie di categoriegiuridiche su cui occorrerebbe acquisire maggior dimestichezza.
Particolarmente circoscritto dal punto di vista istituzionalee cronologico risulta il saggio di Matthew Vester uscito su «Qua-derni storici» nel 2005, dedicato all’autonomia amministrativain Bresse fra 1560 e 158028.
Nell’ambito dei lavori usciti in Italia vanno segnalate, piut-tosto, alcune collane che non toccano direttamente la storia delPiemonte, ma che possono offrire elementi di confronto e diaggiornamento.
A cura di Livio Antonielli e di Claudio Donati, pubblicatida Rubbettino, sono usciti, fra gli altri, i volumi La polizia in Ita-lia nell’età moderna (2002), Corpi armati e ordine pubblico in Italia(XVI-XIX sec.) (2003), Al di là della storia militare: una ricognizionesulle fonti (2005) e Carceri carcerieri carcerati: dall’antico regime al No-vecento (2006), che raccolgono gli atti di un ciclo di seminari,dedicati a temi in sintonia con i progetti dell’ISPRE, in cui sisono confrontate esperienze e risultati di scuole diverse, italia-ne e straniere. Le giornate di studio organizzate recentementein Italia non sono state, del resto, molto attente alle vicendedegli spazi sabaudi: una tendenza che andrebbe corretta ristabi-lendo un giusto contatto fra le scuole.
Prima di passare dalla parte descrittiva a quella propositiva,vorrei ancora ricordare un paio di volumi usciti a cura degliArchivi di Stato, di cui varrebbe la pena tener conto. Si trattadi «Giustizia e criminalità nello Stato pontificio»29 e La corte di Toscanadai Medici ai Lorena 30. Entrambi utilizzano ampiamente fonti diprima mano, che vengono analizzate su un arco temporale nonbreve (secoli XVI-XIX), con la dovuta attenzione alla com-
storia militare e diplomatica 47
28 M. VESTER, Perché l’autonomia istituzionale non significò meno tasse nella Bresse savoiarda(1560-1580), «Quaderni storici», n. 118, a. XL, 2005, 1, pp. 41-71.
29 A cura di M. Calzolari, M. Di Sivo ed E. Grantaliano, Roma, Gangemi, 2001, n.della «Rivista storica del Lazio», IX (2001), quaderno 4.
30 A cura di A. Bellinazzi e A. Contini, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca delloStato, 2002.
plessità territoriale dei singoli Stati e, nel caso toscano, al si-gnificato dell’innesto di una nuova dinastia su un dominio piùantico. La lettura e schedatura di questi volumi hanno contri-buito a suggerirmi le proposte che esporrò qui di seguito.
2. Problemi aperti
Ad alcune tematiche prive di riscontri sufficienti nella sto-riografia, ma essenziali per un piano di ricerca come quelloproposto in queste pagine, ho già fatto riferimento nelle pagineprecedenti: 1. la necessità di un giusto inserimento degli spazi subalpini
nel panorama degli antichi Stati italiani, oltre che della sto-ria europea;
2. la mancanza di dati su molti aspetti non solo istituzionali,ma socio-economici;
3. la scarsità di ricerche specifiche e comparate sulle singolerealtà statuali coesistenti, fra XV e XVIII secolo, in un ter-ritorio che oggi definiamo tout court Piemonte.Vorrei soffermarmi su quelle che ritengo siano le lacune più
evidenti distinguendo fra temi ignorati per ragioni intellettualio per motivi di tipo documentario.
Le ragioni ideologiche che hanno spinto a trascurare lunghiperiodi e importanti nodi della storia piemontese sono facil-mente intuibili. Scelte personali e condizionamenti di scuolahanno pesato a lungo sul silenzio calato sulle fasi di crisi o ditransizione nella storia dei domini sabaudi. Alcuni, pochi mo-menti aurei, che si possono individuare nella seconda metà delCinquecento (la ricomposizione dello Stato sotto EmanueleFiliberto) e in un lungo Settecento (la crescita istituzionale epolitica, le riforme) hanno costituito praticamente fino a oggii veri punti fermi e i ricorrenti terreni d’indagine nella storio-grafia. La breve rassegna storiografica descritta so-pra ne ètestimone.
48 paola bianchi
La stessa questione si pone in riferimento alle realtà statualiche, prima di essere annesse nei domini sabaudi, coesistevanoin area subalpina. L’autunno del Medioevo in spazi come ilSaluzzese, l’Astigiano, il Vercellese ha finito col creare forticesure nella bibliografia, per ragioni che sono analizzate in par-ticolare da Alice Raviola. Andrea Merlotti, che ha incentratodiversi suoi studi sul rapporto, nel Sei-Settecento, fra il go-verno dello Stato sabaudo e le reazioni da parte dei ceti diri-genti, radicati su un territorio che continuò, fino almeno atutto il Settecento, a restare per diversi aspetti disomogeneo, sisofferma sui condizionamenti posti da un persistente torino-centrismo. Un torinocentrismo – si badi – che non risale soloalla vecchia storiografia dinastica o sabaudista, ma che soprav-vive, partendo da presupposti molto differenti, anche in granparte degli studi recenti.
Estendendo il discorso all’epoca successiva alla crisi del-l’Antico Regime, non si può non constatare l’insufficienza deidati in nostro possesso sul periodo del governo provvisoriofrancese (1798-99), dell’occupazione austro-russa (1799-1800),del regime napoleonico in Piemonte (1800-1814) e sulla stes-sa prima Restaurazione, fino almeno agli anni dei moti carbo-nari. Scarse le notizie sulla vita torinese e ancor più frammen-tarie quelle sui territori che iniziavano a definirsi con maggiorconsapevolezza, nel corso di quei decenni, piemontesi. Gli ef-fetti di una storiografia delle idee che ha insistito sul cosid-detto triennio giacobino evitando di affrontare importanti no-di politici, istituzionali e sociali impediscono, a oggi, di cono-scere molti aspetti della storia dei territori subalpini al volgerefra Settecento e Ottocento e alla vigilia del Risorgimento na-zionale. La scarsa attenzione a queste vicende ha una ricadutadi particolare evidenza sulla storia militare, sia a voler conside-rare la breve parentesi repubblicana di fine Settecento come unpunto di non ritorno nonché il vero lievito per la svolta otto-
storia militare e diplomatica 49
centesca sia a voler appoggiare la tesi dell’inefficacia e del viziodi astrattezza fatalmente espresso dai repubblicani locali 31.
Individuerei, pertanto, nei salti cronologici le principali la-cune storiografiche, frutto di scelte operate intenzionalmente.È stata consapevole, del resto, la scelta stessa di reagire perlungo tempo negativamente verso le tematiche storico-militari,in risposta alla vecchia bibliografia apologetica prodotta daautori in divisa. Né è casuale il fatto che, dal secondo dopo-guerra, la qualità degli studi promossi in Italia dall’UfficioStorico dell’Esercito non abbia seguito gli standard scientifici dialtri Paesi (Francia, Inghilterra, Spagna).
A lacune di questo genere si unisce spesso la difficoltà delreperimento e della lettura delle fonti. È chiaro che, in previ-sione di una storia del Piemonte sul lungo periodo, occorreràverificare l’agibilità di archivi e biblioteche sul territorio, nonlimitandosi ai fondi archivistici posseduti a Torino.
Fra la documentazione conservata a Torino andrebbe privi-legiata non tanto quella (assai più nota) che si trova presso lasezione Corte dell’Archivio di Stato quanto il materiale posse-duto nelle sezioni Finanze, Camerale e Guerra dello stessoarchivio (via Piave). Offrirò più avanti alcuni spunti ricavati daquesta autentica miniera documentaria, a oggi non abbastanzavalorizzata dai ricercatori. L’ideale sarebbe far dialogare talifonti con la documentazione depositata in altri centri, piemon-tesi e non.
50 paola bianchi
31 Le accuse di astrattezza e di acritica applicazione di un modello francese avulsodalla realtà degli Stati italiani erano presenti, com’è noto, già negli scritti degli autoridel primo Ottocento mossi da nuovo spirito nazionale. Non solo fra gli intellettualicome Cuoco, ma tra i testimoni delle vicende napoleoniche che erano stati partecipidelle trasformazioni dei primi anni del XIX secolo in ambito sia civile sia militare. Sivedano, in tal senso, i contributi raccolti in occasione del recente convegno Gli italiani inSpagna nella guerra napoleonica (1807-1813). I fatti, i testimoni, l’eredità, atti del convegno inter-nazionale di Novi Ligure, 22-24 ottobre 2004, a cura di V. Scotti Douglas, Alessandria,Edizioni dell’Orso, 2006. Mi permetto di rinviare anche a P. BIANCHI, Carlo Zucchi.Appunti per una biografia militante fra età napoleonica e Risorgimento, «Rivista storica italiana»,CXVIII (2006), fasc. I, pp. 188-218.
I sondaggi e i contatti stabiliti in questi mesi suggerisconodi dare la precedenza ai centri di Vercelli e Asti da un lato,Novara e Alessandria dall’altro.
3. Proposte tematiche
La prima proposta, che porrei come premessa dell’attivitàdell’ISPRE, è quella di affrontare, con il coinvolgimento di stu-diosi italiani e stranieri, uno dei nodi che hanno riportatorecentemente il «Piemonte militare» all’attenzione del dibat-tito storiografico: la questione dell’«eccezione sabauda». Iltema, non nuovo per l’immagine che la tradizione ha associatoal Piemonte, è stato presentato in forma interlocutoria in unadelle ultime pubblicazioni di Gregory Hanlon 32. Quanto divero esiste nella convinzione che la storia militare piemontesevada studiata come un caso a parte rispetto al fenomeno delcalo di esercizio dell’arte guerresca provocato, fra le aristocra-zie del resto della Penisola, dalla fine delle guerre d’Italia? In-dividuando un importante momento di svolta nella pax hispa-nica, compresa fra 1560 e 1620, Hanlon ha tentato di rico-struire, sulla base della letteratura esistente, da un lato i per-corsi che portarono molti comandanti e soldati rimasti disoc-cupati a servire sovrani stranieri, dall’altro lato la gradualedisaffezione verso la guerra diffusa negli Stati italiani dopo il1571, anno della vittoria dell’armata cattolica a Lepanto, finoall’ultimo decennio del Settecento e all’invasione da parte del-l’esercito rivoluzionario francese. Il punto di partenza di Han-lon non era tanto (o non solo) il concetto di «crisi militare
storia militare e diplomatica 51
32 Cfr. G. HANLON, The twilight of a military tradition. Italian aristocrats and European con-flicts, 1560-1800, London, UCL Press, 1998, in particolare, sulla «Piedmontese excep-tion», pp. 275-301; ID., The demilitarisation of an Italian provincial aristocracy: Siena 1560-1740, «Past and present», 1997, n. 155, pp. 64-108. Echi del dibattito storiograficodestato dalle tesi dello storico canadese sono presenti nel volume Guerra e pace, a cura diW. Barberis, in Storia d’Italia, Annali, vol. XVIII, Torino, Einaudi, 2002.
italiana», che Piero Pieri aveva formulato fin dal 1934 e poisviluppato nel 1952 in Il Rinascimento e la crisi militare italiana;Hanlon risaliva, piuttosto, al topos letterario scaturito dalle pa-gine della Storia d’Italia di Guicciardini, ripreso nella Storia delregno di Napoli di Benedetto Croce (1924): l’«historical enig-ma» del progressivo «estrangement of Italian society from mar-tial pursuits».
Di questo «crepuscolo» della tradizione militare italiana, tut-tavia, poco siamo in grado di affermare sulla base di un serioconfronto socio-istituzionale condotto sulla storia delle varierealtà statuali. Gli antichi Stati italiani attendono un lavoro disintesi aggiornato, che faccia luce sugli aspetti dell’organizza-zione militare in modo meno impressionistico di quanto nonsia stato trattato nel volume dello stesso Hanlon tradotto direcente da il Mulino 33.
I riferimenti al quadro europeo sono, come si è detto, ne-cessari per introdurre il discorso su uno Stato come quello sa-baudo, che crebbe di rango fra Sei e Settecento, fino almenoalla Guerra di successione austriaca, grazie al ruolo militareassunto nel gioco delle alleanze che accompagnava ogni grandeconflitto continentale. Il fatto che Geoffrey Parker abbia in-scritto i domini sabaudi nelle zone di massima concentrazionedella «rivoluzione militare» costituisce un elemento da cui par-tire, salvo articolare più puntualmente la periodizzazione (1500-1800) adottata dallo storico inglese 34. Giustamente JeremyBlack suggerisce di declinare sulla base delle varie aree «the cri-tical point which can be seen as the definitive breakthrough ofa new military system»; il Seicento rappresenterebbe, in questosenso, il vero secolo di rottura o meglio l’avvio di una serie dicesure susseguitesi nell’arco di alcuni decenni: « in Sweden inthe 1620s, in Brandeburg-Prussia in the 1650s, in Denmark in
52 paola bianchi
33 G. HANLON, Storia dell’Italia moderna (1550-1800), Bologna, il Mulino, 2002.34 G. PARKER, The military revolution. Military innovation and the rise of the West. 1500-
1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, ed. it. La rivoluzione militare; Leinnovazioni militari e il sorgere dell’Occidente, Bologna, il Mulino, 1990, pp. 16-17.
the 1660s and in Russia in the 1700s»35. Una tale «regionalperspective» può aiutare a interpretare in modo non univocol’assunto dell’«eccezione militare piemontese» rispetto agli an-tichi Stati italiani.
Lo studio delle trasformazioni delle carriere militari costi-tuisce uno dei terreni su cui mettere alla prova questa tesi. Ilrapporto e la competizione fra corpi stranieri e «nazionali», frareggimenti di cavalleria, di fanteria e unità di più recente mili-tarizzazione (artiglieria e genio), i contatti fra gli organici delletruppe di linea e dei reggimenti provinciali, lo scarto fra gliavanzamenti di carriera in tempo di pace e in tempo di guerra:sono questi i nodi che, a un confronto europeo, contribuisconoa relativizzare il concetto di eccezione. Se è vero, per esempio,che la nascita dei dieci reggimenti provinciali creati da VittorioAmedeo II fra 1713 e 1714 precedeva di un paio di decenni ilKantonsystem prussiano introducendo nei domini sabaudi un li-vello intermedio nel mestiere delle armi (tra le milizie e i reg-gimenti di linea) che all’inizio del Settecento mancava in moltiStati europei e italiani 36, è pur evidente che gli effetti sociali ditale riforma si allineavano a tendenze generali già in atto. Nelperiodo compreso all’incirca fra 1660 e 1720 la riconciliazio-ne del potere assoluto con i ceti dirigenti aveva costituito, co-me ha notato Jeremy Black, una caratteristica degli Stati mo-narchici, influendo sulla ricomposizione dei ranghi militari;l’esperienza piemontese dei reggimenti provinciali non si di-scostava da un simile contesto, rappresentando un interessantecaso di impiego di parte dell’aristocrazia provinciale in un ruo-lo che, se pur meno coinvolgente rispetto a quello rivestito da-gli ufficiali dell’ordinanza, si configurava ormai in modo non
storia militare e diplomatica 53
35 J. BLACK, European warfare.1660-1815, London, UCL Press, 1994 p. 53.36 M.S. ANDERSON, War and society in Europe of the old regime, 1618-1789, Phoenix
Mill, Sutton, 1998 (I ed. Leicester, Leicester University Press & Fontana paperbacks,1988), pp. 114-121; A. CORVISIER, Armées et sociétés en Europe de 1494 à 1789, Paris,Presses Universitaires de France, 1976, pp. 62-72.
fittizio 37. In questa prospettiva, in relazione cioè a fenomenipolitico-sociali di ampia portata e di durevoli conseguenze, l’i-dea dell’eccezione finisce col risultare sfumata.
La questione dell’eccezione piemontese – da non respin-gere, ma da ridefinire – tocca peraltro non solo il tasto mili-tare, bensì anche alcuni aspetti della storia civile che hannocaratterizzato quel «bisogno di patria» di cui si è tornati adiscutere per arginare le attuali improbabili definizioni identi-tarie 38. Rimane da approfondire e verificare, sulla scorta dinuove indagini, quanto la storia italiana dello Stato sabaudo siacorsa semplicemente parallela o invece spesso tangente a quelladel resto della Penisola. Se, infatti, come scrive Barberis, «nonfurono simpatia, garbo e cultura, ma senso dello Stato, tecnicaamministrativa e militare e anche un certo patriottismo» a ca-ratterizzare il bagaglio eccentrico con cui nell’Ottocento i pie-montesi si disposero all’incontro con gli altri italiani, va valu-tato nel tessuto sociale e istituzionale e nel medio-lungo pe-riodo in che misura e con quali forme il caso piemontese abbiasviluppato il giusto contemperamento fra pubblico e privato,fra governo centrale e logiche autonomistiche sul territorio. L’or-ganizzazione di un seminario di studi incentrato su questi nodicostituirà l’occasione per offrire spunti concreti contro quell’i-solamento in cui in Italia sembrano da troppo tempo esseretenuti gli studi dedicati agli spazi subalpini in età moderna.
L’ottica interna non basta, come non basta collegare le solerealtà statuali che convissero negli spazi subalpini fra Quattro eSettecento. Oltre alla prossima occasione di studio sull’«ecce-zione piemontese», proporrei di partire dall’indagine di alcunielementi istituzionali indispensabili per cercare confronti entroe al di fuori dei territori oggetto di studio dell’ISPRE: a) l’organizzazione amministrativa delle truppe,b) i costi della guerra,
54 paola bianchi
37 J. BLACK, European warfare cit., pp. 89-92.38 W. BARBERIS, Il bisogno di patria, Torino, Einaudi, 2004.
c) il sistema del reclutamento,d) la composizione dei vari corpi armati (di linea e provincia-
li, nazionali e stranieri).Su una traccia analoga avevo costruito il citato Onore e me-
stiere, limitandomi, però, al periodo compreso fra fine Seicentoe Settecento. In vista della realizzazione di una nuova storia delPiemonte su un arco cronologico più articolato, quasi tutti que-sti punti restano ampiamente scoperti.
L’analisi degli uffici, dei ruoli, delle gerarchie e degli organi-grammi può rientrare in un’opera di sicuro interesse quale ilRepertorio delle cariche che i responsabili delle altre aree tematichepropongono di realizzare ciascuno per il proprio ambito dicompetenza.
Dopo gli studi condotti da Enrico Stumpo 39 non si sono,in particolare, incrementate le ricerche sulla finanza di guerra esul sistema di riscossione straordinaria delle imposte. Resta evi-dente e più complessa da colmare la carenza di dati sul Quat-trocento e sul Cinquecento. Dirò fra poco della ricchezza dialcune serie documentarie conservate presso l’Archivio di Statodi Torino con sede in via Piave, dalla cui schedatura sistematicasi potranno evincere non pochi nuovi dati.
Quanto ai sistemi del reclutamento, grosse lacune impedi-scono, poi, di legare la fase tardo-medievale della composi-zione delle milizie feudali alla successiva crescita di corpi, dif-ferenti per compiti e livello professionale, destinati a confluire,da fine Seicento, in un esercito ormai vicino al concetto mo-derno di struttura permanente. L’idea stessa di milizia feudale,il tramite creato dal servizio armato fra l’antico sistema signo-rile e il servizio dovuto a un principe territoriale sfugge, a oggi,a una definizione chiara, al di là dei pur utili suggerimenti for-niti da Castelnuovo 40 e Barbero 41.
storia militare e diplomatica 55
39 E. STUMPO, Finanza e Stato moderno cit.; ID., Guerra ed economia cit. 40 G. CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo,
Milano, Angeli, 1994.41 A. BARBERO, Gruppi e rapporti sociali, Torino sabauda. Dalle lotte di parte e dalle congiure
La svolta sotto il ducato di Carlo Emanuele II è più o menonota. Ma nei due secoli precedenti qual era la situazionedurante i periodi di guerra, quando accanto alle milizie dove-vano intervenire corpi mercenari stipendiati temporaneamente?Che ne era dei militari in tempo di pace? E inoltre, quale era ilruolo e il peso degli stranieri presenti in Piemonte?
Nei documenti cinque-secenteschi la presenza di un certonumero di italiani emerge costantemente. Penso, per fare unesempio in cui mi sono imbattuta più di una volta nei mieistudi, al ruolo dei ferraresi Villa. Ma si potrebbero anche citarealtre figure d’origine veneta e padana.
In una ricostruzione di lungo periodo biografica e prosopo-grafica si potrà valutare la permeabilità degli spazi subalpini(dai primi domini sabaudi ai territori via via annessi) rispettoagli Stati europei e/o italiani. Indagini di questo tipo trovereb-bero giusto spazio sia in un nuovo Dizionario biografico dei piemon-tesi (fatta salva la dovuta giustificazione dell’attribuzione geo-grafica) sia nel Repertorio delle cariche civili e militari cui facevocenno sopra.
Il discorso militare andrà declinato in parallelo con quellodiplomatico, e in tal senso risulterà importante considerare:a) fasi e caratteristiche delle alleanze internazionali,b) reti di relazione non solo fra dinastie regnanti, ma tra fami-
glie di tradizione militare-diplomatica.È evidente che, anche sotto questo profilo, la realizzazione
di un Dizionario biografico e di un Repertorio delle cariche gioverebbead approfondire il ruolo delle principali figure e dei contesti incui esse agirono.
Contemporaneamente sarebbe utile svolgere un monitorag-gio sistematico delle ricerche svolte in ambito italiano e inter-nazionale privilegiando la storia francese, inglese, spagnola e di
56 paola bianchi
antisabaude a un nuovo equilibrio sociale e istituzionale, Il mutamento dei rapporti fra Torino e le altrecomunità del Piemonte nel nuovo assetto del ducato sabaudo, La vita e le strutture politiche nel quadro dellabipolarità signore-comune, in Storia di Torino, II, Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura di R. Comba, Torino, Einaudi, 1997, pp. 161-241, 373-419, 543-582.
alcuni Stati tedeschi (Baviera, Sassonia, Prussia-Brandeburgo):la pubblicazione di carteggi e memorie, gli atti di convegni sul-la politica estera dei vari Stati, l’edizione di repertori di fonti.
La stesura del Repertorio delle cariche e del Dizionario biografico do-vrebbe costituire lo strumento per avviare una mappatura dellearee militarmente più interessanti:a) zone fortificate,b) centri di accasermamento,c) punti nevralgici per il controllo dell’ordine pubblico,d) tragitti segnati dai trasferimenti delle truppe.
Dalla bibliografia esistente si riesce a evincere il quadro del-le principali fortificazioni e piazzeforti; non si conosce tuttaviala situazione per l’intero periodo compreso fra metà XV-metàXIX secolo. Quello che dovrebbe costituire un oggetto di par-ticolare attenzione per le indagini condotte dall’ISPRE è l’inte-razione fra insediamenti militari e popolazione civile: la rica-duta sull’economia, le forme di disciplinamento, la creazionedi luoghi di sociabilità.
L’accasermamento, com’è noto, rappresentò un fenomenorelativamente tardo per l’età moderna, durante la quale il dirit-to d’alloggio militare fu praticato in modo itinerante e tempo-raneo fino al XVIII secolo. Quartieri e ospedali militari stabilifurono conosciuti da non molti centri subalpini, che fra Set-tecento e Ottocento, eclissato il ruolo strategico di altre aree,consolidarono la propria fisionomia di baluardi. Mi sono oc-cupata, ad esempio, della crisi progressiva dei quartieri dell’an-tico «castello» di Asti fra Seicento e Settecento come conse-guenza dell’arretramento della posizione della città rispetto al-la frontiera orientale dello Stato42. Ho studiato, poi, i lunghieffetti degli insediamenti militari in un’area delicata dal puntodi vista del controllo dell’ordine pubblico come il Cuneese 43.
storia militare e diplomatica 57
42 P. BIANCHI, Una piazzaforte sabauda cit.43 P. BIANCHI - A. MERLOTTI, Cuneo in età moderna cit.
Le storie di città che l’ISPRE si propone di promuovere sonodestinate a verificare anche, caso per caso, i riflessi sul lungoperiodo del rapporto fra insediamenti militari e civili in uncontesto che assistette all’avvicendarsi di dominazioni diverse.Se si dovesse partire da città come Vercelli da un lato, Novara eAlessandria dall’altro, si potrebbe analizzare il peso di un pre-sidio influente fino alla prima metà del XVII secolo e di piaz-zeforti (soprattutto Alessandria) diventate strategiche fra Settee Ottocento grazie al fatto di essere state risparmiate dagliabbattimenti dei piani napoleonici.
Più complesso è individuare percorsi e tappe militari lungole vie di comunicazione, non solo durante le fasi di guerra, maanche nei periodi di pace. Aspetti di questo tipo possono avereun’incidenza sullo studio stesso dei rapporti diplomatici e del-le alleanze fra Stati. È curioso, per esempio, che un tema resonoto da un famoso libro di Geoffrey Parker come il consoli-darsi del Camino Español, che percorreva longitudinalmente i do-mini sabaudi, sia rimasto di fatto estraneo alla storiografia de-dicata alla Savoia e al Piemonte 44. Eppure il forte legame stabi-lito dal duca Emanuele Filiberto con la corona spagnola avevagarantito all’esercito di Filippo II il regolare impiego di queltragitto, che collegava i campi dei Paesi Bassi con le terre delMilanese. Nel 1571 la Spagna aveva inaugurato una sede d’am-basciata stabile a Torino, assicurando la reciprocità delle rap-presentanze al Ducato di Savoia, che fin dagli anni Sessanta delCinquecento aveva incaricato un ambasciatore in Spagna e unagente a Milano. Dal 1602 al 1609 Carlo Emanuele I accettòche un tercio fosse inviato dal Milanese per sorvegliare i princi-pali centri della Savoia posti lungo la «via spagnola», ma nel1609 le guarnigioni spagnole furono espulse dalle terre sa-voiarde, mentre si preparava il terreno all’alleanza del duca conla Francia. Allontanato, il tercio de Saboya era destinato a soprav-
58 paola bianchi
44 G. PARKER, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659, Cambridge,Cambridge University Press, 1972 (ried. 1995).
vivere sino alla fine del XVII secolo, inserito nella guarnigioneordinaria di Milano 45. Un caso come questo si presenta comeuna vicenda esemplare nella prospettiva di una storia insiememilitare e diplomatica, ma le notizie sono scarse e inspiegabil-mente assenti i riferimenti bibliografici.
Figure istituzionali assai utili per uno studio di questo tipoerano i governatori, i cui compiti, al limite fra il militare e ilcivile, permettono al ricercatore di seguire i rapporti fra leguarnigioni, le fortezze, i centri urbani sede di presidio con ilterritorio e la popolazione locale, ma anche lo scontro fratruppe nemiche, le tensioni in zone di confine e altre questionid’ordine pubblico. Ai governatori e ai comandanti di città efortezze Alice Raviola, Andrea Merlotti e io abbiamo dedicatopagine di alcuni saggi individuando ricche serie di documentiprodotti nell’ambito delle sedi di governatorati, che andrannoconsiderate tra gli strumenti d’indagine da privilegiare46.
4. Strumenti di ricerca
I temi suggeriti prevedono che il lavoro venga svolto in granparte su fonti primarie. La descrizione dello stato dell’arte edei problemi aperti giustifica, in tal senso, l’utilizzazione didocumenti di diversa natura, che andranno selezionati evitandodi ricadere in quel torinocentrismo i cui limiti e rischi sonoindicati in tutti i progetti qui uniti.
Raccolta ed esaminata la bibliografia esistente, alla qualefaccio cenno soffermandomi sui titoli più recenti, ho tentato
storia militare e diplomatica 59
45 P. BIANCHI, La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia e i rapporti del Piemonte con laFrancia e la Spagna. Da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II, in Guerra y Sociedad en laMonarquía Hispánica cit., vol. I, pp. 189-216.
46 Cfr. il mio Spunti per una discussione sulle fonti di storia militare cit., dove illustro i risul-tati delle ricerche condotte negli ultimi anni da studiosi fra cui, sul Piemonte, Merlottie Raviola.
di delineare gli oggetti delle future indagini con particolare at-tenzione ad alcune piste di ricerca che andranno tuttavia incre-mentate nel corso degli studi svolti dall’ISPRE.
Una prima riflessione va dedicata alle potenzialità degli ar-chivi di Torino, che raccolgono il materiale necessario per laricostruzione delle vicende precedenti e successive all’annessio-ne di alcuni territori subalpini, come il Marchesato di Saluzzo,la cui storia politico-rituale fra la metà del Due e la metà delCinquecento è stata studiata nella tesi di dottorato di LuisaGentile 47. Lo sguardo da Torino non basta per restituire la sto-ria di altri spazi: per esempio il Monferrato, la cui realtà di«micro-Stato» si trova dispersa in fonti possedute anche adAlessandria, Casale, Acqui, Milano, Mantova, Simancas, comeha bene illustrato Alice Raviola 48. Quanto poi ai rapporti di-plomatici, alle questioni di polizia e ordine pubblico, ai con-flitti di frontiera con Stati confinanti è ovvio che occorra farriferimento a fondi non unicamente piemontesi.
D’altro canto, molto degli archivi di Torino resta da sfrut-tare. Sui temi militari e diplomatici si sono prevalentemente in-terrogate le serie conservate nella sede Corte: Materie militari;Materie politiche per rapporto agli esteri, Lettere ministri; Ma-terie politiche per rapporto agli interni, Lettere di particolari.Limitandosi a queste carte si resterebbe in un solco già ampia-mente battuto, cui occorre invece affiancare la consultazione si-stematica (non la semplice campionatura) dei fondi delle se-zioni Finanze, Camerale e Guerra, custodite in via Piave. Sitratta, in questo caso, di un materiale copioso, solitamentecitato in relazione ad atti notarili (Insinuazione), regolamenti(Segreteria di Guerra, Ordini generali e misti), patenti di no-
60 paola bianchi
47 L. GENTILE, Processi di rappresentazione del potere principesco in area subalpina, XIII-XVIsecolo: riti ed emblemi, tesi di dottorato in Storia medievale, XV ciclo, in cotutela tra leUniversità di Torino e di Chambéry, a.a. 2000-2003.
48 B.A. RAVIOLA, Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-Stato (1536-1708), Firenze, Olsckhi, 2003.
mina e registrazioni di stipendi ad personam o ad annum (Patenticontrollo Finanze, Patenti e commissioni).
Credo di non sbagliare sostenendo che, dai vecchi ma pre-ziosi lavori di Giuseppe Prato e Luigi Einaudi, che risalgono aiprimi anni del Novecento, nessuno studio tanto ambizioso siapiù stato compiuto con l’intento di analizzare i meccanismiistituzionali che regolavano la produzione di questi documenti,indispensabili per comprendere molti aspetti dell’organizza-zione militare e diplomatica dello Stato e numerosi dettagli suirapporti tra le varie aree territoriali 49. La lettura e l’interpreta-zione dei bilanci che Prato ed Einaudi descrivevano un secolofa attraverso la prima e la seconda archiviazione del fondo Fi-nanze (per il periodo della guerra di successione spagnola e perquello immediatamente precedente e seguente le riforme delleSegreterie di Stato del 1717) andrebbero riprese sfruttando ilfatto che oggi si possiedano più inventari di un tempo e che sisia resa disponibile, ordinata e rinumerata, una ricca serie dimazzi afferenti al fondo Real Casa.
Osservato sul lungo periodo, il funzionamento delle Azien-de economiche sabaude si configura in parte come un’aggrega-zione territoriale delle tesorerie, in parte come una non linearegiustapposizione di funzioni. Nel 1630, per esempio, la Teso-reria della Real Casa, che eseguiva i pagamenti delle spese com-piute dalla corte (la «famiglia» del sovrano, compresi i prin-cipi legittimi e i figli legittimati), fu separata dalla Tesoreria dimilizie e da quelle di Artiglieria e di Fabbriche e Fortificazioni;sopravvivevano ancora due Tesorerie generali, a capo rispettiva-
storia militare e diplomatica 61
49 Mi riferisco in particolare a Il costo della guerra di Successione spagnuola e le spese pubblichein Piemonte dal 1700 al 1713 (1907) e a La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII(1908) di Giuseppe Prato, a Le entrate pubbliche dello Stato sabaudo nei bilanci e nei conti dei teso-rieri durante la guerra di successione spagnola (1907) e a La finanza sabauda all’aprirsi del secoloXVIII e durante la guerra di successione spagnola (1908) di Luigi Einaudi. Sul contesto storio-grafico da cui nacquero i lavori di Prato ed Einaudi rinvio a L. ATTANASIO, GiuseppePrato (1873-1928). Biografia e storiografia (1873-1914), tesi di laurea in Storia moderna,Facoltà di Lettere, Università di Torino, rel. Prof. G. Ricuperati, a.a. 1991-1992.
mente dei territori del Piemonte e della Savoia, che drenavanodenaro ricavato dai tributi diretti e indiretti (tasso, gabelle, ac-cense, privative) nella Tesoreria della Real Casa. Nel 1698 ledue Tesorerie generali furono infine unificate.
Ma che peso avevano le spese militari e diplomatiche suibilanci generali prima del Settecento? Quali erano le forme dicontrollo e i passaggi istituzionali? Come erano stati inglobatio sostituiti dagli uffici sabaudi gli organi amministrativi dellearee territoriali annesse ai domini dei Savoia? Sono tutti nodiin gran parte da sciogliere, essenziali in vista della progettatacompilazione del Repertorio delle cariche civili e militari.
Risulterà in tal senso necessaria la lettura incrociata dei do-cumenti conservati nei fondi Camerale, Finanze e Real Casa(presso la sede dell’Archivio di Stato di Torino di via Piave),che coprono prevalentemente gli anni a partire dalla fine delSeicento, ma che possono offrire spiragli anche su periodi pre-cedenti.
Si prendano le carte del Controllo generale di Finanze (nelfondo Finanze), composte da circa 1000 mazzi e registri, da-tati 1692-1859. Fra essi esistono anche copie di documenticinquecenteschi. Si tratta di una serie, priva di ordinamento,che può riservare scoperte interessanti. È bene ricordare infattiche il Controllo, sorto nel 1575, fu riformato nel 1717. L’uf-ficio registrava tutti gli ordini di pagamento dello Stato; le rela-tive lettere patenti emesse dal sovrano erano archiviate contem-poraneamente anche dalla Camera dei Conti (oggi nella sezio-ne archivistica Camerale). Il Controllo generale delle Finanzesospese l’attività nel periodo napoleonico, sul quale il silenziodegli studi è pressoché totale. Ricostituito dopo la Restaura-zione, fu infine soppresso nel 1859, cedendo le proprie com-petenze alla Corte dei conti del Regno d’Italia.
Per quanto ho potuto constatare a un primo sondaggio, iregistri conservati in Controllo Generale di Finanze conten-gono paralleli di spese di anni successivi, bilanci preventivi
62 paola bianchi
approvati e ripartiti in categorie, consuntivi suddivisi in trime-stri, «recapiti spediti e non pagati». In questi bilanci generaliconfluivano, cioè, informazioni prodotte da tutta una serie diuffici subordinati al Controllo: un materiale che è andato spes-so distrutto nei vari passaggi istituzionali, di cui risulta oggicomplesso ricuperare le tappe. Alla consultazione del Control-lo generale delle Finanze andranno confrontati perciò, semprein Archivio di Stato in via Piave, il materiale dell’Azienda dellaReal Casa (i Bilanci dell’Azienda di Sua Maestà, i Ristretti di bi-lancio, gli Spogli di bilancio) e inoltre singoli «articoli» del Came-rale, dove sono i fondi della Camera dei Conti.
Un discorso a sé merita l’Azienda delle Fabbriche e Fortifi-cazioni, la cui struttura si fa risalire ai provvedimenti del 1711.Se pur in modo meno formalizzato, competenze amministra-tive su costruzioni civili e militari erano però già state asse-gnate nel Seicento, quando era stato attivato un Consiglio delleFabbriche e Fortificazioni composto da funzionari, ingegneri eartiglieri (ruoli non ancora militarizzati). Dalle Aziended’Artiglieria e di Fabbriche e Fortificazioni (definitesi nelcorso del Settecento, suddivise nel 1733, poi di nuovo riunitenel 1797) dipendevano maestranze – guardia-magazzini, con-tabili, misuratori, sovrastanti, collaudatori, munizionieri, esti-matori – le cui relazioni costituiscono una fonte preziosa perlo studio del territorio. Anche in questo caso occorrerà analiz-zare in parallelo registri e mazzi delle sezioni Guerra, Finanzee Camerale. Fra le carte della Camera dei Conti, dove sono fi-niti in parte gli atti del Consiglio della Fabbriche e Fortifica-zioni, segnalo l’art. 199, Sessioni tenute dal Consiglio sopra le Fabbrichee Fortificazioni (1633-1714), e l’art. 200 (1678-1683).
È auspicabile che, da un’approfondita schedatura di talifondi, si arrivi a risolvere questioni che la storiografia ha finoracuriosamente trascurato. Chi voglia considerare l’andamentodei bilanci in relazione al valore della moneta è costretto, non acaso, a un’imbarazzante sospensione del giudizio. Di quanto
storia militare e diplomatica 63
crebbero effettivamente, nelle varie fasi storiche, le spese per ladifesa dello Stato (uno degli argomenti cardine negli studidedicati al consolidamento degli eserciti negli Stati europei)?Le risposte non si possono trovare in dati numerici di valoreassoluto, ma vanno cercate in un preciso confronto diacronicoe sincronico. Il terreno delle indagini, da questo punto di vista,è davvero tutto da costruire, a dispetto di tante ricerche svoltesulle riforme politiche nel loro stadio progettuale.
Dicevo della necessità di individuare archivi sul territoriopiemontese, ma anche del fondamentale contributo che do-vrebbe derivare da raccolte di fonti straniere. È difficile deter-minare fin da ora elenchi e tipologie di documenti, la cui con-sultazione dipenderà dalle disponibilità organizzative dell’ISPRE
e dalle risposte offerte dai vari interlocutori istituzionali. Sipuò tuttavia immaginare di partire a selezionare nel territoriopiemontese un paio di centri interessanti per l’approfondi-mento dell’inizio dell’età moderna (Vercelli e Asti) e un paiodi altre realtà urbane significative soprattutto per il Settecentoe l’Ottocento (Alessandria e Novara). La scelta non risulte-rebbe casuale, giacché i fondi documentari di queste città ga-rantiscono un supporto archivistico e strutture di inventaria-zione più agibili di altri.
Quanto agli archivi italiani e stranieri, gioverebbe stabilirecontatti a distanza con alcuni ricercatori che possano costituireun tramite costante e qualificato. In Italia converrebbe avviare icontatti innanzitutto con Milano, Genova, Roma, proseguendocon Venezia, Firenze, Napoli. All’estero varrebbe la pena atti-varsi con gli archivi di Parigi (Archives des Affaires Étrangères,Archives Nationales, Bibliothèque Mazarine, Archives Militai-res - Service Historique de l’Armée presso Château de Vincen-nes), Simancas (Archivo General de Simancas, Estado, Milan,ed Estado, Saboya), Londra (Public Record Office, ForeignOffice e British Library, Manuscripts), Vienna (Kriegsarchiv eStaatsarchiv). I risultati di tali reti di ricerca potrebbero con-
64 paola bianchi
fluire e diventare oggetto di discussione nell’ambito di semi-nari da organizzarsi periodicamente con la partecipazione, investe di relatori, degli stessi collaboratori esterni. Si tratterebbedi uno strumento proficuo per la ricerca e, insieme, utile pergarantire un profilo internazionale all’ISPRE.
storia militare e diplomatica 65
TOMASO RICARDI DI NETRO
Stato e amministrazione.Rappresentatività, ordini intermedi e burocrazianel Piemonte d’Antico Regime
1. Stato dell’arte
Negli ultimi anni la crisi (vera o presunta) del modellodello Stato centrale alla ricerca di formule per lo più
legate al modello federale, derivata da una serie di complessemotivazioni che in parte sono da leggersi sulla scia della crisidello Stato nazionale o nazionalistico ottocentesco, ha portatosul piano storiografico a un nuovo interesse per l’evoluzionedelle strutture statuali e la loro reale applicazione. L’attenzioneviene infatti dedicata sia alla fase ottocentesca (che per l’Italiacoincide con il momento unitario) sia soprattutto a quella pre-cedente, cioè a quell’Antico Regime che ha visto l’emergere dialcuni problemi rimasti aperti, la nascita di alcune prassi ancorain uso oggi e viceversa l’abbandono di altre pratiche più antichedi cui però rimangono vivi echi, se non rimpianti. Se lo storicoè colui che guarda al passato con gli occhi del presente, certa-mente il tema dello Stato (sia come teoria, che come prassi) èoggi di estremo interesse, mentre sono aperti tentativi di ridefi-nizione del suo stesso significato, sia in termini di completorinnovamento, sia in termini di recupero di elementi tralasciati.
Le pagine che seguono cercheranno di delineare un quadrodi riferimento sul tema – Stato e amministrazione – in riferi-mento allo Stato sabaudo nei tre secoli moderni XVI-XVII-XVIII, cercando di tracciare un breve bilancio del panoramastoriografico, in modo da indicare punti di forza e lacune ecosì individuare spunti e modalità di ricerca per l’ISPRE.
Come è noto, nel giugno 1560 Emanuele Filiberto riunì perl’ultima volta gli Stati generali del Piemonte, l’assemblea tardo-medievale che vedeva le rappresentanza dei tre ceti – clero, feu-datari e rappresentanti delle città – e non li convocò più, nédiversamente fecero i suoi successori 1.
Nel 1717 Vittorio Amedeo II riformò in maniera radicalela struttura amministrativa dello Stato creando le tre Segreterie(Interni, Esteri, Guerra) a cui si affiancava l’apparato fiscalecon l’Agenzia Generale delle Finanze 2. Schematicamente i dueeventi segnano le tappe essenziali dell’evoluzione dello Statoassoluto creato dai Savoia: il primo eliminò ogni interferenzada parte dei ceti e ogni velleità di rappresentatività, sciogliendoil sovrano da legami con i propri sudditi; il secondo organizzòin maniera compiuta e razionale lo «Stato ben amministrato»(secondo la nota e riuscita espressione di Giuseppe Ricupera-ti 3), attraverso il quale venne prodotta e realizzata la grandefase delle riforme settecentesche.
Il 1560 e il 1717 sono le date solitamente citate che mar-cherebbero lo Stato sabaudo come paradigma dello Stato asso-luto o comunque come una delle esperienze meglio riuscite nelpanorama europeo. Sarà questo il quadro in cui nel corso delSettecento potranno prendere corpo i vasti programmi di ri-forme dei ministri Ormea e Bogino nella feconda stagione del-le riforme, anche se queste verranno pensate e realizzate senzail «soffio vitale dei lumi» 4.
Anche in Francia, lo Stato assoluto per eccellenza, era acca-duto qualcosa di simile nei contenuti, seppure con una diversaperiodizzazione. Nel 1614 Luigi XIII riunì per l’ultima volta
68 tomaso ricardi di netro
1 Cfr. H.G. KOENIGSBERGER, The Parliament of Piedmont during the Renaissance 1460-1560, in ID., Estates and Revolutions, Ithaca, Cornell University Press, 1971, pp. 19-79,oltre al fondamentale A. TALLONE, Parlamento sabaudo, Bologna, Zanichelli, 1928.
2 G. QUAZZA, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, Modena, STEM,1957, 2 voll. (ed. anastatica Cavallermaggiore, Gribaudo, 1992).
3 G. RICUPERATI, Le avventure di uno “Stato ben amministrato”. Rappresentazione e realtà nellospazio sabaudo tra Ancien Régime e Rivoluzione, Torino, Tirrenia, 1994.
4 Ibidem.
gli Stati Generali, destinati a non essere più convocati fino al 5maggio 1789. Analogamente in Spagna, le istituzioni omolo-ghe, i fueros, persero progressivamente di importanza (sostan-ziale oltre che formale) 5.
Eppure in ambedue i paesi il mito degli Stati generali conti-nuò vivo e forte per i due secoli successivi. Anche sotto LuigiXIV, ancora negli anni della Reggenza e sotto Luigi XV, perio-dicamente la richiesta delle loro convocazioni rimase una co-stante portata avanti in genere dai Parlamenti sovrani, i tribu-nali superiori, che – forti della loro pretesa competenza pub-blicistica, oltre che privatistica – in qualche modo si considera-vano porta parola della rappresentatività. In Spagna, sotto gliAsburgo i fueros dei vari Stati che componevano la monarchiaiberica – seppure depotenziati – continuarono a espletare leloro funzioni per tutto il Seicento. Fu Filippo V, insieme con isuoi ministri francesi usciti dalla scuola di Luigi XIV, ad abo-lirli a partire dal 1707 (nueva planta), non senza contrasti e op-posizioni. Nel caso poi della rivolta di Barcellona e della Cata-logna del 1705-1714, accanto ad altre considerazioni di carat-tere internazionale e sociale, non sono da tralasciare il ruolodella Disputaciò e del Consiglio generale della città di Barcel-lona, che rappresentavano tradizionalmente le istanze dell’inte-ra élite locale.
Il re ha in sé la perfezione della sovranità oppure questa sirealizza insieme con le rappresentanze dei suoi «popoli»? Ifautori alle due risposte possibili sono facilmente intuibili. Tut-tavia la domanda non può essere facilmente elusa con la sem-plice affermazione dello sviluppo dello Stato assoluto. L’inte-resse per tale questione, infatti, non riguarda solo gli aspettiistituzionali, ma si innesta su complesse dinamiche che vannodal piano sociale a quello religioso, come è facilmente intuibile
stato e amministrazione 69
5 Per un quadro generale sul dibattito e sulla prassi amministrativa, con una ampiacomparazione a livello europeo, cfr. A. DE BENEDICTIS, Politica, governo e istituzioni nell’Eu-ropa moderna, Bologna, il Mulino, 2001.
per il caso francese del primo Seicento, in cui grande feudalità,piccola nobiltà, toga e parlamenti si confrontano con i varisovrani e i loro potenti ministri, in un susseguirsi di vivaciopposizioni e di plateali ricomposizioni che traggono motivoanche nei duri e sanguinosi conflitti di religione. Anche per ilSettecento il dibattito non è di secondaria importanza. Anziviene fortemente rilanciato da Montesquieu che vede proprionei corpi intermedi il principale antidoto contro le derivedispotiche della monarchia.
Accanto alle esperienze più assolutistiche di Francia e Spa-gna, continuavano le esperienze invece più legate alla rappre-sentatività dei ceti sia di un regno come l’Inghilterra, sia diquella realtà estremamente complessa quale era l’Impero Ro-mano Germanico, che aveva fatto delle rappresentatività la suacifra. Una consolidata tradizione storiografica ha individuatonell’Inghilterra il paradigma della rappresentatività e del suoesito parlamentare, anche se tra la decapitazione di Carlo I(1649) e la Glorious Revolution la differenza concettuale restanotevole. Oltre a ciò la lettura del Seicento inglese fu (e forse èrimasta almeno ai non specialisti) influenzata dalla storiografialiberale ottocentesca che indicava in quelle esperienze il loropredecessore in opposizione al processo assolutistico continen-tale incarnato dal binomio Luigi XIV / Napoleone 6.
La decapitazione di Carlo I decretata dal Parlamento aLondra e la cruenta svolta assolutistica impressa dal cardinaleMazzarino contro le velleità del Parlamento di Parigi (allonta-namento del re da Parigi, controllata dal Parlamento, e assediodella città da parte del principe di Condé) avvengono ambeduedello stesso anno, il 1649. La coincidenza non è casuale, anziappaiono conseguenza l’una dell’altra.
Altri livelli di lettura possono essere individuati nella evi-dente contrapposizione tra mondo protestante e mondo catto-
70 tomaso ricardi di netro
6 Per tutti, cfr. il tradizionale e paradigmatico, G.M. TREVELYAN, La rivoluzioneinglese del 1688-1689, Torino, Einaudi, 1941 (ed. originale Oxford, 1938).
lico oppure, soprattutto per il periodo napoleonico, tra parla-mentarismo inglese (e corollario del libero mercato) e cesari-smo (e blocco continentale) sul continente.
Ancora differente risulta la situazione dell’Impero RomanoGermanico, dove la rappresentanza dei ceti assume la sua for-mulazione più completa, almeno dal punto di vista formale.Diete, tribunali e camere imperiali sono i luoghi (permanenti osaltuari) in cui i vari ceti, dagli elettori ai principi, dai nobilialle città, si ritrovano o hanno le loro compensazioni. La gran-de contraddizione della struttura imperiale, che ne minerà allaradice le fondamenta, fu la sovranità assoluta dei principaliprincipi (e delle relative unità statali) che lo componevano. Iltermine della Guerra dei Trent’Anni (1648) sancisce appuntola completa assunzione della sovranità da parte degli Elettori edei principi territoriali più importanti. A ciò si aggiunga che lamaggior parte di essi hanno costruito reti dinastiche di vastorespiro che li portano a regnare sovranamente anche su territorinon imperiali, creando complesse situazioni. In primis gliAsburgo, ma anche i Sassonia, o i Brandeburgo, o i Wittle-sbach, o gli Hannover, oltre che principi dell’Impero sono an-che sovrani di mezza Europa. Negli ultimi vent’anni la storio-grafia, specialmente tedesca, ha studiato con nuovo interesse lastruttura e l’apparato dell’Impero, vedendo in esso l’antidotoalle spinte egemoniche tedesche e il « luogo della compensa-zione» della patria tedesca, volendo così indicare come anchenel mondo tedesco non vi sia stata solo una cultura militare (equindi intrinsecamente egemonica)7.
L’orizzonte imperiale, in genere tralasciato dalla storiogra-fia piemontese, deve essere recuperato, in quanto anche il du-cato sabaudo appartenne, seppure con tutta una serie di distin-guo, alla «patria comune» dell’Impero 8.
stato e amministrazione 71
7 H. SCHILLING, Ascesi e crisi. La Germania dal 1517 al 1648, Bologna, il Mulino,1999 (ed. originale Berlino, 1989); ID., Corti e alleanze. La Germania dal 1648 al 1763,Bologna, il Mulino, 1999 (ed. originale Berlino, 1989).
8 G. TABACCO, Lo Stato sabaudo nel Sacro Romano Impero, Torino, Paravia, 1939.
Se dunque, come sembra, lungo tutto l’Antico Regime inogni parte d’Europa il problema della rappresentatività apparenon chiuso, la situazione piemontese si può considerare risoltadall’esperienza assolutistica di Emanuele Filiberto? ClaudioRosso lancia uno spunto di grande interesse quando affermache ancora a metà Seicento, alla fine della Guerra civile, leistanze per una nuova convocazione dei Parlamenti generalierano sentite e forti, anche se poi non trovarono attuazione.Anche Walter Barberis – seppure in un ambito differente –rappresenta un caso forse non sporadico di contrasto tra CarloEmanuele I e la Camera dei Conti a proposito di una nobilita-zione 9. Il contrasto, che si trascinò per otto lunghi mesi (dalgennaio all’agosto 1612), verteva sulla mancata interinazionedelle patenti di Camillo Taffini del feudo di Acceglio da partedei magistrati torinesi, che sostenevano la non congruità dellacifra pattuita per la cessione da parte del patrimonio ducale.Anche negli spazi sabaudi, dunque, fu sentito il problema dellarappresentatività e del suo corollario, cioè l’”indipendenza” del-le magistrature, che nell’Antico Regime si basava proprio sul-l’alienazione (e quindi la loro durata vitalizia) delle cariche? Sesì, in quali forme si manifestò? Oppure (al di là delle istanzegiuridiche) le varie élites (differenziate sia socialmente sia geo-graficamente) trovavano il modo di partecipare alla gestionedello Stato in qualche forma che le gratificava adeguatamente,come la corte o l’apparato statale?
Non che in Piemonte non esistessero forme di rappresenta-tività. Il potere cittadino è saldamente nelle mani della rappre-sentanze delle élites locali (anche se con forme progressivamentesclerotizzatesi), nelle piccole realtà come nelle grandi città,continuando immutata la lunga tradizione delle città comunalimedievali. Nel XIII-XIV secolo, l’ingrandimento dei dominisabaudi, tendenzialmente realizzatosi per « libere» dedizioni,
72 tomaso ricardi di netro
9 W. BARBERIS, Le armi del principe. La tradizione militare sabauda, Torino, Einaudi, 1988,pp. 82-90.
aveva garantito forme di auto-organizzazione e privilegi alle éli-tes delle città che ne erano entrate a far parte. Anche le cittàpiemontesi medievali, alla stregua dei quelle padane o del cen-tro-Italia, avevano i loro Consigli comunali divisi tra famiglie dehospitio e de populo, con una sostanziale chiusura di ceto, le cuiforme rimasero immutate per tutto l’Antico Regime 10. Ri-spetto alle altre esperienze italiane, evolutesi nella città-Stato epoi verso la signoria, le città piemontesi dovettero fare i conticon una realtà diversa, quella sabauda, che riuscì a imbrigliarneforze ed energie, senza tuttavia abolirne forme e privilegi. Unesempio per tutti: i Solaro sono presenti nel Consiglio comu-nale di Asti nel XII secolo, come nell’ultimo Settecento; paral-lelamente sono presenti alla corte orleanese del XV secolo,come a quella sabauda del XVIII (per non dire di quella ita-liana del XX).
Le élites cittadine, in genere divise tra nobili e borghesi (contutte le ambiguità e sfumature che i due termini possono rap-presentare), grazie alla loro trasformazione in patriziati (de fac-to, se non de jure), si sentono autorizzate a trattare con il poteredel principe e poi del sovrano valendosi della propria indipen-denza e auto-genesi.
Oltre che nella prassi, tracce di una simile impostazionefanno capolino di tanto in tanto (come nella storiografia filo-patrizia di Francesco Agostino Della Chiesa o di Filippo Ma-
stato e amministrazione 73
10 La questione è stata affrontata, ma non ancora risolta, per alcune realtà. Per Asti:L. CASTELLANI, Gli uomini d’affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l’Europa (1270-1312), Torino, Paravia Scriptorium, 1998, ed i saggi raccolti in Quando San Secondo diventògiacobino. Asti e la Repubblica del luglio 1797, a cura di G. Ricuperati, atti del convegno diAsti, 12-13 dicembre 1997, Alessandria, dell’Orso, 1999, pp. 127-178; per Saluzzo:L’annessione sabauda del Marchesato di Saluzzo. Tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica. Sec. XVI-XVIII, a cura di M. Fratini, atti convegno di Saluzzo, 1°-2 settembre 2001, Torino,Claudiana, 2004; per Vercelli: A. MERLOTTI, Da confine di Stato a province di periferia. Notesulla storia di Vercelli e Biella fra Sei e Settecento, in Arti figurative a Biella e a Vercelli. Il Sei e ilSettecento, a cura di V. Natale, Biella, Eventi&Progetti, 2004, pp. 9-19. Mancano tuttaviaancora studi puntuali sulle città più strettamente sabaude come Pinerolo, Ivrea, Biella,Savigliano, Fossano, e soprattutto uno sguardo comparativo d’insieme.
labaila), ma i contorni dell’intero fenomeno non sono certa-mente chiari e definiti 11.
I termini del rapporto sono: sovrano-città oppure Stato-ter-ritorio? Il primo binomio ha una connotazione secentesca an-cora carica delle ultime vestigia medievali legate alle città co-munali, mentre il secondo è già settecentesco, denunciando laconcreta applicazione degli stilemi dello Stato di Antico Regi-me, che poi troveranno pieno sviluppo nel corso dell’Otto-cento. Ma il binomio sovrano-città necessita di un’ulterioreanalisi: quale dei due termini ha la preminenza? La visionetorinocentrica non ha dubbi, ma quella localistica può ribaltaredecisamente il problema della fedeltà. Le rivolte di Mondovìdi fine Seicento hanno indicato chiaramente che la fedeltà vaalla patria, che per un abitante del basso Piemonte questa èMondovì con il suo districtus: la città dove ci sono il vescovo, isignori e il mercato. Il resto è distante. Giorgio Lombardi lo haindicato ancora recentemente12. Solo progressivamente la pa-tria si identifica con lo Stato. La parabola personale del mini-stro Ormea e di suo padre ne è un esempio lampante: Alessan-dro Marcello Ferrero, appartenente al patriziato urbano diMondovì e uno dei capi della seconda rivolta del sale, ha unorizzonte essenzialmente monregalese e finirà impiccato (sep-pure in effige), mentre il figlio sarà il grande ministro delloStato assoluto della prima metà del Settecento piemontese. Peril primo la patria è Mon-dovì, per il secondo lo Stato sabaudo.
74 tomaso ricardi di netro
11 A. MERLOTTI, Le nobiltà piemontesi come problema storico-politico: Francesco Agostino DellaChiesa tra storiografia dinastica e patrizia, in Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea, atti delconvegno svolto a Torino e Mondovì, 3-5 ottobre 2001, a cura di A. Merlotti, Torino,Zamorani, 2003, pp. 19-60.
12 G. LOMBARDI, I Ferrero nelle Guerre del sale (1680-1699): l’obbligo politico della “patria”cittadina allo Stato, in Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea cit., pp. 323-344. Sullevicende e sulla complessità della rivolta del sale monregalese, cfr. La Guerra del sale(1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco, a cura di G. Lombardi, 3 voll., Milano,Angeli, 1986.
2. Problemi aperti e proposte tematiche
a) Dinastia, corte, governo, élites
Il problema della rappresentatività permette di affrontare iltema delle forze in campo sulla scena di uno Stato d’AnticoRegime: dinastia, corte, governo, élites.
Ognuna delle componenti ha origine, evoluzione e aspira-zioni di sviluppo differente, di cui ampie zone d’ombra restanoda indagare soprattutto per coglierne appieno le interrelazioni.Anche per quanto riguarda la dinastia, che a primo avviso puòsembrare il settore meno stimolante, al di là dei sovrani, benpoco si conosce dei vari cadetti e dei vari illegittimi. Non visono valide ricostruzioni né della linea dei duchi di Nemours,né dei principi di Carignano 13 o dei conti di Soissons, al di làdi sporadici (e a volte non convincenti) accenni. Solo recente-mente è stato affrontato il tema dei figli naturali di EmanueleFiliberto e di Carlo Emanuele I, evidenziandone il ruolo all’in-terno della corte e dell’apparato militare sabaudo 14. Eppure ilruolo dinastico di questi apparenti corollari della dinastia eraben presente ai contemporanei, e il loro parere e la loro azione(ciascuno infatti è portatore di istanze politiche differenti) fon-damentale nel delineare la politica del sovrano. Il caso più evi-dente è quello della guerra civile tra madamisti e principisti(1638-1642), che sull’aspetto dinastico ha inserito profonde
stato e amministrazione 75
13 Sulle linee cadette dei Savoia cfr. A. MAINARDI, La famiglia dei Savoia Racconigi, in«Bollettino della Società di studi storici, archeologici ed artistici della provincia diCuneo», LII (1985), pp. 171-189; A.M. BERIO, Per una storia dei Savoia Racconigi, in«Bollettino storico bibliografico subalpino», XLII, n.s. VI (1940), pp. 60-107; G.BELTRUTTI, Briga e Tenda. Storia antica e recente, Bologna, Cappelli editore, 1954. Restainoltre utile il vecchio studio di de Panisse Passis Les comtes de Tende de la Maison de Savoie(Paris, 1889).
14 P. BIANCHI, Una riserva di fedeltà. I bastardi dei Savoia fra esercito, diplomazia e carichecuriali, in L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevoe prima età moderna, a cura di P. Bianchi e L.C. Gentile, Torino, Zamorani, 2006, pp. 305-360.
differenze sociali e politiche. Madamista sembra essere la gran-de feudalità e l’apparato centrale dello Stato, mentre principi-ste appaiono le élites urbane che si sentono emarginate dalla ca-pitale 15. Ma analoghe situazioni erano destinate a crearsi anchein seguito.
Anche per il Settecento il quadro non risulta adeguatamen-te investigato. Il complesso problema degli appannaggi deiprincipi cadetti non investe solo l’aspetto economico, ma so-prattutto quello della funzione del «fratello del re». Questapoteva risultare una risorsa, ma anche un potenziale fattore dicoagulo di un malessere sociale e politico, se non di un’opposi-zione vera e propria. L’esperienza appunto della guerra civile ela completa filofrancesità dei duchi di Nemours e dei conti diSoissons per tutto il Seicento fecero sì che nel Settecento l’e-ducazione dei principi fosse differente e si cercasse di coinvol-gerli nella vocazione statale sabauda. In tale ottica, nel Sette-cento i Carignano e il duca del Chiablese rappresentarono per-fetti esempi di “principi coordinati”, perfettamente integraticon la politica della linea regnante. Non è solo una questionedi maggior strutturazione dello Stato del Settecento rispetto alsecolo precedente, dove quindi le loro potenziali istanze paral-lele potevano trovare spazio, ma un reale problema sempreaperto. Ad esempio, in Francia l’azione di opposizione dellalinea cadetta degli Orléans è ben nota e fu certamente unadelle concause della Rivoluzione francese. Come pure nell’Ot-tocento sono evidenti i casi della Spagna e del Portogallo, dovele lunghe e sanguinose guerre civili (portatrici di istanze istitu-zionali, sociali ed economiche ben forti) si innestarono sucomplesse vicende dinastiche.
Quando nel 1741 nacque Benedetto Maurizio, duca del Chia-blese, si pose il problema di quale ruolo interno o internazionale
76 tomaso ricardi di netro
15 Anche la Guerra civile tra principisti e madamisti non ha ancora avuto il suocantore, cfr. ancora G. QUAZZA, La guerra civile in Piemonte 1637-1642. Nuove ricerche, in«Bollettino storico bibliografico subalpino», LVII (1959), pp. 281-321 e LVIII(1960), pp. 5-63.
ritagliare per il secondo figlio del re. Seguendo alcune sugge-stioni, al giovane duca sarebbe toccata l’eredità morale dei Savoia-Soissons, che nel 1736 si era esaurita con la morte del principeEugenio. Il trasferimento a Vienna, il matrimonio con una figliadell’imperatrice Maria Teresa, che gli avrebbe portato in dote ilducato del Tirolo, potevano fare sperare per lui un ruolo nellospazio imperiale simile a quello del grande cugino? Velleità dipadre o un organico progetto di politica internazionale?
Anche il ruolo dei Carignano e le loro strategie restano daindagare. Il matrimonio del IV principe, Luigi Vittorio (1721-1778), con Cristina d’Assia, sorella della testè morta Polissenad’Assia, seconda moglie di Carlo Emanuele III, sembra parlareil linguaggio della rappacificazione tra i due rami di CasaSavoia, dopo le incomprensioni della prima metà del secolo.Eppure tale matrimonio, già ipotizzato, non era stato ritenutoopportuno durante la vita della regina Polissena, in quantoavrebbe creato disparità di rango cerimoniale tra le due sorelle.Solo la morte di Polissena, dunque, aveva permesso il nuovomatrimonio.
Accanto al sovrano, il suo entourage, cioè la corte: un sog-getto tutto da studiare, non essendo il suo ruolo politico esociale ancora sufficientemente delineato. Alcuni studi hannoaffrontato il tema16 per il periodo di Emanuele Filiberto e diCarlo Emanuele I, senza tuttavia affrontare in maniera piena lastruttura della corte e la sua rilevanza. È da poco apparso unvolume miscellaneo ad opera, tra gli altri, di alcuni degli stu-diosi dell’ISPRE e curato da Paola Bianchi, sulla corte sabaudatra Quattro e Seicento, espressamente dedicato agli aspettisociali e politici, in genere rimasti offuscati rispetto a quelli –
stato e amministrazione 77
16 A. BARBERO, La corte ducale sotto Carlo II (1504-1553), in ID., Il ducato di Savoia.Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano (1416-1536), Roma-Bari, Laterza, 2002;C. STANGO, La corte di Emanuele Filiberto: organizzazione e gruppi sociali, in «Bollettino storicobibliografico subalpino», LXXXV (1987), pp. 445-502; P. MERLIN, Tra guerre e tornei.La corte sabauda nell’età di Carlo Emanuele I, Torino, SEI, 1991.
pur essenziali – artistici e architettonici 17. Ma del tutto in om-bra restano gli aspetti sei-settecenteschi, la cui rilevanza assumeinteresse se considerata in parallelo con le riforme amministra-tive contemporanee. Quale, ad esempio, il significato della mol-tiplicazione dei quadri cortigiani voluta da Vittorio Amedeo III:compimento dei percorsi precedenti oppure prodromo dellasclerotizzazione della struttura curiale del secolo successivo?
È necessario restituire alla corte il suo ruolo di cassa di ri-sonanza delle élites degli interi Stati sabaudi. La corte è unmicrocosmo dell’intero Stato, composta da principi, grandi no-bili, piccoli nobili, borghesi e popolani, attraverso il quale ilsovrano gestisce il proprio favore e mantiene il contatto – an-che personale – con i vari gruppi sociali. Secondo il costumedell’Antico Regime, il sovrano non ha contatti diretti, se non inparticolarissime eccezioni, con il resto della società, ma ascolta,parla e agisce attraverso la corte. Dalla prospettiva politica, inol-tre, le tensioni della corte sono tensioni tra gruppi di potere,portatori di reali interessi di rappresentatività ed economici.Funzionamento quotidiano, reclutamento, scandali e tensionisono tutti temi che una nuova stioriografia deve affrontare.
Nel caso delle grandi monarchie, come quella francese, laloro conoscenza ha permesso di comprendere meglio aspettidella grande politica e sfumature della politica estera. Anche inquesto caso, l’analisi prosopografica consentirà notevoli sor-prese. I rari casi in cui è stata effettuata, come in quello degliaiutanti di camera18 o della corte del principe Emanuele Filiber-to Amedeo di Carignano 19 nella metà del Seicento, ha datorisultati di sommo interesse.
78 tomaso ricardi di netro
17 L’affermarsi della corte sabauda cit.18 I. MASSABÒ RICCI - C. ROSSO, La corte quale rappresentazione del potere sovrano, in Figure
del Barocco in Piemonte. La corte, la città, i cantieri, le province, a cura di G. Romano, Torino,CRT, 1988.
19 I. MASSABÒ RICCI - A. MERLOTTI, In attesa del duca: reggenze e principi del sangue nellaTorino di Maria Giovanna Battista, in Torino 1675-1699. Strategie e conflitti del Barocco, a cura diG. Romano, Torino, CRT, 1993.
Infine, la corte è uno di principali luoghi dell’avanzamentosociale con la creazione di vere dinastie di cortigiani soprat-tutto per quanto riguarda il Seicento; ma anche nel Settecento,perfino nell’ultimo periodo, quando il movimento delle élitesviene giudicato sclerotizzato e sostanzialmente bloccato, si re-gistrano numerosi casi di mobilità sociale.
Anche l’aspetto formale della corte, con le sue complesseregole di cerimoniale, sono rimaste in ombra. Eppure il riccocerimoniale, che, dalla sua origine funzionale, spesso si tra-sformò in una vuota ripetizione di prassi desuete, nascondenelle sue pieghe esigenze sociali e politiche. Comprendere ilcerimoniale, leggerne le sottigliezze e giungere all’essenza deirapporti personali permette di rilevare, sia sul lungo periodoche sul breve (data la meticolosità delle descrizione degli eventicuriali), l’immagine della dinastia e della corte da un lato e deirapporti tra i vari personaggi dall’altra. Ad esempio i grandi esolenni eventi che segnarono sul piano formale l’assunzione deltitolo regio da parte di Vittorio Amedeo II nel 1714 sonoestremamente significativi. Le grandi cerimonie del 21 settem-bre 1714, festa di San Maurizio, protettore della dinastia,scelto come giorno di inizio del regno di Sicilia riflettono ilruolo dello Stato sabaudo nel contesto internazionale: lo rap-presentano sia il rinnovato baciamano delle varie istituzionidello Stato (Consiglio di Stato, Senato di Piemonte, Cameradei Conti, Consiglio dei Memoriali) e, soprattutto, la presenzadegli ambasciatori stranieri accreditati. L’eccezionalità dell’e-vento è rimarcata dal nuovo registro iniziato proprio in quelgiorno dal mastro delle cerimonie, Carlo Amedeo di Lusernamarchese d’Angrogna, smagliantemente rilegato in pergamenae ornato dal nuovo stemma regale impresso in oro, che abban-donava i più sobri registri secenteschi legati in semplice pelle.Anche le successive cerimonie che si svolsero a Palermo neimesi successivi evidenziano chiaramente due elementi: da unlato la celebrazione della nuova dignità regale quale fatto in
stato e amministrazione 79
grado di iniziare una nuova storia, dall’altro la volontà di rin-novare il rituale dei sovrani normanni sulla lunga scia di Fe-derico II e di Carlo V, rituale che venne utilizzato per l’entratatrionfale a Palermo (21 dicembre) e la solenne incoronazionenella Cattedrale (24 dicembre). Da segnalare la presenza alfianco dei sovrani del diciasettenne cadetto dei Carignano, ilprincipe Tomaso (1696-1715), forse destinato a ricoprire lacarica di viceré, sulla scia di Emanuele Filiberto (1588-1624),il principe d’Oneglia, che aveva ricoperto la medesima caricaper Filippo IV di Spagna nel 1620. Un valido compromessotra l’aspirazione dei siciliani ad avere tra loro il sovrano stabil-mente per marcare la centralità dell’isola nel nuovo Stato e lavolontà europea di Vittorio Amedeo II pervicacemente legatoallo spazio padano? Un progetto, quello di nominare viceré unprincipe del sangue, abortito per la precoce morte del principe,morto a 19 anni appena rientrato a Torino nel settembre 1715,e poi per il divaricarsi del destino tra Sicilia e Savoia.
La corte, dunque, come cassa di risonanza delle varie partidello Stato. Parallelamente, l’altro grande luogo politico pereccellenza è il governo: il sovrano ascolta tramite la corte e agi-sce tramite i ministri. Nella progressiva costruzione dello Statoassoluto, il tassello più complesso, quello cui il sovrano dedicòpiù energie, risulta proprio la creazione della catena di co-mando, dalla ideazione del proprio volere, alla sua definizionefino alla concreta applicazione. Dai consilia principis 20 tra Quat-tro e Cinquecento ai segretari di Stato21 del Seicento l’evolu-zione è lunga e complessa e la storiografia non sembra deli-neare un quadro omogeneo, indulgendo tra sovrani demiurgicie ministri onnipotenti.
Accanto all’apparato e alla cultura militare, è questo il set-tore più frequentato dalla recente indagine storica, con vari
80 tomaso ricardi di netro
20 I. SOFFIETTI, Verbali del Consilium cum domino residens del Ducato di Savoia. 1512-1532, Milano, Giuffrè, 1969.
21 C. ROSSO, Una burocrazia di antico regime. I segretari di Stato dei duchi di Savoia, 1559-1637, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1992.
contributi: per il Seicento di Rosso 22 e Stumpo23, per il Sette-cento di Ricuperati 24.
Quest’ultimo basa la sua ricostruzione delle strutture e del-l’evoluzione della macchina governativa e amministrativa sette-centesca su una innovativa serie di lavori sulle Segreterie diStato e sulle varie Aziende generali rimasti inediti 25, i cui esitisono poi confluiti nel suo saggio apparso ne Il Piemonte Sabaudo,edito nella Storia d’Italia di Giuseppe Galasso.
Delle varie strutture sono delineati sinteticamente il profiloed i rapporti tra i principali realizzatori della macchina statalesabauda dal Ferrero d’Ormea al Bogino al Perrone di San Mar-tino, in un complesso e articolato gioco tra le varie Segreteriedi Stato e Aziende economiche, che ne esalta sia il rigore am-ministrativo, sia l’afflato riformistico, a partire dalla granderiforma demiurgica del 1717 per giungere ai drammatici annidella Guerra delle Alpi (1792-1798) che interruppe program-mati e attesi esiti riformistici.
Eppure aspetti anche notevoli sono rimasti in ombra. Il mec-canismo della finanza pubblica attende una rivisitazione dopogli studi sul Seicento compiuti nel secondo dopoguerra daBulferetti 26 e per quelli sul Settecento di inizio secolo di
stato e amministrazione 81
22 C. ROSSO, Il Seicento, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, IlPiemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, Torino, Utet, 1994, pp. 127-267.
23 E. STUMPO, Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento, Roma, Istituto storicoitaliano per l’età moderna e contemporanea, 1979.
24 G. RICUPERATI, Le avventure di uno Stato “ben amministrato” cit., e ID., Il Settecento, in P.MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, Il Piemonte sabaudo cit., pp. 441-834.
25 E. BELLINI, Uomini e uffici nel Piemonte del Settecento. La Segreteria degli Interni (1717-1798), tesi di laurea, rel. prof. G. Ricuperati, Dipartimento di Storia, Università diTorino a.a. 1983-1984; V. CAMURRI, La Segreteria di Guerra nello Stato sabaudo. Gli uomini egli uffici, tesi di laurea, rel. Prof. G. Ricuperati, Dipartimento di Storia, Università diTorino a.a. 1985-1986; E. CUCCHI, La Segretaria degli Esteri dello Stato sabaudo. Uomini, ufficie compiti nel secolo XVIII, tesi di laurea, rel. prof. G. Ricuperati, Dipartimento di Storia,Università di Torino a.a. 1985-1986, 2 voll. Tutte e tre le tesi sono citate in G. RI-CUPERATI, Le avventure di uno Stato “ben amministrato” cit., e ID., Il Settecento cit.
26 L. BULFERETTI, Sogni e realtà del mercantilismo di Carlo Emanuele II, in «Nuova rivistastorica», XXXVII (1953); ID., Assolutismo e mercantilismo nel Piemonte di Carlo Emanuele II,in «Nuova rivista storica», XXXVII (1953); ID., La feudalità e il patriziato nel Piemonte di
Einaudi 27 e di Prato 28; così l’apparato amministrativo (ponti,strade, fiumi, educazione, carceri, assistenza, ospedali, scuo-le…) e la stagione della perequazione 29, oppure la strutturadiplomatica (sia nella capillarità delle rappresentanze estere edelle missioni straordinarie, sia nell’evoluzione della strategiainternazionale a Torino). Alcuni studi recentissimi, come quel-lo di Storrs 30 sulla diplomazia sabauda, sono di estremo inte-resse, anche se limitato al trentennio 1690-1720. Discorsoanalogo va condotto sull’amministrazione della giustizia, an-ch’essa sia nella componente locale (tra giudici statali e giudicifeudali) sia in quella centrale (i vari Senati e Camere dei conti).Il reclutamento e le biografie dei senatori di Piemonte delSettecento sono stati studiati da Enrico Genta nel 198331; tut-tavia il periodo precedente e le altre grandi magistrature (acominciare dalle Camere dei Conti) sono stati trascurati.
Parallelamente all’analisi delle istituzioni e del loro funzio-namento, per il Settecento si inserisce un’altra variabile, che sal-da il discorso amministrativo con la storia delle idee: cioè lagrande stagione delle riforme, indagata in molti degli aspetticulturali nel grande affresco di Franco Venturi 32, su basi get-tate già per la parte istituzionale e sociale da Guido Quazza 33
82 tomaso ricardi di netro
Carlo Emanuele II (1663-1675), in «Annali delle facoltà di lettere, filosofia e di magi-stero dell’Università di Cagliari» XXI (1953), pp. 365-624; ID., L’elemento mercantilisticonella formazione dell’assolutismo sabaudo, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LIV(1956).
27 L. EINAUDI, La finanza sabauda all’aprirsi del XVIII secolo e durante la guerra di successionespagnola, Torino, Sten, 1908.
28 G. PRATO, La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII, Torino, Paravia, 1908. 29 I. MASSABÒ RICCI, Perequazione e catasto in Piemonte nel secolo XVIII, in Città e proprietà
immobiliare in Italia negli ultimi due secoli, a cura di C. Carozzi e L. Gambi, Milano, Angeli,1981, pp. 133-152.
30 C. STORRS, War, diplomacy and the rise of Savoy, 1690-1720, Cambridge, CambridgeUniversity Press, 1999.
31 E. GENTA, Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino, Deputazione subal-pina di Storia patria, 1983.
32 F. VENTURI, Settecento Riformatore, v. I Da Muratori a Beccaria, Torino, Einaudi, 1969;e ID., Saggi sull’Europa illuminista. Alberto Radicati di Passerano, Torino, Einaudi, 1955.
33 G. QUAZZA, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento cit.
e per quella giuridica da Mario Viora 34. L’impressione di chiscrive è che tali indagini siano rimaste al livello ideativo, al li-vello della norma, lasciando la prassi, la concreta applicazione,in una zona oscura. Torino elabora le riforme e la provincia laapplica secondo un mero automatismo? Eppure le differenzetemporali e interpretative tra gli impulsi riformatori del centrotorinese e le realizzazioni nelle singole realtà locali sono evi-denti chiavi di lettura di resistenze, di differenti priorità, dirigidità al cambiamento.
In ombra è rimasto anche il momento di sintesi dell’azionedi governo e delle modalità decisionali. Ministri, funzionari ecommis si riuniscono e definiscono un’azione comune o agi-scono autonomamente? Quali i rapporti di forza fra loro? Ladocumentazione in tale settore non sembra generosa, tuttavial’ampia esperienza delle giunte del secondo Settecento, createad hoc, in cui sono presenti i principali esponenti dello Stato,può essere il punto di partenza in tal senso. La loro documen-tazione, infatti, è assai abbondante e può esemplificare la prassidi governo d’Antico Regime.
Un ultimo accenno riguarda il quarto elemento qui preso inesame, cioè le élites, siano esse nobili o borghesi. Merlotti trat-teggia qui i contorni per una analisi del rapporto tra società eceti. Tuttavia nell’area tematica qui presa in considerazione nonpuò essere tralasciato il rapporto della presenza dei ceti nellestesse strutture dello Stato. Paradossalmente lo Stato è compo-sto da esponenti di quegli stessi ceti che in qualche modotende a limitare per prendere definitivamente il sopravvento.Né può essere altrimenti, visto il ridotto “capitale umano” ac-culturato cui fare riferimento. E questo non solo in relazionealla nobiltà, ma anche alle famiglie civili o borghesi. Il rap-porto tra Stato e nobiltà non è semplice: uno dei problemi chequi hanno rilevanza è la loro completa e fluida compenetra-
stato e amministrazione 83
34 M. VIORA, Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il Re di Sardegna. Storiaesterna della compilazione, Torino, Bocca, 1928.
zione. Gli strumenti dello Stato non possono che essere gliesponenti delle varie nobiltà presenti in Piemonte. I governa-tori, così come gli ufficiali o i diplomatici, provengono dallanobiltà, anche la più alta (e quindi potenzialmente la più riot-tosa); l’apparato statale proviene sostanzialmente da fasce piùbasse della nobiltà o da famiglie civili acquisitrici di feudi. Cer-tamente nello Stato essi agiscono individualmente e non comegruppo, ben consapevoli dei livelli differenti di azione. In ognicaso, nell’Antico Regime le fedeltà plurime non rappresentanocertamente un problema insormontabile 35. Studi analitici (senon statistici) sulla presenza delle grandi famiglie nell’apparatostatale, oppure sulle strategie di carriera delle famiglie nell’am-bito dello Stato, della corte, dell’amministrazione non sono an-cora stati prodotti per gli spazi piemontesi. Chi scrive ha ini-ziato già da vari anni una ricerca sui circa 1500 esponenti dellafamiglia dei conti di Piossasco attraverso i nove secoli di esi-stenza (XII-XIX secolo). Le strategie di adattamento, di svi-luppo, di offensiva, di ri-dispiegamento sul panorama sociale epolitico, specialmente nei secoli moderni, risultano continue eproficue riuscendo a mantenere il complesso sistema parentalea dispetto della crisi di alcuni singoli rami, che non riescono atenere il passo con i tempi. Ricerche analoghe di lungo periodoper famiglie che rappresentino tipologie differenti per antichi-tà, censo, collocazione geografica potranno esplicitare intendi-menti e orizzonti altrimenti rimasti sottintesi.
b) L’amministrazione locale
Alcuni accenni sono già stati fatti sugli aspetti locali dello«Stato ben amministrato» dei Savoia nella complessa dinami-ca del rapporto tra centro e periferia. La descrizione delle ma-gistrature locali, delle loro funzioni e della loro evoluzione sem-
84 tomaso ricardi di netro
35 T. RICARDI DI NETRO, Piemontesi nell’Europa delle corti fra Seicento e Settecento, in VittorioAlfieri aristocratico ribelle, a cura di R. Maggio Serra, F. Mazzocca, C. Sisi, C. Spantigati,Milano, Electa, 2003, pp. 202-205.
bra attualmente lacunosa, se non con riferimento a bibliografieobsolete. Lo stesso dicasi per l’analisi dei rapporti intercorrentitra i rappresentanti locali (sindaci - consiglieri comunali - segre-tari) e i rappresentanti del governo centrale (governatori - inten-denti - prefetti). Che rapporti intercorrono tra il governatore(che rappresenta il sovrano ed in genere proviene dall’alta nobil-tà) e il suo vice, il sergente maggiore (espressione dell’élite citta-dina), che in qualche modo devono occuparsi delle medesimefunzioni? Ancora: quali rapporti nascevano tra le magistraturee i funzionari ordinari rispetto a quelli straordinari che veni-vano creati a Torino e poi inviati nella varie province per la so-luzione di determinati problemi? Gli eventuali contrasti pos-sono considerarsi casuali, oppure esprimono malesseri sociali,politici e economici profondi?
Parallelamente alla descrizione e alla periodizzazione delle va-rie istituzioni e magistrature, resta aperto il problema della con-creta realizzazione delle riforme nelle realtà locali. In primis l’ap-plicazione del regolamento dei pubblici del 1775, la grande leg-ge quadro delle amministrazioni comunali che risulterà una del-le tappe più importanti del riformismo sabaudo, ma che saràsoggetta ad adattamenti e a procrastinamenti tattici. Ad esem-pio Alessandria, la cui élite – forte del ruolo di ceto dirigente diuna città-fortezza – ha in mano una concreta arma di contrat-tazione rispetto ad altri centri, continuerà a non recepirlo nellagestione di tipo decurionale36. Ospedali, scuole, carceri, assi-stenza, caserme sono alcuni dei settori di intervento delle ri-forme amedeane sviluppate nel corso del Settecento. Ad essi siaggiungono ponti, argini, canali, strade e comunicazioni. Il lun-go periodo di pace seguito alle guerre di metà secolo certa-mente favorì gli investimenti nelle infrastrutture. Tuttavia la lororealizzazione avvenne secondo priorità non investigate, seguen-do un modello che prevedeva tempi e modalità differenti.
stato e amministrazione 85
36 A. MERLOTTI, L’enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento,Firenze, Olschki, 2000, pp. 139-158, in particolare sulla situazione e sull’azione deldecurionato alessandrino durante le guerre settecentesche.
Un cinquantennio prima Vittorio Amedeo II si era com-portato in maniera analoga nell’introduzione di una delle suepiù importanti riforme, cioè la catastazione e la conseguenteperequazione fiscale. Il progetto, pensato unitariamente, in real-tà – come è ben noto – venne applicato in tappe progressive apartire dalla Savoia per poi coinvolgere le varie province pie-montesi. Il processo di catastazione non era tuttavia ancoraconcluso negli anni di Vittorio Amedeo III.
Alcuni settori del riformismo sabaudo sono stati studiatipiù di altri. Se l’istruzione, specialmente quella torinese, haprodotto i lavori di alcuni ricercatori (da Marina Roggero 37 aPaola Bianchi 38), come in parte anche l’assistenza pubblica(Sandra Cavallo 39), altri temi sono stati solo sfiorati. Inoltre,anche per i settori testè citati, la visione torinocentrica sembraavere la preminenza rispetto alle altre realtà cittadine e provin-ciali.
Nell’ambito della storia del Piemonte, dal punto di vista del-l’amministrazione, resta l’ambiguità della definizione dei con-fini, non definita e forse non definibile se non sulla base del-l’attuale ripartizione statale e amministrativa. Il problema sorgein riferimento alle componenti dello Stato sabaudo oggi nonappartenenti al Piemonte: cioè Savoia40, Nizzardo e, soprat-
86 tomaso ricardi di netro
37 M. ROGGERO, Scuola e riforma nello Stato sabaudo. L’istruzione secondaria dalla Ratio studio-rum alle Costituzioni del 1772, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1981.
38 P. BIANCHI, L’Università di Torino e il Governo provvisorio repubblicano (9 dicembre 1798-26 maggio 1799), in «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», XXVI (1992), pp. 241-266; EAD., L’Università di Torino dopo la chiusura nella crisi dell’Antico regime (1792-1798). Losfaldamento e la sopravvivenza dell’organizzazione didattica, in «Annali della Fondazione LuigiEinaudi», XXVII (1993), pp. 353-393; EAD., Fra università e carriere pubbliche. Strategie nellanomina dei rettori dell’ateneo torinese (1721-1782), in «Annali della Fondazione Luigi Einau-di», XXIX (1995), pp. 287-389; G.F. GALEANI NAPIONE, Del modo di riordinare la RegiaUniversità degli Studi, introduzione, note e cura di P. Bianchi, Torino, Deputazione subal-pina di storia patria, 1993.
39 S. CAVALLO, Charity and power in early modern Italy: benefactors and their motives in Turin(1541-1789), Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
40 J. NICOLAS, La Savoie au XVIIIème siècle. Noblesse et bougeoisie, Paris, Maloine, 1978, 2voll.
tutto, Valle d’Aosta41 e Sardegna42. Al di là di ogni altro tipodi considerazione, dal punto di vista amministrativo tutte que-ste hanno avuto grandi similitudini rispetto alle vicende delPiemonte strictu senso. Anzi in più casi le riforme furono attuatenelle regioni periferiche prima di essere estese all’intero Stato.Di particolare interesse (l’ISPRE potrebbe dedicare proficuecampagne di studio) è la Valle d’Aosta, la quale presenta unulteriore elemento significativo nel dibattito sulla rappresenta-tività, cioè la sopravvivenza dell’istituto di origine medievaledella «paria» (cioè della rappresentanza sociale della nobiltàorganizzata in quanto tale) e delle sue magistrature antiche, chenon furono coinvolte nelle varie riorganizzazioni sei-settecen-tesche. Anche in questo caso i privilegi antichi facevano aggiosulle spinte riformistiche. Solo reiterate e progressive piccolemodifiche all’ordine costituito erano in grado di modificare lasituazione senza spezzare il legame profondo tra le realtà localie il centro.
3. Linee di ricerca ed esiti editoriali
Nella pluralità di linee d’indagine che le pagine precedentihanno rapidamente tratteggiato si individuano tre filoni su cuifar convergere intendimenti ed energie, in modo da creare unsistema omogeneo, confrontabile con quello degli altri temi diricerca. L’obiettivo è quello di creare una griglia di letturauniforme per il periodo considerato (1450-1850).
Uomini, istituzioni, luoghi: questi sono i tre filoni. Unnuovo Dizionario degli uffici e delle cariche sarebbe essenziale percomprendere la macchina amministrativa sabauda. La mappa-
stato e amministrazione 87
41 Progetto per una storia della città, a cura di M. Cuaz, Quart, Musumeci, 1987.42 A. MATTONE, Assolutismo e tradizione statutaria. Il governo sabaudo e il diritto consuetudina-
rio del Regno di Sardegna (1720-1827), «Rivista storica italiana», CXVI (2004), III, p.926 e sgg.; I viceré di Sardegna, atti del convegno (24-26 giugno 2004), a cura di P.Merlin, Roma, Carrocci, 2006.
tura delle varie istituzioni, sia a livello centrale che locale, nonè mai stata realizzata, e neppure una descrizione sistematica.Lo studio di un singolo ufficio contiene il rischio dell’astra-zione dal contesto istituzionale e amministrativo in cui era in-serito; mentre lo studio complessivo (o comunque il momentounitario ultimo di tale ricerca) permetterà di dare un’immagineorganica della macchina amministrativa in ogni sua compo-nente.
Descrizione dell’ufficio, delle sue competenze e soprattuttodella prassi dell’azione quotidiana attraverso l’analisi degli ar-chivi o della corrispondenza prodotta. Il tutto in un quadrodiacronico che ne faccia emergere mutazioni ed evoluzione.Ovviamente il maggior dettaglio permetterà di comprenderemeglio il complesso della struttura amministrativa. Oltre a ciò,tali ricerche non potranno prescindere dall’indicazione dei per-sonaggi che hanno ricoperto tali cariche.
Ne consegue l’importanza di un nuovo Dizionario biografico deipiemontesi, per cogliere l’elemento umano, le carriere, le aspira-zioni dei funzionari statali. Seguire lo svolgersi delle biografiein ambiti statali differenti permetterà di comprenderne megliol’azione. Alcune recenti ricostruzioni biografiche, basate sugli«scritti dell’io», quali epistolari, memorie e relazioni d’ufficio,realizzate nell’ambito dell’attività del Laboratorio di studi sto-rici sul Piemonte e gli Stati sabaudi, hanno voluto riportare l’at-tenzione verso un simile approccio 43.
La terza prospettiva di ricerca è quella delle storie di città,in cui gli elementi già evidenziati troveranno una diversa com-posizione comparata. Su questo tema rimando a quanto scrittoda Alice Raviola, soprattutto per l’esperienza dello Schedario sto-
88 tomaso ricardi di netro
43 T. RICARDI DI NETRO, “Fidel amant, sincer ami, tendre époux”. Uomini, valori e patrimonidelle nobiltà d’antico regime nella corrispondenza di Casimiro e Marianna San Martino di Cardè(1795), Torino, Zamorani, 2003; A. MERLOTTI, Il silenzio e il servizio. Le Epoche princi-pali della vita di Vincenzo Sebastiano Beraudo di Pralormo, Torino, Zamorani, 2003; B.A.RAVIOLA, “Il più acurato intendente”. Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino e la Relazione dellostato politico economico dell’Asteggiana del 1786, Torino, Zamorani, 2003.
rico-territoriale, che rappresenta un formidabile strumento diricerca, attualmente inedito, ma di cui varrebbe la pena di pro-durre esiti editoriali, specialmente se mirati a particolari unitàterritoriali. Oltre agli studi sui singoli luoghi, potranno essereintrapresi quelli su distretti o sub-regioni di particolare signifi-cato (similmente a quanto proposto da Raviola sul Monfer-rato). Città, dunque, ma anche luoghi che creano apparte-nenza, che numerosi esistono in Piemonte, sia per lunghe per-sistenze (il Saluzzese, erede dell’antico marchesato) sia per mo-tivi geografici (le Langhe).
Ulteriori riflessioni andranno spese sulla periodizzazionedegli esiti editoriali, in modo da realizzare opere che abbianoautonomia anche singolarmente. Individuare nuclei territoralioppure nuclei di personaggi con omogeneità temporale, di car-riera, di azione servirà – parafrasando quanto è stato scritto daGalasso nella prefazione alla sua Storia d’Italia – a individuare i«fattori» (cioè «determinate strutture economiche, determi-nati equilibri sociali e una vita civile particolare») che com-pongono la storia del Piemonte, senza raccontare una succes-sione di fatti accaduti in un territorio 44.
stato e amministrazione 89
44 G. GALASSO, L’Italia come problema storiografico. Introduzione alla Storia d’Italia, diretta daG. Galasso, Torino, Utet, 1979.
BLYTHE ALICE RAVIOLA
Territori e poteri.Stato e rapporti interstatuali
1. Orientamenti storiografici su spazi e territori sabaudi
Nel dibattito storiografico sulla formazione degli Stati re-gionali o territoriali dell’ultimo decennio spicca l’assenza
del Piemonte. Scorrendo uno dei volumi che più hanno contri-buito ad animarlo – Origini dello Stato. Processi di formazione statalein Italia fra medioevo ed età moderna 1 – le citazioni riservate aglispazi sabaudi sono poco meno di dieci e del tutto passeggere:una sulla politica di adesione alla Francia condotta a metàQuattrocento dalla Lombardia sforzesca con il coinvolgimentodei duchi di Savoia 2; una sulla Savoia come baluardo naturalecontrollato dagli spagnoli in funzione antifrancese dopo Ca-teau-Cambrésis 3; altre su Torino capitale e corte nel Cinque-cento4; due sulla precoce modernità del ducato 5. Gli Stati sulla
1 A cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1994. Il libro,che raccoglie gli atti del convegno di Chicago, 26-29 aprile 1993, fa parte della collanadegli Annali dell’Istituto storico italo-germanico (Quaderno 39).
2 Cfr. ivi R. FUBINI, Lega italica e ‘politica dell’equilibrio’ all’avvento di Lorenzo de’ Medici alpotere, pp. 51-96, in particolare p. 81 dov’è commentata l’infeudazione di Genova e Sa-vona concessa a Francesco Sforza da Luigi XI nel 1464: «Prezzo reale dell’investiturasu Genova era infatti l’impegno del duca di Milano a farsi garante della fedeltà deiduchi di Savoia al re di Francia, implicandolo pericolosamente nei conflitti transalpinie stimolandone le mire espansionistiche (particolarmente verso Asti e Vercelli, antichidomini viscontei), in modo ancor più incompatibile con la ‘colleganza italiana’».
3 A. MUSI, Stato e relazioni internazionali nell’Italia spagnola, ivi, pp. 133-143, p. 137.4 E. FASANO GUARINI, Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza
degli Stati in età moderna?, ivi, pp. 147-185, p. 175 (con riferimento all’« impetuosa cre-scita di Torino»), e M. FANTONI, Corte e Stato nell’Italia dei secoli XIV-XVI, ivi, pp. 449-466, p. 451.
5 G. MUTO, Modelli di organizzazione finanziaria nell’esperienza degli stati italiani della primaetà moderna, ivi, pp. 287-302, p. 290 (dove si accenna al «Piemonte sabaudo, che per
cui genesi tardomedievale riflettono gli autori dei vari saggisono altri (verrebbe da dire gli altri), riassunti in una questioneposta sul tappeto da Elena Fasano: «Repubblica di Firenze eRepubblica di Venezia; Stato visconteo-sforzesco e ducati pa-dani; Regno di Napoli: di che avviare finalmente una storiacomparata degli ordinamenti territoriali degli Stati nella primaetà moderna?» 6. Stati ai quali va aggiunta la Repubblica diGenova, il cui caso è di riferimento in numerose pagine dellibro.
Eppure, alla luce di nuovi lavori 7 e dell’esperienza di chi staavviando ricerche in tale direzione, non si può dire che ilPiemonte, inteso il nome nella sua accezione più ampia, nonpresenti a partire dal XV secolo tratti comuni a quelli messi inevidenza per le entità statali più studiate:1 - la volontà di compattare i domini territoriali (reali o ri-
vendicati) sminuendo il peso delle autonomie locali (piccoliprincipati, comunità e contadi, enclaves imperiali o di altranatura);
2 - la partecipazione attiva alle relazioni interstatuali con glialtri potentati italiani ed europei;
3 - l’importanza della base feudale riscontrabile anche nelducato di Milano o nel Meridione;
4 - lo sviluppo degli apparati burocratico-militari;5 - la costruzione di una dialettica non solo tra il centro e le
periferie, bensì policentrica.
Ma, più che lamentare la lacuna, è bene chiedersene il per-ché. L’impressione è che lo spazio sabaudo sia stato escluso da
92 blythe alice raviola
molti versi mostra un insospettabile gradiente di ‘modernità’»), e G. CHITTOLINI, Il‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato, ivi, pp. 553-589, p. 576.
6 E. FASANO GUARINI, Centro e periferia cit., p. 166.7 A. BARBERO, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, Roma-
Bari, Laterza, 2002. Ma ora, sebbene con particolare attenzione al fenomeno dellecorti, si vedano pure i saggi del volume L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites inPiemonte fra tardo medioevo e prima età moderna, a cura di P. Bianchi e L. C. Gentile, Torino,Zamorani, 2006.
una visione d’insieme dei processi statuali della penisola nontanto o non solo perché ritenuto ad essi estraneo quanto per-ché ancora fortemente condizionato dalla stessa storiografiapiemontese che, nonostante la parziale revisione operata – nona caso e come si è ricordato nell’Introduzione – da alcuni medie-visti, ha individuato nel 1560 l’anno di nascita di uno Statofinalmente moderno. I punti evidenziati poco sopra sono statitalora trascurati o sottovalutati nella convinzione che, nella suaeccezionalità motivata dalla posizione geografica e dal calco dimodelli francesi, il Piemonte non avesse nemmeno vissutoquelle dinamiche e si fosse formato sin da subito sotto l’egidaprogettuale della dinastia sabauda, predominante, accentratricee poco contrastata. È così che, anche in sintesi recenti 8, delducato di Savoia come Stato territoriale si inizia a parlare daglianni di Emanuele Filiberto e non prima, come se i tentativiconcreti e insistenti messi in atto da Carlo II, se non dai suoipredecessori, di riorganizzare la compagine statale non meri-tassero attenzione perché apparentemente scoordinati e per lopiù infruttiferi.
Non si tratta, naturalmente, di voler forzare l’interpreta-zione costringendo il caso sabaudo ad aderire a modelli con-vincenti elaborati per altre realtà. L’idea, anzi, è di utilizzarlicome termini di paragone ed eventualmente di verifica, pro-vando però a studiare con criteri aggiornati il trascuratissimotardo Quattrocento e l’epoca delle guerre italiane, periodi incui, con tutta probabilità, affondano le radici sia la politica ter-ritoriale sabauda sia i suoi riflessi in ambito estero.
Va precisato, a questo punto, cosa s’intende per territorio omeglio per territori e poteri, secondo l’espressione adottata neltitolo di questo progetto. Dare una definizione precisa ed esau-
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 93
8 Cfr. per esempio la Storia degli antichi stati italiani, a cura di G. Greco e M. Rosa,Roma-Bari, Laterza, 1990; P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, IlPiemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, Torino, Utet, 1994, e G.G. ORTU, Lo Statomoderno. Profili storici, Roma-Bari, Laterza, 2001 (qui, in particolare, p. 97).
riente non è semplice, ma si tenterà di tracciarne una che tengaconto dei molteplici fattori storici che caratterizzano ogni ter-ritorio e delle differenti valutazioni storiografiche di cui sonostati e sono oggetto. Oltre ai cinque aspetti che ho già elencatoe che non vanno disgiunti da questo discorso, tra i fattori chesi possono ritenere parte costitutiva di un territorio considero:a) un’area geograficamente delimitata da elementi naturali (o
giudicati tali nel corso del tempo) e/o da confini politici; b) l’insieme delle risorse ambientali ed economiche che ne pro-
vengono e i modi di sfruttarle; c) l’insistenza sul territorio stesso di centri di potere politico e
fiscale; d) la compresenza di enti ecclesiastici che vi abbiano la cura
delle anime, edifici e terreni.
Si è fatto cenno nell’Introduzione ai due approcci metodolo-gici che hanno condizionato, dagli anni Settanta, lo studio de-gli Stati italiani: uno, quello della Storia d’Italia Einaudi, più in-fluenzato dalle suggestioni provenienti dalle «Annales» e dal-l’incrocio tra discipline non necessariamente storiche; l’altro,della Storia d’Italia Utet, più incline ad accettare una tradizionaleripartizione geo-politica e cronologica delle aree studiate. En-trambe hanno preso in esame il territorio accentuando ora l’u-na ora l’altra caratteristica (l’economia da un lato, ad esempio,e il ruolo delle città capitali dall’altro) e solo in tempi relativa-mente vicini, anche grazie agli spunti provenienti dalle discus-sioni sollevate da testi come Origini dello Stato, si è provato a su-perare la dicotomia imposta dai due modelli coniugando temie percorsi di ricerca intersecabili.
Per la storia del Piemonte, tuttavia, va registrato anche inquesto caso un certo ritardo. Escludendo i lavori della scuoladi Tabacco, che hanno tenuto e tengono assai conto dell’intera-zione tra poteri e territorio, ma che, essendo dedicati al Me-dioevo, esulano dal nostro campo d’azione, i due orientamenti
94 blythe alice raviola
individuati hanno generato studi e interpretazioni quasi oppo-ste e difficilmente conciliabili. Per quello più istituzionale, sin-tetizzato ancora una volta da Il Piemonte sabaudo, il territorio, vi-sto sostanzialmente da Torino, è uno spazio su cui governarecancellando le tracce delle indipendenze passate. Per i ricerca-tori ispirati alla lezione dell’antropologia storica o, volendo ci-tare un autore, a Edoardo Grendi e ai suoi lavori sulla Ligu-ria 9, il territorio acquista vita proprio quando non è letto dallacapitale o attraverso le sue fonti, presentando all’osservatoreuna realtà puntiforme, insofferente verso il potere centrale ecapace di autoregolarsi mediante un sistema empirico basato sufaide, fazioni, composizioni e compromessi sociali 10.
È evidente, almeno a mio parere, che ciascuno dei dueapprocci ha in sé elementi di indubbia efficacia, consentendo ilprimo di conoscere nel dettaglio i programmi concepiti e messiin atto dallo Stato territoriale e il secondo, nella sua otticamicro-storica, di vagliarne l’effettiva capillarità. Meno utile, senon sterile, è invece la persistente frizione tra i due modi diconcepire la storia piemontese: se è vero, infatti, che è impossi-bile (e inutile) far combaciare visioni che partono da presup-posti totalmente divergenti, mi pare altrettanto necessariosuperarne i limiti più evidenti rinunciando all’eccessivo centra-lismo della prima e correggendo il vero e proprio rifiuto dellacategoria Stato della seconda. Che lo Stato esistesse e si muo-vesse secondo meccanismi evolutisi dal XV secolo è ormaiassodato, così come lo è il fatto che al suo interno sopravvives-sero, nascessero o prosperassero forme alternative di poteresocio-economico.
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 95
9 Da citare sono almeno Il Cervo e la Repubblica: il modello ligure di antico regime, Torino,Einaudi, 1993, e, per i travagliati contorni di Piemonte, Monferrato e Genovesato, Lapratica dei confini. Mioglia contro Sassello, 1725-1745, in «Quaderni storici», 63 (1986), pp.811-845.
10 A. TORRE, Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delleLanghe tra Sei e Settecento, in «Quaderni storici», n. 63 (1986), pp. 775-810.
Pertanto, studiare oggi gli spazi sabaudi significa aver pre-sente il più possibile l’intreccio tra strutture statali e realtàlocali; il che è fattibile dando maggior vigore agli studi di ca-rattere prosopografico che consentono di analizzare la compo-sizione sociale dei ceti dirigenti della capitale e delle città delducato e il ruolo di questi non solo nella vita politica, maanche nella gestione delle risorse territoriali di cui disponevanoda supervisori o da proprietari (o in entrambe le vesti). La dia-lettica tra lo Stato e le amministrazioni municipali, che è statasin qui vista per lo più a senso unico, presenta infatti una talevarietà di sfaccettature sul lungo periodo da costituire uno deiprincipali banchi di prova per chi voglia rimodernare la letturadegli spazi sabaudi e completarne la conoscenza. A tutt’oggi,salvo grazie a pochi lavori di matrice localistica, chi conosceper esempio la situazione del Novarese o del Verbano in etàmoderna? Solo riequilibrando obiettivi e aree di ricerca saràpossibile acquisire una visione d’insieme di uno Stato che èrimasto composito fino a metà Settecento (non si dimentichi,inoltre, la Sardegna e ancor prima la breve parentesi siciliana) ein cui il modello assolutistico, già esaltato dalla pubblicisticacontemporanea, sublimato dalla storiografia sabaudista e ripro-posto anche in tempi non lontani 11, ha funzionato fino a uncerto punto.
Un segnale di apertura storiografica proviene in verità dadue spazi dell’attuale Piemonte meridionale: il Saluzzese e ilMonferrato. Potrà apparire paradossale, ma non lo è, il fattoche siano stati entrambi non sabaudi e che solo in piena etàmoderna, il primo nel 1601, il secondo nel 1708, siano statiuniti al ducato. Proprio la loro origine altra, infatti, ha destatol’interesse degli studiosi che hanno cercato o stanno cercando
96 blythe alice raviola
11 Cfr. G. SYMCOX, L’età di Vittorio Amedeo II, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX
- G. RICUPERATI, Il Piemonte sabaudo cit., pp. 271-438, di cui si vedano soprattutto leconsiderazioni finali (pp. 426 sgg.), commentate poi con scetticismo da G.G. ORTU, LoStato moderno cit., p. 80.
di coglierne le peculiarità, la storia pregressa all’annessione e inquesta le difficoltà di assimilazione. Del Monferrato – di cui siè occupata chi scrive 12 anche a seguito di una suggestione diClaudio Rosso che giustamente deplorò l’assenza di letteraturasulla «regione, vero e proprio crocevia di esperienze e influen-ze»13 – dirò solo che si è rivelato un terreno di lavoro proficuoe meritevole di ulteriori approfondimenti. Distogliere losguardo dal Medioevo è servito a mettere in luce dinamichepolitico-territoriali del tutto intersecantisi con quelle sabaudedel tardo Quattrocento e della prima metà del Cinquecentononché caratteristiche interne che offrono valide spiegazionialla sostanziale impermeabilità dell’antico marchesato alle rifor-me sabaude del XVIII secolo 14. Sono in programma, inoltre,nuove iniziative sui Paleologo – di cui, nel 2006, si sono cele-brati con varie iniziative i 700 anni dall’ingresso in Monferra-to15 – che proprio nel cruciale XV secolo, più volte ostaco-lando la politica estera dei duchi di Savoia, seppero trasfor-mare Casale in diocesi e capitale 16 secondo modelli padaniestranei al Piemonte stricto sensu.
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 97
12 Cfr. B.A. RAVIOLA, Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708), Firenze, Olschki, 2003, e EAD., Le immagini di un territorio. Descrizioni del Monferratoin età moderna, introduzione a Cartografia del Monferrato. Geografia, spazi interni e confini in unpiccolo Stato italiano tra Medioevo e Ottocento, atti del convegno, Acqui Terme - Nizza Mon-ferrato - Casale Monferrato, 11-13 marzo 2004, a cura di B.A. Raviola, Milano, Fran-co Angeli, 2006, pp. 19-44.
13 C. ROSSO, Il Seicento, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, IlPiemonte sabaudo cit., pp. 173-267, p. 858.
14 P. BIANCHI, Stato nello Stato? Appunti sull’incompiuta perequazione del Monferrato a fineSettecento, in Cartografia del Monferrato cit., pp. 221-255.
15 Oltre a una serie di giornate di studi che hanno avuto luogo in località legate aldominio dei Paleologo (tra queste segnalo il seminario di Trisobbio del 30 settembre2006, I Paleologi di Monferrato: una grande dinastia europea nel Piemonte tardomedievale), tra CasaleMonferrato, Moncalvo e Serralunga di Crea il 14-15 ottobre 2006 si è svolto il conve-gno «Quando venit marchio Grecus in terra Montisferrati ». L’avvento di Teodoro I Paleologo nel VIIcentenario (1306-2006) coordinato scientificamente da Aldo A. Settia.
16 A. SETTIA, «Fare Casale ciptà»: prestigio principesco e ambizioni familiari nella nascita di unadiocesi tardomedievale, in «Rivista di Storia Arte Archeologia per le Province di Alessandriae Asti», XCVI-XCVII (1987-88), pp. 285-318.
Analogo discorso si può fare per il Saluzzese su cui sonostati pubblicati gli atti del convegno L’annessione sabauda del mar-chesato di Saluzzo promosso dalla Società di Studi Valdesi 17 e, tra2004 e 2005, quelli delle giornate di studio sui marchesi Lu-dovico I e Ludovico II organizzate dalla Società di studi storicidella Provincia di Cuneo 18. Nel primo caso le analisi dei parte-cipanti hanno insistito sulla diffusione di movimenti etero-dossi in un marchesato prossimo alla fine della sua autonomiae sulle prime operazioni di governo messe in opera dai Savoiacon l’ausilio della dinastia stessa dei di Saluzzo; nel secondo sisono invece sondate le fasi di consolidamento di quest’ultima,restituendo la reale dimensione politica, tutt’altro che piccola oinsignificante, del suo dominio quattrocentesco. Inutile ricor-dare che l’anticipazione al 1450 del termine a quo per lo studiodel Piemonte di età moderna consentirebbe di mettere a fruttoquesti risultati e di porli a confronto con i processi di forma-zione e sviluppo del ducato subalpino.
Ribadisco poi il principio per cui la ricognizione socio-isti-tuzionale non possa andare disgiunta da quella economica eche, in tale ambito, si dovrebbe dar voce non solo alla produt-tività delle zone considerate o alla qualità della produzione, maanche ai gruppi subalterni che ne furono il motore. È andatoin parte in tale direzione un volume sulle Valli Belbo e Bor-mida, tra gli esempi più recenti di storia del territorio piemon-tese, curato, non a caso, da un modernista di scuola grendiana
98 blythe alice raviola
17 L’annessione sabauda del marchesato di Saluzzo tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica. Secc.XVI-XVIII, atti del XLI convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi inItalia, Torre Pellice - Saluzzo, 1-2 dicembre 2001, a cura di M. Fratini, Torino,Claudiana, 2004.
18 Ludovico I marchese di Saluzzo. Un principe tra Francia e Italia (1416-1475), atti del con-vegno, Saluzzo, 6-8 dicembre 2003, a cura di R. Comba, Cuneo, Società per gli studistorici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2003, e Ludovico II marchese diSaluzzo, condottiero, uomo di Stato e mecenate (1475-1504), atti del convegno, Saluzzo, 10-12dicembre 2004, a cura di R. Comba, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologicied artistici della provincia di Cuneo, 2005.
(Torre) 19. L’idea è stata quella di isolare un’area geografica-mente omogenea ma amministrativamente divisa tra Stato sa-baudo e Monferrato gonzaghesco per analizzarne più da vici-no i percorsi socio-economici e la comunanza di influenze agri-cole, commerciali, culturali, artistiche. Avendo preso parte all’i-niziativa, mi è lecito dire che non è forse del tutto riuscita: icontributi, politematici, non sempre dialogano tra loro e mipare abbia prevalso la tendenza ad accentuare la vocazione eco-nomica delle due valli senza tener troppo conto degli sviluppipolitici in chiave diacronica. Tuttavia va detto che il libro èfrutto di riflessioni maturate in seno a un più ampio progetto,concepito da Renato Bordone con l’ausilio dello stesso Torre(nonché di Sandro Lombardini e Paola Guglielmotti) e por-tato avanti da un decennio con il sostegno della Regione Pie-monte con il nome di Schedario storico territoriale dei Comuni piemon-tesi [SSTCP]20. Lo Schedario si prefigge di studiare il territorioprendendo in esame ogni singolo insediamento che oggi costi-tuisca Comune, attraverso una scheda preformata che i ricerca-tori (soprattutto storici medievisti e modernisti, tra cui la sot-toscritta) devono compilare fornendo nella prima parte dati dicarattere tecnico (popolazione, superficie, etc.) e storico (dio-cesi, origine della comunità, enti ecclesiastici, feudo, etc.) edelaborando nella seconda, detta parte narrativa, un profilodella comunità in oggetto che si soffermi soprattutto sui suoisviluppi territoriali, dalla genesi del nucleo abitativo alla crea-zione di un catasto all’andamento demografico più recente.Completato per il Torinese, il Monregalese, l’Astigiano e l’Ales-sandrino, si tratta, come si può intuire, di un corpus assai vastodi informazioni (e, ne si è consapevoli, di interpretazioni) al
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 99
19 Tra Belbo e Bormida. Luoghi e itinerari di un patrimonio culturale, a cura di A. Torre ed E.Ragusa, Asti, Provincia di Asti, 2003.
20 Il materiale finora raccolto sotto forma, appunto, di schede dedicate ai singoliComuni della Regione è ora disponibile on-line (www.regione.piemonte.it/cultura/gua-rini/schede/at/dwd, cui far seguire il nome del Comune di cui si desidera consultare lavoce).
quale attingere per arricchire la bibliografia esistente e conoscerefonti di prima mano provenienti dagli archivi locali. Sempre dal-l’esperienza dello SSTCP è derivato un convegno sullo spaziopolitico locale tenutosi ad Alessandria durante il quale, anchegrazie alla comparazione con altre aree della penisola (ilGranducato di Toscana o la Puglia, ad esempio), è stato avviatouno stimolante dibattito su alcuni aspetti nodali dell’evoluzioneterritoriale del Piemonte di età moderna: la polverizzazione deicentri abitati (a tutt’oggi è la regione italiana con più Comuni),la lunga durata di alcuni processi (incastellamento, insignori-mento, etc.), la disomogeneità amministrativa di alcune zone (leprovince di nuovo acquisto, ma anche le aree montane)21.
Altrettanto proficue si stanno rivelando le ricerche su Fron-tiere e confini nell’Italia moderna finanziate dal Ministero dell’Uni-versità e della Ricerca in qualità di PRIN (Progetto di rilevanteinteresse nazionale) per il quadriennio 2003-07 e portate avan-ti dalle Università di Verona, Venezia, Padova, Udine, Milano,Alessandria, Pisa e Torino22. Dell’unità di ricerca di quest’ul-tima hanno fatto parte alcuni degli autori dei papers finalizzatiall’orientamento scientifico dell’ISPRE (Bianchi e Merlotti) econ essa ancora collabora chi scrive, con compiti amministra-tivi e un’indagine in corso su fiumi e frontiere; è innegabile chela possibilità di confrontarsi con gli indirizzi storiografici dialtri ambiti accademici su temi complessi e poliedrici quali ilconcetto stesso di confine – sulle cui varie accezioni si tornerà
100 blythe alice raviola
21 Ne sono appena usciti gli atti: Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contem-poranea, a cura di R. Bordone. P. Guglielmotti, S. Lombardini, A. Torre, Alessandria,Dell’Orso, 2007.
22 I primi risultati tangibili sono costituiti dai volumi Confini e frontiere nell’etàmoderna. Un confronto fra discipline, a cura di A. Pastore, Milano, Franco Angeli, 2007; Allefrontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna, a cura di C. Donati, Milano,Franco Angeli, 2006; Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime, acura di A. Torre, Milano, Franco Angeli, 2007; Comunità e questioni di confini in Italia setten-trionale (XVI-XIX sec.), a cura di M. Ambrosoli e F. Bianco, Milano, Franco Angeli,2007; il già citato Cartografia del Monferrato. Fanno tutti parte della collana Confini e fron-tiere nella storia. Spazi, società, culture nell’Italia dell’età moderna creata appositamente per ospi-tare gli esiti del progetto coordinato da Pastore.
rapidamente nel § 3 – costituisca un’esperienza utile a romperel’isolamento culturale di cui gli spazi piemontesi, riguardo i pro-blemi di storia territoriale, negli ultimi tempi hanno sofferto.
A questo proposito, mi preme fare un’ultima considerazio-ne. Discorrendo recentemente delle analogie e soprattutto del-le differenze tra la Storia di Venezia avviata dalla FondazioneGiorgio Cini nel 1985 e la Storia di Torino Einaudi (1997-2002), Gherardo Ortalli ha sottolineato «sulle pagine vene-ziane… la numerosa presenza di studiosi stranieri» e, di con-tro, quella «assolutamente marginale, ai limiti dell’inesistente»nei volumi su Torino 23. La spiegazione, secondo Ortalli, èsemplice: «La Storia di Torino mostra subito di avere alle spalleun milieu storiografico estremamente robusto e in grado di co-prire da solo tutti i settori e gli spazi, senza bisogno di altrisupporti. La scarsa presenza di aperture all’esterno, dunque,non ha per nulla il carattere della chiusura provinciale, maappare piuttosto come la prova della solidità di una scuola e diuna tradizione storiografica» 24.
In realtà, pur essendo l’analisi in parte veritiera, il dato dellamancanza di contributi di ricercatori provenienti da altri am-biti accademici e geografici non mi pare del tutto rassicurante.Capovolgendo, anzi, la lettura venezianocentrica della questio-ne, non si può non notare che, rispetto alla Dominante e fattele debite eccezioni (i lavori di Symcox, di Storrs, di Broers, matutti sul Settecento25), gli spazi sabaudi e la loro capitale siano
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 101
23 G. ORTALLI, La Storia di Venezia tra ricerca, divulgazione e mercato, in Storia di Torino,storia di città, a cura di M. Guglielmo, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 131-150 (la cita-zione da p. 142).
24 Ivi, p. 143.25 Alludo a G. SYMCOX, L’età di Vittorio Amedeo II cit.; C. STORRS, War, Diplomacy and
the rise of Savoy. 1690-1720, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, e M.BROERS, Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy: 1770-1821. State building in Piedmont,Lampeter, The Edwin Meller Press, 1997. Per il Seicento sono però importanti lericerche di Robert Oresko: cfr. il suo The House of Savoy in search for a royal crown in the seven-teenth century, in Royal and Republican Sovereignty in Early Modern Europe. Essays in memory ofRagnhild Hatton, edited by R. Oresko, G. C. Gibbs anc H. M. Scott, Cambridge,Cambridge University Press, 1977, pp. 272-350.
abbastanza estranei al dibattito internazionale. Allo stesso mo-do, se non si può parlare di provincialismo per tutti i settoridella ricerca, è innegabile che l’attenzione per il territorio, lun-gi dall’attirare specialisti stranieri, sia per lo più viva presso entie storici locali i cui studi poco contribuiscono a svecchiare l’im-magine di un Piemonte d’antan, ora cristallino sotto l’egida del-la dinastia sabauda ora irrigidito nelle vesti di Stato preunita-rio. A farne le spese sono state e sono così le ricerche più ade-guate sul piano metodologico, magari maturate in seno all’acca-demia ma viste con sospetto da alcuni dei suoi stessi membri.
2. Problemi aperti
Avendo circostanziato, per linee comuni, il concetto di Pie-monte in età moderna e chiarito, innanzitutto, che nell’ambitodei progetti elaborati in vista della futura attività dell’ISPRE
s’intende porre l’accento sugli spazi sabaudi intesi nella lorocomplessità e iniziale disomogeneità, restano da segnalare di-verse lacune storiografiche. La prima, va da sé, riguarda pro-prio la mancanza di studi che tentino di affrontare il discorsoin chiave globale, vale a dire una sorta di storia del Piemonteche tenga conto non solo delle implicazioni istituzionali, chepure sono imprescindibili, ma anche dei riflessi socio-econo-mici sul territorio analizzato diacronicamente e sul lungo perio-do. L’opera che più si avvicina a questo risultato è senza dub-bio, ancora, Il Piemonte sabaudo (1994) i cui autori offrono, cia-scuno per l’epoca di sua competenza, una sintesi esaustiva dellevicende del ducato di Savoia dalla risistemazione di EmanueleFiliberto al declino prenapoleonico. Grazie alla bibliografia ra-gionata, tuttora la più completa a disposizione, sono eviden-ziati i temi cardine del lavoro di Merlin, Rosso, Symcox e Ri-cuperati: le magistrature, le istituzioni politico-militari, quelleecclesiastiche ed economiche, le relazioni diplomatiche specie
102 blythe alice raviola
nei frangenti di guerra e con particolare attenzione agli anni diVittorio Amedeo II, il passaggio da ducato a regno, le riformedell’età boginiana, la cultura e la crisi di fine Settecento. Tutta-via, venendo al campo specifico di questo paper, le sezioni dellabibliografia dedicate alla Storia dei territori, città e comunità sono lepiù povere di titoli. A spiegarne in parte le ragioni è ClaudioRosso per il Seicento:
Il carattere ancora composito ed eterogeneo dello Stato sabaudonella prima età moderna fa sì che rivestano la massima importanzagli studi sulle singole realtà regionali e locali. L’enfasi posta perlungo tempo sulle vicende dinastiche e il fatto che sia stata tradizio-nalmente data per scontata una precoce evoluzione centralizzatriceha però a lungo confinato – forse più che in altri contesti – taliricerche in una sfera marginale, lasciandone il monopolio a studiosilocali e non integrandoli in una visione complessiva 26.
La riflessione è di indubbia verità e trova puntuale riscontronell’esame della letteratura esistente su spazi e comunità sabau-de dal tardo Quattrocento in poi. Non stupisce per esempioche, in un volume di largo respiro come L’Europa delle città diMarino Berengo27, le città piemontesi abbiano scarso rilievo eche quelle ricordate – Torino in primo luogo, poi, con unacitazione o poco più, Asti, Vercelli, Cuneo, Novara, Alba, Ca-sale, Pinerolo, Fossano, Mondovì e Saluzzo – lo siano più chealtro in relazione al Medioevo (sull’origine dei consigli, la con-fezione di statuti, l’incidenza sui contadi circostanti) o comecasi anomali rispetto alla maggior parte dei centri urbani ita-liani (Torino, per esempio, è subito presentata come l’unicavera città capitale, un’eccezione nel panorama dei luoghi consi-derati dall’autore). Nello stesso Piemonte sabaudo l’attenzione alterritorio e ai territori, nonostante la programmaticità del sot-totitolo, è soggetta alla deformazione di uno sguardo inevita-
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 103
26 C. ROSSO, Il Seicento cit., p. 857.27 M. BERENGO, L’Europa delle città, Torino, Einaudi, 1999.
bilmente – date le fonti consultate e la bibliografia a disposi-zione – torinocentrico.
La percezione muta solo nel Settecento di Ricuperati 28 lad-dove sono ricostruiti con ritmo la crisi degli anni Novanta e ildialogo, difficile, intermittente o decisamente compromesso, trala capitale e le comunità piegate da congiunture economicheparticolarmente sfavorevoli o politicamente più consapevoli.Ma si trattava di rapporti inquinati dall’emergenza, che pocoavevano a che vedere con la consuetudine e le pratiche di lungoperiodo, contraddistinte da meccanismi variamente consolidati(come l’inserimento a corte di esponenti delle élites locali e laricaduta del fenomeno sui luoghi di provenienza), da tentatividi collaborazione o comunque da tensioni di altra natura.
Negli ultimi anni, tuttavia, si è manifestato un certo risve-glio nei confronti di questi temi, dettato sia dagli orientamentistoriografici nazionale e internazionale sia dall’effettiva consta-tazione della inadeguatezza delle opere esistenti. L’impresa piùmacroscopica è stata indubbiamente l’edizione della Storia diTorino Einaudi, operazione lunga e complessa che forse, al di làdei pregi e delle novità di alcuni contributi, almeno per la partemoderna non è riuscita a superare del tutto il limite della ri-proposizione di studi già noti e solo lievemente aggiornati.Non a caso le pecche del poderoso lavoro sono state discusse apiù voci in un volume intitolato Storia di Torino, storia di città incui autorevolissimi lettori hanno non solo vagliato, ciascunoper i temi di sua competenza, i contributi contenuti nei varitomi, ma anche confrontato l’operazione einaudiana con altrestorie di città italiane compiute o in fase di completamento.Ne emergono spunti assai utili per impostare nuove ricerchesugli altri centri urbani piemontesi che ancora non hanno rice-vuto attenzione e che, a mio parere, dovrebbero essere un pun-
104 blythe alice raviola
28 G. RICUPERATI, Il Settecento, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICU-PERATI, Il Piemonte sabaudo cit., pp. 441-834, ripubblicato come ID., Lo Stato sabaudo nelSettecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d’Antico Regime, Torino, Utet, 2001.
to di partenza ineludibile per una storia del territorio di piùampia accezione.
Cuneo e il Cuneese paiono, al momento, costituire un’isolaprivilegiata. Si è fatto cenno agli ultimi lavori su Saluzzo e nonva trascurata l’ampia produzione della Società per gli studi sto-rici della Provincia di Cuneo di cui, a campione e più specificiper l’età moderna, si possono citare un volume miscellaneo suiGiochi di palla nel Piemonte medievale e moderno 29 – in cui hannoscritto quasi tutti gli autori dei progetti ISPRE (Merlotti, Bian-chi, Cozzo, Raviola) evidenziando come, dietro momenti e con-testi ludici, potessero celarsi tensioni politico-sociali di nonpoco conto – e l’edizione, nel 2003, della Descrizione della provin-cia di Mondovì dell’intendente Corvesy30. Sempre sul Monrega-lese non si possono dimenticare i tre volumi sui conflitti per ilsale che interessarono la zona a fine Seicento, tuttora validomodello per chi voglia studiare sotto vari profili (istituzionale,economico, sociale) un’area di transito nel tempo breve di undecennio31. Cuneo, inoltre, se si eccettua il caso di Torino, èl’unica città sabauda cui, negli ultimi anni, sia stata dedicatauna storia di taglio accademico, capace di correlare fattori so-cio-economici e istituzionali 32.
Il discorso cambia se si passa a considerare Vercelli. Nono-stante l’indiscussa importanza della città tra la seconda metàdel XV secolo e la prima del XVI – periodo durante il qualefunse da capitale al posto di Torino e fu dunque sede di unacorte e di apparati di governo – la bibliografia è tutt’altro che
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 105
29 Giochi di palla nel Piemonte medievale e moderno, atti del convegno, Rocca de’ Baldi, 30settembre – 1° ottobre 2000, a cura di A. Merlotti, Cuneo, Società per gli studi StoriciArcheologici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 2001.
30 Descrizione della provincia di Mondovì. Relazione dell’intendente Corvesy. 1753, a cura di G.Comino, Mondovì, Centro Studi Monregalesi e Società per gli studi Storici Archeolo-gici ed Artistici della Provincia di Cuneo, 2003.
31 La guerra del sale, 1680-1699: rivolte e frontiere del Piemonte barocco, a cura di G.Lombardi, Milano, Franco Angeli, 1986, 3 voll.
32 P. BIANCHI - A. MERLOTTI, Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte di AnticoRegime, Milano, Franco Angeli, 2002.
ricca e aggiornata. Preponderante pare l’attenzione per l’altoMedioevo e per l’età comunale, cui sono stati dedicati studi dicarattere topografico33, istituzionale34 e culturale35. Come peraltre realtà urbane, non mancano poi titoli di storia romana econtemporanea, di storia dell’arte, ecclesiastica e della lettera-tura; il territorio è presente sotto forma di guide e itinerari na-turalistici o, nel caso specifico, di monografie sulla risicoltura.Langue, tuttavia, la produzione sull’età moderna e i pochi stu-di recenti, se si escludono gli atti di un convegno sui gesuiti inloco 36 e un volume sull’erudizione vercellese nel Cinquecen-to37, insistono soprattutto sugli assedi di cui la città fu suomalgrado protagonista durante la Guerra dei Trent’anni 38.Qualche interesse hanno infine destato figure isolate di vercel-lesi illustri: non tanto Mercurino Arborio di Gattinara, la cuibiografia trova spazio in quelle dedicate a Carlo V, quantopiuttosto Giovanni Antonio Ranza, di cui un convegno del2001 ha celebrato il bicentenario della morte39.
106 blythe alice raviola
33 Tra gli altri cfr. G. GULLINO, Uomini e spazio urbano: l’evoluzione topografica di Vercelli traX e XII secolo, Vercelli, s.n.t., 1987.
34 F. PANERO, Terre in concessione e mobilità contadina: la campagna fra Po, Sesia e Dora Baltea.Secc. XII-XIII, Bologna, Cappelli, 1984; ID., Istituzioni e società a Vercelli. Dalle origini delComune alla costituzione dello Studium (1228), Vercelli, Società storica vercellese, 1994; R.RAO, I beni del Comune di Vercelli: dalle rivendicazione all’alienazione (1183-1254), Vercelli, So-cietà storica vercellese, Università del Piemonte Orientale, 2005.
35 Cfr. per esempio L’Università di Vercelli nel Medioevo, atti del II congresso storico ver-cellese, 23-25 ottobre 1992, Vercelli, Chiais, 1994, e Letteratura di frontiera. Il Piemonteorientale, atti del convegno di studi 22-24 ottobre 2001, a cura di R. Carnero, Vercelli,Mercurio, 2003.
36 La Compagnia di Gesù e la società piemontese. Le fondazioni del Piemonte orientale, atti delconvegno Vercelli 16 ottobre 1993, a cura di B. Signorelli, P. Uscello, Vercelli, Arti gra-fiche, 1995.
37 M. BOCCALINI, L’antiquaria vercellese tra Cinque e Seicento. Manoscritti inediti di antichistivercellesi, Vercelli, Gruppo Archeologico Vercellese, 1995.
38 Si tratta per lo più di studi di carattere localistico: E. GORINI, L’occupazione spagnoladi Vercelli. 1638-1659, Parma, s.n.t., 1969; D. BELTRAME, La fortificazione di Vercelli nel primo’600. Ulteriori interventi sabaudi, assedio e breve occupazione spagnola (1616-1618), in «Bol-let-tino storico vercellese», n. 55 (2000), pp. 45-94; Dio di mal vi guardi. Assedianti e assediatia Vercelli, Mostra di stampe, disegni, documenti, libri sugli assedi di Vercelli del XVII e XVIII secolo, acura di P. Carpo e G. Brugnetta, Vercelli, Artigiana San Giuseppe, 2002.
39 Giovanni Antonio Ranza nel bicentenario della morte (1801-2001), atti del convegno 24novembre 2001, Vercelli, Vercelliviva, 2002.
Il caso di Asti è leggermente diverso. Alla sproporzione,comprensibile ma non per questo insuperabile, tra gli studi sulformidabile Medioevo e quelli (pressoché nulli) sulla più grigiaetà moderna, negli ultimi anni è seguita una nuova sensibilitàper il Settecento che, osservato a partire dall’eclatante vicendadella Repubblica Astese del 179740, si è rivelato ricco di sfac-cettature socio-economiche. Intanto, per comprendere l’episo-dio repubblicano, è stato necessario affrontare l’analisi del cetodirigente urbano41, considerare il ruolo subalterno ormai gio-cato da Asti nel sistema difensivo sabaudo 42, esaminare lacomposizione sociale del clero 43 e dei giacobini astigiani 44. Inseconda battuta, estendendo lo sguardo al di là delle mura cit-tadine, sono state ricostruite le reazioni delle comunità agri-cole della provincia 45 ricavando un quadro complessivo di di-namismo, incertezza e crisi che trova rispondenza con le espe-rienze di altre zone piemontesi e italiane.
Di qui, a ritroso e per via di iniziative differenti, è statarestituita voce ai due intendenti che, nel 1753 e nel 1786, for-nirono al sovrano una descrizione puntuale e talora impietosadell’Astigiano sotto il profilo economico-amministrativo: se ilprimo, ovvero Giovan Francesco Balduini di Santa Margherita,si limitò a compilare, ligio alle direttive della Segreteria degliInterni, un resoconto fedelissimo dello stato delle comunità del-la provincia, il secondo, Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino,
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 107
40 Cfr. G. RICUPERATI, Il Settecento cit., pp. 784-801, e Quando San Secondo diventò gia-cobino. Asti e la Repubblica del luglio 1797, a cura di G. Ricuperati, Alessandria, Edizionidell’Orso, 1999.
41 A. MERLOTTI, Nobiltà e sociabilità aristocratica ad Asti nel Settecento, in Quando San Se-condo diventò giacobino cit., pp. 71-125.
42 P. BIANCHI, Una piazzaforte sabauda: esercito, difesa e controllo sociale ad Asti nel Settecento,ivi, pp. 127-178.
43 M.T. SILVESTRINI, Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa ad Asti nel Settecento, ivi, pp.179-201.
44 F. BENZI, Utopia e coraggio di una minoranza: gli avvocati giacobini, ivi, pp. 217-241.45 B.A. RAVIOLA, Le rivolte sincrone del luglio 1797 nel Piemonte meridionale, ivi, pp. 245-
301 (lo stesso contributo è apparso, in forma lievemente ridotta, in «Studi storici», n.2, aprile-giugno 1998, pp. 401-447, quindi in Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolarinell’Italia giacobina e napoleonica, a cura di A. M. Rao, Roma, Carocci, 1999 pp. 123-169).
imbevuto di cultura illuministica, colse l’occasione per bac-chettare le disfunzioni riscontrate in più luoghi e per proporreriforme ancor più drastiche del regolamento dei pubblici (1775).In entrambi i casi emerge un’istantanea della situazione che hadato spunto a una rilettura diacronica del costituirsi dell’unitàprovinciale 46 e a un’ulteriore analisi della realtà astigiana di fineSettecento47. Ma questo filone di studi, che pure lascia intrave-dere precedenti interessanti, è strettamente legato alla secondametà del XVIII secolo. Bisogna colmare la voragine storiogra-fica che affligge, anche qui, il Cinque-Seicento, partendo dallepreziose indicazioni disponibili sulla dominazione orleanese 48,sul passaggio del contado d’Asti a Beatrice di Portogallo nel153149 e sul governo della città durante i ducati di EmanueleFiliberto e Carlo Emanuele I 50.
A soffrire maggiormente di prolungata trascuratezza storio-grafica sono forse state, però, e sono tuttora le cosiddette pro-vince di nuovo acquisto. Mi riferisco in particolare ad Alessan-drino e Novarese, lasciati per lo più in balia delle iniziative diappassionati ed enti culturali locali (piccole accademie o rivi-ste) o, nei casi migliori, lambiti marginalmente dalle ricerche distudiosi delle Università piemontesi o lombarde che però, an-che a causa della inevitabile dispersione documentaria, se ne oc-
108 blythe alice raviola
46 A. MERLOTTI, Costruire lo Stato in provincia: l’intendenza astigiana di Giovan FrancescoBalduini di Santa Margherita (1750-54), introduzione a G.F. BALDUINI, Relazione della provin-cia di Asti (1753-54), a cura del Gruppo Ricerche Astigiane, in corso di stampa.
47 «Il più acurato intendente». Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino e la Relazione dello statopolitico economico dell’Asteggiana del 1786, Introduzione e cura di B.A. Raviola, Pre-fazione di G. Ricuperati, Torino, Zamorani, 2004.
48 R. BORDONE, La dominazione francese di Asti: istituzioni e società tra Medioevo et età mo-derna, in Gandolfino da Roreto e il Rinascimento nel Piemonte meridionale, a cura di G. Romano,Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, 1998, pp. 16-45, e ora R. BOR-DONE - D. GNETTI, Cortesia, corti, cortigiani: Asti all’autunno del Medioevo, in L’affermarsi dellacorte sabauda cit., pp. 193-216.
49 M. MARCOZZI, Asti « fidelissima» e « separata»: soggezione e autonomia nel primo secolo didominio sabaudo (1531-1630), in «Rivista di storia arte archeologia per le province diAlessandria e Asti», CXII.1, 2003, pp. 83-104.
50 B.A. RAVIOLA, Carriere, poteri, onori di un’élite: i governatori nei domini sabaudi da Ema-nuele Filiberto a Carlo Emanuele I (1559-1630), tesi di laurea, Università di Torino, Facoltàdi Lettere e Filosofia, a.a. 1995-96, rel. Prof. G. Ricuperati.
cupano come di un oggetto distante, di confine, sempre meri-tevole di ulteriori approfondimenti.
Si prenda l’esempio di Novara. Il caposaldo bibliografico re-sta Novara nella sua storia di Francesco Cognasso, che data ormaial 1952. A fine anni Ottanta è stato pubblicato un volume daltitolo (ambizioso) Il Settecento novarese. Dalla Lombardia asburgica alPiemonte sabaudo 51, con contributi politematici di docenti auto-revolissimi, tra cui Giuseppe Ricuperati, Carlo Capra, Cesare Moz-zarelli e Gian Savino Pene Vidari, in cui tuttavia si è andatipoco lontani dalla semplice enunciazione di possibili temi distoria novarese, colti peraltro sì nel momento cruciale del cam-bio di dominazione, ma senza uno scavo sufficiente dei feno-meni socio-economici di età spagnola, non comprendendo iquali risulta difficile analizzare appieno le dinamiche manife-statesi nei decenni dell’assimilazione sabauda. Nuova linfa allericerche sulla città sta provenendo dall’opera Una terra tra duefiumi, la provincia di Novara nella storia, il cui primo volume, curatoda Mirella Montanari nel 2002 e dedicato a L’età medievale (secoliVI-XV), ospita saggi di autori vari che si soffermano soprat-tutto, dato il periodo affrontato, sull’origine della diocesi esulle vicende di un territorio segnato, come giustamente recitail titolo, dal Sesia e dal Ticino nonché dalla forza attraente del-l’orbita milanese. Il secondo volume su L’età moderna (secoli XVI-XVIII) colma ulteriori lacune e prelude così a una storia dellacittà concepita più organicamente.
Discorso analogo, mutatis mutandis, è fattibile per Alessandriae l’Alessandrino: alla fievole attenzione per l’età moderna fa dacontraltare l’enfasi posta sugli anni napoleonici e in particolaresull’episodio della battaglia di Marengo, oggetto di ricostru-zioni e convegni di vario livello scientifico. Il ricupero dellamemoria è pure affidato, come spesso accade nel Piemontemeridionale, all’Istituto per la Storia della Resistenza (molto
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 109
51 Il Settecento novarese. Dalla Lombardia asburgica al Piemonte sabaudo, Novara, CooperativaSan Francesco, s.d. (ma 1988).
attivo anche ad Asti, per esempio), mentre sembra non esistereun reale interesse per la storia cittadina di lungo periodo. Men-tre la «Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province diAlessandria e Asti», oggi vicina all’agonia, è stata per decenniil collettore di ricerche isolate (su personaggi celebri, sulle ori-gini della città, sulle sue vicende militari, sul Monferrato deiPaleologo e dei Gonzaga che rientra territorialmente nell’am-bito della provincia), le poche esperienze recenti degne di notanon prescindono dal ruolo strategico della piazza 52 o dal suosviluppo culturale e protoindustriale sette-ottocentesco53.
In entrambi i casi – Alessandrino e Novarese – si tratta diaree geograficamente connotate da un fitto reticolo idrograficoche influì notevolmente sull’economia di stampo agricolo-com-merciale dando vita a percorsi viari e fluviali tali da rendereplausibile la definizione di Piemonte orientale che si va utilizzandoper denominarle amministrativamente 54 e in cui trova spazioanche il Vercellese. Da queste suggestioni, credo, si dovrebbepartire per comprendere realtà apparentemente ibride e cheinvece, proprio grazie alla posizione, furono terreno fertile peresperienze e convivenze multiformi – si pensi alla floridezzadella comunità ebraica della stessa Alessandria, ma anche diquelle di Casale, Asti, Moncalvo, Nizza Monferrato – e luoghidi sperimentazione politica per gli amministratori che via via sisusseguirono nel governarle.
Per quanto riguarda l’analisi del territorio e dei territori – ilplurale, anche in questo caso, è d’obbligo data la complessitàoriginaria del Piemonte di età moderna – occorrerebbe poi ve-rificare, con l’ausilio di prove documentarie concrete, l’imma-gine di Stato feudale e assolutista che negli ultimi decenni è
110 blythe alice raviola
52 A. FARA, La città da guerra nell’Europa moderna, Torino, Einaudi, 1993.53 I. GADDO - C. MANGANELLI - C. ZARRI, Tipografie, accademie, uffici d’arte. Aspetti di
storia alessandrina, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2003.54 Cfr. B.A. RAVIOLA, Disciplinare la frontiera: l’acquisizione delle province di nuovo acquisto e
la ridefinizione del confine orientale, in Il teatro delle terre. Cartografia sabauda tra Alpi e pianura, cata-logo della mostra, Torino, 4 marzo-9 aprile 2006, a cura di I. Massabò Ricci, G.Gentile, B.A. Raviola, Savigliano, L’Artistica, 2006, pp. 161-182.
stata trasmessa dalla letteratura sugli antichi Stati italiani.Valgano ad esempio le pagine dedicate al ducato sabaudo nellaStoria degli antichi stati italiani curata da G. Greco e M. Rosa nel199055, in cui peraltro è riproposta in sintesi la periodizza-zione legata ai nomi di Emanuele Filiberto e Vittorio AmedeoII. Senza negare l’impatto che la feudalità – o la rifeudalizza-zione 56 – ebbe nella genesi del Piemonte moderno, non va tra-scurato il confronto con realtà non troppo dissimili per que-st’aspetto, come il ducato di Mantova 57 o alcune aree del-l’Italia meridionale 58, né si deve rinunciare a valutare, magarigrazie allo studio dei catasti e degli archivi privati, l’effettivaportata socio-economica del fenomeno in spazi alquanto diffe-renti tra di loro (il Cuneese multicolturale, ad esempio, o ilVercellese risicolo). L’analisi quantitativa di fonti seriali, legataal lungo periodo qui suggerito, consentirebbe di riesaminarlopartendo dai primordi quattrocenteschi dello Stato, sorto pro-prio sulle ceneri di antichi potentati feudali, per giungere allaridefinizione delle proprietà terriere avviatasi durante la primametà del XIX secolo.
Analogamente il 1450 – la pace di Lodi, considerata lospartiacque che segna l’inizio della diplomazia moderna 59, èdel ’54 – è un buon punto di partenza per lo studio dei rap-porti interstatuali enunciati dal titolo di questo progetto. Alproposito è necessario chiarire che per rapporti interstatuali
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 111
55 Si vedano in particolare il brano di M. VERGA, Le istituzioni politiche, in Storia degliantichi stati italiani cit., pp. 3-58, alle pp. 17-20, e i cenni di M. ROSA, La cultura politica, ivi,pp. 59-116, alle pp. 79-80.
56 R. AGO, La feudalità in età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1993.57 Su cui sono fondamentali C. VIVANTI, Le campagne del Mantovano nell’età delle riforme,
Milano, Feltrinelli, 1959, e C. MOZZARELLI, Lo Stato gonzaghesco. Mantova dal 1382 al1707, in L. MARINI - G. TOCCI - C. MOZZARELLI - A. STELLA, I Ducati padani, Trento eTrieste, vol. XVII della Storia d’Italia diretta da G. Galasso, Torino, Utet, 1979 (19922),pp. 359-488.
58 Cfr. almeno M.A. VISCEGLIA, Territorio, feudo e potere locale: terra d’Otranto tra medioevoed età moderna, Napoli, Guida, 1988, e Signori, patrizi e cavalieri nell’età moderna (nell’Italia cen-tro-meridionale), a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari, Laterza, 1992.
59 D. FRIGO, Politica estera e diplomazia: figure, problemi e apparati, in Storia degli antichi statiitaliani cit., pp. 117-161.
non s’intende, o non esclusivamente, una disamina della poli-tica estera seguita attraverso il suo dipanarsi cronologico maanche, sulla base di riflessioni piuttosto recenti, lo studio dei«rapporti fra aggregazioni politico-territoriali che godono diun rilevante grado di sovranità» 60.
In tal senso il piano su cui lavorare è duplice: se, infatti, trail 1450 e il 1550 il Piemonte a macchia di leopardo contava alsuo interno piccoli Stati e formazioni territoriali politicamenteautonome con cui era costretto a porsi in relazione diplomati-camente, dalla metà del Cinquecento in poi e più compiuta-mente dagli anni Settanta del secolo (allo sciogliersi dei presidispagnoli di Asti, Santhià e Vercelli), il concetto va inteso nelsenso più classico di contatti con altri Stati italiani e con po-tenze estere, mediante un sistema di ambasciatori e inviati chein buona misura ancora ci sfugge. Se, infatti, disponiamo dialcuni studi sulla diplomazia sabauda del Settecento che siconcentrano sulla ribalta piemontese di Utrecht61, sulle ri-forme realizzate in seno alla Segreteria degli Esteri 62, sui con-cordati con Roma e in particolare sulla figura del marchesed’Ormea 63, manca del tutto un’analisi delle prime – peraltronumerose e pressoché costanti – relazioni diplomatiche intrec-ciate dal ducato nelle sue strategie di sopravvivenza e premi-nenza in seno alla penisola italiana e sullo scacchiere europeo.Anche in questo caso, il Piemonte è stato penalizzato dalla sto-riografia accademica e locale e, fatto salvo il frequente ricorsoalle notissime Relazioni degli ambasciatori veneti edite sugli spazi sa-
112 blythe alice raviola
60 A.K. ISAACS, Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all’età moderna, in Origini delloStato cit., pp. 113-132, in particolare p. 113.
61 C. STORRS, War, Diplomacy and the rise of Savoy cit.62 D. FRIGO, Principe, ambasciatori e « jus gentium». L’amministrazione della politica estera nel
Piemonte del Settecento, Roma, Bulzoni, 1991.63 G. RICUPERATI, Il Settecento cit.; ID., La scrittura di un ministro. La Relazione sulle
negoziazioni con la corte di Roma di Carlo Francesco Vincenzo Ferrero, marchese d’Ormea, inNobiltà e Stato in Piemonte cit., pp. 207-229; C. STORRS, Ormea as a Foreign Minister: theSavoyard State between England and Spain, ivi, pp. 231-248, e B.A. RAVIOLA, «Le tout-puissant»:Carlo Francesco Vincenzo Ferrero d’Ormea nella corrispondenza degli ambasciatori francesi, ivi, pp.249-277.
baudi (ducato di Savoia e Monferrato), continuano a esserepoco conosciuti i protagonisti delle missioni presso le cortiestere, i loro obiettivi, i mezzi messi in atto per conseguirli, irisultati raggiunti. Basti qui ricordare i ripetuti contatti d’inizioCinquecento con i marchesi di Monferrato o con Francesco Idi Saluzzo nell’ottica di ricomporre, se non i presunti dominiterritoriali, una compagine difensiva in funzione antimilanese;le estenuanti trattative con Carlo V per la cessione del Mon-ferrato alla morte dell’ultimo Paleologo (1533-36); il ruolo dimediazione giocato dal ducato di Emanuele Filiberto e CarloEmanuele I nella risoluzione di controversie tra principi ita-liani (come i Medici e gli Este, ad esempio) e, nel contempo, iltentativo di conseguire il titolo granducale, se non regio, giàalla fine del XVI secolo. Questo e altri aspetti meriterebberosenz’altro maggior evidenza perché contribuirebbero non soloa scalfire l’idea radicatasi ultimamente di un Piemonte ano-malo e appartato rispetto agli altri Stati italiani, ma anche,cogliendone le effettive peculiarità, a rivedere il paradigma del-la vocazione all’italianità che è stato vessillo di certa tradizionestoriografica ottocentesca e fascista 64.
Un ultimo punto – e con questo mi riallaccio ai problemiindividuati nell’Introduzione e ai temi sin qui elencati – va anno-verato tra le carenze da superare: così come nel caso citatodella Asti moderna, è stato ed è notoriamente il Settecento apredominare sul piano storiografico. Le riforme amedeane, ilmagistero di Franco Venturi, la riscoperta dei fermenti innova-tori (anche se in senso accentratore e conservatore) del lungoregno di Carlo Emanuele III hanno finora catalizzato l’atten-zione di studiosi di diversi ambiti disciplinari, dalla storia delleistituzioni a quella delle idee, dal settore economico a quello,più recente, del connubio tra analisi socio-istituzionale, mili-
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 113
64 Cfr. U. LEVRA, Fare gli italiani. Memoria e celebrazione del Risorgimento, Torino, Istitutoper la storia del Risorgimento italiano, 1992, e anche le sintetiche osservazioni di A.MUSI, L’Italia dal Sacro Romano Impero allo Stato nazionale, in Il piccolo Stato cit., pp. 171-195.
tare e culturale. Singolarmente, dunque, chi voglia oggi occu-parsi di storia del Piemonte sulla traccia della periodizzazioneproposta deve soprattutto arretrare, evitando il rischio di leg-gere con criteri telonistici gli eventi e le congiunture quattro-seicentesche e, d’altro canto, tenere ben presenti queste ultime,e non solo la celebrata stagione del XVIII secolo, nell’interpre-tare coerentemente la cesura di epoca napoleonica e la sostan-ziale ripresa dell’Ancien Régime garantita dalla Restaurazione.
3. Proposte tematiche e indirizzi di ricerca
Dando per assodato che la storia territoriale degli spazisabaudi – come quella di ogni altro Stato regionale o nazionale– vada affrontata in un’ottica policentrica, evitando che la capi-tale o un altro centro di rilievo assorbano le energie dei ricerca-tori rispetto al resto dello Stato o della zona circostante, è con-sequenziale alle lacune individuate nel paragrafo precedente laproposta di avviare gli studi in questo settore muovendo dallastoria di alcune città. Le candidate migliori, almeno nella pri-ma fase delle attività dell’ISPRE, potrebbero essere Vercelli, Astie Novara, nell’intento di lavorare, nel primo caso, su una cittàappartenente ai domini sabaudi sin dal Medioevo, nel secondosu un contado annesso nel Cinquecento dopo l’intensa paren-tesi francese, nel terzo sul capoluogo di una delle province dinuovo acquisto modellato dalla lunga stagione lombardo-spa-gnola. Vercelli e Novara, inoltre, afferiscono all’attuale Pie-monte orientale di cui, lo si ripete, si sa poco dal punto di vistadella storia moderna, mentre Asti, come si è detto, conta unaserie di studi già pubblicati sia sul fronte tardo-medievistico siamodernistico.
Impostare la storia di un centro urbano non è naturalmenteun’operazione semplice, né neutra. Come hanno ben eviden-ziato alcune delle discussioni sulla Storia di Torino, e in partico-
114 blythe alice raviola
lare quella di Giorgio Chittolini su Milano65 e quella, già ri-cordata, di Ortalli su Venezia, il primo problema è quello dellascelta dei collaboratori, non disgiunto da quello della sparti-zione cronologica. Quest’ultima, nel nostro caso, ricadrebbenelle date indicate come contenitrici dei progetti ISPRE (1450-1850), salvo richiedere poi ulteriori, variabili scansioni interne.Circa gli autori, la soluzione può essere duplice: pensare a vo-lumi politematici che raccolgano i saggi di più studiosi oppurea libri che, a seguito di alcuni anni di indagine e scavo archivi-stico, siano scritti a quattro-sei mani. Entrambe presentanovantaggi – un maggior approfondimento la prima; una mag-gior coerenza narrativa e interpretativa la seconda – e svantaggi– un’eccessiva frammentazione dei temi la prima; una minorricchezza disciplinare la seconda. Si potrà decidere come im-postare il lavoro, tuttavia, solo dopo l’avvio della schedaturadelle fonti e il vaglio di ricercatori che si siano occupati delluogo o dei problemi che interessano.
All’obiezione (lecita) che le storie di Asti, Vercelli, Novara edi altri centri urbani piemontesi non presentino certo le diffi-coltà poste da quelle delle grandi capitali italiane di Ancien Ré-gime, si risponde rammentando il felice caso di Prato storia di unacittà 66 che, oltre a essere divenuto un formidabile modello distoria della città italiana ed europea, ha dimostrato che è possi-bile servirsi di documentazione locale senza scadere nel provin-cialismo e fare di una cittadina – in tal caso a forte vocazioneindustriale – un laboratorio di confronto tra discipline e ap-procci diversi. L’intento, insomma, non è quello di collezionaremonografie di gusto erudito né quello di realizzare, aggiornan-dolo, un catalogo che erediti la tradizione del Dizionario di Ca-salis. Piuttosto, anche alla luce delle suggestioni provenienti da
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 115
65 G. CHITTOLINI, Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato, in Origini dello Stato cit., pp. 553-589;ID., L’idea e la realizzazione di una « grande opera collettiva». Alcune note sulla Storia di Milanodella Fondazione Treccani degli Alfieri, in Storia di Torino, storia di città cit., pp. 105-130.
66 E. FASANO GUARINI, Prato storia di una città, in Storia di Torino, storia di città cit., pp.151-171.
esperienze di ricerca magari all’apparenza frammentarie, macostruttive, come si presenta oggi lo Schedario storico-territoriale, sitratta di dotarsi di strumenti indispensabili per rileggere la sto-ria piemontese mettendo alla prova il dogma centro-periferia eridimensionando, se necessario, la reale influenza di una Torinofagocitatrice 67.
Partiamo, dovendo suggerire un piano di lavoro, dal caso diVercelli. Un buon inizio potrebbe essere offerto da un inqua-dramento della realtà urbana tardoquattrocentesca, focalizzatal’attenzione sul ruolo di capitale che, come si è già detto, lacittà rivestì durante il ducato di Carlo II. Interessato dalla dra-stica riduzione della sua diocesi messa in opera nel 1474 alfine di creare quella di Casale, il Vercellese non cessò di costi-tuire una frontiera strategica di eccezionale importanza duran-te le tumultuose guerre italiane di inizio Cinquecento per dive-nire, dopo Cateau-Cambrésis e fino al 1575, uno dei presidimantenuti dagli spagnoli in Piemonte 68. Avendo chiaro losfondo evenemenziale, si tratterà in primo luogo di osservarepiù da vicino il rapporto tra Vercelli e i Savoia; l’emergere divercellesi a corte e il trasferimento a Torino dei più capaci (suquesti aspetti, però, si rinvia al progetto di Merlotti); le dina-miche interne al patriziato urbano prima, durante e dopo lapresenza ducale. Il Seicento vercellese, ugualmente contraddi-stinto da eventi bellici d’impatto, sarà da studiare nelle suecongiunture socio-economiche e, come le altre componenti ter-ritoriali dei domini sabaudi, nei processi di ridefinizione dellacompagine ducale; processi che ebbero seguito, tra referendari eintendenti, nel corso del secolo successivo quando l’acquisizio-ne del Novarese e dell’Alessandrino spostò più avanti il confineorientale sminuendo il peso della piazza di Vercelli.
116 blythe alice raviola
67 G. LEVI, Centro e periferia di uno Stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in etàmoderna, Torino, Rosenberg&Sellier, 1985.
68 Cfr. A. BUONO, Frontiere politiche, fiscali e corporative dello Stato di Milano. La conquista ed ilmantenimento del presidio di Vercelli (1638-1650), in Alle frontiere della Lombardia cit., pp. 151-176.
Per Asti si dovranno in primo luogo riprendere le file deldiscorso sull’aristocrazia del denaro sviluppatasi localmente nelMedioevo69 per verificarne percorsi e atteggiamenti concomi-tanti al declino comunale e all’approssimarsi delle dominazionifrancese e sabauda. La devoluzione del 1531 innescò in cittàprocessi analoghi a quelli riscontrabili in altre realtà italiane? Ilpatriziato imboccò la via della chiusura dei ranghi o tentòpiuttosto di mantenersi in equilibrio tra amministrazione mu-nicipale, corte e feudalità nel contado? Una risposta parziale aquesti interrogativi, che propende per la seconda ipotesi, è of-ferta dai pochi saggi a disposizione e per esempio dai risultatidi una giornata di studio sul casato dei Roero (Asti, 9 giugno2005, I Roero tra Medioevo ed età moderna); ma molto resta ancorada fare. Manca pure un lavoro accurato sul contado testè chia-mato in causa: il processo di separazione tra la città e la cam-pagna circostante non fu indolore e se, per certi versi, nell’A-stigiano assomigliò a quello di alcune aree lombarde 70, nonandrebbero dimenticati né il ruolo giocato dalla magistraturacinquecentesca del Tribunale delle Ultime Appellazioni delContado d’Asti – eccezionale concessione ducale in omaggioall’antica autonomia della città – né lo smembramento dellelocalità direttamente dipendenti dalla giurisdizione urbana com-piuto negli anni della prima guerra di Monferrato. Del tuttoneglette, poi, sono state finora la realtà economica e quella eccle-siastico-religiosa: eccetto alcuni contributi provenienti da tesidi laurea e articoli su riviste locali e non («Il Platano», ma
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 117
69 L. CASTELLANI, Gli uomini d’affari astigiani. Politica e denaro tra il Piemonte e l’Europa(1270-1312), Torino, Paravia, 1998. Ma si possono citare, perché vanno in direzione diun approfondimento dei temi del credito e dell’ascesa sociale fino alle soglie dell’etàmoderna e oltre, alcuni lavori promossi dal Centro Studi sui Lombardi e il credito nelMedioevo di Asti, diretto da Renato Bordone: Politiche del credito. Investimento, consumo, soli-darietà, atti del convegno, Asti, 20-22 marzo 2003, a cura di G. Boschiero e B. Molina,Asti, Grafiche TSG, 2004, e Dalla carità al credito. Ricchezza e povertà ad Asti dal Medioevoall’Ottocento, a cura di R. Bordone, Asti, Editrice Omnia, 2005.
70 G. CHITTOLINI, La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, sec. XIV-XV), in«Archivio storico italiano», CLX (2002), pp. 47-78.
anche il «Bollettino storico-bibliografico subalpino»), non siregistrano ricerche in corso su temi che giacciono sotto l’eti-chetta, generica, di crisi del Seicento e che sarebbero invecepropedeutici, come si è anticipato, alla comprensione del piùnoto XVIII secolo.
A proposito delle riviste di storia locale mi preme peraltroaprire una breve parentesi: è un dato che lo spoglio integrale diquesto genere di letteratura sia necessario per individuare l’edi-zione di documenti inediti, contributi di buona fattura, lineestoriografiche seguite nel corso dei decenni, se non dei secoli.Tuttavia occorre sempre maneggiarle con cautela, non perden-do di vista l’obiettivo di far uscire la storia del Piemonte dacircuiti ristretti e di metterla al passo con il resto della produ-zione accademica italiana. Evito per questo di proporre qui unarassegna completa di articoli sulle singole città piemontesiosservando che serviranno da corredo alle ricerche d’archivio esuppliranno in parte alla scarsa presenza di studi sui territorisabaudi tra le pagine delle riviste nazionali. Non si esclude,inoltre, che a corollario dei libri in programma sulle città si pos-sa pensare a incontri e momenti di riflessione storiografica sulproblema stesso della storia locale e della sua funzione pub-blica.
Passo ora al caso di Novara. Per studiare questo centro ur-bano la cui reale identità tuttora pendola tra Piemonte e Lom-bardia – forse con una maggiore, ideale appartenenza alla se-conda – non si può prescindere dall’incrocio di fonti prove-nienti dagli Archivi di Stato di Milano, Torino e Novara e dal-l’Archivo General de Simancas. Su queste tornerò rapidamentenel paragrafo successivo, per concentrarmi qui sulla cronologiae su alcuni spunti tematici. Anno cruciale per la storia della cit-tà, soprattutto dal punto di vista sabaudo, è ovviamente il1738, che ne siglò il passaggio al Regno di Sardegna dopo labreve stagione asburgica durata dal Trattato di Utrecht (1713)alla fine della Guerra di successione polacca. I due cambi di
118 blythe alice raviola
dominazione costituiscono già di per sé motivo d’interesse: dalpunto di vista della storia territoriale, essi avvennero in anni diacceso riformismo sia viennese sia torinese e sarebbe bene ri-tornarvi partendo dalle fonti di carattere economico che susci-tarono l’intelligente curiosità di Giuseppe Prato 71. Lo studiodella seconda metà del Settecento attraverso l’analisi della pe-requazione del Novarese e del Vigevanasco permetterà però digettare uno sguardo anche sul passato spagnolo, non dimenti-cando che, nel XVI secolo, questa fu una delle aree in cui at-tecchì maggiormente il modello pastorale, tutto controriformi-stico, di Carlo Borromeo, applicato nella diocesi di Novara dalcelebre vescovo Bascapè. Ma oltre al piano ecclesiastico-reli-gioso (su cui rinvio in generale al paper di Paolo Cozzo), meri-tano nuovi studi gli assetti territoriali del Novarese della primaetà moderna cui facevano capo il Lago Maggiore e il suo baci-no innervato di corsi d’acqua e le località di Intra e Pallanzaoggi riunite nel capoluogo di Provincia di Verbania. L’analisidella feudalità della zona e dei sistemi di conduzione delle pro-prietà potrà essere d’aiuto alla comprensione delle difficoltà in-contrate dai funzionari sabaudi nel tentativo di omologazionedel territorio appena acquisito.
Un aspetto fondamentale su cui, lo si ripete, la letteraturapregressa non è sufficiente così come non lo sono le pochericerche in corso è quello economico. Considerando, per esem-pio, i volumi 3 e 4 della Storia di Torino, gli unici contributi inmateria sono quelli di Enrico Stumpo 72, incentrati inevitabil-mente sulla capitale e sulla corte quale centro di operazioni fi-nanziarie legate al loisir e alla guerra. Ma questa dimensione
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 119
71 G. PRATO, La vita economica in Piemonte a mezzo il secolo XVIII, Torino, STEN (poiParavia), 1908.
72 E. STUMPO, Spazi urbani e gruppi sociali (1536-1630), in Storia di Torino, vol. III, Dalladominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630), a cura di G. Ricuperati,Torino, Einaudi, 1998, pp. 185-220, e ID., Economia urbana e gruppi sociali, ivi, vol. IV, Lacittà fra crisi e ripresa (1630-1730), a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi, 2002, pp.247-271.
urbana dei fenomeni economici pone un altro problema, che èquello dei contorni entro cui comprendere la storia di unacittà: limitarsi al mero recinto cittadino o estendere lo sguardoal contado, se non alle altre aree della regione? L’attenzione aldato economico farebbe propendere senza alcun dubbio perquesta seconda ipotesi, la sola che garantirebbe di mettere inluce i flussi commerciali di cui ciascun luogo era punto d’ap-prodo e di partenza e che allontanerebbe il rischio di una pro-spettiva troppo chiusa. I circuiti su cui poteva contare Torinocomprendevano senz’altro la Chieri socialmente ed economica-mente dinamica studiata a suo tempo da Luciano Allegra 73,ma anche altre località – Moncalieri, Rivoli, Susa, Pinerolo pernon citarne che alcune – che appaiono poco contemplate tra lepagine della Storia di Torino. Allo stesso modo, occuparsi di Ales-sandria significherebbe tener conto anche di Casale, di Tortona,di Ovada, di Novi, di Felizzano, sulla cui vocazione commer-ciale e sul cui sviluppo agricolo ha scritto pagine dense e illu-minanti Giovanni Levi 74.
Cardine del sistema economico degli spazi sabaudi furonola rete stradale e quella idroviaria. Se alla prima è stata riservataqualche osservazione marginale, la seconda – se si escludonogli studi sull’opera di canalizzazione nel Piemonte dell’800 75 –necessita di una riscoperta pressoché totale. Ho avviato, da treanni circa, uno studio sulla navigazione del Po in età modernae il primo dato a emergere, anche in questo campo, è l’esiguitàdella bibliografia disponibile a fronte dell’importanza dell’ar-gomento e dell’attenzione di cui comprensibilmente gode inLombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Dell’uso dei fiumi in
120 blythe alice raviola
73 L. ALLEGRA, La città verticale. Usurai, mercanti e tessitori nella Chieri del Cinquecento, Mi-lano, Franco Angeli, 1987.
74 G. LEVI, Centro e periferia cit., pp. 153 sgg.75 A. ACTIS CAPORALE - T. RICARDI DI NETRO, Irrigazione rurale e acquedotti interni. Da
Langosco a Cavour, da Birago a Vische a Del Carretto di Balestrino, in Famiglie nobili e borghesi.Dall’Arsenale a nuovi mestieri, a cura di F. Gianazzo di Pamparato, Torino, Piemontecul-tura, 2002, pp. 171-199.
ambito sabaudo è quasi scomparsa la memoria e i pochi contri-buti editi riguardano per lo più gli aspetti tecnico-scientificidel problema 76. Eppure la documentazione consultata sta resti-tuendo la presenza di numerosi porti sul Po e sul Ta-naro, diempori commerciali nelle loro vicinanze, di legiferazione inmateria sin dal Cinquecento, di progetti per rendere navigabilicorsi d’acqua e tratti impervi al fine di sfruttare anche in areasubalpina una risorsa indispensabile nella regione padana. Cre-do pertanto che incentivare le ricerche sulla rete fluviale pie-montese potrà contribuire a arricchire il panorama di studi sulsistema delle strade liquide italiane (anch’esso non così florido,a dire il vero) e a comprendere meglio alcuni meccanismi eco-nomico-commerciali interni allo Stato sabaudo77. Non va di-menticato, infatti, che dietro a questi si celano reti sociali atrama fitta e percorsi tra luoghi tutt’altro che isolati o mal col-legati tra loro, così come non si può tacere, per restare in temadi acque, l’aspirazione sabauda alla navigazione in mare. Andràquindi riconsiderata anche l’attività dei porti di Nizza eVillafranca di Nizza nella loro veste poliedrica di ba-luardimilitari alle frontiere con la Francia, avamposti filospagnoli,sede di governatorati importanti e albergo (con relativo ceri-moniale) della piccola flotta dei duchi di Savoia 78.
Pertiene alla storia territoriale anche lo studio dei confini. Iltema, come si è anticipato, è attualmente oggetto d’indagine
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 121
76 Cfr. L. GRIVA, Imprese di navigazione sul Po in Piemonte tra Sei e Settecento, in «Studi pie-montesi», marzo 1997, vol. XXVI, fasc. 1, pp. 93-100, ma soprattutto L. MOSCATI,Giambattista Beccaria: misura e regime giuridico delle acque nel Piemonte del Settecento in Studi in memo-ria di Mario E. Viora, Roma, Fondazione Sergio Monchi Onory, 1990, e EAD., In materia diacque: tra diritto comune e codificazione albertina, Roma, Fondazione Sergio Monchi Onory,1993.
77 Su questi problemi, con indirizzi bibliografici di carattere internazionale, mi per-metto di rinviare a B.A. RAVIOLA, La strada liquida. Costruire un libro sul Po in età moderna, in«Rivista storica italiana», II sem. 2006, pp. 1048-1071.
78 Alcune osservazioni in un altro mio breve studio: La frontiera sul mare: i governatorisabaudi di Nizza e Villafranca tra XVI e XVII secolo, in Frontières dans la ville, frontières de la ville:les échanges économiques et leurs acteurs, actes du colloque international, Nice, 15-16 dicem-bre 2005, en presse.
delle unità aderenti al PRIN 2003-05 sulle frontiere nell’Italiamoderna. Nel caso del ducato sabaudo un precedente biblio-grafico importante è La frontiera da Stato a nazione. Il caso Piemon-te 79 (1987). Negli ultimi anni, tuttavia, gli storici tout courthanno quasi dimenticato i confini piemontesi lasciandoli alvaglio degli storici della geografia che, giustamente, hanno tesoa occuparsene più da un punto di vista cartografico 80 che poli-tico. Proprio quest’ultimo aspetto, invece, merita di tornare inauge perché sono storiograficamente assai pregnanti quelle chepossiamo definire frontiere interne (i territori annessi come ilMonferrato, le province di nuovo acquisto, persino la Sicilia ela Sardegna come appendici sabaude in mare) così come i con-fini interstatali da osservare senza limitarsi a rispolverare i trat-tati diplomatici che via via li definirono, ma studiando il lavo-rio incessante che li precedette, le pratiche (e le liti) di confine,il contrabbando, etc. Si sono mossi in tale direzione i lavori delseminario su Frontiere, scambi intellettuali e circolazione dei testi svoltositra il 17 e il 19 ottobre 2005 in seno alle attività dell’unitàtorinese del menzionato Cofin. Il programma delle prime duegiornate verteva infatti su Il problema della frontiera e lo spazio sa-baudo e le relazioni che si sono susseguite 81 consentono di get-tar nuova luce su tematiche trasversali. Fa da apertura, intanto,un saggio di Daniel Nordman che è uno dei massimi speciali-sti europei del concetto di frontiera 82 e la cui chiarezza defini-toria è indispensabile per maneggiare correttamente categoriecomplesse come, appunto, quelle di frontiera e di confine. Gli altricontributi, poi, muovendosi su piani differenti, introducono il
122 blythe alice raviola
79 Edito a cura di C. Ossola, Cl. Raffestin e M. Ricciardi per i tipi di Bulzoni,Roma.
80 Cfr. Rappresentare uno Stato. Carte e cartografi degli Stati sabaudi dal XVI al XVIII secolo, acura di R. Comba e P. Sereno, Torino-Londra-Venezia, Allemandi, 2002, 2 voll., eanche Il teatro delle terre cit.
81 Edite a cura di chi scrive, nella collana Temi di storia – Frontiere e confini con il titoloLo spazio sabaudo. Intersezioni, frontiere, confini in età moderna, Milano, Franco Angeli, 2007.
82 Cui ha dedicato vari studi, il maggiore dei quali è Frontières de France. De l’espace auterritoire. XVIe-XIXe siècle, Paris, Gallimard, 1998.
lettore all’analisi di luoghi e momenti critici per la storiasabauda: si va da quello di Giuseppe Ricuperati sulla costitu-zione degli spazi sabaudi letta in chiave storiografica a quelli diDonatella Balani, Dino Carpanetto, Paolo Palumbo e MarinaCavallera rispettivamente sui confini del Regno di Sardegnacon Francia, Svizzera, Repubblica di Genova e Stato diMilano; da quelli di Paolo Cozzo e Chiara Povero sulle fron-tiere ecclesiastico-giurisdizionali e confessionali a quello diPierpaolo Merlin sulla Sardegna, riscoperta di recente attra-verso lo sguardo dei viceré 83, al mio sul Monferrato e su altrepiccole realtà territoriali la cui rappresentazione cartograficaaveva una valenza fortemente politica; a due ricerche, infine, diVincenzo Sorella sull’immagine di Piemonte restituita dalle pa-gine di Denina, e di Giorgio Monestarolo che presenta un ine-dito carteggio tra l’economista Donaudi delle Mallere 84 e l’in-tendente generale Ugo Vincenzo Botton di Castellamonte. Inquesti ultimi casi, s’intende, le frontiere non sono soltantoquelle fisiche, da attraversare con merci, eserciti, uomini diChiesa, ma anche quelle meno restrittive della cultura deiLumi. Peraltro, che un’accezione ampia dell’idea di frontiera sipresti a interpretazioni che per gli storici vanno al di là deldato geo-morfologico è ora ben dimostrato dal primo dei vo-lumi della collana creata appositamente per il Cofin di cui si èdetto: in Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’etàmoderna, a cura di Claudio Donati 85, sono annunciati sin dalsottotitolo gli indirizzi d’indagine offerti da una regione attra-versata dal cammino spagnolo per le Fiandre e confinante coni Grigioni.
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 123
83 Cfr. Governare un regno. Viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento, attidel convegno nazionale di studi, I viceré e la Sardegna nel Settecento, Cagliari, Palazzo Vi-ceregio, 24-26 giugno 2004, a cura di P. Merlin, Roma, Carocci, 2005.
84 Personaggio di cui ha ricostruito la biografia intellettuale in Negozianti e imprendi-tori nel Piemonte d’Antico Regime. La cultura economica di Ignazio Donaudi delle Mallere (1744-1795), Firenze, Olschki, 2006.
85 Milano, Franco Angeli, 2006.
Dai confini alla questione dei rapporti interstatuali il passocomunque è scontato. Mi limito anche qui a fornire qualchespunto di massima per ricerche che potrebbero prendere il viagrazie all’ISPRE. Innanzitutto va fatto un accenno a iniziativeche altrove stanno dando buoni frutti e che, valutata la consi-stenza delle fonti piemontesi, potrebbero essere prese a mo-dello. Mi riferisco, per esempio, ai carteggi degli oratori man-tovani a Milano pubblicati sotto la direzione di Franca Le-verotti. Avviata nel 1999 con il patrocinio del Ministero per iBeni e le attività culturali e dell’Ufficio centrale per i beni ar-chivistici, l’opera si articola in ben 16 volumi che copronol’arco temporale 1450-1500 e, corredata da introduzioni eindici dei nomi, si sta rivelando uno strumento di notevolevalore per chi si interroghi sui problemi della diplomazia, suirapporti tra le corti e, più in generale, sul tema delle originidello Stato moderno da cui ha preso il via questo progetto. Sisa che, quasi al pari dei colleghi veneziani, gli ambasciatorimantovani hanno contribuito più che altrove a garantire la so-pravvivenza politica del piccolo ducato gonzaghesco e a dar lu-stro a una delle corti più magnificenti d’Europa 86. Altro ècerto il discorso per il Piemonte sabaudo, la cui capacità diinterloquire con l’esterno (con l’estero) si sviluppò più tardi emeno organicamente, ma è pur vero che le fonti, setacciate concura, potrebbero riservare qualche sorpresa.
Innanzitutto, lo studio delle reti diplomatiche e dei prota-gonisti della diplomazia subalpina, nonché dei loro pendants eu-ropei, andrebbe pianificato e intrecciato con i progetti relativialla storia militare di cui si occupa un altro dei progetti ISPRE
(Bianchi). Nella consapevolezza, infatti, che il tessuto delladiplomazia è costante e prolungato nel tempo (quindi anche
124 blythe alice raviola
86 Cfr. R. QUAZZA, La diplomazia gonzaghesca, Milano, Istituto per gli studi di politicainternazionale, 1941, e D. FRIGO - A. MORTARI, Nobiltà, diplomazia e cerimoniale alla corte diMantova, in La corte di Mantova nell’età di Andrea Mantegna: 1450-1550, a cura di C. Moz-zarelli, R. Oresko, L. Ventura, Roma, Bulzoni, 1997.
nel tempo di pace, ad esempio sul versante della politica matri-moniale), è innegabile che siano i frangenti di guerra o di con-flitto imminente quelli in cui acquista maggior spessore e, so-prattutto, produce più documentazione. Si è già fatto cenno amomenti cruciali da questo punto di vista, ma si pensi ancoraai complessi rapporti tra lo Stato sabaudo e la Repubblica diVenezia per tutta l’età moderna; alla rivalità coi Medici e iGonzaga; all’alternanza tra aderenza filo-francese e filo-spa-gnola che condizionò le fazioni di corte dalla fine del XVIsecolo a tutto il XVII almeno, e in particolare durante la guer-ra civile; al ricorso sempre più massiccio agli Asburgo di Vien-na a partire dalle due guerre per la successione del Monferratoe, tra fine Sei e inizio Settecento, per la spinosa questione deifeudi imperiali e pontifici; o, ancora, agli screzi (e alle vere eproprie guerre) con la Repubblica di Genova per questioni con-finarie e di controllo sul mare che trovarono una drastica solu-zione solo con l’annessione ottocentesca della Liguria. Il primolavoro da compiere riguardo la massa di fonti che a tutto ciò siriferisce sarebbe quello di individuare innanzitutto i diploma-tici più rappresentativi e di ricostruirne quindi un profilo dainserire nel Repertorio delle cariche che dovrebbe rientrare nel pro-gramma delle attività dell’ISPRE. Quindi occorrerebbe spogliar-ne i carteggi abbandonando un approccio meramente istituzio-nale e traendo invece informazioni non solo sulla politica este-ra sabauda, ma anche su quella economica indistricabilmentelegata ad essa. Per citare un esempio concreto, quando ErcoleTommaso Roero di Cortanze – di cui ho seguito l’attività pre-cedente la nomina a viceré di Sardegna 87 – fu ambasciatore inInghilterra tra il 1719 e il 1726, ragguagliò la corte di Torinoanche sugli affari britannici lasciando intravedere possibilità diaccordi commerciali vantaggiosi. Mirabile, all’incirca per glistessi anni, è la corrispondenza degli ambasciatori francesi a
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 125
87 B.A. RAVIOLA, Prima del viceregno. Ercole Tommaso Roero di Cortanze, patrizio di Asti, mili-tare e diplomatico, in Governare un viceregno cit., pp. 83-104.
Torino, vivaci testimoni del declino di Vittorio Amedeo II edell’ascesa al potere di Carlo Emanuele III e del suo ministroFerrero d’Ormea; tra le testimonianze di maggior pregnanzameriterebbe, per esempio, di essere pubblicata la Relation de l’am-bassade du marquis de Senecterre (1734-43) di cui ho parlato al-trove88.
In stretta correlazione con le tematiche finora elencate è ilproblema della presenza, in territorio sabaudo, di numerosifeudi imperiali. Fenomeno tipico di alcune aree italiane (il Pie-monte appunto, ma anche la Garfagnana, l’Emilia, lo Statopontificio) come ha contribuito a mettere in luce un recenteconvegno 89, il feudo imperiale è un fossile medievale che hasaputo attraversare indenne i secoli dell’Antico Regime. Nono-stante il progressivo potenziamento del potere statale, infatti, ititolari di tali possedimenti, contando sul legame diretto conl’Impero, riuscirono a vedersi confermate nei secoli che ci inte-ressano prerogative e autonomie giurisdizionali di non pocopeso, grazie alle quali interrompere la continuità giuridico-ter-ritoriale dello Stato. Valutandone posizione – non è un caso se,come nel Montefeltro o in Lunigiana, si trovino alle periferiedel ducato o in aree di altra provenienza signorile (le Langhe, ilMonferrato)90 – e ruolo politico, sarà possibile mostrare an-cor più concretamente la genesi composita degli spazi sabaudie sollevare nuovi argomenti di studio. Per non citare che duecasi, non si potrà prescindere dai feudi dei Del Carretto –dinastia marchionale cui varrebbe la pena di dedicare un conve-gno o una pubblicazione pensata tra Piemonte e Liguria – e
126 blythe alice raviola
88 B.A. RAVIOLA, «Le tout-puissant» cit.89 I feudi imperiali, in corso di stampa.90 B.A. RAVIOLA, Un complesso intreccio di giurisdizioni. I feudi imperiali del Monferrato gonza-
ghesco, in I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo, atti del convegno, Albenga-FinaleL.-Loano, 27-29 maggio 2004, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Roma, Bulzoni, incorso di stampa, e ora EAD., The Imperial System in early modern Northern Italy: a web of duke-doms, fiefs and enclaves along the Po, in The Holy Roman Empire/Das Heilige Römische Reich, 1495-1806, actes of the international conference, Oxford, New College, 30 August - 2September 2006, edited by R. W. Evans, Oxford University Press, in printing.
dal principato di Masserano dei Ferrero-Fieschi, vero e propriomicro-stato attorno cui ruotarono le ragioni della famiglia stes-sa, di Torino, di Genova, di Vienna. Così come per comunità ecittà, anche su questi temi si dovrà partire da una bibliografiapiuttosto esigua – magari ben informata ma pur sempre fruttodi studi locali 91 – per approdare presto a più solide ricerched’archivio.
Alla complessità delle persistenze imperiali va aggiunta l’e-sistenza di feudi pontifici direttamente dipendenti, dal puntodi vista giurisdizionale, dalla Chiesa di Roma. Concentrati pre-valentemente in territorio astigiano (motivo per cui sono notianche come feudi della Chiesa d’Asti) e per lo più in manoall’aristocrazia della zona, essi furono a maggior ragione isoledi autonomia e luoghi del contendere tra Torino e il papato insecoli in cui i rapporti tra le due corti andarono complican-dosi. Salvo pochi recenti cenni 92, anche queste enclaves atten-dono indagini aggiornate, che puntino all’esame di questo tipoparticolare di feudalità, degli incroci politico-diplomatici conRoma e Vienna, dei laici ed ecclesiastici che ne furono incari-cati (ma si vedano, su questo, le proposte di P. Cozzo).
4. Strumenti di ricerca e fonti
Come illustrano anche gli altri progetti e com’è noto, perchiunque voglia accostarsi alla storia degli spazi sabaudi i fondidell’Archivio di Stato di Torino, conservati nelle due sezioni
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 127
91 Cfr. per esempio G. CASANOVA, Il marchesato di Zuccarello, Albenga, Edizioni delDelfino Moro, 1989 e Piccoli principati liguri. Oneglia, Finale, Monaco. 1400-1795, Intro-duzione di G. Guadalupi, Milano, Franco Maria Ricci, 2002.
92 Cfr. T. MÖRSCHEL, Buona amicitia? Die Römish-Savoyischen Beziehungen unter Paul V.(1605-1621). Studien zur Früneuzeitlichen Mikropolitk in Italien, Mainz, von Zabern, 2002,pp. 358 sgg. Per un discorso più ampio sulla costituzione delle diocesi sabaude si vedaP. COZZO, La geografia celeste dei duchi di Savoia. Religione, devozioni e sacralità di uno Stato di etàmoderna (secoli XVI-XVIII), Bologna, il Mulino, 2006.
Corte e Riunite, sono fondamentali. Non si tratta, infatti, dellesole serie istituzionali – a tutt’oggi le più scandagliate – maanche di documentazione di carattere giuridico, economico,cartografico che, se schedata massicciamente, fungerebbe dabase solidissima per la ricostruzione dei rapporti tra le autoritàcentrali e i territori del ducato e delle relazioni interstatuali delPiemonte col resto d’Europa.
Per la storia delle città, un comodo punto di partenza ècostituito senza dubbio dal fondo Paesi per A e B conservatopresso la sezione Corte. Di natura visibilmente artificiale, essoraccoglie, nei casi migliori, documentazione che va dal Medio-evo all’unità d’Italia con un’interruzione negli anni napoleo-nici. Per le città, più che per i piccoli centri, le tappe cronolo-giche sono abbastanza serrate e consentono di individuare pas-saggi politico-amministrativi di particolare rilevanza o eventidi un qualche interesse. Si prenda Novara, di cui si proponequi la stesura della storia: i mazzi nel complesso sono cinque(N, mm. 13-17) e contengono documenti che coprono l’arco1304-1861. La parte più cospicua è quella sette-ottocentescapoiché, com’è ovvio, il materiale relativo agli anni spagnoli sitrova a Milano e a Novara; tuttavia, per non fare che un esem-pio, la Relazione della Camera de’ conti di Torino a S.M. sopra alcuni abusiinvalsi e tollerati nella città di Novara del 1741 (m. 14, fasc. 3) è giàindicativa dei primi difficili contatti delle autorità sarde con lacittà da poco annessa e dei punti da esse individuati come con-troversi: tensioni interne al patriziato urbano, fortemente do-minato dalla famiglia Tornielli; la presenza di una milizia ur-bana dotata di un certo potere; la gestione delle risaie, che ol-tretutto rendevano insalubre l’aria. In Materie economiche sarannoda vedere anche gli atti del Censimento dei paesi di nuovo acquisto, ilcui arco cronologico (1548-1828) fornisce notizie non solo apartire dagli anni della perequazione sabauda, ma anche dei duesecoli precedenti.
A Milano, oltre a 13 scatole dell’Archivio sforzesco inerentila città (Novara, 1450-1535), si potranno consultare i carteggi
128 blythe alice raviola
dei governatori lombardo-spagnoli confrontandoli, possibil-mente, con i documenti delle Secreterías Provinciales dell’ArchivoGeneral de Simancas 93. L’Archivio di Stato di Novara è abba-stanza ricco per quanto riguarda la storia delle magistraturecittadine, delle fortificazioni della piazza, che fu importanteavamposto militare, della gestione delle acque fluviali, lacustrie irrigue, del contado e del Vigevanasco.
Valido complemento alle fonti enumerate, per Novara e perqualunque altro centro urbano si voglia studiare approfondita-mente, sono poi gli Ordinati comunali, in questo caso conservatipresso lo stesso Archivio di Stato (per l’arco cronologico 1501-1849) e non in quello storico del Comune. Fonte seriale e ri-petitiva, se passata in rassegna sul lungo periodo può invecerivelarsi fondamentale per la ricostruzione delle dinamiche in-terne ai ceti dirigenti locali, dell’amministrazione economicaurbana, del rapporto tra città e campagne circostanti e così via,a seconda delle peculiarità del luogo in questione.
Il fondo Paesi per A e B andrà ripercorso per Vercelli, su cui sidispone anche di 41 mazzi della serie Paesi, Vercelli città e provincia,e sulla quale si dovranno poi sondare le fonti del locale Archi-vio di Stato, dando risalto alle carte della Prefettura (1560-1801) e dell’Intendenza (1696-1801, con documenti dal 1513).Assai cospicui – e il discorso vale ancor più per l’Archivio diStato di Alessandria – sono i fondi notarili, in merito ai qualisarebbe necessario impostare un piano di lavoro concreto: sot-tostimati o utilizzati per lo più occasionalmente, così come gliatti dell’Insinuazione, offrono in realtà una miniera di infor-mazioni che, adeguatamente selezionate, restituirebbero spac-cati socio-patrimoniali da porre a confronto con il più ampioquadro politico-istituzionale. Per quanto riguarda le vicendediplomatico-militari sarebbe poi utile schedare i dispacci spa-
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 129
93 Titulos y privilegios de Milan. Siglos XVI-XVII, por A. Gonzalez Vega y A.M. DiezGil, Valladolid, Catalogo XXXIII del Archivo General de Simancas, 1991, pp. 437-438.
gnoli conservati presso l’Archivo General de Simancas che ren-derebbero più evidente il contesto europeo. Volendo insisteresul territorio, inoltre, non andranno trascurati i principali ar-chivi familiari (Arborio di Gattinara; Arborio Mella; Avo-gadro; Buronzo) e le sezioni di Archivio di Stato di Biella eVarallo – località che in età moderna erano entrambe compresenella provincia di Vercelli – il primo contenente, per esempio,l’Archivio Dal Pozzo della Cisterna, il secondo le carte sulSacro Monte e su vari enti ecclesiastici, da considerare nonsolo sotto il profilo devozionale. Si dovrà infine setacciare l’ar-chivio delle tesi di laurea assegnate all’Università di Vercelli perverificare che ne esistano di efficaci sulla storia cittadina; comenel caso di Alessandria, il cui polo universitario è affiliato aquello del Piemonte Orientale, l’impostazione di nuove ricer-che storiche potrebbe anzi fornire l’occasione per avviare undialogo con enti la cui attività, al momento, risulta piuttostoisolata.
Per Asti si ricorrerà, per restare a Torino, a fonti analoghe aquelle ricordate poco sopra: in prima battuta Asti città e provincia,che contempla anche carte sui menzionati feudi della Chiesad’Asti, Paesi per A e B e i fondi camerali; quindi le carte dell’Ar-chivio di Stato di Asti tra le quali, pur prevalendo materialeotto-novecentesco, si trovano archivi familiari degni di nota,come quello dei Roero di Cortanze o quello dei Cocconito diMontiglio, del tutto intatto. La documentazione di carattereeconomico è abbondante e in buona misura inesplorata: di re-cente ho potuto constatare la ricchezza, quasi ovvia, dell’Insi-nuazione astigiana nonché della documentazione su censi e cre-diti urbani che si trova presso l’Archivio storico del Comu-ne 94. Rispetto ad altre realtà urbane, Asti vanta inoltre unaserie di Ordinati comunali piuttosto completa, pressoché ininter-rotta dalla fine del Quattrocento al declino dell’Antico Regi-
130 blythe alice raviola
94 B.A. RAVIOLA, Il mercato dei censi ad Asti tra Cinque e Settecento. Note sullo studio di un pro-blema di storia socio-economica, in Dalla carità al credito cit., pp. 49-64.
me. Conservati anch’essi presso il locale Archivio storico e inparte già frequentati da chi scrive, alcuni dei volumi sono do-tati di rubrica e, specie per i secc. XVII-XVIII, non sarebbedisagevole né troppo dispersivo esaminarli con continuità.
Sulle vicende socio-economiche del ducato subalpino e del-le sue componenti interne si dovrà schedare a fondo la serieMaterie economiche della sezione Corte dove, tra le varie serie, sitrovano documenti sulle gabelle, sui dazi doganali, sulle stradee sulla gestione dei corsi d’acqua, sulla produzione manifattu-riera e protoindustriale, sulla perequazione avviata a fine Sei-cento, etc. La prevalenza di carte prodotte nel Settecento erelative alle riforme di quel secolo andrà compensata con lostudio di fonti locali – non da ultimi i catasti che si trovanovariamente distribuiti sul territorio95 e negli archivi di Stato ecomunali – ma soprattutto con intensi lavori di schedatura delfondo Camerale delle sezioni Riunite. Tralasciando qui le fontidi carattere fiscale originate dalle esigenze militari dello Stato(che forse sono la maggior parte e sulle quali rinvio al progettodi Paola Bianchi), mi limito a citare i Conti riguardanti le Gabellediverse e l’esercizio degli appalti in tutte le province del ducato.Da carte di questo genere si desumono spesso informazioni chevanno al di là della semplice riscossione di taglie e imposizionidoganali: per restare ai casi del Monferrato, dell’Alessandrino edel Novarese, molti dei documenti sulle gabelle risalgono alXVII secolo restituendo la normativa e gli usi in materia delledominazioni precedenti. Una menzione merita il fondo Feuda-lità che raggiunge quasi i 2000 pezzi. A parte la documenta-zione specificamente legata alla concessione dei titoli, alle inve-stiture e alle infeudazioni, vi si reperiscono atti sui conflitti digiurisdizione causati dal possesso di beni feudali, dall’utilizzo
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 131
95 EAD., Feudalità, comunità e catasti in età moderna tra Monferrato e Astigiano, in Lo spazio poli-tico locale in età medievale, moderna e contemporanea. Pratiche di ricerca, problemi di metodo, esperienze digestione, atti del convegno, Alessandria, 26-27 novembre 2004, a cura di R. Bordone e A.Torre, Alessandria, Edizioni dell’Orso, in corso di stampa.
di acque e mulini o da problemi simili, tutti funzionali allacomprensione di fenomeni quali la distribuzione delle proprie-tà, la catastazione, gli attriti tra aristocrazia, municipalità e isti-tuzioni centrali. In tale prospettiva, tra le carte dell’Ufficio gene-rale delle Finanze, Prima e Seconda Archiviazione, saranno anche dascorrere i mazzi su Acque, Boschi, caccia e pesca, Strade e ponti, Provincefinalizzando le ricerche in modo da costruire una trama fittacon le fonti locali principali.
Circa i confini, le fonti di maggior impatto sono quelle car-tografiche, che vanno lette però con l’ausilio di relazioni o diatti di liti territoriali, spesso alla base della produzione di car-tografia di larga scala (tipi dei luoghi contesi, come strade, pon-ti, fiumi; catasti; etc.). Un esempio in tal senso è fornito dalfondo Confini della grande serie Monferrato, sempre conservatapresso la sezione Corte dell’Archivio di Stato di Torino. Com-posto da volumi contenenti gli incartamenti prodotti dalle par-ti nel corso di liti per la rivendicazione di un terreno, di unbene, di un diritto d’uso, offre un buon campionario dei pro-blemi confinari più comuni: dalla possibilità di utilizzo di unarisorsa specifica (l’acqua di una bealera, un gerbido, un bo-sco…) al transito su una strada (o un’idrovia) che metteva incomunicazione comunità diverse; dalla presenza di un vero eproprio confine di Stato (con il Piemonte, il Ducato di Mi-lano, la Repubblica di Genova) e i conseguenti problemi digestione giurisdizionale al contrabbando. La schedatura di que-sta e altre fonti simili, di solito frequentate episodicamente esolo in relazione a una data località, consentirebbe di unire iltema delle frontiere interne agli spazi sabaudi a quelli, già enu-cleati, dei rapporti interstatuali, dello sviluppo delle struttureeconomiche (vie di comunicazione, transiti di merci, mercati,porti fluviali), dell’intreccio delle giurisdizioni laiche ed eccle-siastiche.
Sempre su questi temi andrà vista la serie Paesi di nuovo acqui-sto (362 mazzi con carte dall’899 al 1839) la cui ossatura è
132 blythe alice raviola
costituita proprio dalle trattative per la delimitazione dei con-fini tra Stato sabaudo, Alessandrino, Novarese, Tortonese efeu-di imperiali delle Langhe e, una volta annessi, dalle cartediplomatiche relative alla rideterminazione dei contorni delledivisioni amministrative del Regno di Sardegna. Sul versantelombardo, ancora in Paesi, è il fondo Milanese che comprende,distribuita in 81 mazzi, documentazione a partire dal XIIsecolo. Sensata sarà pure la consultazione del fondo Confinidell’Archivio di Stato di Milano (381 buste inventariate per glianni 1518-1802) su cui peraltro sta già lavorando l’unitàCofin dell’Università Statale con la quale sono stati avviatiproficui contatti. Lì, come nella ricchissima sezione Acque (1310buste con carte dal Cinquecento al 1801), si possono trovarerisposte complementari ai problemi di definizione delle fron-tiere tra i due Stati e di utilizzo delle vie liquide delle provincedi nuovo acquisto. In vista poi di impostare nuovi lavori suiconfini con la Svizzera e la Francia si segnalano il cospicuomateriale su Ginevra (in Paesi, Genève, 121 mazzi con docc. dalXII sec.) e quello, decisamente più abbondante, dell’Archive duMinistère des Affaires Étrangères di Parigi che, specie per ilSettecento, richiederebbe davvero più attenzione da parte deglistudiosi degli spazi sabaudi.
Concludo con qualche cenno sulle fonti relative ai rapportiinterstatuali. Poiché, come si è anticipato, gli studi sulla diplo-mazia sabauda sono ancora frammentari, allo spoglio della bi-bliografia esistente dovrà seguire in primo luogo una disaminaaccurata della corrispondenza conservata nella sezione Cortedell’Archivio di Stato di Torino (non solo Corti estere e Lettereministri in Materie politiche per rapporto all’Estero, ma anche le Lettere diprincipi diversi e le Minute di lettere della corte, preziose per la primametà del Cinquecento), quindi la ricerca di fondi notevolipresso archivi italiani e stranieri (senza tralasciare l’ArchivioSegreto Vaticano), tra i quali posso ricordare quelli intitolatiPiamonte y Saboya e Estados Pequeños de Italia dell’Archivo General
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 133
de Simancas. Lo stesso vale per le enclaves imperiali e pontificie,la cui manifestazione più appariscente si ha proprio attraversole carte della diplomazia: tra la fine del Seicento e l’inizio delSettecento, infatti, uno dei principali obiettivi del giovane Vit-torio Amedeo II e dei suoi ministri più accorti, come PierreMellarède, fu quello di incamerare queste realtà politiche semi-autonome per riplasmarle alla luce delle riforme in atto su tut-to il territorio. Partendo dai carteggi di quegli anni – alcunigià noti, altri, a Roma e Vienna, assai meno – si tratterà diripercorrere i destini di queste anomale formazioni politicheper l’intero Antico Regime, meditando anche, com’è stato fattoalcuni anni or sono a San Marino, sul problema del piccoloStato di boteriana memoria 96.
Si noterà che ho fornito tracce prevalentemente circoscritteagli estremi cronologici dell’età moderna, seppur con il ter-mine a quo anticipato al 1450. La ragione è duplice e risiede sianella ribadita esigenza di approfondire gli studi sul Quattro-Seicento sia nelle competenze che ho acquisito nel corso degliultimi anni. Ciò non esclude, tuttavia, che i temi suggeriti, sot-toposti ad adattamenti e verifiche, non possano trovare unaprosecuzione ideale nel periodo della Restaurazione. Infatti, purtenendo conto della frattura napoleonica e delle novità, anchearchivistico-documentarie, che essa portò con sé, non va di-menticato che le fonti ottocentesche, specialmente quelle degliarchivi storici comunali, appaiono non solo straordinariamenteabbondanti e riconducibili a quelle di Antico Regime, ma deci-samente neglette per quanto riguarda la storia del territorio. Ese per storia del territorio intendiamo, come ho cercato di pro-porre, un’analisi a vasto raggio di luoghi, aree e problemi, va dasé che studiare il Piemonte di età moderna vorrà dire compren-derne l’evoluzione interna, dall’accorpamento di altre entitàstatuali alla definizione della maglia amministrativa ottocente-
134 blythe alice raviola
96 Il piccolo Stato. Politica storia diplomazia, atti del convegno, San Marino 11-13 ottobre2001, a cura di L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso, San Marino, Aiep, 2003.
sca97, secondo processi da cui oggi non può andar slegata l’i-dea di Piemonte-Regione europea che risuona nella denomina-zione stessa dell’erigendo ISPRE.
territori e poteri. stato e rapporti interstatuali 135
97 M.L. STURANI, Innovazioni e resistenze nella trasformazione della maglia amministrativa pie-montese durante il periodo francese (1798-1814): la creazione dei dipartimenti ed il livello comunale, inDinamiche storiche e problemi attuali della maglia istituzionale in Italia. Saggi di geografia amministrativa,a cura di M.L. Sturani, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001, pp. 89-118.
ANDREA MERLOTTI
Società e ceti. Le complessità della strutturaper ordini nel Piemonte d’Antico Regime
1. Lo stato dell’arte
Può sembrare curioso che, a confronto con altre tematichedi storia piemontese, i ceti sociali non abbiano ispirato nel
secolo che si è appena chiuso una storiografia particolarmentenutrita. Curioso e paradossale.
In passato, al fine di esaltare la concordia ordinum sotto le inse-gne della casa regnante, i ceti dirigenti erano stati definiti omeno membri della nobiltà sulla base di una prospettiva orafilo-patrizia (e cioè fautrice del ruolo politico consolidato deipatriziati urbani) ora filo-governativa. Non posso che ribadireconsiderazioni già formulate osservando che uno dei limiti del-la produzione storiografica sulle élites nei domini sabaudi in etàmoderna sia stato quello di nascere pressoché esclusivamentein ambito nobiliare: una letteratura opera di esponenti di unceto intenzionato ad auto-rappresentarsi e ad auto-definirsi 1.
Tutto ciò non si è verificato in altre realtà politico-geografi-che italiane ed europee. Quando in Piemonte a scrivere di no-biltà, di sistemi signorili, di patriziati erano autori come An-tonio Manno, in altri Paesi erano storici di professione anco-rati non già a una tradizione cetuale, bensì a discipline storico-
1 A. MERLOTTI, L’enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento, Firenze,Olschki, 2000; ID., Le nobiltà piemontesi come problema storico-politico: Francesco Agostino DellaChiesa tra storiografia dinastica e patrizia e Patriziato, «nobiltà civile», feudalità. Le declinazioni del cetodirigente monregalese fra Sei e Settecento, in Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero d’Ormea, atti delconvegno svolto a Torino e Mondovì, 3-5 ottobre 2001, a cura di A. Merlotti, Torino,Zamorani, 2003, pp. 19-56, 83-109; ID., Storia dello Stato e storia « locale» in Piemonte,« Iulia Dertona», LI (2003), II sem., II serie, fasc. 88, pp. 35-51; ID., Dall’integrazioneall’emarginazione. La nobiltà di Saluzzo e lo Stato sabaudo nel XVII secolo, in L’annessione sabauda delMarchesato di Saluzzo. Tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica (sec. XVI-XVIII), a cura di M.Fratini, Torino, Claudiana, 2004, pp. 87-116.
sociali ormai professionalmente consapevoli e scientificamentefondate. Il riferimento alle scuole francesi da un lato, tedeschedall’altro è scontato.
Ora, tutta una ricca letteratura erudita fiorita nel corso delNovecento nell’alveo del Patriziato subalpino del barone AntonioManno (letteratura rappresentata da saggi dedicati a singolefamiglie o a spazi geografici circoscritti) è certo meritoria diaver coltivato un genere – la genealogia – a torto miscono-sciuto dagli storici accademici, quanto meno da certe scuolerecenti. Lo strumento genealogico, come ha mostrato RobertoBizzocchi 2, costituisce un indispensabile prisma per la rico-struzione della cultura aristocratica; ma di uno strumento ap-punto si tratta, che ha bisogno di essere calato in un precisocontesto e di essere verificato. Un discorso analogo potrebbeessere esteso alla tradizione erudita dell’araldica e della sfragi-stica, su cui, da una prospettiva storica complessa, è tornata ariflettere Luisa Gentile 3.
I toni apologetici, l’erudizione priva di una necessaria con-testualizzazione dei fatti e dei personaggi, la miopia nel con-fronto con altre situazioni storiche indispensabili a non ren-dere il Piemonte sabaudo un oggetto di studio chiuso in sestesso: sono tutti aspetti facilmente constatabili nella lettera-tura fiorita sui ceti dirigenti piemontesi. Ma è altrettanto evi-dente che, al di là del ruolo rivestito dalle élites, su altri gruppisociali, rurali e cittadini, la conoscenza storica ha fatto calare ilsilenzio.
Non amo usare per il periodo pre-ottocentesco l’espres-sione «borghesia» con disinvoltura, anche se il concetto è sicu-ramente applicabile a determinate fasce di popolazione dei ter-ritori subalpini. In Francia Jean Nicolas lo applicava negli anniSettanta alla realtà savoiarda usandolo in senso antinomico
138 andrea merlotti
2 R. BIZZOCCHI, Genealogie incredibili. Scritti di storia dell’Europa moderna, Bologna, ilMulino, 1995.
3 L.C. GENTILE, I riti e gli emblemi. Processi di rappresentazione del potere principesco in areasubalpina, XIII-XVI secolo, Torino, Zamorani, 2007.
rispetto alla nobiltà detentrice di giurisdizioni feudali 4. Ma,prescindendo da classificazioni metodologicamente datate, aquali attività economiche può essere effettivamente associata laborghesia d’Antico Regime negli spazi savoiardi, nizzardi, su-balpini, monferrini, saluzzesi? Non mi pare sufficiente l’ap-proccio di alcuni risorgimentisti che continuano a semplificarela definizione e il ruolo della borghesia piemontese tra fineSette e inizio Ottocento senza porre con la dovuta profonditàquesiti ai quali solo una seria storia sociale comparata e diacro-nica potrà offrire risposte convincenti 5.
Esiste, d’altro canto, una lacuna a mio avviso particolar-mente evidente e grave, che incide trasversalmente sulle varieunità tematiche presentate in questo progetto: la scarsità dellericerche di tipo economico. Come è possibile ragionare sullaconsistenza e sulle caratteristiche dei gruppi borghesi, sullecondizioni della popolazione rurale, sull’andamento dei mer-cati in assenza di studi articolati sull’economia nei territorisubalpini nell’arco dell’età moderna? I consueti, se pur impor-tanti, riferimenti bibliografici restano i lavori, che risalgono aquasi un secolo fa, di Giuseppe Prato e Luigi Einaudi, sullafinanza di guerra e le pubbliche entrate negli anni tra fine Sei eprima metà del Settecento. Enrico Stumpo ha approfondito leripercussioni della politica mercantilistica nel secondo Seicentofornendo dati, confronti e valutazioni preziosi 6. Ma i suoisaggi costituiscono tasselli di un mosaico che rimane in granparte da comporre. Mi basti osservare che, per stimare la ric-chezza e prosperità dei vari gruppi sociali, occorrerebbe cono-
società e ceti 139
4 J. NICOLAS, La fin du régime seigneurial en Savoie 1771-1792, in L’abolition de la féodalitédans le mond occidental, Paris, CNRS, 1971, t. I, pp. 27-108; ID., La Savoie au XVIIIe siècle.Noblesse et bourgeoisie, Paris, Maloine, 1978, 2 voll.
5 Cfr. S. MONTALDO, La borghesia, in Il Piemonte alle soglie del 1848, a cura di U. Levra,Torino, Istituto per la Storia del Risorgimento, 1999, pp. 49-99.
6 E. STUMPO, Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento, Roma, Istituto storicoitaliano per l’età moderna e contemporanea, 1979; ID., Guerra ed economia: spese e guadagnimilitari nel Piemonte del Seicento, «Studi storici», XXVII (1986), pp. 371-395.
scere l’andamento dei prezzi, il valore della moneta ed altrequestioni basilari, che tuttora si ignorano.
Il problema economico è centrale anche a non voler tornarea schemi un po’ obsoleti di storia delle classi sociali. La strut-tura cetuale (e cioè l’organizzazione della società sulla base digerarchie giuridico-simboliche indipendenti dalla posizione eco-nomica rivestita dai membri dei vari gruppi) mi sembra permolte ragioni, come è stato sostanzialmente confermato negliultimi decenni dalla storiografia internazionale, la prospettivapiù consona alle indagini sull’Antico Regime. Anche da questopunto di vista è difficile non notare la scarsità della bibliogra-fia sul Piemonte.
Uno degli elementi su cui in genere gli storici insistono neldescrivere le caratteristiche istituzionali degli Stati territorialiin età moderna (sec. XV-XVIII) è, fra gli altri, il rapportocontrattuale fra potere sovrano e assemblee di rappresentanzadei ceti. Ma che cosa conosciamo di tali istituzioni nella realtàpiemontese? Poco. Si sa che fin dall’età di Emanuele Filibertole assemblee di rappresentanza cetuale erano state sospese. Ildato è stato riportato fino agli studi abbastanza recenti di Mer-lin7 senza che si sia prestata, a mio avviso, adeguata attenzionealle conseguenze di una tale eccezione, che va collocata nel-l’ambito di rapporti istituzionali che rimasero non uniformifra i territori transalpini e i territori cisalpini; varrebbe la penadi approfondire, a questo riguardo, il discorso comparativo,nella prospettiva diacronica e sincronica, con le realtà statualiconfinanti progressivamente annesse ai domini sabaudi (Mar-chesato di Saluzzo, Monferrato). La Savoia, la Val d’Aosta e leterre subalpine avevano, del resto, alle loro spalle un tessutosociale differente che non è stato indagato con sufficiente am-piezza e profondità, almeno per i secoli dell’età moderna, intutti i suoi risvolti istituzionali.
140 andrea merlotti
7 P. MERLIN, Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l’Europa, Torino, SEI, 1995.
Restituendo il clima di alta conflittualità tra fazioni princi-piste e madamiste alla conclusione della guerra civile del 1638-1642, Claudio Rosso ha per esempio ripreso, da un precedentestudio di Luigi Bulferetti, la notizia del tentativo operato dalprincipe Tomaso di Carignano di ripristinare il costume delleassemblee di rappresentanza a oltre un secolo dalla loro man-cata convocazione8; un tema come questo, di estremo interesseper la ricostruzione del non lineare rapporto fra ceti, territori esovrano, andrebbe approfondito verificando motivazioni, pro-poste di applicazione e soggetti chiamati in causa.
Ho fin qui fatto riferimento alla storiografia esistente inmodo un po’ rapsodico. In realtà, sintetizzare lo stato dell’artedegli studi sui gruppi sociali nei domini sabaudi con particolareattenzione agli spazi subalpini non è compito particolarmentearduo. Scegliendo di non descrivere la bibliografia esistente senon a partire dalla seconda metà del Novecento, per uniformitàcon le relazioni unite a questo progetto, il campo si restringe dimolto. Come accennavo sopra è quasi imbarazzante constatarel’esiguità delle indagini condotte tra gli anni Cinquanta e oggi.Imbarazzante se si guarda alla varietà della produzione fiorita inItalia e all’estero. Sono pochi gli autori e non numerosi i saggida essi dedicati alla storia sociale piemontese.
Storici come Guido Quazza, Luigi Bulferetti, Lino Marini,Stuart John Woolf, attivi tutti fra gli anni Cinquanta e Sessanta,hanno offerto contributi importanti, ma oggi superati; mentre apartire dagli anni Settanta (quando la ripresa del concetto diceto e le indagini sui gruppi dominanti negli antichi Stati ita-liani iniziavano a essere intensificate dai dibattiti aperti da stu-diosi quali Marino Berengo, Angelo Ventura, Giorgio Chittolini,Elena Fasano Guarini, Cesare Mozzarelli) l’attenzione verso la
società e ceti 141
8 C. ROSSO, Il Seicento, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, IlPiemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna, Torino, Utet, 1994, pp. 243-244; L.BULFERETTI, La fine del Parlamento di Saluzzo sotto la pressione del capitalismo feudale, in Studi inonore di Emilio Crosa, I, Milano, Giuffrè, 1960, in particolare alla pp. 303-305.
struttura cetuale negli spazi subalpini si è andata attenuando. Lostudio sui ceti dirigenti piemontesi nel Settecento che ho pub-blicato nel 2000 credo abbia contribuito a riaprire la discus-sione su questioni che Claudio Rosso aveva parzialmente toc-cato tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta9.
Le ragioni della discontinuità temporale nella produzionestoriografica si possono cercare in fattori di diversa natura, coin-cidenti per il fatto di aver avuto proprio negli anni Settanta laloro maturazione. Da un lato si è verificato il progressivo disa-moramento per tutto ciò che sapesse di sabaudo-piemontese,dietro il condizionamento di chiare forme di revisionismo del-la storia nazional-risorgimentale. Unica eccezione in tal sensoè costituita dalle indagini di Enrico Stumpo del 1979 e 1986,che hanno contribuito, non a caso da parte di un autore cheoperava ormai al di fuori del Piemonte, a mettere in luce il te-ma di un ceto in ascesa fra Sei e Settecento: quello degli appal-tatori legati alla politica mercantilistica dei duchi sabaudi 10.Dall’altro lato la predilezione fra gli storici modernisti dellascuola accademica torinese per la storiografia delle idee ha fi-nito, più o meno consapevolmente, col tagliar fuori il Pie-monte dalla crescita di un rinnovato filone di ricerche socio-istituzionali in ambito italiano ed europeo.
Chi, dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, si è misuratocon lo studio della società piemontese in età moderna non hafatto a meno di prendere a modello gli assunti di Guido Quaz-za11 e di Stuart J. Woolf 12. Nel caso di Quazza il discorso
142 andrea merlotti
9 A. MERLOTTI, L’enigma delle nobiltà cit.10 E. STUMPO, Finanza e Stato cit.; ID., Guerra ed economia cit.11 G. QUAZZA, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, Modena, STEM,
1957, 2 voll. (ed. anast. Cavallermaggiore, Gribaudo, 1992); ID., Guerra civile in Piemonte.1637-1642 (nuove ricerche), «Bollettino storico bibliografico subalpino», LVII (1959),pp. 281-321; ID., Guerra civile in Piemonte. 1637-1642 (nuove ricerche), «Bollettino storicobibliografico subalpino», LVIII (1960), pp. 5-63.
12 S.J. WOOLF, Studi sulla nobiltà piemontese nell’età dell’assolutismo, «Memorie dell’Acca-demia delle Scienze di Torino», Classe di scienze morali, storiche e filologiche, serie IV,V (1963), pp. 1-243.
sulla società era inserito in una più ampia riflessione sul con-cetto di riforme maturate entro lo Stato sabaudo nella primametà del Settecento: una prospettiva che per certi versi appiat-tiva la ricostruzione alle sole direttive politiche torinesi, peraltri toccava la questione sociale contrapponendo in modo net-to l’idea di una nobiltà (intesa come nobiltà feudale) a una nonmeglio definita borghesia, su cui a tuttora mancano indaginiarticolate e aggiornate. Quanto a Woolf, il suo studio del 1963rappresentava una descrizione per tipologie della nobiltà pie-montese, che si fondava su esempi di grandi famiglie feudali: iFalletti di Barolo, i Saluzzo di Paesana, i Valperga di Rivara. Lericerche di questi due storici non hanno, in sostanza, evitato dicadere nella semplificazione di un quadro che rimase a lungoassai articolato. Sia Quazza sia Woolf hanno ritagliato unaperiodizzazione troppo angusta per comprendere i meccanismidi trasformazione e di permanenza nei secoli dell’Antico Re-gime; nei loro lavori si considera, inoltre, come unico centrodinamico la capitale e si ignora il potere contrattuale esercitato,in aree territoriali differenti, da élites socialmente tutt’altro cheuniformi e non sempre fedeli alle direttive del governo. Non cisi allontanava, in questa prospettiva, dall’immagine di una no-biltà piemontese avvezza a ricevere di buon grado dal sovranole norme per la propria condotta, una visuale che già la storio-grafia ottocentesca aveva abbracciato e che ancora le ricercheeconomico-giuridiche di Giuseppe Prato e Luigi Einaudi ave-vano seguito nel primo Novecento. Ho motivato, nel corsodelle mie indagini, il dubbio che tali letture possano dirsi cor-rette ed esaustive per la ricostruzione di una realtà complessacome quella dello Stato sabaudo 13, per comprendere il qualeritengo sia utile ricorrere piuttosto al concetto di «monarchiacomposita» applicato con successo ad altri Stati europei d’etàmoder-na: l’Impero asburgico e la monarchia spagnola.
società e ceti 143
13 A. MERLOTTI, L’enigma delle nobiltà cit.
Come ciascuno dei progetti qui uniti illustra da un punto divista particolare, uno degli scopi delle iniziative promosse dal-l’ISPRE dovrebbe essere proprio quello di tornare a far dialo-gare storie territoriali incrociate. Nel corso dei secoli terre sa-voiarde e nizzarde, «antiche province» (spesso indicate sempli-cemente come Piemonte, anche se tale termine aveva un usopiù ristretto), province «di nuovo acquisto» (Alessandrino eNovarese), Monferrato, Sicilia, Sardegna si trovarono a coesi-stere all’interno di una compagine statale che mirò, sino allafine dell’Antico Regime, a uniformarle, realizzando solo par-zialmente i propri obiettivi. Le resistenze incontrate dalle auto-rità centrali dipendevano da un tessuto sociale talvolta alienodall’accogliere passivamente l’atto di sudditanza verso i Savoia.Lo Stato sabaudo riuscì, del resto, a contenere il fenomeno del-le rivolte, assistendo solo raramente all’esplosione cruenta ditensioni politiche e sociali. Il Seicento, con gli anni della guerracivile e delle rivolte nel Monregalese, chiuse una fase ed aprì, difatto, un lungo periodo di riforme che non conobbe altri scon-tri del genere se non dopo la crisi dell’Antico Regime e la ca-duta del regno sabaudo sotto l’onda d’urto della Franciarepubblicana.
Su questi aspetti non sono mancati gli studi, che hanno tut-tavia spesso affrontato la questione più dal punto di vista poli-tico-istituzionale che non sociale. Come lavoro a più mani de-gno di attenzione per la complessa e puntuale ricostruzione delcontesto sociale, vanno segnalati i tre volumi a cura di GiorgioLombardi dedicati agli episodi delle guerre del sale combattutenel Monregalese 14. Si tratta di un’indagine per molti aspettiindicativa di un’esperienza storiografica isolata; in questo stu-dio comparivano infatti insieme storici del diritto, demografi,storici dell’economia, tutti autori che, negli anni successivi,avrebbero intrapreso percorsi paralleli, ma non comunicanti: da
144 andrea merlotti
14 La guerra del sale (1680-1699). Rivolte e frontiere del Piemonte barocco, a cura di G.Lombardi, Milano, Angeli, 1986, 3 voll.
un lato la storia delle istituzioni in chiave giuridico-teorica,dall’altro lato (penso ad autori come Angelo Torre e SandroLombardini) l’adesione a metodi di ricerca di tipo sociologicoe antropologico volti a indagare la microstoria (la storia cioè dicomunità locali sganciate dal tessuto amministrativo sovra-lo-cale) anziché il complesso gioco dei rapporti interstatuali.
Una nuova storia dei territori subalpini quale quella che sipropone di realizzare l’ISPRE non può prescindere dall’indaginecomparata di realtà statuali inizialmente contigue e col tempoconfluite sotto un unico regno (Saluzzese, Monferrato, provin-ce già lombarde), superando la visuale un po’ miope della sto-ria delle comunità locali quale veniva concepita fino a una ven-tina d’anni fa. Il rischio di cadere in una prospettiva troppo cir-coscritta territorialmente (che è anche, del resto, il limite ditanti contributi d’erudizione locale che ho scelto di non pas-sare in rassegna in queste pagine) è quello di non riuscire a ri-connettere le parti con il tutto, di non cogliere la storicità deifenomeni in una durata medio-lunga.
In relazione ai temi di cui tratto in queste pagine, credo cheuno studio in particolare di Angelo Torre debba essere preso inconsiderazione per la serietà dell’indagine: Il consumo di devozio-ni 15. In questo studio l’autore, anziché percorrere il terreno fintroppo abusato delle mentalità collettive, tanto à la mode fino aqualche decennio fa fra gli storici a lui vicini per formazione,sceglie di privilegiare il rapporto fra cultura laica ed ecclesia-stica, fra usi contadini e norme applicate dal clero, concentran-dosi su cerimonie, sacramenti, processioni, ma anche su luoghifisici e soggetti sociali concreti: le confraternite e le confrarie.Tornerò più avanti su questi aspetti per sottolineare come sitratti, a tutt’oggi, di nodi scoperti eppure importanti per laricostruzione della vita sociale negli spazi subalpini. Torre, inrealtà, si è mosso entro un’area limitata del Piemonte meridio-
società e ceti 145
15 A. TORRE, Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime,Venezia, Marsilio, 1995.
nale – le diocesi di Mondovì, Alba e Asti fra XVI e XVIIIsecolo –, a dispetto di quanto il lettore si aspetti di trovaredalle indicazioni del sottotitolo del libro: Religione e comunità nellecampagne dell’Ancien Régime.
Analogo metodo, ma maggior chiarezza nel definire il con-testo storico particolare, si trova nello studio dedicato alle cor-porazioni torinesi fra Sei e Settecento di Simona Cerutti 16. Alcentro di questo volume è il problema della formazione di soli-darietà sociali trasversali. Giustamente il libro, anche se in mo-do non del tutto limpido, riserva un certo spazio agli anni cen-trali del XVII secolo, e cioè alle conseguenze delle fratturecreate dalla guerra civile del 1638-42.
I contributi di Torre e della Cerutti vanno letti e confron-tati con lo studio di Luciano Allegra sulla storia urbana diChieri nel Cinquecento17. Si tratta di una serie di lavori chepotrebbero smentire l’idea che, tra gli anni Settanta e gli anniNovanta del secolo che si è chiuso, si siano interrotte le ricer-che dedicate alla società piemontese da parte di storici attivi inarea subalpina; di fatto, però, gli autori di tali saggi hanno ope-rato subendo scarsi condizionamenti dalla scuola torinese, man-tenendo invece stretti contatti con l’École parigina e con le scuo-le di Giovanni Levi (ateneo di Venezia) e di Edoardo Grendi(Università di Genova). Al di là delle loro scelte metodologiche,piuttosto lontane dalle prospettive degli studi previsti dall’I-SPRE, il merito di questi studiosi è stato certamente quello diaver aperto il confronto con altre scuole storiografiche, di aver al-largato il raggio d’interesse a gruppi sociali non limitati alle éli-tes, spaziando in secoli meno frequentati: il Cinque e il Seicento.
Rimangono, in ogni caso, ampiamente scoperti gli studi sulQuattrocento, secolo fondamentale, come chiarisce la premessasulle scelte di periodizzazione, per cogliere non solo l’avvio del-
146 andrea merlotti
16 S. CERUTTI, Mestieri e privilegi. Nascita delle corporazioni a Torino. Secoli XVII-XVIII,Torino, Einaudi, 1992.
17 L. ALLEGRA, La città verticale. Usurai, mercanti e tessitori nella Chieri del Cinquecento,Milano, Angeli, 1987.
l’età moderna in uno Stato come quello sabaudo, ma in parti-colare le dinamiche dei rapporti fra i vari territori subalpini.Altrettanto lacunose risultano le indagini sull’epoca napoleoni-ca e, a dispetto della produzione esistente, anche sulla primametà dell’Ottocento.
Prima di passare dalla parte retrospettiva a quella proposi-tiva di questo progetto, vorrei aggiungere quanto ho potutoriscontrare in un rapido censimento compiuto su riviste e pub-blicazioni recenti, per verificare se sia stato recepito il discorsosull’esistenza, negli spazi subalpini, di un policentrismo ammi-nistrativo e sociale e dunque di una nobiltà al plurale 18. Se siescludono alcuni studi degli autori dei progetti qui raccolti, iltema appare ancora assai poco recepito, probabilmente anche acausa di quell’isolamento della storiografia sul Piemonte daidibattiti maturati in ambito italiano cui facevo cenno sopra. Aoggi è più facile che il Piemonte attiri l’attenzione di studiosistranieri, fenomeno che non può trovare come unica spiega-zione il fatto che i territori subalpini abbiano per secoli avutoparte attiva nelle vicende europee. Il Piemonte come portad’Italia costituisce anche una realtà storica dietro la quale sinascondono legami molto forti con la Penisola, ignorati o perlo meno taciuti da molta storiografia.
2. Problemi aperti
Da quanto esposto sopra emerge che i problemi aperti nonsono pochi. Accennavo alla carenza di studi economici sullungo periodo, in particolare sul Quattro-Cinquecento, que-stione che ritengo essenziale e centrale per procedere in nuovipercorsi di ricerca. Senza avere a disposizione indagini aggior-nate su grandi temi (andamento del mercato, valore della mo-
società e ceti 147
18 Cfr. supra, n. 1.
neta, costo delle merci, vie commerciali) non sarà possibile scio-gliere le polemiche che hanno talvolta punteggiato le paginedella storia sabauda.
Tra gli oggetti di discussione posti sin dagli anni Cinquantanell’ambito dei dibattiti allora accesi sulla vexata quaestio dellatransizione dal feudalesimo al capitalismo, vi è il ruolo da asse-gnare alle iniziative economiche avviate da alcune famiglie del-l’élite piemontese. I vecchi contributi di Bulferetti, favorevoli auna lettura proto-capitalistica di tali imprese, sono stati recen-temente rivisitati da Cesare Morandini, che si è occupato didue casi dei primi decenni del Settecento a loro modo esem-plari, legati all’aristocrazia monregalese: la produzione di pannipromossa rispettivamente dal marchese Giovanni Giacomo Fon-tana di Cravanzana e dal marchese Carlo Francesco VincenzoFerrero d’Ormea 19. Il nodo consiste nella valutazione del tipodi iniziativa. Mentre Bulferetti non esitava a far rientrare nelgrande alveo del capitalismo tali interventi, altri studiosi, apartire da Stumpo, li hanno invece collocati più cautamente inun contesto fortemente condizionato dalla politica statale mer-cantilistica. Secondo questa linea interpretativa, sposata anchein una delle ultime annate della «Rivista di storia economica»,i mercantilisti subalpini avrebbero scelto fino al Settecento unavia poco vantaggiosa: quella della rincorsa obsoleta ed estrema-mente dispendiosa al mercato dei panni fini, anziché a una pro-duzione nazionale su larga scala di panni ordinari, come i gran-di concorrenti europei, gli inglesi soprattutto, stavano facendocon successo20.
148 andrea merlotti
19 L. BULFERETTI, La feudalità e il patriziato nel Piemonte di Carlo Emanuele II (1663-1675), «Annali della Facoltà di Lettere, Filosofia e di Magistero dell’Università diCagliari», XXI (1953), pp. 365-624; ID., I piemontesi più ricchi degli ultimi cento anni dell’as-solutismo sabaudo, in Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, Firenze, Sansoni, 1958, vol. I, pp.39-91. C. MORANDINI, L’anti-Ormea: il marchese Fontana di Cravanzana e l’impresa al serviziodello Stato, in Nobiltà e Stato in Piemonte cit. pp. 427-456.
20 Cfr. M. AMBROSOLI, The market for textile industry in eighteenth century Piedmont: qualitycontrol and economic policy, «Rivista di storia economica», XVI (2000), pp. 343-363.
Sulle vicende piemontesi non sono mancati alcuni cammeidi storia economica. Si possono citare, in questo senso, le ri-flessioni di Allegra sulle «risorse distribuite» e sul sistema del-le doti nel ghetto ebraico di Torino, un contributo sul XVIIIsecolo riferito a uno spazio e a un periodo storico assai limi-tati 21. Gli studi che occorrerebbe incrementare, tuttavia, do-vrebbero coprire tematiche trasversali e affrontare nodi centraliper letture di medio-lungo periodo.
È inevitabile che chi proceda attraverso una ricerca docu-mentaria di prima mano circoscriva il proprio oggetto di stu-dio. Nell’ambito di progetti coordinati quali quelli promossidall’ISPRE occorrerebbe però che le singole indagini rientras-sero in una cornice di riferimento, per restituire la quale re-stano appunto da risolvere non irrilevanti interrogativi generalidi storia economica. Come valutare, per esempio, l’incrementoo meno di un bilancio, la crescita della ricchezza in un’impresao in un gruppo sociale senza poter disporre di dati sull’anda-mento del tasso d’inflazione? Come interpretare quei processidi rifeudalizzazione che in altre aree geografiche sono stati am-piamente studiati e associati a epoche precise senza possederedati certi sulle rendite e sul valore della terra? Come leggere iprocessi di urbanizzazione senza conoscere l’andamento del mer-cato immobiliare e i costi materiali della vita in città rispettoalle campagne? La scarsità o l’assenza di studi su questi macro-temi impedisce, a tutt’oggi, di conoscere la storia di molti im-portanti centri urbani subalpini, e la stessa storia di Torinoresta in tal senso priva di alcune coordinate strutturali di im-portanza basilare.
È evidente che, anche ad assumere la prospettiva della storiaper ceti superando le vecchie contrapposizioni fra scuola mar-xiana e scuola weberiana e cioè fra stretta prospettiva economi-cistica e giuridico-simbolica, il dato economico rimane fonda-
società e ceti 149
21 L. ALLEGRA, Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento, Torino, Zamorani,1996, pp. 72-86, 170-185.
mentale. Diversi temi risultano in tal senso trattati in modolacunoso nella storia sociale degli spazi subalpini, pur essendoessenziali per la comprensione delle dinamiche cetuali d’AnticoRegime.
Uno di questi è il permanere di una evidente concentrazio-ne di ricchezza in mano a un gruppo ristretto di aristocraticiappartenenti alla più antica nobiltà medievale. Un processo dilunga durata che è stato individuato nei suoi esiti ottocenteschipost-unitari, che era stato colto nel suo delinearsi già nei secoliprecedenti, ma sul quale credo vadano compiute analisi più am-pie, capaci di restituire le complesse strategie delle singole fa-miglie, in relazione anche all’area territoriale di provenienza eal mancato o avvenuto contatto e inserimento nella capitale del-lo Stato22.
Nei domini sabaudi, come è stato notato, la crescita nume-rica dell’aristocrazia non significò un rimescolamento indiffe-renziato dei ranghi e degli onori, ma al contrario l’accentua-zione delle distanze fra nobiltà antiche e recenti. In Piemonte,fra Quattro e fine Settecento, la vera divisione interna al cetoche deteneva giurisdizioni signorili non era stata quella franobili di spada e nobili di toga (come in Francia), ma tra espo-nenti di famiglie aristocratiche riconosciute tali in età medie-vale e non dipendenti originariamente dai Savoia e membri dicasate costituitesi in seguito per acquisto di feudi concessi dalpotere sabaudo. Cardoza ha sottolineato come, nell’Italia libe-rale che si era andata imborghesendo, il Piemonte registrasseun ritmo di declino aristocratico più lento. Gli stili culturali, lepratiche simboliche, i meccanismi informali del prestigio ave-vano riservato alla nobiltà di lignaggio precise forme indirettedi influsso sulla vita politica ed economica. Non mi sembratuttavia che la breve premessa dedicata da Cardoza alla forma-
150 andrea merlotti
22 Cfr. rispettivamente L. BULFERETTI, I piemontesi più ricchi cit.; A. CARDOZA, Ari-stocrats in Bourgeois Italy. The Piedmontese Nobility, 1861-1930, Cambridge, Cambridge Uni-versity Press, 1997 (trad. it. Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell’Italia liberale,Roma, Donzelli, 1999).
zione della nobiltà piemontese fra 1600 a 1848 renda ragionedel radicarsi progressivo dell’egemonia esercitata dalla grandenobiltà medievale; né l’accostamento al caso prussiano degliJunkers è in grado di restituire la complessità del problema, cheandrebbe affrontato con una nuova attenzione alla diacronia ealle differenze territoriali 23.
Altro tema di natura economica, oltre che giuridica, stretta-mente legato alla struttura cetuale è quello del funzionamentodei sistemi dotali e della legge del maggiorascato. Nata percontenere la frantumazione dei diritti e dei punti di giurisdi-zione che nell’ultimo Quattrocento i consortili non riuscivanopiù a gestire, la primogenitura assegnava a un’unica personabeni e diritti, ma attribuiva anche ai vari membri della famigliaprecisi ruoli e responsabilità. Al primogenito spettava la guidaeconomica e simbolica della famiglia sulla scena sociale, men-tre ai cadetti, esclusi dalla gestione patrimoniale, erano offertispazi d’azione meno formalizzati, ma talvolta più aperti al suc-cesso su scala internazionale: gli eserciti, le corti, la Chiesa, gliordini cavallereschi costituivano percorsi consueti, entro i qualile alleanze familiari potevano creare l’occasione per carriere dialto profilo.
L’approccio giuridico a questi temi fornisce le necessarie coor-dinate normative; in relazione ai territori subalpini e all’arcocronologico lungo preso in considerazione in questi progetti, sidevono segnalare gli studi che Elisa Mongiano ha dedicato allesuccessioni intestate fra Cinque e Settecento e alla successionelegittima nell’«età dei codici», e cioè fra Restaurazione e anniSessanta dell’Ottocento24. L’analisi della ricaduta delle normenella pratica della vita familiare va individuata, d’altro canto, incasi specifici e nel loro confronto temporale e spaziale. Alcuniimportanti risultati sono scaturiti in tal senso da recenti inda-
società e ceti 151
23 A. CARDOZA, Aristocrats in Bourgeois Italy cit., pp. 6-34.24 E. MONGIANO, Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII: il caso degli Stati
Sabaudi, Torino, Giappichelli, 1990 (ried. 1998); EAD., Patrimonio e affetti: la successione legit-tima nell’età dei codici, Torino, Giappichelli, 1999.
gini individuali e collettive. Lo studio di una famiglia ramifi-cata e dalla storia complessa come quella dei Ferrero d’Ormea,che ho avuto modo di seguire coordinando il lavoro di diversistorici medievisti e modernisti, ha consentito di rinnovare nonpoco l’immagine di un casato che era considerato fino a qual-che decennio fa tipica espressione di una promozione dalla«borghesia» degli «avvocati burocrati» alla nobiltà feudale 25.Era la tesi di Guido Quazza, che ha segnato le interpretazionifino alla pubblicazione del volume di atti che ho curato. Inquesto volume è affiorato non solo un chiaro profilo «civile»(non già borghese) dei Ferrero, saldamente radicati nel Monre-galese fra Quattro e Seicento, ma si sono evidenziati gli effettidel ruolo guida esercitato a Mondovì nell’ultima grande sta-gione di rivolte in Piemonte sotto l’Antico Regime: le guerredel sale. Si sono messi in luce infeudazioni e percorsi di car-riera nell’esercito, a corte, negli ordini cavallereschi precedentil’investitura marchionale e l’insediamento presso la capitale delfamoso ministro Carlo Francesco Vincenzo. Grande attenzioneè stata posta, inoltre, alla politica matrimoniale, che puntò, inun ramo della famiglia, al legame con esponenti della nobiltàfeudale francese, con non insignificanti effetti patrimoniali edereditari sulle strategie dei vari rami del casato. In questo stu-dio l’interdisciplinarietà e la possibilità di spaziare su fonti do-cumentarie non solo torinesi e non solo pubbliche ha fornitonon pochi elementi sulla trasmissione dei beni, sulle strategiedifferenti tra linee maschili e ruolo svolto dalle donne e dallerispettive doti.
Dati di estremo interesse, in riferimento a una famiglia di-versa dai Ferrero per profilo sociale e per area d’origine, stannoemergendo in uno studio che Tomaso Ricardi ha avviato daanni sulla famiglia dei Piossasco, tipico esempio di antica feu-dalità declinata in percorsi di carriera che non si limitarono alpanorama del solo Stato sabaudo. Un’anticipazione di tali ri-
152 andrea merlotti
25 Nobiltà e Stato in Piemonte cit.
cerche è offerta dal saggio che è stato pubblicato nel volume acura di Paola Bianchi e Luisa Clotilde Gentile L’affermarsi dellacorte sabauda. In questo articolo, incentrato sulla figura di Gia-como Piossasco, all’incirca coetaneo del duca Emanuele Fili-berto, e sulla sua discendenza, vengono ricostruiti i rapportitra la famiglia feudale e le comunità locali, dalle profonde dif-ferenze esplose all’interno del consortile nel corso del XV se-colo all’introduzione dell’istituto della primogenitura come stru-mento per porre un limite alla progressiva alienazione dei pun-ti di giurisdizione e alla parcellizzazione patrimoniale 26.
Indagini di questo tipo estese a diverse aree subalpine e svol-te lungo un arco temporale di più secoli aiuterebbero a ricucirele fila di un discorso socio-economico ancor in gran parte dacostruire. Se, d’altro canto, la storiografia italiana ed europeaha spesso trascurato il peso di molte figure e nuclei parentali d’o-rigine piemontese radicatisi all’estero con una certa fortuna,ciò è dovuto anche alla scarsa sistematicità che si è dedicatafino ad ora ad analisi prosopografiche complesse come quelleche ho appena descritto. Il problema consiste sostanzialmente,come ho mostrato nelle mie ricerche recenti, nel mettere in di-scussione l’immagine stereotipata di una nobiltà feudale unita-ria colta in un univoco rapporto con Torino 27.
In un progetto dedicato alla struttura cetuale è evidente, delresto, che non ci si debba occupare di sole élites, ma che si debbaallargare il campo delle ricerche anche ad altri ambiti: non, tut-tavia, a una generica ricostruzione delle condizioni degli stratipiù bassi della popolazione. A temi come il pauperismo e leriforme caritative sono infatti già stati dedicati alcuni saggicapaci di offrire dati sulla situazione nella capitale e in alcuni
società e ceti 153
26 T. RICARDI DI NETRO, Servir due principi. Giacomo Piossasco de Feys tra le corti dei Farnesee dei Savoia, in L’affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardomedioevo e prima età moderna, a cura di P. Bianchi e L.C. Gentile, Torino, Zamorani, 2006,pp. 507-524.
27 Cfr. supra, n. 1.
centri provinciali 28. Il tema della «storia popolare» può portarea nuovi risultati solo grazie all’incrocio, in senso verticale eorizzontale, degli stili di vita e della cultura materiale fra i ceti.
Terreno da dissodare, da questa prospettiva, è quello del cor-porativismo, sulle cui dinamiche torinesi conosciamo alcuniaspetti sei-settecenteschi, che non esauriscono però il proble-ma29. Nel caso di Torino la nascita tardiva della rete delle cor-porazioni è stata collocata in un rapporto dialettico con duecentri di potere, la municipalità e la corte, senza tener conto,per esempio, di un soggetto di grande importanza decisionale,che, pur agendo dietro le quinte della politica ufficiale, condi-zionava non poco i meccanismi di promozione sociale. Mi ri-ferisco alla Compagnia di San Paolo, di cui è stata avviata unastoria in più volumi – alcuni già pubblicati, altri in corso direalizzazione – che mi ha consentito di iniziare a svolgere inda-gini a campione che meritano di essere integrate e completatecon il confronto fra più di un’area urbana 30. Poco si sa, in ef-fetti, del nesso fra sviluppo delle corporazioni e crescita delloStato, dell’incontro, cioè, fra quello che alcuni storici francesihanno definito étatisme municipal ed étatisme monarchique. Ciò che inFrancia si era verificato nel XV secolo in Piemonte accaddesolo nel XVI con Emanuele Filiberto, scriveva già Bulferetti.Ma di quali dati disponiamo per valutare le cesure cinquecen-tesche rispetto al Quattrocento? Che cosa si sa del ruolo deiceti nelle corporazioni e nelle confraternite delle singole cittàsubalpine? Quale fu il destino di queste tipiche forme di
154 andrea merlotti
28 S. CAVALLO, Charity and power in early modern Italy: benefactors and their motives in Turin.1541-1789, Cambridge, Cambridge University Press, 1995; P. BIANCHI - A. MERLOT-TI, Cuneo in età moderna. Città e Stato nel Piemonte d’antico regime, premessa di R. Comba, Mi-lano, Angeli, 2002.
29 S. CERUTTI, Mestieri e privilegi cit.30 A. MERLOTTI, La Compagnia di San Paolo alla metà del XVIII secolo. Un’élite politico-eco-
nomica tra corte e municipalità, in Per una storia della Compagnia di San Paolo (1563-1853), vol.II, a cura di B. Signorelli e W. Crivellin, Torino, Compagnia di San Paolo, Quadernidell’Archivio storico, 2005, pp. 131-183.
aggregazione d’Antico Regime nel volgere dal Sette all’Otto-cento?
Espressioni di sociabilità formalmente molto lontane traloro nei secoli e nella sostanza, fondate su una struttura gerar-chica e cetuale, poi su nuove forme di coesione (casini nobi-liari, conversazioni, confraternite, corporazioni, logge massoni-che, ecc.), possono rivelare continuità nel momento in cui ci siaccosti allo studio degli adepti e non si recidano astrattamentele successive generazioni 31. Per il periodo sette-ottocentescosarebbe utile recuperare, in questo senso, quei suggerimenti dimetodo che sono stati offerti sin dagli anni Settanta da Mau-rice Agulhon. L’interpretazione di Agulhon della sociabilità co-me banco di prova per verificare gli andamenti sfasati di svi-luppo del sociale e del politico può offrire ancora spunti perstudiare le complesse fasi di superamento del sistema cetuale 32.
3. Proposte tematiche
Nella parte propositiva di questo progetto non intendo de-dicare spazio al solo problema delle élites, argomento che mi ècerto più congeniale per le ricerche che ho già intrapreso, mache va arricchito da un nuovo lavoro di squadra coordinato supiù periodi, su più spazi e su fasce sociali più ampie. Auspicoche si possa porre attenzione a un discorso complessivo più ge-nerale sulla struttura cetuale subalpina. Le mie osservazioni van-no lette, in tal senso, in stretta connessione con le linee esposte
società e ceti 155
31 A. MERLOTTI, Salotti in una città cosmopolita. Gentildonne e conversazioni nella Torino delsecondo Settecento, in Salotti e ruolo femminile in Italia tra fine Seicento e primo Novecento, a cura diM.L. Betri ed E. Brambilla, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 129-130; P. BIANCHI, Il ruolodella massoneria napoleonica fra antico regime e nuovi spunti di modernizzazione, «Società e storia»,in corso di stampa.
32 Sulla bibliografia dedicata al tema inaugurato da Agulhon tra anni Sessanta eSettanta del secolo che s’è chiuso cfr. Forme di sociabilità nella storiografia francese contemporanea,introduzione e cura di G. Gemelli e M. Malatesta, Milano, Feltrinelli, 1982.
negli altri progetti, in particolare in quelli di Paolo Cozzo e diPaola Bianchi. Ruoli, gerarchie, funzioni sono, infatti, oggettidi studio che toccano non solo la definizione dei vertici di ungruppo sociale, ma l’analisi dei comportamenti fra ceti diversi,da estendersi, con la dovuta attenzione, alle varianti territoriali.
I criteri enunciati nella premessa sulla periodizzazione sonovolti a cercare di uscire da steccati troppo stretti (secondo Cin-quecento-fine Settecento) in cui si è circoscritta la storia pie-montese in età moderna, anche dal punto di vista sociale. Oc-correrà, perciò, monitorare i lavori svolti in campo medievisti-co e contemporaneistico (quanto meno in ambito ottocentista)recependo spunti dai dibattiti in corso.
Sul tema dei feudi e delle giurisdizioni signorili merita, peresempio, di essere ripreso e proseguito, per la prima età mo-derna, il discorso affrontato in un recente articolo di GuidoCastelnuovo uscito on-line33. Oggetto di tale articolo è la di-versificazione, che si compì fra Due e Quattrocento, dell’o-maggio feudale nei domini dei Savoia. Il XV secolo costituì dapiù punti di vista l’avvio di nuovi processi di aggregazione ter-ritoriale, che ebbero precisi riflessi sui rituali e sulla cultura po-litica signorili. Nelle infeudazioni e negli omaggi il Quattro-cento vedeva prevalere ormai la subordinazione politica sul con-tratto volontario. Sottomessi a una giurisdizione, i vassalli quat-trocenteschi apparivano, almeno teoricamente, sottoposti tuttial potere del duca. In realtà la «grammatica feudale» avevaadattato le proprie complesse gerarchie, mentre la politica sa-bauda di crescente «neutralizzazione della nobiltà rurale» stavaavviando una nuova fase di disciplinamento dei legami feudalie signorili. Di qui la volontà di imporre a tutti i livelli alcuniufficiali come modelli di riferimento su scala regionale (i balivi
156 andrea merlotti
33 G. CASTELNUOVO, Omaggio, feudo e signoria in terra sabauda (metà ’200 - fine ’400), inPoteri signorili e feudali nelle campagne dell’Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti dilegittimità e forme di esercizio, atti del convegno Milano, 11-12 aprile 2003, a cura di F.Cengarle, G. Chittolini e G.M. Varanini, «Reti Medievali», V (2004), 1, http://www.dssg.unifi.it/_rm/rivista/atti/poteri.htm.
e i loro balivati) e locale (i castellani e le castellanie). L’omag-gio signorile al principe non si prestava più nel proprio ca-stello, ma nel più vicino centro amministrativo. Quanto alle éli-tes, esse avevano iniziato a interessarsi al mondo degli uffici pre-stando sempre più frequentemente servizio in qualità di castel-lani.
Da questa prospettiva varrebbe la pena tornare sul tema del-la venalità delle cariche, per verificarne l’incidenza e le forme apartire dal tardo Quattrocento. Dagli anni Ottanta del Trecen-to, come Barbero e Castelnuovo hanno messo in evidenza, l’am-ministrazione sabauda era ricorsa spesso ad anticipi contabilidi una certa consistenza che erano concessi da quelli che sareb-bero diventati poi ufficiali (soprattutto in veste di castellani edi giudici); il meccanismo dei prestiti veniva infatti ampiamen-te ripagato dalle entrate garantite dal rispettivo ufficio34. Lepratiche legate al sistema della venalità, impostosi nella tarda etàmedievale, consentono di essere indagate sino almeno alla metàdel Quattrocento. Suggerirei di non interrompere le indagini alXV secolo, ma di restituire da questo punto di vista anche ilperiodo del primo Cinquecento.
Se il mondo signorile tre-quattrocentesco era diventatosempre più frastagliato e la dedizione ai Savoia aveva creatonuove geografie feudali, sarebbe utile tradurre in una carta lamappatura delle varie aree, evidenziando scarti o coincidenzefra possedimenti feudali (più o meno ampi, più o meno aggre-gati) e luoghi d’origine delle singole famiglie e dei differenti con-sortili. Ho avuto modo di riflettere sul caso dei titoli di giuri-sdizione signorile nel Cuneese, convincendomi che tale indagi-ne andrebbe estesa e incrociata con ricerche su altre porzioni diterritorio35. La mappatura delle zone infeudate, allodiali, de-maniali consentirebbe di visualizzare in modo diacronico (pre-
società e ceti 157
34 A. BARBERO, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano, Roma- Bari, Laterza, 2002; G. CASTELNUOVO, Omaggio, feudo e signoria cit.
35 P. BIANCHI - A. MERLOTTI, Cuneo in età moderna cit.
disponendo cioè una serie di carte in successione cronologica)entità ed estensione delle giurisdizioni signorili. In questo mo-do l’immagine un po’ stereotipata del Piemonte quale terraeminentemente feudale e non patrizia potrebbe essere, nel caso,documentata e commentata.
L’inventariazione dei documenti sulle materie feudali pre-senti in Archivio di Stato di Torino e opere di consultazionenote agli studiosi come i dizionari di Antonio Manno e diFrancesco Guasco possono costituire un’utile base di partenzaper l’elaborazione dei dati e la loro trasposizione in chiave sto-rico-geografica 36.
La realizzazione di una carta feudale degli spazi subalpinipotrebbe costituire un’opera a sé, non priva di ricadute anchesul piano didattico e turistico. La recente tendenza piemontesealla riconfigurazione dell’immagine del proprio territorio comeportatore di storia e di cultura può favorire la promozione diiniziative capaci di far incontrare la ricerca pura con la scuola egli enti deputati alla conservazione e alla valorizzazione dei be-ni paesaggistici, artistici e architettonici. Di qui uno sprone alegare le future attività dell’ISPRE con la fioritura di eventi, mo-stre, allestimenti attinenti alla storia piemontese e sabauda neisecoli XV-XIX. Una nuova carta feudale potrebbe inoltre, piùsemplicemente, corredare il Repertorio delle cariche civili e militari checiascuno degli autori di questi progetti considera fra gli obiet-tivi da perseguire, a medio termine, da parte dell’ISPRE.
L’avvio del lavoro di progettazione e stesura della storia dialcune città piemontesi, che caldeggio come importante tra-guardo da raggiungere, è strettamente correlato allo studio deltessuto feudale. Come convivevano i nuclei urbani, esenti da in-feudazione, con i possedimenti signorili? Quale era il rapporto
158 andrea merlotti
36 Cfr. A. MANNO, Dizionario feudale degli antichi Stati della monarchia di Savoia: Savoia,Aosta, Piemonte, Monferrato, Saluzzo, Novara, Lomellina, Nizza, Oneglia (1720-1797) (Firenze,1895), ed. anastatica Bologna, Forni, 1969 e 1979; F. GUASCO, Dizionario feudale degliantichi Stati Sardi e della Lombardia dall’epoca carolingia ai nostri tempi (774-1909) (Pinerolo,1909-1911), ed. anastatica Bologna, Forni, 1989.
fra una città e i ceti feudali che detenevano titolo e possesso deiterritori circostanti? Come si rapportavano, a loro volta, città eceti feudali rispetto all’amministrazione e alla giurisdizionedello Stato? Sono alcuni degli interrogativi che andranno postinello svolgimento contemporaneo dei due tipi di indagine.
Da quanto è stato esposto sopra e da quanto è motivato inciascuno dei progetti uniti a questo emerge la necessità di pre-vedere tempi non strettissimi per la realizzazione della storia deiprincipali centri subalpini, visti i molti problemi che restanoaperti. Questioni patrimoniali, corporativismo, forme di socia-bilità, rapporti di dedizione o di resistenza alle direttive del go-verno centrale, espressioni di ritualità cetuale: sono tutti nodiche ritengo essenziali per la definizione di una nuova e com-plessa storia del Piemonte, che si delineeranno via via che siacquisiranno maggiori elementi sulle vicende delle sue città 37.
Tali ricerche offriranno ulteriori occasioni per ricucire i rap-porti con la storiografia italiana che, come accennavo, ha svi-luppato in questi anni percorsi d’indagine socio-istituzionali pri-vi di sostanziali confronti con i territori subalpini. Occorre,cioè, restituire alle specificità territoriali e cittadine il ruolo cherivestivano nella distribuzione dei poteri. Se il Piemonte si di-stingueva per la consistenza della propria feudalità, non era pe-rò estraneo dalle dinamiche che investirono molte delle cittàitaliane nel corso dell’età moderna. In prospettiva di uno stu-dio sul lungo periodo, dal Quattro all’Ottocento, sarà fonda-mentale seguire le varie fasi di gestione dell’amministrazionelocale. Da quanto già è noto, la nobiltà feudale piemontesenon rinunciò mai a esercitare un preciso controllo sui Consiglicomunali, sicché storia feudale e storia urbana non vannointese come piste di ricerca indipendenti l’una dall’altra 38.
società e ceti 159
37 È recente la pubblicazione di uno studio su Bra che giustamente legge nel lungoperiodo le riforme amministrative settecentesche: F. GUIDA, Il Comune di Bra e il riordina-mento amministrativo sabaudo del primo Settecento, Cuneo, Società per gli studi storici dellaProvincia di Cuneo (tipografia La Ghisleriana), 2005.
38 P. BIANCHI - A. MERLOTTI, Cuneo in età moderna cit.
Certo andrà posta la dovuta attenzione ai contrasti, maanche ai contatti presenti, col trascorrere dei secoli, fra ammi-nistratori di estrazione sociale differente: nobili feudali d’anti-ca o di recente data, ceti «civili», notabili, borghesi ecc. In que-sto senso, la svolta segnata dalla caduta dell’Antico Regime edalla sovrapposizione istituzionale, prima della Restaurazione,del regime napoleonico potrà offrire non poche spie per co-gliere il progressivo affiorare dell’identità regionale.
Dal punto di vista del metodo, va a questo punto precisatomeglio che cosa si debba intendere per storia di città/storiaurbana. Da almeno un paio di decenni gli studiosi italiani, sol-lecitati dall’esempio delle indagini condotte dalle scuole fran-cesi e anglosassoni, sono tornati a discutere dell’opportunità diincrociare dati e strumenti forniti da alcune discipline ausilia-rie: urbanistica, storia dell’arte, geografia 39. Da un’impostazio-ne del genere è nata, per esempio, la collana uscita da Laterzadedicata a Le città nella storia d’Italia, che va debitrice soprattuttoalle indagini degli storici dell’architettura e dei geografi umani.
Diverse, per ragioni oggettive oltre che metodologiche, le scel-te che suggerisco di operare per impostare le storie delle cittàpiemontesi. Non escluderei, in particolare, la collaborazionecon storici dell’arte, storici dell’architettura e geografi, ma nonriserverei a tali discipline una parte preponderante, né sezionispecifiche e autoreferenziali. Così facendo si ripeterebbe, infat-ti, la struttura di studi miscellanei già esistenti, che hanno avu-to il merito di segnalare interessanti piste di ricerca, senza peròtener conto di imprescindibili approfondimenti storici e conte-stuali. In altri termini: il contributo di uno storico dell’arte odell’architettura, di un geografo, di un antropologo e così viaalla storia del Piemonte promossa dall’ISPRE dovrà saper usciredal-la rigida difesa degli steccati dei singoli specialismi. Di unedificio, di una struttura urbana, delle forme di antropizza-
160 andrea merlotti
39 Cfr. B. LEPETIT, La storia urbana in Francia. Scenografia di uno spazio di ricerca, «Societàe storia», 1984, n. 25, pp. 639-666.
zione di un territorio andranno valutati cioè, di volta in volta,le relazioni con i committenti, il rapporto con il tessutosociale, le interazioni con le autorità che a diverso livello licontrollavano.
L’impianto di queste nuove storie di città dovrebbe potersireggere, in generale, su un nucleo ampio e coeso di storia eco-nomica, sociale e istituzionale, offrendo anche digressioni ditipo culturale e artistico, ma non tradendo l’impostazione e gliinteressi precipui dei progetti legati all’ISPRE. Si potranno cor-reggere, in tal senso, la frammentarietà e le vistose lacune tema-tiche presenti in un’opera pur ambiziosa e recente come la Sto-ria di Torino patrocinata dall’Accademia delle Scienze; mi riferi-sco non tanto al volume, per diversi aspetti utile come mo-dello, sui secoli XIV e XV 40, bensì ai volumi sull’età moder-na 41.
Vercelli, Asti, Alessandria e Novara sono state individuatecome le prime tappe di un percorso di ricostruzione che dovràproseguire con le indagini su altri centri subalpini. A questoproposito, data la relativa scarsità di informazioni sulla storiain età moderna di queste città, posso immaginare che valga lapena progettare, parallelamente allo svolgersi delle ricerche, lapubblicazione di fonti documentarie, la cui consistenza e na-tura è difficile prevedere fin da ora. Rispetto ai fondi conser-vati a Torino, di più facile accesso archivistico, converrebbe,qualora il documento lo meriti, dare la precedenza a fonti con-servate in provincia o in archivi privati. Sarebbe poi auspicabileche i vari materiali preparatori (gli elenchi delle cariche urbane,la composizione dei Consigli comunali ecc.) fossero pubblicatiautonomamente. Ciascuno di questi materiali potrebbe costi-
società e ceti 161
40 Storia di Torino, vol. II, Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura diR. Comba, Torino, Einaudi, 1997.
41 Storia di Torino, vol. III, Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630), a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi, 1998; vol. IV, La città fra crisi e ripresa(1630-1730), a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi, 2002; vol. V, Dalla città razionalealla crisi dello Stato d’antico regime (1730-1798), a cura di G. Ricuperati, Torino, Einaudi,2002.
tuire la base indispensabile per la compilazione del Repertoriodelle cariche civili e militari, nonché per la definizione e redazionedei lemmi del Dizionario biografico dei piemontesi.
Non occorre ripetere che tanto il Repertorio delle cariche quantoil Dizionario biografico si innestano perfettamente in un progettodi studio ampio sulla società. Entrambi i lavori dovranno tut-tavia seguire un’impostazione metodologica aggiornata, mo-strando grande attenzione alla comparazione, nel tempo e nel-lo spazio, delle realtà istituzionali e delle vicende individuali.All’elenco delle cariche e degli organigrammi dovrebbe essereaffiancato, per esempio, un discorso sulle origini e trasforma-zioni dei vari uffici o gradi, non senza confronti con casi sto-rici coevi non piemontesi. Nel dizionario biografico, che siprevede articolato in volumi tematici (non semplicemente alfa-betici), a ogni personaggio dovrebbe corrispondere una schedaragionata sul retroterra familiare e sulle relazioni sociali.
4. Strumenti di ricerca
Le storie di città, il repertorio delle cariche, il dizionariobiografico necessitano della consultazione di molte fonti diprima mano, trattandosi di opere che possono contare su unabibliografia esistente relativamente esigua o quanto meno di-scontinua. Nessuna di queste opere ha, d’altro canto, precisicorrispettivi nella storiografia italiana, neppure il dizionario bio-grafico, che intenderemmo distinguere dai criteri, pur prege-voli, seguiti dal Dizionario pubblicato dall’Istituto dell’Enciclo-pedia Italiana (opera alla quale hanno partecipato, chi più chimeno, tutti gli autori di questo volume, a partire da chi scrive).
Se per le storie di città sarà indispensabile partire dalla clas-sica documentazione d’archivio prodotta in sede locale (verbalidei Consigli comunali, statuti, bandi, atti notarili) incrocian-dola con le fonti emanate dal governo centrale (patenti, decretidi nomina, relazioni di vari funzionari), in modo tale da co-gliere il rapporto della capitale con le varie aree di esercizio
162 andrea merlotti
dell’amministrazione sul territorio, per il repertorio delle cari-che e per il dizionario biografico si dovrà ricorrere, oltre che afonti primarie, a studi giuridici, a opere erudite, a testimonian-ze letterarie, a pagine di storia piemontese già scritte, dalle qua-li ricavare dettagli importanti per inquadrare un ruolo istitu-zionale o una figura particolare. Molte riflessioni storiche sullanatura delle varie cariche, sul loro effettivo potere e rango so-no, però, tutte da costruire.
A che cosa corrispondeva, per fare un esempio fra i tanti,l’ufficio di un auditore camerale e in quale tipo di carriera rien-trava rispetto ai ruoli di pari livello in altre magistrature? Qualifigure sociali vi erano reclutate di preferenza? Domande di que-sto tipo si potrebbero formulare per molte cariche istituzionali,che varrebbe la pena studiare anche nel loro progressivo defi-nirsi, entro una struttura amministrativa che era nata dall’an-nessione di territori in precedenza controllati da magistraturedifferenti. Come si era passati, per esempio, in Monferrato, dalMagistrato camerale gonzaghesco e dagli uffici per la gestionedelle gabelle alla dominazione sabauda, e come furono inte-grati, se lo furono, i discendenti delle élites amministrative cheavevano prestato servizio ai Gonzaga dopo il cambio di regi-me?42 Il caso monferrino, studiato per l’epoca del governo gon-zaghesco da Alice Raviola, si presta a precise indagini prosopo-grafiche, che partirebbero da una base di ricerca già svolta inmodo articolato; ma così non è per altre aree territoriali an-nesse al Piemonte.
Su alcune magistrature, come il Senato di Piemonte, dispo-niamo di utili studi istituzionali e prosopografici 43; si trattatuttavia di indagini compiute pressoché esclusivamente sul Set-tecento, secolo di grandi riforme e quindi di più facile approc-cio a livello legislativo. Considerazioni analoghe valgono per
società e ceti 163
42 Sulle magistrature gonzaghesche cfr. B.A. RAVIOLA, Il Monferrato gonzaghesco. Isti-tuzioni ed élites di un micro-Stato (1536-1708), Firenze, Olsckhi, 2003.
43 E. GENTA, Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino, Deputazione subal-pina di Storia patria, 1983.
gli studi sulle professioni giuridiche, indagini che si sono mos-se dalle riforme universitarie settecentesche restando spesso pri-gioniere delle concezioni giuridiche trasmesse a livello didatti-co e normativo44.
Il repertorio delle cariche che abbiamo immaginato nell’am-bito delle attività dell’ISPRE dovrà saper dialogare ampiamentecon la storia sociale estendendosi su un arco temporale lungo einterrogandosi sulle discontinuità tipiche degli «Stati compo-siti» d’Antico Regime. Per colmare le molte lacune sarà indi-spensabile e preliminare il lavoro di ricerca su documenti di pri-ma mano.
Per orientare il reperimento delle fonti su cui basare tanto ilrepertorio delle cariche quanto il dizionario biografico sarà fon-damentale definire gli indici e i lemmari delle due opere. Sitratterà di dar spazio tanto alle cariche civili quanto a quellemilitari dipendenti dallo Stato, così come ai ruoli delle giuri-sdizioni ecclesiastiche e alle funzioni amministrative e di ordi-ne pubblico dipendenti dalle città; tutto ciò implicherà lo stu-dio di documentazione conservata anche in provincia. La sfidanon è semplice. Si potrà tuttavia circoscrivere inizialmente unpercorso da svolgere in alcune strutture archivistiche meglio ac-cessibili, partendo in particolare dagli Archivi di Stato e Co-munali di Vercelli, Asti, Novara e Alessandria, passando suc-cessivamente ad altre sedi.
Nel corso delle ricerche proporrei di monitorare, a livellonazionale, le pubblicazioni promosse dagli archivi e dalle bi-blioteche nelle cui collane compaiono edizioni di documenti erepertori istituzionali, che potrebbero servire per un confrontocon la realtà subalpina. Ho presente, in tal senso, una serie diiniziative promosse negli ultimi dieci anni dall’Archivio di Sta-to di Roma, presso il quale, a cura di un’équipe di storici e di
164 andrea merlotti
44 D. BALANI, Studi giuridici e professioni nel Piemonte del Settecento, «Bollettino storicobibliografico subalpino», 1978, I, pp. 185-278; EAD., Toghe di Stato. La facoltà giuridicadell’Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento, Torino, Deputazione subalpinadi storia patria, 1996.
archivisti, sono state avviate la schedatura e l’inventariazione dimateriale inedito sul controllo dell’ordine pubblico nello Statopontificio. Alcuni convegni organizzati nell’ambito di tali ini-ziative devono ancora produrre gli atti; il contatto con il grup-po di lavoro che vi ha preso parte potrebbe giovare a creare unasintonia d’intenti e utili scambi di competenze.
Quanto al dizionario biografico, opera importante se si vuo-le uscire da una storia politica e istituzionale impersonale, oc-correrà uscire dalla prospettiva del semplice censimento dellegrandi figure di funzionari, militari, diplomatici e letterati (glistessi che già compaiono nel Dizionario biografico degli italiani), in-dividuando gruppi di personaggi legati a vario titolo e in variomodo ai territori piemontesi: includendovi perciò sicuramenteanche ufficiali di livello inferiore, artisti, musicisti, mercanti,uomini d’affari.
Non essendo possibile definire ulteriormente a priori il di-scorso sulle fonti al di là dei suggerimenti di metodo fin quiesposti, vorrei chiudere questo progetto accennando a uno stru-mento che gli ultimi mesi di lavoro mi hanno convinto essereparticolarmente fruttuoso per colmare molte lacune sulla sto-ria culturale e simbolica della società subalpina. Mi riferiscoallo strumento iconografico.
Spesso la storia del Piemonte è stata descritta senza resti-tuire volti e immagini. Non si tratta, evidentemente, di caderein un discorso esornativo, né di raccogliere una campionaturadi puro impatto divulgativo. Dotte discipline quali l’iconogra-fia e l’iconologia insegnano che le forme di rappresentazionerivelano sempre l’uso di codici precisi, di cui spesso è venutameno la memoria storica. Individuare, in tal senso, il personag-gio raffigurato in un ritratto riconoscendone alcune caratteri-stiche esteriori – l’abito, lo stemma, un distintivo o l’emblemadi appartenenza a un ordine, a una corporazione, a una confra-ternita – può aprire ad altre identificazioni, indispensabili perdatare le trasformazioni del costume, la creazione di nuovi ruo-
società e ceti 165
li, cariche o funzioni. La complessità della società cetuale d’An-tico Regime si fondava infatti su una continua esplicitazionedei vari status.
Gli storici italiani, anche se ciò potrebbe sembrare parados-sale per un Paese con una tradizione artistica quale il nostro, sirivelano assai più cauti degli stranieri non solo nell’invadere ilcampo bensì nell’alimentare salutari scambi interdisciplinari esintonie di interessi con gli storici dell’arte. Non mancanoalcune esperienze di questo tipo, ma la bibliografia prodottaresta assai poco folta. Tra i lavori recenti si possono citare glistudi di Massimo Firpo e di Roberto Zapperi 45, i quali, purnon essendosi occupati di storia piemontese, suggeriscono allostorico del Piemonte, attraverso le loro indagini storico-artisti-che, chiavi interpretative da non trascurare. Si tratta, credo, dispunti tutt’altro che ancillari.
166 andrea merlotti
45 M. FIRPO, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo: eresia, politica e cultura nella Firenze diCosimo I, Torino, Einaudi, 1997; ID., Artisti, gioiellieri, eretici: il mondo di Lorenzo Lotto traRiforma e Controriforma, Roma-Bari, Laterza, 2001; G. BRIGANTI - A. CHASTEL - R.ZAPPERI, Gli amori degli dei: nuove indagini sulla Galleria Farnese, a cura di C. Giantomassi,Roma, Edizioni dell’Elefante, 1987; R. ZAPPERI, Tiziano, Paolo III e i suoi nipoti: nepotismoe ritratto di Stato, Torino, Bollati Boringhieri, 1990; ID., Eros e Controriforma: preistoria dellagalleria Farnese, Torino, Bollati Boringhieri, 1994; ID., La leggenda del papa Paolo III: arte e cen-sura nella Roma pontificia, Torino, Bollati Boringhieri, 1998.
PAOLO COZZO
Storia religiosa.Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosanel Piemonte di età moderna
1. Premessa
Se è vero che nel Novecento (e in particolar modo dopo ilconcilio Vaticano II) l’esigenza del riconoscimento dello sta-tuto storico del cristianesimo si è imposta con sempre maggiorforza 1, è solo nell’ultimo quarto di secolo che, complessiva-mente, la storia della Chiesa e del cristianesimo sono state «“sdo-ganate” da un certo stile apologetico e autoreferenziale»2. Nondeve dunque stupire, allora, che negli ultimi decenni l’approc-cio storico alla Chiesa e alla vita religiosa (un approccio «par-ticolarmente adeguato e fecondo per cogliere lo snodarsi neltempo delle manifestazioni della fede cristiana» 3) abbia rac-colto nuovi stimoli e forti motivazioni. Non che in passatoquesto approccio fosse disconosciuto o meno praticato; tutta-via, oggi più di ieri le ricerche «hanno investito tutti gli aspettidella vita cristiana, non solo le istituzioni ma anche le dottrine,non solo gli aspetti biografici individuali ma anche quelli so-ciali e squisitamente ecclesiali, non solo la vita esterna e mate-riale ma anche la spiritualità e la devozione» 4.
1 G. ALBERIGO, Conoscenza storica e teologia, in «Römische Quartalschrift», 80 (1985),pp. 207-222.
2 S. NEGRUZZO, Rassegna di studi sul clero dell’età moderna pubblicati in Italia negli anniNovanta, in Chiesa chierici sacerdoti. Clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo, Siena, Archiviodi Stato, Seminario arcivescovile, 21 maggio 1999, a cura di M. Sangalli, Roma,Herder, 2000, pp. 39-83, in part. p. 39.
3 G. ALBERIGO, Presentazione, in Il Cristianesimo Grande Atlante, direzione scientifica diG. Alberigo, G. Ruggieri, R. Rusconi, I, Dalle origini cristiane alle chiese contemporanee, direttoda R. Rusconi, Torino, Utet, 2006, pp. V-VII, in part. p. V.
4 Ibid., p. VI.
La crescita del ruolo della storia nella comprensione delfenomeno religioso è un dato ormai acquisito: sia pur attra-verso non poche difficoltà (e nonostante periodici rigurgiti didiffidenza) la dimensione storica è entrata a pieno titolo (o losta facendo sempre più) in quella religiosa. Si può dire la stessacosa del contrario? Possiamo cioè affermare con la stessa dosedi certezza che la dimensione religiosa sia stata pienamente ac-cettata nella dimensione storica? Rispondere con estrema cau-tela a questa domanda sarebbe stato d’obbligo fino a qualcheanno fa, quando anche da parte di autorevoli studiosi non ve-nivano celati i problemi ad «assumere a livello storiografico»fenomeni e atteggiamenti tipici di «un’esperienza – indivi-duale e collettiva – vissuta in rapporto con quello che di voltain volta è sentito come sacro, come appartenente a una sferanon esaurita dalla vita economica, politica culturale, istituzio-nale, dalla quotidiana realtà materiale»5.
Negli ultimi due decenni il panorama sembra tuttavia esseremutato: in una società sempre meno ideologizzata e semprepiù chiamata al confronto con etnie, culture e fedi diverse l’ele-mento religioso, complice anche la forte ricaduta sul piano cul-turale di grandi eventi di elevato impatto mediatico (come igiubilei, e, più recentemente, la ritualità legata alla successioneal soglio pontificio), sta uscendo dagli stretti confini (anchestoriografici) entro i quali era stato a lungo relegato. Ecco,allora, che « il panorama delle ricerche di storia politico-istitu-zionale ha potuto talora arricchirsi di apporti provenienti dal-l’attenzione rivolta alle istituzioni ecclesiastiche», con la conse-guenza che « l’impianto rigido, che ha caratterizzato a lungo lericerche storico-giuridiche sulle istituzioni ecclesiastiche si è re-so oggi particolarmente flessibile proprio grazie al gioco coin-
168 paolo cozzo
5 G. DE ROSA - T. GREGORY - A. VAUCHEZ, Prefazione, in Storia dell’Italia religiosa, I,L’Antichità e il Medioevo, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. VII-XVI, inpart. p. VII.
volgente le istituzioni ecclesiastiche nella dinamica politica esociale»6.
In un contesto nel quale sempre più « l’ambito accademicoe la storiografia non ecclesiastica riconoscono la necessità difar interagire le scienze umane con il fatto religioso, di rileg-gere il dipanarsi della storia degli antichi Stati italiani ancheattraverso il divenire della Chiesa cattolica nella sua duplicevalenza di potenza temporale e autorità morale» 7, la storiareligiosa (la vera protagonista – stando a recenti discussioni suinuovi orientamenti degli studi storici – del panorama storio-grafico italiano degli ultimi anni 8) è divenuta « imprescindibileper l’analisi delle società di Antico Regime, nelle quali po-litica e religione si intrecciavano in un nesso inestricabile»9.Questa considerazione sembra essere avvalorata dal notevolesuccesso riscosso da alcuni temi d’indagine (gerarchie curiali,ordini religiosi, pratiche devozionali, spazi e riti sacri), verso iquali gli studiosi – grazie anche all’apertura al pubblico di al-cuni importanti fondi documentari rimasti per secoli inaccessi-bili, primo fra tutti quelli del Sant’Uffizio 10 – hanno indiriz-
storia religiosa 169
6 M. ROSA, Introduzione, in Clero e società nell’Italia contemporanea, Roma-Bari, Laterza,1992, pp. 3-41, in part. pp. 3-4.
7 S. NEGRUZZO, Rassegna di studi cit., p. 39.8 Si veda l’intervento introduttivo di Mario Rosa alla tavola rotonda Nuove tendenze
della storiografia modernistica (Istituto storico italo-germanico in Trento, 10-11 febbraio2005), i cui atti sono in corso di pubblicazione. Non sembra casuale che questa consta-tazione sia stata fatta proprio da Mario Rosa, uno studioso al quale è stato autorevol-mente riconosciuto il merito di aver dimostrato, attraverso la sua opera storiografica,che « l’histoire de la religion de l’époque moderne pouvait être une discipline à partentière lorsqu’elle était conduite avec méthode et sans passion apologétique» (L. CHÂ-TELLIER, Pour l’histoire religieuse de l’époque moderne, in «Rivista di storia e letteratura reli-giosa», 40, 2004, pp. 601-604, in part. p. 601).
9 M. CAFFIERO, Premessa, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica»,1/2005, pp. 7-11, in part. p. 8.
10 Cfr. a tal proposito L’inquisizione e gli storici: un cantiere aperto. Tavola rotonda nell’ambitodella Conferenza annuale della ricerca, Roma 24-25 giugno 1999, Roma, Accademia Nazio-nale dei Lincei, 2000; L’Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale, atti delseminario internazionale, Montereale Valcellina, 23 e 24 settembre 1999, a cura di A.Del Col, G. Paolin, Trieste, Università di Trieste, 2000; L’ inquisizione, atti del simposiointernazionale (Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998), a cura di A. Borromeo, Cittàdel Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2003; Gli archivi dell’Inquisizione in Italia: pro-
zato i loro interessi 11. Pensiamo, ad esempio, al grande con-senso riscontrato da ricerche dedicate alla dissidenza religiosa,all’inquisizione, alla censura ecclesiastica; oppure alla figura delpapa, alle congregazioni pontificie e alla curia romana, oppure,ancora, agli ordini religiosi, alle pratiche devozionali, agli spazisacri e alla loro ritualità.
Anche la storiografia sul Piemonte d’età moderna ha risen-tito di questa rinnovata attenzione per la vita religiosa e le isti-tuzioni ecclesiastiche, sia pur con tempi e sfumature diversi ri-spetto ad altri contesti. In Piemonte sembra infatti persistere,più che altrove, l’eredità di quel «divorzio» fra storiografia ci-vile e storiografia ecclesiastica, intrapreso nel XVIII secolo econsumatosi pienamente nell’Ottocento, «come se l’oggetto del-la ricerca storica si fosse sdoppiato evidenziando due mondi op-posti e incomunicabili» 12.
Se questa non è certo la sede per illustrare ragioni, dinami-che e attori di tale frattura, vale tuttavia la pena soffermarsi bre-vemente sui suoi effetti. Il separatismo storiografico, riverberoculturale di un più profondo separatismo ideologico, ha spessocondotto ad un arroccamento, tematico e metodologico, fra glistudiosi delle istituzioni ecclesiastiche e della vita religiosa 13.
170 paolo cozzo
blemi storiografici e descrittivi (Roma, Archivio di Stato, 18 febbraio 2005), a cura di A. DelCol, in «Cromohs» (Cyber Review of Modern Historiography), 2006 (http://www.cromohs.unifi.it/11_2006/inquisindex.html).
11 Questa attenzione si è manifestata, fra l’altro, in alcune opere collettive chehanno riscosso notevole successo come, ad esempio, La Chiesa e il potere politico (Storia d’I-talia, Annali 9), a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Torino, Einaudi, 1986; Storia dell’Italiareligiosa, a cura di G. De Rosa, T. Gregory, A. Vauchez, (I-III), Roma-Bari, Laterza,1993-1995; Clero e società nell’Italia moderna, cura di M. Rosa, Roma-Bari, Laterza, 1992;Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyla(Storia d’Italia, Annali 16), a cura di L. Fiorani, A. Prosperi, Torino, Einaudi, 2000; Ilpapato e l’Europa, a cura di G. De Rosa e G. Cracco, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2001;Religione, cultura e politica nell’Europa dell’Età moderna. Studi offerti a Mario Rosa dagli amici, a curadi C. Ossola, M. Verga, M.A. Visceglia, Firenze, Olschki, 2003.
12 G. CRACCO, Introduzione, in Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo, Roma,Viella, 1998, pp. XIX-XLVI, p. XXV.
13 Cfr., a questo proposito, le considerazioni di G. BATTELLI, Gli studi sui vescovi e lediocesi del Nord-Italia tra Cinquecento e Novecento. Panorama storiografico dell’ultimo secolo, in «Rivi-sta di storia e letteratura religiosa», 28 (1992), pp. 391-426.
Da un lato, infatti, la storia religiosa è stata considerata (nonsolo da modesti apologeti, ma anche da specialisti rigorosi chesi richiamavano alla lezione di maestri quali Hubert Jedin) co-me disciplina interna al cattolicesimo, da analizzare e raccon-tare con strumenti e finalità «naturalmente» confessionali, nel-la convinzione – tutta jediniana, appunto – che «centro dellastoria della Chiesa non è l’uomo, considerato in sé e nei suoirapporti sociali, ma Dio»14. Dall’altro, invece, la storia reli-giosa, giudicata priva di una sua propria specificità, è stata alungo interpretata come semplice funzione di altre dimensioni(implicitamente indicate o esplicitamente dichiarate più im-portanti), cioè come variabile dipendente della storia politica,sociale, economica. Si sono così manifestate due diverse moda-lità di approccio alla storia religiosa, spesso in contrasto fra diloro: una – scritta da cattolici, per un pubblico tendenzialmen-te cattolico – che, assimilandosi a esercizio di analisi e di rifles-sione autoreferenziale, finiva per configurarsi come strumentodi affermazione di un’identità ritenuta in pericolo; un’altra –scritta da laici, per un pubblico tendenzialmente laico – che as-surgeva a prova della necessaria integrazione (e, per certi versi,subordinazione) del fenomeno religioso all’interno di una civil-tà che della religione sembrava non aver più bisogno.
Certo, molto tempo è passato dagli anni nei quali un catto-lico intransigente, Tommaso Chiuso, si proponeva di raccon-tare la storia ecclesiastica del Piemonte come relazione degliavvenimenti che «afflissero» la Chiesa nei secoli XVIII e XIX,mentre uno dei massimi esponenti della cultura sabaudista,Ferdinando Gabotto, scherniva come «molto attesa dai topidelle parrocchie del vescovado» una storia diocesana fruttodi erudizione ecclesiastica15. Le distanze si sono col tempo
storia religiosa 171
14 H. JEDIN, Kirchengeschichte als Heilsgeschichte?, in «Saeculum», 5 (1954), pp. 119-128(nella traduzione italiana apparsa in «Critica sociale», I 1962, pp. 181-194, p. 192).
15 La vicenda (relativa ai sei volumi delle Notizie e documenti della Chiesa pinerolese, com-poste dal canonico Pietro Caffaro), sulla quale cfr. E. ARTIFONI, Scienza del sabaudismo.Prime ricerche su Ferdinando Gabotto storico del medioevo (1866-1918), in «Bullettinodell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», 100 (1995-1996), pp. 167-191, in
ricomposte, anche se la tendenza a considerare la dimensionereligiosa come una realtà «subalterna» (oppure, nel miglioredei casi, solamente «alternativa») alla storia di un’epoca èrimasta viva anche in alcuni fra i maggiori storici del secoloappena trascorso. Per un maestro come Franco Venturi, ad esem-pio, nella «storia politica delle idee», quella religiosa dovevarivestire un peso relativo, se – come ebbe a scrivere – «solo ciinteressa il rapporto tra l’una e l’altra cosa, tra l’illuminismocioè e la vita politica, sociale ed economica del Settecento»16.Questa posizione, peraltro, non impedì a Ven-turi (che, consi-derando l’Illuminismo nel suo «atteggiamento di rottura sulpiano religioso», aveva intuito la forza dell’idea religiosa, inse-rendo ad esempio il giansenismo fra «gli elementi costitutividell’epoca delle riforme» 17) di manifestare il suo interesse neiconfronti della Chiesa, o meglio dei rapporti fra Stato eChiesa, analizzati nell’ottica (specie per ciò che concerne ilPiemonte, dal Radicati di Passerano al secondo volume delSettecento Riformatore) del giurisdizionalismo.
Questa attenzione a «uomini, momenti, problemi di unoscontro che non si svolse soltanto sul piano della rivendica-zione dei diritti regi nei confronti della Santa Sede, ma solle-citò anche a interrogarsi sull’organizzazione della Chiesa»18 hacaratterizzato settori diversi e significativi della storiografiasubalpina più recente. Da alcuni decenni, ormai, si studiano afondo le esperienze «civili e religiose» dei protagonisti del giu-
172 paolo cozzo
part. pp. 167-168, è stata ripresa da G. CRACCO, Introduzione cit., p. XXVIII, e da G.G.MERLO, Le circoscrizioni ecclesiastiche del Piemonte, in Il Settecento religioso nel Pinerolese, a cura diA. Bernardi, M. Mar-chiando Pacchiola, G.G. Merlo, P. Pazè, Pinerolo, Museo dioce-sano, 2001, pp. 15-22, in part. pp. 17-18.
16 Il passo, tratto dall’intervento di F. VENTURI, L’illuminismo nel Settecento europeo, alXI Congrès International de sciences historiques (Stoccolma 1960), è citato da L.GUERCI, Gli studi venturiani sull’Italia del ’700: dal Vasco agli Illuministi italiani, in Il coraggio dellaragione. Franco Venturi intellettuale e storico cosmopolita, a cura di L. Guerci e G. Ricuperati,Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1998, pp. 203-241, in part. p. 217.
17 Ibid., pp. 238, 224.18 Ibid., p. 223.
risdizionalismo, le forme e i modi del governo ecclesiastico delterritorio, gli attori di un conflitto – quello fra Chiesa e Stato– che continua ad essere interpretato da molte parti come pre-supposto (logico e cronologico) della secolarizzazione, e quindidella modernità.
Il punto focale di questa visione della storia religiosa è il nes-so fra religione e politica, fra Chiesa e potere, fra clero ed élites.Si tratta di una visione, questa, che ha privilegiato nettamentele istituzioni ecclesiastiche, la cui storia «è anche una storia piùo meno diretta o riflessa delle forme di organizzazione del po-tere, e ne illustra anzi alcuni aspetti essenziali» 19, mentre halasciato in secondo piano la vita religiosa, la cui storia – è statoribadito a proposito del XVIII secolo – è anche storia «deisentimenti e delle credenze religiose collettive» di cui la Chiesacattolica si fece «interprete e portatrice nel suo progetto di con-quista cristiana della società»20.
Nell’analisi storiografica si è dunque spesso assistito ad unadicotomia: da un lato le istituzioni ecclesiastiche, di cui si èprevalentemente evidenziata la costante tendenza ad interagirecon il potere politico e ad assimilarsi con la società, dall’altrola vita religiosa, di cui si è sottolineato soprattutto il ruolo avu-to dai gruppi, dai movimenti e dalle figure carismatiche. Taledicotomia ha contribuito ad una progressiva omologazione del-la Chiesa all’interno di un più generale quadro istituzionale:parroci, abati e – soprattutto – vescovi sono stati infatti visti,prevalentemente, come espressione dei ceti dirigenti, come ele-menti di raccordo fra centro e periferia dello Stato, come ca-nali di comunicazione e di interazione fra corte e territorio 21.
storia religiosa 173
19 G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, Introduzione, in La Chiesa e il potere politico cit., pp.XVII-XXV, in part. p. XX.
20 M. ROSA, Premessa, in Settecento religioso. Politica della Ragione e religione del cuore, Vene-zia, Marsilio, 1999, pp. 9-14, in part. p. 12.
21 In questa prospettiva cfr., ad esempio, M.T. SILVESTRINI, La politica della religione. Ilgoverno ecclesiastico nello Stato sabaudo del XVIII secolo, Firenze, Olschki, 1997; e, in relazionealla politica ecclesiastica dei Gonzaga nel Monferrato, B.A. RAVIOLA, Il Monferrato gonza-
D’altro canto, la vita religiosa (che negli anni appena tra-scorsi è stata analizzata nell’ottica prevalente dei rapporti «tragli aspetti “sociali” e “religiosi”»22 emergenti da alcune speci-fiche tipologie di fonti, come le visite pastorali o le relationes adlimina) si è vista spesso ridotta a «caso particolare» di «formeculturali» riconducibili a pratiche possessorie e linguaggi giuri-sdizionali 23.
Che la storia religiosa debba essere intesa nelle sue molte-plici dimensioni, tenendo in pari considerazione tanto le pro-spettive politico-istituzionali quanto quelle economico-sociali,tanto gli aspetti artistico-culturali quanto – non ultimi – quellispirituali e devozionali (giacché la Chiesa – è stato scritto tem-po fa – è sì un complesso sistema istituzionale, ma anche un«corpo mistico» in perenne equilibrio fra terra e cielo24) ap-pare oggi un’esigenza improcrastinabile. Tanto più per una real-tà storiografica – quella rivolta al Piemonte – nella quale staemergendo, sia pur a fatica, la consapevolezza dell’importanzadella dimensione religiosa nella storia del territorio, delle città,delle istituzioni, così come in quella dello Stato e della corte.
Certo, molto rimane ancora da fare affinché la storia reli-giosa non venga più trattata come un semplice corollario, oun’appendice utile ma non indispensabile ad altre storie. Unatteggiamento, questo, meno frequente oggi che in passato, mapur sempre presente, se è vero che in una recente riflessionesull’ultima grande storia di Torino – quella promossa dall’Acca-demia delle Scienze – (un’opera la quale ha voluto leggere lacittà come «crocevia» anche religioso oltre che economico,
174 paolo cozzo
ghesco, Istituzioni ed élites di un micro-stato (1536-1708), Firenze, Olschki, 2003, pp. 351-413.
22 A. TORRE, Vita religiosa e cultura giurisdizionale nel Piemonte di antico regime, in Fonti eccle-siastiche per la storia sociale e religiosa d’Europa: XV-XVIII secolo, a cura di C. Nubola, A. Tur-chini, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 181-211, in part. p. 181.
23 A. TORRE, Il consumo di devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime,Venezia, Marsilio, 1995, p. XIV e ss.
24 B. GEREMEK, Chiesa, in Enciclopedia, direzione R. Romano, vol. II, Torino, Einau-di, 1977, pp. 1077-1141, in part. pp. 1087-1089.
sociale, politico e culturale 25) Chiesa e religione non trovanospazio, quasi come se si trattasse di elementi estranei o incom-patibili con altri (l’urbanistica, la scienza e la tecnica, le arti, laletteratura, la cultura politica e la struttura sociale) presentatiinvece come costitutivi di una identità civica26.
Rilevando il ruolo assunto dalla dimensione religiosa nellastoria del Piemonte di età moderna risulterà forse meno arduoaffrontare un compito al quale la storiografia non può ulte-riormente derogare: ricomporre separazioni artificiali fra cam-pi d’indagine che, benché dotati di una propria peculiarità, ri-sultano tra di loro profondamente legati e intercomunicanti.
2. Una questione preliminare: il problema delle fonti ecclesiastiche
Negli ultimi anni molto si è riflettuto sulla versatilità euri-stica delle fonti ecclesiastiche, sulla loro duttilità, sulla fre-quenza con la quale esse sono state lette, analizzate e diffuseattraverso nuove metodologie di ricerca 27. L’uso sistematico distrumenti informatici, applicati a tipologie documentarie qualile visite pastorali, ha infatti permesso un significativo sviluppodelle conoscenze sulla realtà delle diocesi di età moderna. Inarea veneta e trentina, ad esempio, gli studi sulle chiese localihanno largamente beneficiato della creazione di dettagliatebanche dati sulle visite pastorali, di indici storico-toponoma-stici sulle parrocchie, gli enti ecclesiastici e le persone « in sa-cris» citate negli atti di visita 28.
storia religiosa 175
25 G. RICUPERATI, Capitale, municipalità, corte: i ruoli di una città complessa, in Storia diTorino cit., III, pp. XVII-XXXIII, in part. p. XXIX.
26 Cfr. Storia di Torino, storia di città, a cura di M. Guglielmo, Bologna, il Mulino,2004.
27 Fonti ecclesiastiche cit. Interessanti anche le riflessioni emerse nel recente seminarioGli archivi per la storia degli Ordini religiosi. Materiali per una guida. I Fonti e problemi (secoli XVI-XVII), svoltosi a Teramo, 27-28 novembre 2006.
28 Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le visite della diocesi di Trento (1537-1940),a cura di C. Nubola, Bologna, il Mulino, 1998.
In Piemonte – così come in gran parte d’Italia – invece,questa strumentazione non è disponibile. Non solo; per lo stu-dioso interessato alla storia religiosa un primo (e spesso insor-montabile) problema si rivela addirittura l’accesso fisico allefonti ecclesiastiche, in larga parte conservate da enti e istitu-zioni religiose per lo più impreparate (quando non velatamenterestie) ad aprire i loro fondi alla curiosità dei ricercatori. Tran-ne alcune rare eccezioni, quasi tutti gli archivi diocesani dei 17vescovadi del Piemonte risultano infatti difficilmente accessi-bili: non solo per il ridotto orario di apertura (spesso limitatoa poche ore alla settimana che, in alcuni casi, non viene nep-pure osservato), ma anche per l’assenza di adeguati strumentidi reperimento del materiale (inventari, cataloghi, repertori,ecc.). Tale situazione si aggrava ulteriormente (anche qui, fattesalve alcune isole felici) passando agli archivi e alle bibliotechedi altri luoghi pii e istituzioni religiose (parrocchie, chiese col-legiate, abbazie, monasteri, conventi, santuari, seminari del cle-ro), la cui fruizione viene spesso negata per assenza di perso-nale addetto e di locali adeguati alla consultazione dei docu-menti.
Questo fatto, che nella sua contingenza può sembrare per-sino banale, si dimostra invece decisivo nell’orientamento delleindagini. Le oggettive difficoltà di accesso agli archivi ecclesia-stici hanno portato all’esito, per certi versi paradossale, che perstudiare la vita religiosa e le istituzioni ecclesiastiche si sia do-vuto ricorrere prevalentemente a fonti conservate negli archivicivili (in particolare quelli di Stato).
Il problema della « lamentevole situazione di molti archividiocesani»29 è del resto generale se è vero – com’è stato no-tato – che « in Italia strumenti fondamentali per la ricerca sto-rica quali indici, repertori di fonti, regesti, elenchi di fondi ar-chivistici, guide agli archivi sono ancora parziali e carenti e, seesistono, sono manoscritti o dattiloscritti, riservati ad uso in-
176 paolo cozzo
29 P. PRODI, Presentazione, in Per una banca dati delle visite pastorali cit., pp. 7-9, in part. p. 8.
terno dell’archivio o della biblioteca, oppure sono di difficilereperimento, pubblicati da case editrici locali con limitate pos-sibilità di diffusione» 30.
Questa carenza, che travalica i limiti del contesto locale 31,investe anche gli scrigni della memoria della Chiesa universale.Non è un caso che nell’Archivio Segreto Vaticano, oltre ai fon-di ben noti agli studiosi di storia piemontese (in particolare ilfondo Segreteria di Stato, Savoia, 1560-1803), esista un importantefondo Archivio della Nunziatura di Torino, diviso in Feudi del Piemonte(253 volumi, 1561-1863), Corrispondenza e Cancelleria (105 bu-ste e 200 volumi, 1602-1860), che, a causa della mancata inven-tariazione, «attende ancora di essere compiutamente descrittoe utilizzato»32.
L’esistenza di queste oggettive difficoltà nell’accesso alle fon-ti ecclesiastiche e nella loro adeguata fruizione è una questioneche, se non risolta, potrebbe rappresentare un limite significa-tivo al progresso delle conoscenze sulla storia religiosa del Pie-monte. È evidente che la risoluzione di tale problema non puòessere lasciata all’intraprendenza del singolo studioso, ma deveinvece essere l’esito di un serio confronto con le istituzioni ec-clesiastiche (italiane e straniere) interessate allo sviluppo dellaricerca storica: innanzitutto le diocesi subalpine (i cui archivicostituiscono un patrimonio documentario insostituibile), e laSanta Sede (alla quale spetta il compito di procedere nella si-
storia religiosa 177
30 C. NUBOLA - P. PAOLETTI, Eidon: una banca dati per le visite pastorali italiane, ibid., pp.25-42, in part. p. 26. Un utile – benché assai parziale – strumento di ricerca è tuttaviarappresentato da I fondi archivistici: catalogo delle guide ed inventari editi (1861-1990), a cura diM.T. Piano Mortari, I. Scandaliato, introduzione e indice dei fondi di P. Carucci,Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivi-stici, 1995, dove sono puntualmente riportate informazioni su guide, censimenti einventari di archivi diocesani e capitolari, di seminari, di chiese e parrocchie.
31 Cfr. in merito P. PRODI, A proposito della storia locale dell’età moderna: cultura, spiritualità,istituzioni ecclesiastiche, in La storia locale. Temi, fonti e metodi della ricerca, a cura di C. Violante,Bologna, il Mulino, 1982, pp. 143-156.
32 G. GUALDO, La nunziatura apostolica di Venezia e i suoi archivi. In margine ad una recentepubblicazione, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2000, pp. 525-539, in part. p.537.
stemazione dei fondi archivistici vaticani ritenuti irrinunciabi-li). E ciò anche alla luce del Concordato, che all’art. 12 stabili-sce che « la conservazione e la consultazione degli archivi di in-teresse storico e delle biblioteche» appartenenti agli enti e alleistituzioni della Chiesa «saranno favorite e agevolate sulla basedi intese tra i competenti organi delle due parti» 33.
3. Percorsi tematici
a) Le cellule del tessuto ecclesiastico: le diocesi del Piemonte
Nel panorama storiografico più recente sugli Stati italianidi età moderna, vescovi e diocesi sono stati oggetto di un inte-resse «particolarmente complesso da analizzare» 34, influen-zato da prospettive e sensibilità diverse. Ciò anche perché moltistorici, «soprattutto quelli di quest’ultimo trentennio, non cer-cano più tanto l’affermarsi di una ortodossia cattolica nell’etàmoderna, né i rapporti tra Chiesa istituzionale e Stati moder-ni… quanto piuttosto la rilevanza antropologica e il ruolo so-ciale e politico che ebbero le istituzioni, le credenze e la disci-plina»35.
Al vescovo, inteso come figura apicale della gerarchia eccle-siastica locale ma anche come elemento di raccordo tra le chie-se italiane e la curia romana fra tardo Cinquecento e pieno Set-tecento, si è ad esempio rivolto Claudio Donati 36, mentre unaltro maestro, Mario Rosa, ha concentrato le sue attenzioni al
178 paolo cozzo
33 Cfr. a tal proposito P. CARUCCI, Gli archivi ecclesiastici: aspetti giuridici nei rapporti traStato e Chiesa, in Chiesa chierici sacerdoti cit., pp. 13-23, in part. p. 14.
34 G. BATTELLI, Gli studi sui vescovi e le diocesi cit., p. 391.35 P. STELLA, Introduzione, in Chiesa, chierici, sacerdoti cit., pp. 1-13, in part. p. 2.36 C. DONATI, Vescovi e diocesi d’Italia dell’età post-tridentina alla caduta dell’antico regime, in
Clero e società cit., 321-389; ID., La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760), in La Chiesa e il potere politico cit., pp. 721-766; cfr. anche A. MENNITI IPPOLITO,Politica e carriere ecclesiastiche nel secolo XVII. I vescovi veneti fra Roma e Venezia, Bologna, ilMulino, 1993.
vescovo del XVIII secolo, un soggetto animato (spesso in mo-do contraddittorio) da intenti riformistici, sensibilità di rinno-vamento cultuale e istituzionale, istanze di rigore morale, vo-lontà di collaborazione con le autorità civili, ricerca di equili-brio tra i doveri verso Roma e quelli verso lo Stato 37.
Negli ultimi anni in Piemonte l’interesse per la figura delvescovo è tornato vivo anche grazie ai lavori di Angelo Torre,che si è avvicinato alla figura dell’ordinario diocesano con unapproccio «configurazionale» 38. Per Torre, che ha utilizzatocome fonte privilegiata delle sue indagini le visite pastorali del-le diocesi subalpine, il vescovo piemontese d’Antico Regime èprincipalmente un «creatore» di giurisdizione, che esprime lasua autorità in rituali socialmente e culturalmente codificati.
Anche per merito di questi recenti stimoli, si è ravvisata lanecessità di ricondurre la dimensione episcopale nel dibattitosulle fonti della ricerca storico-ecclesiastica. Nuovi filoni d’in-dagine (ad esempio i processi per le cause matrimoniali 39), ocampi già ampiamente coltivati ma ora dissodati con rinnovata
storia religiosa 179
37 M. ROSA, Tra Cristianesimo e Lumi. L’immagine del vescovo nel ’700 italiano, in «Rivistadi storia e letteratura religiosa», XXIII (1987), pp. 240-278; ID., Politica ecclesiastica e ri-formismo religioso in Italia alla fine dell’antico regime, in «Cristianesimo nella storia», X (1989),pp. 227-249; ID., La Chiesa in Italia tra «ancien régime» ed età napoleonica, in Chiesa e società inSicilia. I secoli XVII-XIX, atti del III convegno internazionale organizzato dall’arcidiocesidi Catania, 24-26 novembre 1994, a cura di G. Zito, Torino, SEI, 1995, pp. 3-22; esoprattutto M. ROSA, Settecento religioso cit.
38 A. TORRE, Il consumo di devozioni cit.; ID., Il vescovo di antico regime. Un approccio configu-razionale, in «Quaderni storici», 91, XXXI, 1996, pp. 199-216; ID., Vita religiosa e culturagiurisdizionale nel Piemonte di antico regime, in Fonti ecclesiastiche cit., pp. 181-211.
39 Su questo nuovo tema di ricerca cfr. Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII alXVIII secolo, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2000; I tribu-nali del matrimonio (sec. XV-XVIII), a cura di S. Seidel Menchi e D. Quaglioni, Bologna, ilMulino, 2007. Cfr. anche S. SEIDEL MENCHI, La fanciulla e la clessidra. Nota sulla periodizza-zione della vita femminile nella società della prima età moderna, in Tempi e spazi di vita femminile tramedioevo ed età moderna, a cura di S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn,Bologna, il Mulino, 1999, pp. 105-156, in particolare pp. 138-155; D. HACKE, “Non lovolevo per marito in modo alcuno”. Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il1680, ibid., pp. 195-224; e, più in generale, G. ZARRI, Il matrimonio tridentino, in Il conciliodi Trento e il moderno, a cura di P. Prodi e W. Reinhard, Bologna, il Mulino, 1996, pp.437-483.
sensibilità critica e differenziate modalità di approccio (il casopiù evidente è proprio quello delle visite pastorali), stanno adevidenziare che la figura dell’ordinario diocesano, l’organizza-zione degli apparati burocratici curiali, l’amministrazione e lagiustizia vescovile, le competenze giurisdizionali delle chieselocali riserbano molti elementi importanti ancora largamenteinesplorati ma assai utili per una più profonda comprensionedella vita politica e sociale dell’età moderna.
Certamente si è ancora lontani dal tentativo ambizioso diredigere una storia delle chiese locali italiane, così come si èandato realizzando a partire dagli anni Settanta in Francia at-traverso l’Historie des diocèses de France diretta da J.R. Palanque e B.Plongeron 40. In questa prospettiva sembrerebbe andare l’uscitadel primo volume della storia della diocesi di Ivrea 41, che apreuna collana significativamente battezzata «Chiese d’Italia», qua-si a voler suggerire la reminiscenza dell’imponente opera del Cap-pelletti, «Le Chiese d’Italia»42.
Il ritardo di un progetto articolato su scala nazionale è forsesegno di una accentuata sensibilità regionale o «metropolita-na» che anima ancora l’interesse per la storia delle istituzioniecclesiastiche territoriali nel nostro paese, come testimonianoalcune pubblicazioni dell’ultimo decennio 43.
180 paolo cozzo
40 La collezione Histoire des diocèses de France, avviata negli anni Settanta, è compostada una ancienne sèrie che comprende studi sulle diocesi di Marsiglia, Metz, Tarbes e Lour-des, Bourges, e da una nouvelle sèrie che sta trattando le altre sedi episcopali transalpine.
41 Storia della Chiesa d’Ivrea dalle origini al XV secolo, a cura di G. Cracco, con la collabo-razione di A. Piazza, Roma, Viella, 1998, al quale fanno seguito Storia della Chiesa d’Ivreain epoca contemporanea, a cura di M. Guasco, M. Margotti, F. Traniello, Roma, Viella,2006, e il volume dedicato all’età moderna in corso di stampa.
42 Le Chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, uscito a Venezia a partire dal 1844.43 Storia della Chiesa di Bologna, a cura di P. Prodi e L. Paolini, Bologna, Istituto per la
storia della chiesa di Bologna (Bergamo, Bolis), 1997; Il cammino della Chiesa genovese dalleorigini ai nostri giorni, a cura di D. Puncuh, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1999;R. TURTAS, Storia della Chiesa di Sardegna dalle origini al 2000, Roma, Città nuova, 1999; D.CERVATO, Verona sacra: profilo di storia della Chiesa veronese, dal 1630 ai nostri giorni, Verona,Della Scala, 2000; M. AL KALAK, Storia della Chiesa di Modena: dal Medioevo all’età contempora-nea. Profili di vescovi modenesi dal IX al XVIII secolo (prefazione di A. Spaggiari), Modena,Poligrafico Mucchi, 2006; A. ARECCO, La Diocesi di Albenga-Imperia e i suoi vescovi: storia
Nonostante l’affermazione di questo approccio assai atten-to alla valorizzazione delle peculiarità regionali e cittadine, inPiemonte gli studi sulle chiese locali in età moderna stentanoancora a trovare un loro spazio specifico, non solo nel quadrostoriografico generale più recente sulla regione, ma anche al-l’interno delle indagini di storia ecclesiastica e religiosa. Accan-to ad opere di erudizione locale, risalenti al secolo XIX e aiprimi decenni del XX, di cui è apprezzabile soprattutto la mes-se di informazioni, di dati, di rinvii archivistici, piuttosto chel’impostazione generale, inevitabilmente superata, spesso legataad un andamento biografico-cronachistico e sovente animatada intenti apologetici e controversistici, nel tempo si sono svi-luppate ricerche di grande respiro e di notevole rigore docu-mentario.
Se sin dalla fine del XVIII secolo il canonico monregaleseGioachino Grassi aveva delineato un primo esempio di storiadiocesana con le sue Memorie storiche della chiesa vescovile di Montere-gale 44, appena preceduto dalla Storia della Chiesa di Susa di CesareSacchetti 45 e seguito, nella prima metà del XIX secolo, dallaStoria della Chiesa Metropolitana di Torino di Giovanni Battista Se-meria 46, tra Otto e Novecento uscirono gli importanti lavori diTommaso Chiuso 47 e di Fedele Savio 48 (il primo dedicato allaChiesa subalpina dall’età napoleonica al pieno Ottocento, ilsecondo alle Chiese piemontesi dall’evangelizzazione sino albasso Medioevo). Negli stessi anni vennero alla luce anche al-
storia religiosa 181
della chiesa ingauna dalle origini all’inizio del Quattrocento, Albenga, Diocesi di Albenga-Imperia,2006; ulteriori aggiornamenti bibliografici in M. ROSA, Clero cattolico e società europea nel-l’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 143-145.
44 G. GRASSI DI S. CRISTINA, Memorie storiche della chiesa vescovile di Monteregale in Pie-monte dall’erezione del vescovado sino a’ nostri tempi, Torino, Stamperia Reale, 1789, 2 voll.
45 C. SACCHETTI, Storia della Chiesa di Susa, Torino, Briolo, 1788.46 G.B. SEMERIA, Storia della Chiesa Metropolitana di Torino, Torino, Fontana, 1840.47 T. CHIUSO, La Chiesa in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, 5 volumi, Torino, Spei-
rani, 1887-1904.48 F. SAVIO, Gli antichi vescovi di Torino. Studi storici con documenti inediti, Torino, Speirani,
1889; ID., Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Il Piemonte, Torino,Bocca, 1899.
tre storie diocesane: la Novara sacra curata da Giuseppe Raviz-za49, le Memorie storiche sulla Chiesa d’Ivrea di Giovanni Saroglia 50,la Storia della Chiesa di Asti di Gaspare Bosio 51, le Notizie storichedella città di Fossano 52 di Pietro Paserio, le Notizie e documenti dellaChiesa Pinerolese di Pietro Caffaro 53, la Vercelli sacra di RiccardoOrsenigo54, e le storie dei vescovi saluzzesi nell’ultimo secolodi vita del marchesato e nel primo di dominio sabaudo, curateda Carlo Fedele Savio 55.
Nel corso del Novecento gli studi si moltiplicano56 e si raf-finano gli strumenti e le metodologie di ricerca. Dopo le pri-me, pionieristiche ricerche di Franca Maria Mellano e MicheleGrosso sulla Controriforma nelle diocesi subalpine 57 (che han-no contribuito a far scoprire le potenzialità di fonti – le vi-sitepastorali, le visite apostoliche e le relationes ad limina – sino adallora poco utilizzate dalla storiografia), compaiono alcuniapprofondimenti sull’erezione del vescovado di Alessandria 58,
182 paolo cozzo
49 La Novara sacra del vescovo venerabile Carlo Bascapé, Novara, Merati, 1878.50 G. SAROGLIA, Memorie storiche sulla Chiesa d’Ivrea. Cenni biografici, Ivrea, Tomatis, 1881.51 G. BOSIO, Storia della Chiesa d’Asti, Asti, Michelerio, 1894.52 P. PASERIO, Notizie storiche della città di Fossano, III, Torino, Ferrari, 1866.53 P. CAFFARO, Notizie e documenti della Chiesa Pinerolese, I-VI, Pinerolo, Chiantore Ma-
scarelli, 1893-1903.54 R. ORSENIGO, Vercelli sacra. Brevissimi cenni sulla diocesi e sue parrocchie, stato delle parroc-
chie e del clero, Como, Unione tipografica Ferrari, 1909.55 C.F. SAVIO, Saluzzo e i suoi vescovi (1475-1601), Saluzzo, Lobetti - Bodoni, 1911;
ID., Saluzzo marchesato e diocesi nel secolo XVII (1601-1635), Saluzzo, Lobetti-Bodoni, 1915.56 Un esempio significativo, a tal proposito, viene dalla cospicua produzione sulla
storia religiosa nel Cuneese promossa nel primo Novecento da A.M. Riberi (uno deifondatori, nel 1929, della Società per gli Studi storici della Provincia di Cuneo) sulquale cfr. Monsignor Alfonso Maria Riberi. Uomo di chiesa, uomo di studio (1876-1952), a curadi G. Griseri, G.M. Gazzola, L. Mano, atti del convegno, Borgo San Dalmazzo, 6dicembre 2002, Cuneo, 7 dicembre 2002, in «Bollettino della Società per gli Studi sto-rici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 129, 2003; per la sua produ-zione cfr. A.M. RIBERI, Repertorio di antiche memorie: I, Storia della nostra diocesi; II, Paesi,uomini, chiese, Cuneo, Primalpe, 2002.
57 Il riferimento è alle ricerche di M.F. MELLANO, La Controriforma nella diocesi diMondovì (1560-1602), Torino, Stabilimento tipografico Impronta, 1955, e a quelle diM. GROSSO - M.F. MELLANO, La Controriforma nell’arcidiocesi di Torino (1558-1610), I-III,Città del Vaticano, Tipografia poliglotta vaticana, 1958.
58 Cfr. G. FIASCHINI, La fondazione della diocesi di Alessandria ed i contrasti con i vescoviacquesi, in Popolo e stato in Italia nell’età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega lombarda (Rela-
mentre alla soglia dell’istituzione della diocesi di Saluzzo si ar-resta lo studio di Ettore Dao sulla Chiesa del marchesato 59.
Alla fine degli anni Settanta risalgono invece le ricerche diGiampiero Casiraghi sulla diocesi di Torino nel Medioevo 60, enel 1979 esce il fondamentale studio di Achille Erba, che ri-mane un punto di partenza insostituibile per comprendere lageografia e l’organizzazione ecclesiastico-territoriale degli Statisabaudi nell’età della Controriforma, ma anche per seguire losviluppo di una politica religiosa costretta a confrontarsi contradizioni giurisdizionalistiche diverse (gli usi gallicani) e ad af-frontare – caso unico in Italia – una presenza protestante nu-mericamente significativa e strategicamente organizzata sul ter-ritorio61.
In anni ancora più recenti, lo studio sulle chiese piemontesi(specie in rapporto alla loro costituzione) si arricchisce di pre-ziosi contributi. Accanto a nuovi approfondimenti sulla chiesamonregalese 62, la diocesi di Casale Monferrato è oggetto diuna magistrale ricerca di Aldo A. Settia, che descrive (con talericchezza documentaria e rigore metodologico da fare del sag-gio un «gioiello» storiografico) le dinamiche (ecclesiastiche, po-litiche e diplomatiche) che condussero nella seconda metà delQuattrocento i marchesi di Monferrato e papa Sisto IV a «fa-re Casale ciptà»63.
storia religiosa 183
zione e comunicazioni al XXXIII Congresso storico subalpino, Alessandria 6-9 otto-bre 1968), Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1970, pp. 495-512; V.POLONIO, La diocesi di Alessandria e l’ordinamento ecclesiastico preesistente, ibid., pp. 563-576.
59 E. DAO, La Chiesa saluzzese fino alla costituzione della diocesi di Saluzzo (1511), Saluzzo,Cassa di Risparmio di Saluzzo, 1965.
60 G. CASIRAGHI, La diocesi di Torino nel Medioevo, Torino, SASTE, 1979.61 A. ERBA, La Chiesa sabauda tra Cinque e Seicento. Ortodossia tridentina, gallicanesimo sa-
voiardo e assolutismo ducale (1580-1630), Roma, Herder, 1979.62 Cfr. Mondovì città e diocesi 1388-1988: documenti di 600 anni di vita civile, religiosa e
sociale nella diocesi e città di Mondovì, a cura di G. Comino, N. Vassallo, Mondovì, Fracchia,1988.
63 A.A. SETTIA, “Fare Casale ciptà”: prestigio principesco e ambizioni familiari nella nascita diuna diocesi tardomedievale, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, atti del VIIconvegno di storia della Chiesa in Italia, Brescia 21-25 settembre 1987, a cura di G. DeSandre Gasparini, A. Rigon, F. Trolese, G.M. Varanini, II, Roma, Herder, 1990, pp.675-715.
Al rapporto tra nuova chiesa vescovile e potere marchionalededica i suoi interessi anche Grado G. Merlo, che traccia unprimo tentativo di ricostruzione della nascita della diocesi diSaluzzo64 proprio alla luce dello sforzo congiunto del marche-sato e del papato di consolidare l’identità dinastico-territorialedel piccolo Stato attraverso la «sovrapposizione» di una giuri-sdizione ecclesiastica (il vescovado, appunto), non suffraganeaa Torino ma dipendente da Roma, ad una giurisdizione civilesempre più esposta alle mire espansionistiche sabaude e fran-cesi. Lo stesso Merlo è più volte tornato sul problema dell’or-ganizzazione territoriale delle diocesi piemontesi nel tardoMedioevo e nella prima età moderna 65, così come ha fattoGiorgio Cracco nella sua introduzione alla già citata Storia dellaChiesa d’Ivrea 66.
Diocesi e vescovi costituiscono dunque il punto di partenzaper una complessiva riflessione sul tessuto ecclesiastico del Pie-monte. Un tessuto che fra tardo Quattrocento e inizio Otto-cento si trasforma sensibilmente, con la nascita di nuovi vesco-vadi e il ridimensionamento di antiche diocesi, esito finale distrategie religiose ma anche politiche e diplomatiche67. L’evo-luzione della geografia ecclesiastica subalpina, segnata dalla fran-tumazione delle antiche e grandi circoscrizioni episcopali edalla parallela e progressiva razionalizzazione delle circoscri-zioni abbaziali, potrebbe essere oggetto di una ricerca appro-
184 paolo cozzo
64 G.G. MERLO, Le origini della diocesi di Saluzzo, in «Bollettino della Società per gliStudi storici, archeologici ed artistici nella Provincia di Cuneo», n. 113, 1995, pp. 89-98.
65 Si vedano i contributi di G.G. MERLO, La Chiesa e le chiese di Torino nel Quattrocento,in Storia di Torino, II, Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura di R.Comba, Torino, Einaudi, 1997, pp. 767-794, e Le circoscrizioni ecclesiastiche nel Piemonte cit.
66 G. CRACCO, Introduzione cit.67 A questo proposito mi permetto di rinviare a P. COZZO, Il confine fra geografia poli-
tica e geografia ecclesiastica nel Piemonte di età moderna: una complessa evoluzione, in Lo spazio sabaudo.Intersezioni, frontiere, confini in età moderna, a cura di B.A. Raviola, Milano, Franco Angeli,2007, pp. 195-206.
fondita. Partendo dalla documentazione esistente nell’Archiviodi Stato di Torino (i 64 mazzi del fondo Arcivescovadi e vescovadidella sezione Materie ecclesiastiche), che andrebbe necessariamenteintegrata con quella conservata nei singoli archivi diocesani, eprendendo spunto dalle già accennate indagini sull’erezionedelle diocesi di Casale (1475) e Saluzzo (1511), si potrebberocosì seguire le dinamiche che portarono alla nascita delle chiesedi Fossano (1596), Pinerolo (1747), Susa e Biella (1772),Cuneo (1817) e, ampliando l’analisi agli Stati sardi, quelle diChambéry (1775), Iglesias (1763) e Nuoro-Galtelly (1779).L’istituzione di nuovi vescovadi è un fenomeno che la politicasabauda, specialmente nel corso del XVIII secolo, finalizzòall’omologazione delle circoscrizioni ecclesiastiche con quellecivili (intendenze e province). Come tale, questo fenomeno an-drebbe analizzato dal punto di vista delle relazioni internazio-nali: l’erezione di un nuovo vescovado giungeva infatti al ter-mine di complesse trattative con la Sede apostolica, e in più diun’occasione esso coinvolgeva Stati terzi (come la Francia, ilMilanese, la Repubblica di Genova) sotto la giurisdizione deiquali ricadevano alcune terre appartenenti alle chiese localisabaude. Il fenomeno meriterebbe un approfondimento ancormaggiore dal punto di vista delle implicazioni interne, per co-noscerne le ricadute sul piano dei rapporti fra centro e perife-ria dello Stato. Sarebbe dunque opportuno porsi alcune do-mande. Innanzitutto, come reagisce uno Stato di Antico Re-gime di fronte al moltiplicarsi dei vescovadi sul suo territorio?Quali sono le conseguenze di questo processo sulla corte e suiceti dirigenti? E poi (spostando l’attenzione al livello locale),come si trasforma una città promossa a sede episcopale? Qualisono le reazioni delle sue élites civili e religiose? Come evolve ilsuo assetto sociale e culturale? Come si modifica la sua strut-tura urbanistica e architettonica?
Rispondere a queste domande significa analizzare da vicinola natura di quel «devoto condominio» che fu la città italiana
storia religiosa 185
di età moderna 68, ossia uno spazio dove sacro e profano, reli-gione e politica, ecclesiastico e laico, a ben vedere, tendono afondersi più che a dividersi, ad accordarsi più che ad opporsi.
b) Il clero nel Piemonte di età moderna
Come in altri coevi ambiti territoriali, nel Piemonte di etàmoderna il clero non costituisce una realtà monolitica ma unricco e variegato mosaico69. Non tutti i tasselli di questo mo-saico appaiono però con la stessa evidenza: accanto ad alcuni,sui quali negli anni più a lungo e approfonditamente si è po-sata la lente degli studiosi, ne esistono altri – e sono la maggio-ranza – ancora largamente inesplorati.
Il vescovo e, sia pur in misura minore, il parroco sono ledue figure ecclesiastiche sulle quali si sono concentrate le atten-zioni della storiografia. Ciò non può stupire, se si pensa chetali figure, le cui competenze e il cui ruolo furono sensibil-mente potenziati in età post-tridentina, rappresentano il perso-nale addetto alla guida delle due istituzioni (la diocesi e la par-rocchia) che stanno alla base dell’organizzazione territoriale del-la Chiesa cattolica.
Anche in ambito subalpino, dunque, la storia religiosa si èperciò spesso identificata con la storia delle diocesi e delle par-rocchie. Per verificarlo non occorre risalire alla storiografia difine Ottocento e di inizio Novecento; anche le opere più re-centi e metodologicamente più innovative hanno in larga parteprivilegiato lo studio delle circoscrizioni ecclesiastiche e delleloro gerarchie. Sia pur in tempi diversi, con prospettive e meto-dologie differenti, Maria Franca Mellano e Angelo Torre, Achil-le Erba e Pier Giorgio Longo, Luciano Allegra e Maria Teresa
186 paolo cozzo
68 R. ROSOLINO, Un devoto condominio: spazi rituali e famiglie di una confraternita palermitana,in «Quaderni storici», 33 (1998), 97, pp. 171-200.
69 Per considerazioni generali su questo problema cfr. Clero e società nell’Italia modernacit.; G. GRECO, La Chiesa in Italia nell’età moderna, Roma-Bari, Laterza, 1999; M. ROSA,Clero cattolico e società europea, cit.
Silvestrini – per limitarci a qualche nome – hanno concentratoi loro interessi sul clero parrocchiale e quello diocesano, trat-tati come due facce di un’unica medaglia: da un lato i vescoviche osservano, visitano, e «conoscono per governare» in nomedella Chiesa ma anche di uno Stato sempre più propenso a con-siderarli suoi alti funzionari; dall’altro i parroci, guide religiosedelle comunità urbane e rurali, osservati (innanzitutto attraver-so i giudizi dei vescovi) nel loro ruolo di mediazione sociale eculturale.
A ben vedere, tuttavia, sul personale ecclesiastico di vesco-vadi e parrocchie molto rimane da scoprire e da raccontare. An-che per il Piemonte sembrano valere le osservazioni di ClaudioDonati, per il quale « lo studio delle istituzioni episcopali inItalia, intese come “insieme degli organi di governo della dio-cesi”, ha costituito a lungo uno dei terreni meno battuti daglistorici dell’età moderna» 70. Da qui il bisogno di fare luce nonsolo sulla figura del vescovo o del parroco, ma anche sui nume-rosi soggetti che operavano insieme e attorno al responsabiledella diocesi o della parrocchia. Tale approccio appare partico-larmente utile per analizzare le curie vescovili, i loro ufficiali ele loro incombenze. Ancora troppo poco, infatti, sappiamo suivicari generali delle diocesi piemontesi, sui criteri di nomina,sul loro ruolo all’interno della curia, sulla loro estrazione so-cio-culturale, sulla loro formazione, sui loro rapporti con le éli-tes locali, sulle loro potenzialità economiche. Eppure questi«vice-vescovi» (che nella prassi canonica si distinguevano perle diverse competenze « in spiritualibus», « in temporalibus» e « inpontificalibus») svolgevano spesso – e soprattutto quando il tito-lare rivestiva incarichi nella corte pontificia o si occupava di af-fari politici e diplomatici – un ruolo chiave nell’organigrammadella diocesi. Il vicario generale, tra l’altro, era chiamato a pre-siedere quei tribunali vescovili ai quali erano affidate «funzioni
storia religiosa 187
70 C. DONATI, Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell’età moderna:percorsi di ricerca, in Fonti ecclesiastiche cit., pp. 213-229, p. 213.
non solo strettamente giudiziarie e repressive, ma anche buro-cratiche, amministrative, cancelleresche»71.
Analoghe considerazioni possono essere fatte per altre figu-re operanti a stretto contatto con il vescovo: non solo ecclesia-stici (come i vicari e i decani foranei, i canonici dei capitoli cat-tedrali, gli arcidiaconi) ma anche laici (i notai, i cancellieri, gliattuari) che popolavano le curie episcopali. Non meno profi-cua risulterebbe l’analisi – rimasta anch’essa finora assai spora-dica – sui soggetti di altri ambiti ecclesiastici: quelli bassi (co-me le parrocchie, le pievi, le rettorie) e quelli alti (come i capi-toli delle cattedrali, delle collegiate e delle abbazie).
Le abbazie, in particolare le abbazie nullius dioecesis (sulle qua-li, generalmente, «non vi sono quelle conoscenze e quella con-sapevolezza» che pure meriterebbero 72), rappresentano un veroe proprio buco nero nel quadro delle conoscenze sulla Chiesasubalpina d’età moderna. Mentre per il Medioevo l’istitutoabbaziale (con tutti i suoi risvolti di carattere sociale, culturaleed economico) è stato oggetto di numerose e articolate inda-gini 73, per i secoli dell’età moderna esso risulta un terrenoancora pressoché inesplorato. Non solo manca una mappaturaprecisa e dettagliata delle fondazioni monastiche sorte in età
188 paolo cozzo
71 D. ZARDIN, Tra continuità delle strutture e nuovi ideali di « riforma»: la riorganizzazioneborromaica della curia arcivescovile, in Lombardia borromaica, Lombardia spagnola 1554-1659, a cu-ra di P. Pissavino, G. Signorotto, Roma, Bulzoni, 1995, pp. 695-764, in part. p. 697.
72 G. GRECO, La Chiesa in Occidente. Istituzioni e uomini dal Medioevo all’Età moderna, Ro-ma, Carocci, 2006, p. 167.
73 Si segnalano fra le più recenti (in particolare per il Piemonte meridionale):L’abbazia di Staffarda e l’irradiazione cistercense nel Piemonte meridionale. Atti del convegno (Staffarda-Revello 17-18 ottobre 1998), a cura di R. Comba, G.G. Merlo, Cuneo, Società per glistudi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 1999; Il monastero di Ri-freddo e il monachesimo cistercense femminile nell’Italia occidentale (secoli XII-XIV), a cura di R.Comba, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia diCuneo, 1999; Certosini e cistercensi in Italia (secoli XII-XV), a cura di R. Comba e G. Merlo,Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo,2000; Santa Maria di Casanova. Un’abbazia cistercense fra i marchesi di Saluzzo e il mondo deicomuni, a cura di R. Comba e P. Grillo, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologicied artistici della provincia di Cuneo, 2006; Il fascino dell’eremo. Asceti, certosini e trappisti sulMombracco: sec. XIII-XVIII, in corso di stampa.
post-tridentina, ma anche per quelle di origine medievale assailacunose sono le informazioni relative agli abati, ai priori, ai vi-cari capitolari attivi sino alle soppressioni napoleoniche.
Tale problema si collega ad una questione di più ampio spes-sore: la complessiva carenza di dati sul clero nel Piemonte mo-derno. Tale carenza, che per il clero secolare si manifesta nellaquasi totale assenza di ricerche sui seminari delle diocesi subal-pine 74, diventa ancora più lampante per ciò che riguarda il cle-ro regolare. Va peraltro precisato, che « la sottovalutazione de-gli Ordini nella storiografia sull’età moderna»75 è un limiteche va ben oltre l’ambito piemontese, nel quale se, da un lato,negli ultimi anni non sono certo mancate ricerche di notevolevalore su gesuiti e cappuccini (ossia gli ordini più impegnatinell’attività di repressione del dissenso religioso e di riconqui-sta cattolica delle aree più esposte all’infiltrazione della riformaprotestante76), dall’altro ancora assai critico appare lo stato
storia religiosa 189
74 Il problema della carenza di studi e ricerche sui seminari del clero è comunquegeneralizzabile all’intera Penisola: cfr. M. GUASCO, Per una storia della formazione del clero:problemi e prospettive, in Chiesa, chierici, sacerdoti cit., pp. 25-38, in part. p. 25.
75 M.C. GIANNINI, Introduzione, in Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare nell’Eu-ropa d’antico regime, a cura di M.C. Giannini («Cheiron», XXII, 43-44, 2005), pp. 7-23,in part. p. 8.
76 Sul ruolo dei cappuccini e dei gesuiti nella «riconquista» delle valli pinerolesi ecuneesi cfr. B. PAZÉ BEDA - P. PAZÉ, Riforma e Cattolicesimo in Val Pragelato: 1555-1685,Pinerolo, Alzani, 1975; C. POVERO, La residenza dei padri gesuiti a Pinerolo, «Bollettino dellaSocietà Piemontese di Archeologia e Belle Arti», 51, 1999, pp. 313-334; EAD., Le mis-sioni cappuccine nelle Valli del Marchesato di Saluzzo, in L’annessione sabauda del marchesato di Saluzzo,tra dissidenza religiosa e ortodossia cattolica (secoli XVI-XVIII), atti del XLI convegno di studisulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, Torre Pellice-Saluzzo, 1-2 settembre2001, a cura di M. Fratini, Torino, Claudiana, 2004, pp. 215-245; C. POVERO, Missioniin terra di frontiera. La Controriforma nelle Valli del Pinerolese (secoli XVI-XVIII), Roma, Istitutostorico dei cappuccini, 2006. Alla presenza dei gesuiti nel Piemonte moderno sonoinoltre dedicati i contributi raccolti in La Compagnia di Gesù e la società piemontese. Le fonda-zioni del Piemonte orientale. Atti del convegno (Vercelli, 16 ottobre 1993), a cura di B. Signo-relli, P. Uscello, Vercelli, Gallo Arti Grafiche, 1995; La Compagnia di Gesù nel Piemontemeridionale (secoli XVI-XVIII). Atti del convegno (Mondovì, 10 settembre 1995), a cura diG. Griseri, Cuneo, Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provinciadi Cuneo, 1995; La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto aquelli di Carlo Alberto. Atti del convegno (Torino 14 settembre 1997), a cura di B. Signorelli,P. Uscello, Torino, Società piemontese di archeologia e belle arti, 1998.
delle conoscenze su altri ordini religiosi. Troppo poco si sasugli sviluppi in età moderna degli insediamenti subalpini deigrandi ordini monastici e conventuali. Eppure, celebri luoghidello spirito, ma anche importanti centri di cultura quali fu-rono nel Medioevo Staffarda, Novalesa, Fruttuaria, San Mi-chele della Chiusa, Ranverso (per citare solamente i più noti)non cessarono certo di esercitare un forte peso nella società,nell’economia, nella vita intellettuale del Piemonte anche neisecoli successivi. Allo stesso modo, la grande spinta di rinnova-mento religioso che, sin dal XIII secolo, i minori e i predicatoriportarono nelle città piemontesi – un caso emblematico, quel-lo di Pinerolo, venne analizzato in tale ottica qualche anno fa77
– non può essere ignorata spostando il nostro interesse versol’età moderna. Come potremmo analizzare – per fare so-lo unesempio tra i tanti possibili – lo sviluppo delle Univer-sità inPiemonte senza valorizzare in modo opportuno il decisivoruolo assunto (e mantenuto per secoli) dai frati francescani,dai domenicani e successivamente dai gesuiti e dagli espo-nentidi altre «congregazioni religiose insegnanti»78 in questi centridi formazione e di diffusione culturale?
Anche gli studi sui «nuovi» ordini, quelli nati in età triden-tina e post-tridentina, meriterebbero un significativo sviluppo:fatta eccezione per i già ricordati interessi rivolti all’azione con-troriformistica di gesuiti e cappuccini, il vuoto appare quasi to-tale. Su somaschi, barnabiti, teatini, oratoriani e sugli ordinibenedettini riformati come i trappisti o i foglianti non abbia-mo conoscenze approfondite, e i pochi dati a nostra disposi-zione continuano ad essere – tranne qualche rara eccezione –quelli emersi da ricerche ormai attempate, oppure limitate aspecifici contesti locali, oppure ancora dedicate a singole per-sonalità di questo o quell’ordine religioso. Così, per analizzare
190 paolo cozzo
77 A. PIAZZA, I frati e il convento di San Francesco di Pinerolo (1248-1400), Pinerolo,Parlar di storia, 1993.
78 M. SANGALLI, Le congregazioni religiose insegnanti in Italia in età moderna: nuove acquisizionie piste di ricerca, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1/2005, pp. 25-47.
la presenza dei barnabiti in Piemonte, aldilà di un recente con-tributo79, occorre ancora fare riferimento a Orazio Premoli 80 –infatti lo studio di Elena Bonora non si occupa degli insedia-menti di quest’ordine in area subalpina 81 – oppure soffermarsisu alcuni casi particolari 82, o ancora concentrasi su certuneeminenti figure dell’ordine, alla quali in passato sono statidedicati brevi “medaglioni” biografici 83.
Altrettanto carenti sono gli strumenti a disposizione deglistudiosi di altri ordini, che pure giocarono un ruolo tutt’altroche secondario nel Piemonte d’età moderna 84, non solo da unpunto di vista propriamente religioso, ma anche per le fortiimplicazioni (politiche, sociali, culturali, artistiche) legate alloro insediamento. Prendiamo l’esempio dei monaci cistercensi
storia religiosa 191
79 M.M. RAGAZZONI, Un contributo allo studio della Provincia piemontese-savoiarda dei barna-biti (1608-1982), in «Barnabiti studi», 20, 2003, pp. 239-329.
80 O. PREMOLI, Storia dei Barnabiti nel Cinquecento, Roma, Desclee e C., 1913; ID., Sto-ria dei Barnabiti nel Seicento, Roma, Industria Tipografica Romana, 1922; ID., Storia deiBarnabiti dal 1700 al 1825, Roma, Società Tipografica A. Manuzio, 1925.
81 E. BONORA, I conflitti della Controriforma. Santità e obbedienza nell’esperienza religiosa deiprimi barnabiti, Firenze, Le Lettere, 1998.
82 Il Real collegio e i barnabiti a Moncalieri: educazione e custodia delle memorie, a cura di C.Bertolotto, Torino, CELID, 1997; U. MODULO, I Barnabiti ad Asti, Roma, Don Bosco,1986.
83 G. COLOMBO, I Padri Isidoro Pentorio e Tobia Corona Barnabiti, e Carlo Emanuele I diSavoia. Memorie, Piacenza, Bertola, 1877; ID., Cenni biografici e lettere dei monsignori GiustoGuerin, Ottavio Ainari, Francesco e Giovanni Mercurino Arborio di Gattinara vescovi barnabiti, Tori-no, Tipografia Litografia San Giuseppe, 1877.
84 Per i somaschi cfr. A.M. STOPPIGLIA, Il collegio San Giorgio dei padri somaschi in NoviLigure, Genova, Scuola tipografica Derelitti, 1930; per i trappisti cfr. P. TORRIONE, Sto-ria della Trappa nei monti del Biellese, Biella, SATEB, 1939; per gli oratoriani cfr. Gli oratoriania Torino (1649-1999), Torino, Congregazione dell’oratorio di San Filippo Neri, 1999,oltre ai diversi approfondimenti (anche biografici) su Giovenale Ancina, fra cui P. DA-MILANO, Giovenale Ancina musicista filippino (1545-1604), Firenze, Olschki, 1956; S. MO-STACCIO, L’oratoriano Giovenale Ancina vescovo di Saluzzo e la riforma del clero, in Per il Cinquecentoreligioso italiano. Clero, cultura, società, atti del convegno internazionale di studi, Siena, 27-30giugno 2001, a cura di M. Sangalli, introduzione di A. Prosperi, Roma, Edizioni del-l’Ateneo, 2003, I, pp. 255-263; P. ROSSO, Gli studi universitari di Giovenale Ancina e i suoicontatti con la cultura medica piemontese, in «Bollettino della Società per gli Studi storici,archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 135 (2006), pp. 13-35; P. VI-SMARA, «In servizio di Dio e delle povere anime». Giovenale Ancina, vescovo del rinnovamento cattolico,ibid., pp. 37-53; M.F. MELLANO, Il processo per la beatificazione di G.G. Ancina e il card. Lam-bertini (prima metà del ’700), ibid., pp. 55-98; per i camaldolesi cfr. la Vita del venerabileAlessandro Ceva di Tommaso Chiuso.
riformati di San Benedetto, più noti come foglianti, dal nomedell’abbazia francese di Feuillant ove nacque questa congrega-zione istituita da Jean de la Barrière nella seconda metà delCinquecento. I foglianti, che in seguito al trasferimento del lo-ro fondatore a Roma innalzarono la loro casa madre a SantaPudenziana, ebbero una straordinaria diffusione nel ducatosabaudo. Piemonte e Savoia furono infatti le regioni europeecon la maggior densità di fondazioni foglianti. Tali insedia-menti furono spesso abbinati a spazi sacri di notevole rilievoeconomico e di alto valore simbolico: la Consolata di Torino,Staffarda, Novalesa, Santa Maria di Pinerolo, San Michele del-la Chiusa, Vicoforte, per citare solo i più celebri in ambito su-balpino. Tale destinazione fu ovviamente programmata dallaSede apostolica di comune accordo con la corte ducale, che nelconsolidamento di legami col nuovo ordine intravedeva un effi-cace strumento funzionale al nascente assolutismo sabaudo ealla sua politica interna, tesa al rafforzamento dell’autorità sta-tale e al parallelo indebolimento delle autonomie locali. Rico-noscere l’importanza assunta dai foglianti nel Piemonte mo-derno (dimostrata dalle brillanti carriere percorse da alcuni espo-nenti dell’ordine, come ad esempio l’abate di Vico GiovanniBona, una delle più interessante figure della letteratura religiosad’età barocca, promosso alla porpora cardinalizia nel 1669 85)consentirebbe, fra l’altro, di offrire un significativo apporto aldibattito storiografico che oggi si interroga sul ruolo giocatodagli ordini «nella costruzione delle identità delle differentinazioni»86. Ebbene, nonostante queste premesse, sui fogliantinon esiste (tranne qualche raro e sporadico accenno in operegenerali o su singole realtà locali) una specifica bibliografia,tale da mettere nel dovuto risalto il peso assunto da questacongregazione nella storia subalpina87.
192 paolo cozzo
85 Sull’attività letteraria del Bona, autore nel 1657 della Via compendii ad Deum, cfr. larecente edizione dell’opera curata da S. Stroppa, Firenze, Olschki, 2005.
86 M. CAFFIERO, Premessa cit., p. 11.87 Per ora il contributo più significativo è quello di P. BENOIST, La bure et le sceptre: la
Tale lacuna storiografica appare tanto più grave se messa inrelazione alla ricchezza del materiale documentario sugli ordinireligiosi a disposizione degli studiosi. Oltre alle fonti custoditenegli archivi romani e negli archivi diocesani, moltissimi docu-menti sono infatti conservati negli archivi pubblici, primo fratutti quello di Stato di Torino. Qui, la sezione Materie Ecclesia-stiche, comprende i 500 mazzi del fondo Abbazie, i 494 mazzidel fondo Regolari e i 224 mazzi del fondo Monache nei qualiconfluirono anche gli archivi delle corporazioni religiose sop-presse nel Settecento88. Bisognerebbe dunque partire da questoenorme patrimonio documentario (che per il solo Archivio diStato di Torino si compone di oltre 1200 mazzi), senza peral-tro dimenticare fonti analoghe conservate in altre sedi dislocatesull’intero territorio subalpino. Ad esempio: non si potrebbericostruire la storia della presenza camaldolese in Pie-montesenza tener conto di una fonte settecentesca – gli Annali dellaCongregazione Camaldolese Eremitica di Piemonte dall’anno 1612 si-noall’anno 1763 composti dal padre don Apollinare Chiomba camaldolese ere-mita di Piemonte – recentemente ritrovata e oggi conservata nellaBiblioteca storica della Provincia di Torino89.
Altrettanto utile sarebbe valorizzare i lavori di ricerca (tesidi dottorato e di laurea in primo luogo) che negli ultimi anni sisono occupati del mondo dei religiosi, spesso partendo da do-cumentazione inedita reperita a livello locale. Prendiamo come
storia religiosa 193
congregation des Feuillants dans l’affirmation des États et des pouvoirs princiers (vers 1560-vers 1660),Paris, Publications de la Sorbonne, 2006.
88 Un esempio è quello della certosa di Collegno, il cui fondo nell’Archivio diStato di Torino comprende anche documentazione relativa alle certose di Losa, Banda,Monte Benedetto e Mombracco (cfr. E. GIURIOLO, Le carte della certosa di Collegno pressol’Archivio di Stato di Torino, in Certose di montagna, certose di pianura: contesti territoriali e sviluppomonastico [Villar Focchiardo, Susa, Avigliana, Collegno, 13-16 luglio 2000], a cura di S.Chiaberto, Borgone di Susa, Melli, 2002, pp. 39-54).
89 Sulla fonte – due volumi manoscritti rispettivamente dedicati agli anni 1612-1681 e 1681-1763 – cfr. W. CANAVESIO, L’intervento alfieriano alla chiesa dell’eremo di Precetto.Una rilettura degli Annali di Apollinare Chiomba, in «Studi piemontesi», 2004, XXXIII/2,pp. 405-416. Una versione di questa cronaca è conservata nella Biblioteca Civica diCherasco, Memorie istoriche della Congregazione Camaldolese eremitica in Piemonte.
esempio Pinerolo: sugli insediamenti religiosi nella città e nelsuo territorio (in particolare gesuiti, carmelitani e monachevisitandine) nell’ultimo decennio le conoscenze hanno com-piuto notevoli passi in avanti grazie proprio alla scoperta dinuovi documenti, molti dei quali editati per la prima volta 90.Questi, come molti altri contributi, potrebbero fornire mate-riale prezioso per la redazione di una prima mappatura dellageografia religiosa del Piemonte, obiettivo e al tempo stessostrumento di una ricerca tesa a definire, per prima cosa, unquadro preciso dei luoghi pii (chiese, monasteri, conventi, san-tuari) presenti in area subalpina in età moderna; ma anche deisoggetti (parroci, preti, monaci, monache, frati, rettori) che intali luoghi vissero e operarono. La necessità di raccogliereinformazioni dettagliate sullo stato del clero si inserisce in unapiù ampia esigenza di un nuovo, riformulato approccio proso-pografico alla ricerca storica. La storia religiosa (ma il discorsoè valido anche per altri settori) non può infatti fare a meno didati personali, di notizie biografiche, di nozioni particolariinerenti la vita, la famiglia, la formazione, la carriera, la cultura,le vicissitudini degli uomini e delle donne di Chiesa. Non sitratta, è ovvio, di un invito a ridurre la ricerca ad una meraaccumulazione di nozioni quantitative, bensì di una constata-zione della necessità di impostare le riflessioni sul clero pie-montese a partire dall’analisi di informazioni frutto di un’ap-posita (e tutt’altro che semplice) indagine di carattere proso-
194 paolo cozzo
90 Per i gesuiti cfr. C. POVERO, Tre residenze dei Gesuiti nel Pinerolese durante il secoloXVIII: Pinerolo, Finestrelle e Cumiana, in Il Settecento religioso nel Pinerolese cit., pp. 227-299;per le visitandine cfr. E. BRUERA Gli inizi del Monastero della Visitazione di Pinerolo (1634 –1696): esperienze religiose femminili in età moderna (tesi di laurea, Università di Torino, Facoltàdi Lettere e Filosofia, a.a. 1997-1998, relatore prof. G. Cracco), i cui risultati sonostati condensati da EAD., Il Monastero della Visitazione, in Il Settecento religioso nel Pinerolese cit.,pp. 301-337; per i carmelitani cfr. G. AIROLDI, Prime ricerche sul santuario di Maria VergineSantissima del Monte Carmelo presso Pinerolo, tesi di laurea, Università di Torino, Facoltà diScienze Politiche, a.a. 1999/2000, relatore prof. G. Cracco, interessante soprattuttoper l’edizione del settecentesco Liber rerum notabilium et decretorum pro hoc conventu SancteMariae Gratiarum Carmeli Colletti.
pografico, i cui attuali strumenti – si pensi ai vari «archivi bio-grafici»91 – appaiono ormai inadeguati.
c) Roma e il Piemonte: politica, diplomazia, cultura
Quello delle relazioni fra lo Stato sabaudo e la Sede apo-stolica è risultato essere uno dei temi più dibattuti dalla storio-grafia piemontese sin dai tempi di Pier Carlo Boggio e di Do-menico Carutti 92, e poi ancora fra tardo Ottocento e primoNovecento quando l’interesse per gli aspetti politico-diploma-tici dei rapporti fra papato e corte torinese si manifestò attra-verso nuovi contributi 93.
Negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, l’avvio –da parte dell’Istituto storico per l’età moderna – del grande pro-getto di edizione del materiale documentario inerente le nun-ziature apostoliche negli Stati italiani sembrò aprire la strada,anche per il Piemonte, ad una sistematica acquisizione dellefonti vaticane. Nel 1960 venne pubblicato il primo – e desti-nato ad essere l’unico – volume della collana Nunziature di Sa-voia. Curato da Fausto Fonzi, questo lavoro, che presentava l’e-dizione del carteggio dei rappresentanti pontifici residenti aTorino fra il 1560 e il 1573, sembrava giustificare e al tempostesso alimentare il notevole interesse cresciuto attorno alla fi-gura del nunzio di Savoia, il quale agli occhi degli studiosi ap-pariva «a volte come un diplomatico, a volte come rappresen-
storia religiosa 195
91 Il riferimento è a E. BELLONE, Archivio biografico piemontese, I-VI [s.l., s.n.t., 1990],dattiloscritto ed elaborato elettronico conservato presso la biblioteca storica dellaProvincia di Torino.
92 Cfr. P.C. BOGGIO, La Chiesa e lo Stato in Piemonte. Sposizione storico-critica dei rapporti frala Santa Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854 compilata su documenti inediti, I-II, Torino,S. Franco, 1854; D. CARUTTI, Storia della diplomazia della corte di Savoia (1494-1773), I-IV,Torino, S. Franco, 1875-1880.
93 Ad esempio la pubblicazione, a cura di F. Pagnotti, di una Relazione di una nunzia-tura in Savoia (1624-1627), scritta da Bernardino Campello uditore del nunzio a Torino, in «Ar-chivio della Regia Società Romana di Storia Patria», XVI (1893), pp. 447-500, e delle“Instrutioni” di Carlo Emanuele I agli inviati sabaudi in Roma con lettere e brevi al duca dei ponteficisuoi contemporanei, a cura di E. Passamonti in Carlo Emanuele I. Miscellanea, I, Torino,Miglietta, 1930, pp. 167-328.
tante del papa di fronte al clero e ai fedeli dei domini sabaudi,con funzioni di controllo e di direzione su vescovi ed inquisi-tori»94. A fronte di una così «spiccata vitalità politica» dellanunziatura di Savoia, i cui titolari – più che altrove – «furonosoggetti politici attivi nella valutazione di un arretramento del-le pretese giurisdizionaliste e di una sostanziale collaborazio-ne»95, le ricerche hanno segnato il passo. Arenatosi il progettoavviato dal Fonzi, non si sono più avute edizioni di consistenticarteggi diplomatici, e neppure approfonditi studi su significa-tive figure di nunzi. Basti pensare che su protagonisti della di-plomazia pontificia in servizio in Piemonte, caratterizzati daun grande spessore politico e culturale e da una rinomanza dilivello europeo, non esistono specifiche ricerche, né tanto menoaggiornate edizioni di carteggi. È forse anche per questo mo-tivo che – è stato giustamente lamentato96 – la nunziatura diSavoia è stata in gran parte «dimenticata» dagli approcci com-parativi sulle figure della diplomazia italiana di età mo-derna 97.
Una prima e parziale risposta a questo vuoto è venuta dallastoriografia tedesca, dove recentemente sono maturate interes-santi indagini volte a studiare nunzi e nunziature quali osserva-tori privilegiati della politica (interna e internazionale) degliStati di età moderna. Si veda, ad esempio, la corposa ricerca suirapporti fra Roma e Torino all’epoca di papa Borghese 98, che,
196 paolo cozzo
94 R. CIASCA, Le nunziature pontificie negli Stati italiani, in «Economia e storia», a. VI,fasc. 1 [1959], pp. 48-63, in part. pp. 56-57.
95 S. ANDRETTA, Le Nunziature in Italia nei secoli XVI e XVII, in Kurie und Politik. Standund Perspektiven der Nuntiaturberichtsforchung, herausgegeben von A. Koller, Tübingen, Nie-meyer, 1998, pp. 17-34, in part. p. 22.
96 G. GUALDO, La nunziatura apostolica di Venezia cit.97 Si pensi, ad esempio, a Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in età moderna, a
cura di D. Frigo («Cheiron» XV, 30, 1998).98 T. MÖRSCHEL, Buona amicitia? Die römisch-savoyischen Beziehungen unter Paul V.
(1605-1621). Studien zur frühneuzeitlichen Mikropolitik in Italien, Mainz, von Zabern, 2002.Sempre a proposito della diplomazia pontificia ai tempi di Paolo V, assai interessante(anche per i molti riferimenti al Piemonte sabaudo) risulta essere l’imponente studiocurato da S. Giordano, Le Istruzioni generali di Paolo Vai diplomatici pontifici (1605-1621), I-
sin dal titolo, adotta un’ottica problematica per guardare aglisviluppi della politica ducale e pontificia agli albori del Sei-cento. Nell’ampio scenario tracciato dall’autore un personag-gio di spicco della corte sabauda – il cardinale Maurizio diSavoia – è stato assunto quale figura particolarmente significa-tiva per illustrare e valutare il peso e le caratteristiche della pre-senza piemontese nella Roma di Paolo V 99. Tale interesse nonpuò stupire se si pensa che il cardinale Maurizio, figura digrande mecenate e di ricco collezionista, pochi anni prima eragià stato oggetto di un ampio studio da parte di uno storicodell’arte elvetico100.
L’approccio biografico è sembrato riscuotere un certo suc-cesso negli ultimi anni. Si pensi, per fare solo qualche esempio,alle indagini su Marc’Antonio Bobba, Pier Francesco e GuidoFerrero101, allo studio sull’abate Alessandro Scaglia di Verrua,ambasciatore sabaudo a Londra 102, alla monografia su Giovan-ni Ercole Gromo di Ternengo, un abate biellese la cui espe-rienza (umana, politica e religiosa) si svolse fra il ducato sa-baudo delle due Madame Reali e l’Urbe di fine Seicento 103, ainuovi approfondimenti su Carlo Vincenzo Maria Ferrero, pri-mo cardinale di Corona del Regno di Sardegna 104.
storia religiosa 197
III, Tübingen, Niemeyer, 2003, che si affianca a precedenti ricerche dedicate ai nunzi diClemente VIII e Gregorio XV (Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII für die Nuntien undLegaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592-1605, bearb. von K. Jaitner, Tübingen, Nie-meyer, 1984; Hauptinstruktionen Gregors XV für di Nuntien und Legatenan an den europäischenFürstenhöfen 1621-1623, bearb. von K. Jaitner, Tübingen, Niemeyer, 1984).
99 T. MÖRSCHEL, Il cardinale Maurizio di Savoia e la presenza sabauda a Roma all’inizio delXVII secolo, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2/2001, pp. 147-178.
100 M. OBERLI, “Magnificentia Principis”: das Mäzenatentum des Prinzen und Kardinals Mau-rizio von Savoyen (1593-1657), Weimar, GVerlag und Datenbank fur Geisteswissen-schaften, 1999.
101 P. MERLIN, I cardinali sabaudi nell’età di Emanuele Filiberto (1559-1580), in La corte diRoma tra Cinque e Seicento «teatro» della politica europea, a cura di G. Signorotto e M. A. Vi-sceglia, Roma, Bulzoni, 1998, pp. 299-321.
102 T. OSBORNE, Dynasty and Diplomacy in the Court of Savoy. Political Culture and the ThirtyYears’War, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
103 G. DELL’ORO, L’abate conte Giovanni Ercole Gromo tra il Piemonte sabaudo e la Roma tardobarocca (1645-1706), Milano, Unicopli, 2001.
104 P. COZZO, Una porpora “a lustro della real corona”. Carlo Vincenzo Maria Ferrero (1682-
Tutte queste indagini rappresentano – anche metodologica-mente – un importante tentativo di superamento di quei tradi-zionali confini storiografici che in passato troppo spesso han-no rigidamente chiuso – fino a renderli, in alcuni casi, imper-meabili – ambiti di ricerca che oggi si presentano invece pro-fondamente legati e interconnessi. Sembra ormai assodato chegli studi sulla storia delle relazioni politiche e diplomatiche fraTorino e Roma non possono prescindere da quelli sulle rela-zioni artistico-culturali e religiose fra la capitale sabauda el’Urbe, così come appare ormai arduo ricostruire le vicendeartistiche intercorse fra Torino e Roma senza leggerle alla lucedel loro specifico contesto politico. In questa prospettiva sisono mosse, ad esempio, innovative ricerche sulla dimensioneartistica della corte di Carlo Emanuele I nelle quali il collezio-nismo del duca è stato indagato anche grazie ad un attentospoglio del carteggio diplomatico fra le due corti 105. Allo stes-so modo, chi si vuole occupare degli spazi sacri e della vita reli-giosa della dinastia sabauda può trovare nella corrispondenzapolitico-diplomatica fra i due Stati un fertile terreno di inda-gine 106.
In quest’ottica si dovrebbe dunque muovere un progetto diricerca capace di cogliere le numerose connessioni e le variegatearticolazioni del rapporto fra Roma e il Piemonte, tanto nellefonti edite quanto in quelle inedite, conservate sia negli ArchiviVaticani (il già citato fondo Segreteria di Stato, Savoia) sia in quellipiemontesi, in primo luogo nei 293 mazzi del fondo Materieecclesiastiche per categorie conservato nella sezione Materie ecclesiastiche,
198 paolo cozzo
1742) primo cardinale di corona della monarchia sabauda, in Nobiltà e Stato in Piemonte. I Ferrero fraQuattro e Ottocento, atti del convegno di studi, Torino-Mondovì 2-4 ottobre 2001, a curadi A. Merlotti, Torino, Zamorani, 2003, pp. 295-320.
105 Si vedano, a tal proposito, i saggi contenuti in Le collezioni di Carlo Emanuele I, acura di G. Romano, Torino, Fondazione CRT, 1995.
106 Mi permetto di rinviare a P. COZZO, “Regina Montis Regalis”. Il santuario di Mondovìda devozione locale a tempio sabaudo. Con edizione delle «Memorie intorno alla SS. Vergine di Vico»(1595-1601), Roma, Viella, 2002.
nei 428 mazzi di corrispondenza degli ambasciatori sabaudi aRoma conservati nel fondo Lettere Ministri della sezione MateriePolitiche per Rapporto all’Estero dell’Archivio di Stato di Torino. Sitratta di un enorme materiale documentario, noto agli studiosi(si pensi alla fortuna avuta dall’ottocentesca Istoria delle relazionidella reale Casa di Savoia colla corte di Roma sino all’anno 1742 dal cano-nico della metropolitana di Torino Ottavio Moreno 107) ma sinora utiliz-zato solamente in minima parte. Occorrerebbe dunque ripren-dere seriamente in considerazione l’ipotesi di una edizione si-stematica dei carteggi diplomatici relativi a quei nunzi o aquelle epoche ritenute particolarmente significative per la sto-ria della relazioni fra le due corti, sfruttando – laddove possi-bile – lavori di edizione già esistenti, e impostando un ampioprogetto di pubblicazione dei carteggi inediti 108.
storia religiosa 199
107 Archivio di Stato di Torino, Materie Ecclesiastiche, cat. I, m. 40-41. Lo stesso autoredell’Istoria, Ottavio Moreno, meriterebbe di essere studiato. Questo erudito ecclesiastico(1777-1852), fratello del vescovo di Ivrea Luigi Moreno, percorse infatti un’interes-sante carriera nella vita politica del regno sardo: economo generale presso l’Economatoregio e apostolico dei vescovati e abbazie vacanti, nel 1845 venne nominato commen-datore dell’Ordine mauriziano e nel 1849 senatore del regno. La sua opera, rimastamanoscritta (ne venne trascritta una succinta versione, oggi conservata nella BibliotecaReale di Torino) è un interessante esempio di storiografia ecclesiastica a servizio del-l’autorità civile. Pare infatti che fu Carlo Alberto a commissionare a Moreno il compitodi redigere una dettagliata relazione storica, in forma annalistica, dei rapporti diploma-tici fra lo Stato sabaudo e la Sede apostolica. Per la dovizia di informazioni desunte dafonti conservate nei regi archivi (nei quali Moreno lavorò per diversi anni come appli-cato), l’opera si presenta come una vera e propria miniera di documenti (molti dei qualitrascritti dall’autore) indispensabili per ricostruire la storia delle relazioni fra Torino eRoma. Su Moreno e la sua opera cfr. A. MERLOTTI, Negli archivi del re. La lettura negata delleopere di Giannone nel Piemonte sabaudo (1748-1848), in «Rivista storica italiana», CVII(1995), fasc. 2, pp. 332-385 (in particolare pp. 366-375); G. RICUPERATI, La scrittura diun ministro. La Relazione sulle negoziazioni con la corte di Roma di Carlo Francesco Vincenzo Ferrero, mar-chese d’Ormea, in Nobiltà e Stato in Piemonte cit., pp. 207-229, in particolare pp. 207-208.
108 È il caso, per fare solo un esempio, dell’interessante carteggio del nunzio SantaCroce, attivo alla corte sabauda fra il 1577 e il 1580, oggetto negli anni Settanta diun’ampia tesi di laurea ( R. LIVRAGHI - A. BENANTI, Nunziatura di Savoia [1577-1580],tesi di laurea, Università di Torino, relatore A. Erba, a.a. 1976-1977). Sul Santa Crocecfr. A. KOLLER, Diplomazia e vita quotidiana. Il nunzio Ottavio Santacroce e la sua familia, in Peril Cinquecento religioso italiano cit., pp. 635-648.
A tal proposito, assai arduo appare indicare delle priorità.Certamente alcune figure della diplomazia pontificia residentea Torino e di quella sabauda di stanza a Roma rivestono un’im-portanza tale da rendere auspicabile e urgente un significativoampliamento delle nostre conoscenze su di esse. Citiamo, an-che qui a titolo di esempio, il cardinale Vincenzo Lauro (1523-1592), vescovo di Mondovì, inviato pontificio in Francia,Scozia, Polonia e nunzio in Savoia in due distinte fasi (1568-1573 e 1580-1585). Su questo interessante personaggio, cheebbe modo di confrontarsi con la politica interna ed estera didue principi sabaudi, Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I,non esistono studi recenti; inoltre, il materiale documentarioedito sinora riguarda solamente la sua prima nunziatura, non laseconda, che pure ebbe notevole peso nell’evoluzione degli as-setti interni e internazionali del ducato.
Compiendo un salto in avanti di quasi due secoli, fra lemolte figure dei nunzi apostolici residenti a Torino particolar-mente significativa e poco studiata appare quella di LudovicoMerlini (?-1762), protagonista – insieme ad altri attori dellacuria pontificia e della diplomazia sabauda, dal cardinale Ales-sandro Albani al conte Balbis di Rivera – di quella lunga sta-gione delle relazioni fra Sede apostolica e regno sardo apertasicon il concordato fra Benedetto XIV e Carlo Emanuele III, eterminata con la chiusura della nunziatura di Torino a causadella mancata promozione cardinalizia dello stesso Merlini.
Per ricostruire la biografia e l’operato di queste e di moltealtre figure della diplomazia occorre far riferimento ad unvasto materiale documentario che, pur apparendo a prima vistalimitato alla sfera politico-diplomatica, consente invece di apri-re ampi squarci non solo sulla complessa realtà dei rapporti frale due corti, ma anche sulle ricadute sociali e culturali nell’Ur-be e in Piemonte. Un esempio particolarmente significativo èquello dell’importanza attribuita dalla corte di Torino e daisuoi rappresentanti a Roma alla diffusione dei culti subalpini
200 paolo cozzo
(in primo luogo quelli della dinastia sabauda) nella città pa-pale: si tratta di una vicenda che interessa tutto l’arco cronolo-gico di nostro interesse e che presenta notevoli riflessi in am-bito letterario, artistico e religioso.
I Savoia, tramite i loro agenti presso la corte pontifica, sisforzarono di promuovere nell’Urbe i culti più rappresentatividei loro domini, primi fra tutti quelli della Sindone, del BeatoAmedeo e di San Maurizio. Questo tentativo non era finaliz-zato solo alla celebrazione delle glorie familiari, ma anche alrafforzamento del prestigio statale in una città da tutti consi-derata come «teatro del mondo». In questo teatro molti attorigiocavano ruoli competitivi: in particolare i principi della peni-sola si confrontavano quotidianamente attraverso le armi dellapropaganda e del cerimoniale. I Savoia, affacciatisi tardi, rispet-to alle altre dinastie italiane, sulla scena romana, cercarono diricuperare il tempo perduto « investendo» massicciamente sututte quelle manifestazioni devozionali utili ad accrescere la re-putazione della stirpe e del ducato nei confronti della curia edelle altre dinastie rappresentate presso la Sede apostolica.
Con queste premesse si può capire meglio la grande atten-zione rivolta dagli ambasciatori ducali a Roma ai risvolti pro-pagandistici di cerimonie e funzioni religiose pubbliche incen-trate sulle devozioni sabaude, nonché l’aperto sostegno assicu-rato dalla corte di Torino alla fondazione (a metà Cinquecen-to) della chiesa nazionale e della confraternita dei sudditi pie-montesi e savoiardi residenti a Roma, non casualmente intito-lata al Santo Sudario. La chiesa e la confraternita, assurti a verie propri centri di promozione dei culti sabaudi e di diffusionedella cultura piemontese nell’Urbe, attendono ancora di esseredebitamente studiate, stante anche la ricchezza del materialedocumentario – oltre 300 unità archivistiche, contenenti fontiin gran parte inedite – conservato a Roma109.
storia religiosa 201
109 L’archivio, conservato presso la sede dell’Ordinario Palatino, contiene materialedocumentario in buono stato di conservazione ma in disordine. Fra le 320 unità che lo
La promozione dei culti dinastici non può essere compresase non inserendola nel più ampio progetto di rafforzamentodella presenza sabauda a Roma, nella curia e in particolare nelSacro Collegio. A questo progetto i Savoia lavorarono sin daquando, con Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I, il loroducato assunse un ruolo di primo piano nel panorama politicoitaliano ed europeo. Torino percepì subito che l’esiguo numerodi sedi episcopali nei domini ducali, la scarsità di sudditi sa-baudi nella curia, la pressoché costante assenza di esponentidella stirpe all’interno del Sacro Collegio erano tutti fattoriche rischiavano di limitare la corsa del ducato verso l’egemoniain Italia.
Di ciò sembra avere una lucida percezione il vescovo diFossano Agassino Solaro di Moretta, il quale nel 1622 (annoin cui il territorio del ducato sabaudo veniva suddiviso in do-
202 paolo cozzo
compongono, vi sono gli atti dell’arciconfraternita, dell’ufficio del cappellano maggioredella Presidenza della Repubblica, e le carte personali dei cappellani. Si trascrive qui diseguito l’inventario dell’archivio, tratto dal Repertorio degli archivi delle confraternite romane, inStoriografia e archivi delle confraternite romane, («Ricerche per la storia religiosa di Roma», VI,1985), a cura di L. Fiorani, pp. 175-413, in part. pp. 403-404. Atti ufficiali: Copia dellabolla di istituzione di Clemente VIII (2 giugno 1597), Aggregazioni di confraternite;Visita Apostolica (1632-1932). Statuti: 1643 (copia ottocentesca manoscritta). Chiesa:Memorie storiche della chiesa (secoli XVII-XIX); Messe (1720-1960) 12 voll.; Inven-tari della chiesa (1598-1953); Giornali, appunti, piante della chiesa (secc. XIX-XX) 8voll.; Copie di atti di proprietà della chiesa (1597-1827); Privilegi e concessioni (secc.XVIII-XX); Cappelle Palatine (fabbriche, messe, affari diversi delle cappelle in Italia,secc. XVIII-XX) 37 voll. Patrimonio: Locazioni (1545-1680); Istrumenti e testamenti(1597-1847). Amministrazione e contabilità: Liti diverse (1589-1833); Entrate e uscite(1597-1837) 5 voll.; Mandati (1597-1813) 4 voll.; Giustificazioni (1598-1847) 22voll.; Contabilità (1676-1855) 12 voll.; Libri mastri (1751-1836) 2 voll.; Rubricelladel libro mastro (s.d.); Amministrazione dell’ufficio del cappellano maggiore (secc.XIX-XX) 116 voll.; Resoconti e spese per le regie cappelle (secc. XIX-XX) 17 voll.Varie: Inventario dell’archivio (1876); Indice delle scritture d’archivio della chiesa(1726); Reale Casa di Savoia (battesimi, matrimoni, funerali funzioni ed altro, 1750-XX sec.) 41 voll.; Visite di sovrani d’Italia al papa dopo la conciliazione (XIX sec.) 2voll.; Beatificazioni nazionali e della Casa Savoia (XIX-XX secc.) 4 voll. Archivi privati:Anzino (lettere, carteggio Rosmini, corrispondenza, XIX-XX secc.) 5 voll.; Niti (cor-rispondenza, progetto di conciliazione con la Stato italiano, XIX-XX secc.) 6 voll.;Beccaria (appunti di teologia e di riordinamento archivio del Sudario, carteggi, cartevarie, secc. XIX-XX) 13 voll; Stellardi (lettere di cardinali e vescovi, studio per un col-legio di avvocati, vertenze di privati, istanze, XIX sec.) 13 voll.
dici province), suggeriva a Carlo Emanuele di richiedere allaSede apostolica l’erezione di sei nuovi vescovadi, in modo taleda far coincidere i confini politico-amministrativi delle pro-vince appena istituite con quelli ecclesiastico-religiosi dellediocesi piemontesi. L’istituzione di nuove cattedre episcopaliavrebbe garantito un miglior controllo del territorio statale, esarebbe stato percepito come segno del prestigio sabaudo. Conun maggior numero di diocesi Carlo Emanuele avrebbe infattidimostrato che i suoi domini non erano inferiori ad un regno«per numero di città, per moltitudine de’ popoli, né per gran-deza», come si poteva facilmente verificare con l’esempio delregno di Napoli, che traeva più splendore «dal numero dellecittà e de’ vescovi che da altra cosa». E poi, di tutti quei vescovi– continuava il consigliere del duca – «qualch’uno ne riuscirà,con i favori et aiuto suoi, cardinale et forsi papa, la qual cosaapportarebbe utile grande e riputatione al Stato» 110.
Questo processo di penetrazione all’interno della curia pon-tificia, che sembra concretizzarsi nella breve ma assai significa-tiva esperienza cardinalizia del quartogenito di Carlo Ema-nuele, Maurizio di Savoia, troverà nel corso del XVII secolo unbrusco arresto. Basti pensare che dopo la rinuncia di Mau-rizioalla porpora (1642), più nessun esponente della casa du-caleottenne il cappello rosso, e solamente tre furono i sudditi sa-baudi che divennero cardinali: Francesco Adriano Ceva (1585-1655), nel 1643, Giovanni Bona (1609-1674), nel 1669, CarloTommaso Maillard de Tournon (1668-1710), nel 1707.
Nel Settecento la distensione dei rapporti determinata dallapolitica concordataria favorì l’incremento della presenza pie-montese a Roma, in special modo nella curia pontificia. Lanomina del vescovo di Vercelli (il domenicano Carlo Vincenzo
storia religiosa 203
110 Archivio di Stato di Torino, Corte, Materie ecclesiastiche, cat. 2, Materia benefiziaria,fasc. 7, Proposizioni fatte a Sua Altezza Reale dal cavalier di Moretta per l’erezione de’ vescovadi inCuneo, Pinerolo, Susa, Ceva, Biella, Savigliano (1622), f. 1r. Il documento – su cui si era sof-fermato G.G. MERLO, Le circoscrizioni cit., – è ora integralmente pubblicato da P. COZZO,La geografia celeste cit., pp. 300-304.
Maria Ferrero) a primo cardinale di Corona della monarchiasabauda preparò il terreno, per così dire, ad altre significativepromozioni cardinalizie: quelle di Vittorio Amedeo Delle Lan-ze, di Giovanni Battista Roero di Pralormo, di Carlo AlbertoGuidobono Cavalchini, di Enrichetto Virginio Natta. Per rico-struire le carriere di queste personalità in una prospettivacapace di valorizzarne insieme alle implicazioni politiche e di-plomatiche, anche le ricadute di carattere artistico e culturale,sarebbe necessario, innanzitutto, lo spoglio del materiale docu-mentario conservato a Roma (oltre al già citati fondi Segreteria diStato, Savoia; Archivio della Nunziatura di Torino nell’Archivio SegretoVaticano, i fondi Congregazione dei Vescovi e Regolari, Dataria Aposto-lica, Segreteria di Stato, Cardinali, Segreteria di Stato, Principi; da segna-lare, inoltre, l’ampio fondo Patetta della Biblioteca ApostolicaVaticana, e alcuni fondi della Biblioteca Angelica e della Bi-blioteca Vallicelliana).
Un ulteriore elemento, fra le tracce di ricerca sull’insiemedei rapporti fra Sede apostolica e Stato sabaudo, concerne ilgiurisdizionalismo, che è stato, anche in anni recenti, uno deitemi più trattati e dibattuti dalla storiografia piemontese 111.Ne parliamo per ultimo non per sminuirne l’importanza, maper mettere in evidenza, sulla scorta delle considerazioni fattein precedenza, alcuni aspetti rimasti sinora parzialmente inombra. In particolare, il tema sul quale molto rimane da dire èquello dei feudi ecclesiastici in terra piemontese, vere e proprieisole giurisdizionali all’interno dei domini sabaudi. Mentre sulprincipato di Crevacuore e Masserano, nel Vercellese, (due feu-di pontifici passati sotto la sovranità sabauda solamente nel1767) l’attenzione degli studiosi è viva ormai da alcuni anni 112,
204 paolo cozzo
111 Si vedano ad esempio fra gli ultimi lavori: E. MONGIANO, Gli effetti civili dei votireligiosi tra “usi gallicani” e “usi d’Italia”, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», 74-75(2001-2002), pp. 79-131; F. GORIA, Una controversia fra Stato e Chiesa nel Piemonte delXVIII secolo: la prevostura di Oulx, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», 76 (2003),pp. 291-338.
112 V. BARALE, Il principato di Masserano e il marchesato di Crevacuore, con una nota intro-duttiva di P. Torrione sulla protostoria del Biellese orientale, Biella, Associazione cultu-
su quelli dell’Astigiano molto ancora rimane da sapere. Leterre di Govone, Magliano, Castellinaldo, Castagnito, Vezza,Piobesi, Monticello, Santa Vittoria, Pocapaglia, Montaldo,Monteu Roero, Santo Stefano, Cellarengo, Corveglia, Piea,Cortanze e Cossombrato rimasero sino al XVIII secolo sottola giurisdizione spirituale e temporale del vescovo di Asti. Ciòcomportò periodiche frizioni fra il potere sabaudo – impe-gnato in un’opera di progressiva e sistematica omologazionepolitica e amministrativa dell’intero territorio statale –, il ve-scovado di Asti e la curia romana – ostinatamente decisi amantenere diritti e prerogative sui feudi ecclesiastici – sullequali – com’è stato recentemente ricordato 113 – occorrerebbeindagare a fondo.
d) Geografia sacra, geografia politica e mappatura della dissidenza religiosa
Ora che molte discipline afferenti alla storia religiosa (comela storia delle devozioni e l’agiografia), dopo aver privilegiatomarcatamente il tardo antico e il Medioevo 114, sembrano final-mente aver “scoperto” anche l’età moderna e i suoi protagoni-sti istituzionali (le città, gli Stati, i principi e le corti) 115, ap-
storia religiosa 205
rale Bugella, 1987; L. CAPUANO, Un principato conteso. Masserano tra Stato Pontificio, Spagna eDucato sabaudo nel primo Seicento, in «Cheiron», n. 33, pp. 199-242.
113 Ad esempio in occasione dell’incontro di studi I Roero fra medioevo ed età moderna,Asti, 9 giugno 2005, promosso dal Centro Studi sui Lombardi e sul credito nelMedioevo. Nell’incontro è stata sottolineata una diffusa carenza di ricerche, anche acarattere locale, sull’identità politica e giurisdizionale dei feudi vescovili dell’Astigiano(una parziale eccezione è rappresentata dalle riflessioni sul peso giocato dalla questionedei feudi nelle relazioni fra le corti di Torino e Roma nel primo Seicento, di T. MÖR-SCHEL, Buona amicitia? cit., pp. 358-372).
114 Una considerazione storiografica sul ritardo con cui l’agiografia ha scopertol’età moderna e contemporanea è venuta da F. SCORZA BARCELLONA, Dal tardo anticoall’età contemporanea e ritorno: percorsi scientifici e didattici della storiografia agiografica, in Santità, culti,agiografia. Temi e prospettive, a cura di S. Boesch Gajano, Roma, Viella, 1997, pp. 15-26.
115 D. JULIA, Pour une géographie européenne du pèlerinage à l’époque moderne et contemporaine, inPèlerins et pèlerinages dans l’Europe moderne, sous la direction de Ph. Boutry, D. Julia, Rome,École Française de Rome, 2000, pp. 3-126; Europa Sacra. Raccolte agiografiche e identità politi-che in Europa fra Medioevo ed Età moderna, a cura di S. Boesch Gajano, R. Michetti, Roma,Carocci, 2002; M. GOTOR, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2004;
pare possibile leggere in un’ottica nuova – per certi versi ana-loga a quella già adottata per analizzare gli intrecci fra politicae religione in età medievale 116 – anche la storia degli Stati sa-baudi nei secoli XVI-XVIII.
Le dinamiche religiose, intese non solo come risvolti, più omeno fortuiti, di eventi socio-politici, bensì come fattori stra-tegici accuratamente pianificati e finalizzati, possono infatti ri-velarsi utili paradigmi per la comprensione di complessi itine-rari storici, come ad esempio il progressivo consolidamentodell’autorità centrale sui poteri periferici. La religione entrainfatti nel processo di affermazione del prestigio statale e dina-stico nella misura in cui diventa oggetto di scontro – simbo-lico, ma non solo – fra centro e periferia. Le devozioni civichee territoriali, attorno alle quali da sempre si era compattatol’orgoglio particolaristico, furono il primo obiettivo della poli-tica sabauda. Conquistare i culti locali – il cui vigore, tutt’altroche assopito in età moderna, andrebbe analizzato a fondo, spe-cie in un’ottica di continuità/discontinuità con la tradizionemedievale –, piegarli alla logica dello Stato e declinarli nell’i-dioma sacrale della dinastia significava infatti colpire al cuore
206 paolo cozzo
S. DITCHFIELD, Il mondo della Riforma e della Controriforma, in Storia della santità nel cristiane-simo occidentale, Roma, Viella, 2005, pp. 261-329; R. von FRIEDENBURG, Religiosità e conce-zione del ruolo istituzionale. Filippo d’Assia e Maurizio d’Assia-Kassel, in La società dei principinell’Europa moderna (secoli XVI-XVII), a cura di C. Dipper e M. Rosa, Bologna, il Mulino,2005, pp. 321-339; J.L. BARREIRO RIVAS, Mille anni di pellegrinaggio a Santiago: sopravvivenzae trasformazione di un luogo sacralizzato, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XLII(2006), n. 3, pp. 573-590.
116 Cfr. A.M. ORSELLI, L’immaginario religioso della città medievale, Ravenna, M. Lapucci,Ed. del girasole, 1985; La religion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam),actes du colloque organisé par le Centre de recherche «Histoire sociale et culturelle del’Occident, XII-XVIII siècle» de l’Université de Paris X Nanterre et l’Institut universi-taire de France (Nanterre, 21-23 juin 1993), sous la direction de A. Vauchez, Rome,École Française de Rome, 1995; P. GOLINELLI, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano,Bologna, CLUEB, 1996; Il santo patrono e la città. San Benedetto il Moro: culti, devozioni, strategiedi età moderna, a cura di G. Fiume, Venezia, Marsilio, 2000; M.J. DEL RIO BARREDO,Madrid, Urbs regia cit.; G. CHITTOLINI, Società urbana, Chiesa cittadina e religione in Italia alla finedel ’400, in «Società e storia», 22, 2000, pp. 1-17; A. BENVENUTI, La civiltà urbana, inStoria della santità nel cristianesimo occidentale cit., pp. 157-221; G. CRACCO, Santuari e pellegri-naggi nella storia cristiana, in Il Cristianesimo. Grande atlante cit., pp. 880-907.
lo spirito autonomistico delle città, privarle delle loro tradizio-nali competenze sulla sfera religiosa, far loro perdere uno deipiù importanti attributi di identità.
Torino, divenuta baricentro dei domini ducali e sede dellacorte, fu la prima realtà urbana a subire compiutamente questoprocesso di progressivo assorbimento di simboli e spazi sacri,da parte e per iniziativa della dinastia sabauda. In pochi de-cenni culti e luoghi pii, che nei secoli avevano definito un’arti-colata topografia devozionale urbana, furono sottratti al patri-monio celeste della città e ascritti a quello della stirpe ducale, esotto questa nuova forma promossi e rilanciati in tutti idomini. La svolta avvenne con il trasferimento della Sindoneda Chambéry a Torino, che fece della città il teatro della sacra-lità sabauda e dei suoi rituali, segnando profondamente l’as-setto (anche urbanistico) della nuova capitale. Poi il processocoinvolse l’intero ducato, specialmente quelle terre che, permotivi diversi, apparivano più lontane (e più ostili) al centrali-smo statale. Le terrae novae e le città di antica tradizione comu-nale furono infatti le realtà sulle quali i Savoia concentrarono iloro sforzi di conquista, attraverso la sistematica opera di ap-propriazione e di riconversione di quelle espressioni di pietàcollettiva che erano tipiche della periferia. La consacrazionedella capitale e dei domini periferici alla religione della corte,accompagnò (e al tempo stesso celebrò) il processo di conqui-sta dell’intero territorio statale.
Sottomesso il Piemonte, i Savoia rivolsero poi il loro sguar-do verso nuove terre, da conquistare con la potenza delle armi,con l’abilità della diplomazia, con la forza della religione. Nona caso le frontiere con gli Stati italiani (quella orientale, cheseparava il Piemonte dalla fertile Val Padana e dalla ricca pia-nura lombarda, e quella meridionale, che lo divideva dal mare)divennero ben presto gli avamposti di una pietà dinastica chetendeva a proiettarsi fuori, attraverso una fitta rete di santuari,sacri monti e patronati familiari. Fu anche grazie a questo com-
storia religiosa 207
plesso sistema cultuale, sapientemente irradiato e propaganda-to, che i Savoia riuscirono a entrare in competizione con altrecasate d’Europa, che ormai da secoli avevano imparato a trat-tare la religione non solo come instrumentum regni, ma soprat-tutto come modus vivendi di una multiforme e poliglotta societàdei principi, dove l’unico linguaggio veramente condiviso sem-brava essere quello della devozione.
Questa prospettiva (recentemente elaborata per i ducati diEmanuele Filiberto e Carlo Emanuele I 117) potrebbe essere im-piegata per analizzare logiche e dinamiche di sviluppo di spazisacri e luoghi pii in tutto il territorio piemontese (conside-rando dunque anche le realtà politicamente non sabaude, cioèil Monferrato, il Novarese e le altre terre appartenute allaLombardia spagnola e austriaca) e su di un arco temporaleesteso sino al XVIII secolo. Gli strumenti per questo appro-fondimento risultano assai diversificati: non solo quelli tradi-zionali (le fonti archivistiche diocesane, che per altro riman-gono ancora in gran parte da esplorare), ma anche quelli piùinnovativi, come, ad esempio, i dati emersi dal recente censi-mento dei santuari cristiani d’Italia (un’iniziativa promossadall’École française de Rome e realizzata in sinergia con ilCNR e con molte Università italiane), che nell’area subalpinaha individuato oltre trecento esempi di questi luoghi di culto(circa il 10% dell’intera Penisola) 118. I risultati del censimentopermettono di guardare ai santuari (e, più in generale, aglispazi sacri) con un’ottica nuova e di superare alcune prospet-tive di interpretazione a lungo avallate anche dalla storiogra-fia 119. Innanzitutto, è da rivedere profondamente la definizione– densa di implicazioni ideologiche e sociologiche – di religio-
208 paolo cozzo
117 P. COZZO, La geografia celeste cit.118 Cfr. a tal proposito P. COZZO, Il censimento dei santuari cristiani del Piemonte e della Valle
d’Aosta: analisi dei dati e prime riflessioni, in Andare per santuari, atti delle giornate di studio peroperatori del turismo religioso (Torino, 15 ottobre e 19 novembre 2004), a cura di G.Cracco e P. Cozzo, Aosta, Diocesi di Aosta, 2006, pp. 45-60.
119 G. CRACCO, Il santuario:definizione, metodi di studio, significato storico, ibid., pp. 9-21.
sità «popolare» 120, che per molti anni è stata assunta per de-scrivere ogni manifestazione religiosa che non trovasse una pre-cisa dimensione istituzionale. Il caso piemontese dimostra chia-ramente che la devozione è un fenomeno trasversale, capace dicoinvolgere ogni ambito sociale, politico e culturale. Apparedunque inadeguata la lettura – autorevolmente condotta fino aqualche lustro fa – del mondo dei santuari, dei pellegrinaggi,delle compagnie devote come espressione del sentimento reli-gioso delle classi subalterne della società piemontese121. Sap-piamo infatti che quello è un mondo frequentato – sia pur conforme e modalità differenti – da tutti i gruppi sociali e da tuttii ceti, dalle masse popolari alla corte. Di questo fatto occorreessere ben consapevoli nella programmazione di una ricercache dovrebbe finalmente liberare da un certo «isolamento» sto-riografico una realtà – quella degli spazi sacri meta di culto –troppo spesso considerata marginale, in Piemonte come nelresto della Penisola dove, a differenza di altre realtà europee,« l’interesse per una ricerca sui pellegrinaggi ad ampia cronolo-gia e su base geografica allargata è fatto assolutamente nuo-vo»122.
Un’altra riflessione che i nuovi strumenti di ricerca impon-gono di fare riguarda la geografia devozionale del Piemontemoderno. Per anni si è insistito sulla fondamentale importanzadella montagna quale ambiente ideale per la nascita e lo svi-luppo degli spazi sacri (si pensi ai sacri monti), mentre i datidel recente censimento hanno dimostrato che quello dei luoghidi devozione è un fenomeno prevalentemente legato alla pia-
storia religiosa 209
120 Su questa espressione si sono soffermati O. NICCOLI, Oltre la « religione popolare»,in Fonti ecclesiastiche cit., pp. 541-563; D. ZARDIN, La «religione popolare» interpretazioni storio-grafiche e ipotesi di ricerca, in Arte, religione, comunità nell’Italia rinascimentale e barocca, a cura di L.Saccardo e D. Zardin, Milano, Via e Pensiero, 2000, pp. 3-23.
121 Strumenti per ricerche sulla religione delle classi popolari, I, Problemi di impostazione e di metodo.Il caso di Fossano, a cura di F. Bolgiani, Torino, Tirrenia stampatori, 1981.
122 P. HERSCHE, Santuari e pellegrinaggi fra folklore e storia. Un bilancio delle ricerche nel mondogermanico, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», 40, 2004, pp. 351-385, in part.p. 353.
nura. Appare dunque fuorviante considerare il contesto alpinocome condizione necessaria e sufficiente per lo sviluppo di spa-zi sacri: se ciò è vero per il versante alpino settentrionale (i datidella diocesi di Novara sembrano confermarlo) lo è meno perquello occidentale. Tale considerazione dovrebbe aiutarci anchea comprendere meglio, o forse a superare, la lettura, a voltetroppo rigida, dei santuari alpini, specialmente quelli sorti inetà moderna, quali baluardi antiprotestanti 123; lettura che, seappare corretta per alcune realtà (quelle appartenenti al conte-sto lombardo-borromaico, dove, non casualmente, fiorisce ilfenomeno dei sacri monti 124), appare meno fondata per altre,come quella più occidentale, dove il problema della rispostaalla diffusione della Riforma venne affrontato in altri modi(azione missionaria, riorganizzazione del territorio ecclesiasti-co) sui quali occorrerebbe fare maggior chiarezza.
Conseguentemente, queste riflessioni mettono in luce la ne-cessità di procedere ad una completa mappatura, anche per ilPiemonte, della dissidenza religiosa e dell’eterodossia, della cen-sura dell’inquisizione: fenomeni, questi, fra i più trattati e di-
210 paolo cozzo
123 Sui rischi di un «riduzionismo» nella valutazione del complesso fenomeno san-tuariale cfr. P. COZZO, Santuari del Principe. I santuari subalpini d’età moderna nel progetto politicosabaudo, in Per una storia del santuari cristiani d’Italia: approcci regionali, a cura di G. Cracco,Bologna, il Mulino, 2002, pp. 91-114, in part. pp. 100-105; P. COZZO, La Madonna diTirano nella geografia mariana di età moderna: specificità e analogie, in «Bollettino della Societàstorica valtellinese», 58, 2005, pp. 61-72.
124 Sui Sacri Monti piemontesi e lombardi esiste una vastissima bibliografia, di cuisi segnalano solamente alcuni fra i lavori più recenti: M. CENTINI, I Sacri Monti dell’arcoalpino italiano, Ivrea, Priuli e Verlucca, 1990; Sacri Monti: devozioni, arte e cultura della Contro-riforma, a cura di L. Vaccaro, F. Ricardi, Milano, Jaca book, 1992; Atlante dei Sacri Monti,Calvari e Complessi devozionali europei, a cura di A. Barbero, Novara, Istituto geografico DeAgostini, 2001; Terra santa e Sacri Monti, (atti della giornata di studio, Università Cat-tolica Milano 25 novembre 1998), a cura di M.L. Gatti Perrer, Milano, I.S.U., 1999;Gerusalemme nelle Alpi. Per un atlante dei Sacri Monti prealpini, a cura di L. Zanzi, P. Zanzi,Milano, Fondazione Cariplo, 2002; I Sacri Monti nella cultura religiosa e artistica del NordItalia, a cura di D. Tuniz, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2005; Religioni e Sacri Monti, attidel convegno internazionale (Torino, Moncalvo, Casale Monferrato), 12-16 ottobre2004, a cura di A. Barbero e S. Piano, Ponzano Monferrato, ATLAS, Centro di docu-mentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, 2006.
battuti dalla storiografia a livello generale 125 ma complessiva-mente sottovalutati a livello regionale, tranne alcune significa-tive eccezioni riconducibili a impostazioni storiografiche or-mai superate oppure afferenti a contesti confessionali ben defi-niti. Al primo caso si ascrive la contraddittoria tradizione sa-baudista, che si era mostrata divisa nel giudizio sull’atteggia-mento della dinastia nei confronti dei protestanti piemonte-si 126; al secondo, invece, la tradizione valdese che, uscita dai ca-noni apologetici del XIX secolo, nel corso del Novecento (especialmente negli ultimi decenni) non ha mancato di attualiz-zare, con apporti originali, le indagini sulla Riforma e i movi-menti religiosi in quella terra subalpina rimasta, per certi versi,un po’ ai margini del grande affresco cantimoriano 127.
Così, mentre alcune aree del Piemonte sono state privile-giate dalle indagini, altre sono invece rimaste assai o del tutto
storia religiosa 211
125 Fra i lavori più recenti: E. BRAMBILLA, Alle origini del Sant’Uffizio: penitenza, confessionee giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo, Bologna, il Mulino, 2000; Censura ecclesiastica ecultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento (VI Giornata Luigi Firpo, atti del convegno,5 marzo 1999), a cura di C. Stango, Firenze, Olschki, 2001; G. ROMEO, L’Inquisizionenell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2002; M. FIRPO, «Disputar di cose pertinente alla fede».Studi sulla vita religiosa del Cinquecento italiano, Milano, Unicopli, 2003; A. PROSPERI, L’inqui-sizione romana: letture e ricerche, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003; A. AUBERT,Eterodossia e Controriforma nell’Italia del Cinquecento, Bari, Cacucci, 2004; A DEL COL,L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano, Mondadori, 2006; V. FRAJESE, Nascitadell’Indice: la censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma, Brescia, Morcelliana, 2006.
126 Sul diverso atteggiamento della storiografia sabaudista, divisa fra un’ala filoval-dese (rappresentata da Ercole Ricotti e da Domenico Carutti), e un’ala anti-valdese(rappresentata da Gaudenzio Claretta) cfr. A. MERLOTTI, «Stranieri al Piemonte»: i valdesinella storiografia piemontese dell’Ottocento, in La Bibbia, la coccarda e il tricolore. I valdesi fra due Eman-cipazioni (1798-1848), atti del XXXVII e del XXXVIII convegno di studi sulla Ri-forma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 31 agosto – 2 settembre 1997 e30 agosto – 1 settembre 1998), a cura di G.P. Romagnani, Torino, Claudiana, 2001,pp. 455-492, in part. pp. 479-490.
127 Per una considerazione generale sulla più recente storiografia relativa alla Ri-forma in Italia cfr. Cinquant’anni di storiografia italiana sulla Riforma e i movimenti ereticali inItalia (1950-2000), atti del XL convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti reli-giosi in Italia (Torre Pellice 2-3 settembre 2000), a cura di S. Peyronel, Torino, Clau-diana, 2002; sulla storiografia valdese e sulla sua evoluzione G.P. ROMAGNANI, Verso unanuova storia dei valdesi? Questioni di storiografia a mo’ di introduzione, in Valdesi e protestanti a Torino(XVIII - XX secolo). Convegno per i 150 anni del tempio valdese (1853-2003), a cura di P.Cozzo, F. De Pieri, A. Merlotti, Torino, Zamorani, 2005, pp. 13-36.
scoperte. Al primo caso appartengono il Pinerolese e le sue val-li, il Saluzzese e il Cuneese 128, la città di Torino; al secondo vainvece ricondotta gran parte delle terre piemontesi, per le qualimancano ancora organici e sistematici studi sulla presenza, l’or-ganizzazione, e la repressione di comunità eterodosse. Eppure,nel XVI secolo fermenti religiosi più o meno latenti sono se-gnalati in molti centri subalpini, grandi e piccoli: da Asti aCasale, da Chieri a Peveragno.
È un dato che la storiografia continua giustamente a indi-care come elemento critico, senza peraltro riuscire a richiamaresu di esso la dovuta attenzione degli specialisti. Proprio perquesto, in un articolato programma di ricerca dovrebbe trovareadeguato spazio l’analisi delle manifestazioni di eterodossia,del loro radicamento sociale e culturale, delle loro implicazionipolitico-istituzionali, nonché una disamina delle modalità edelle dinamiche di repressione da parte delle autorità ecclesia-stiche e civili, specialmente in età postridentina, e particolar-mente nei centri (anche quelli minori) rimasti finora al di fuoridei grandi circuiti di ricerca sulla dissidenza religiosa.
4. Strumenti di ricerca
Condizione necessaria per affrontare i temi di ricerca sinqui delineati sembra essere la redazione di nuovi, aggiornati efunzionali strumenti – sinora mancanti, datati, o comunque da
212 paolo cozzo
128 Sulla diffusione della Riforma protestante nel Cuneese cfr. A. PASCAL, Storia dellaRiforma protestante a Cuneo nel secolo XVI, Pinerolo, Tipografia sociale, 1913; G. JALLA, Storiadella Riforma in Piemonte fino alla morte di Emanuele Filiberto (1517-1580), Firenze, Claudiana,1914; P. BIANCHI, Riforma religiosa e ragion di Stato. Gruppi e forme di vita religiosa nel Cuneese fraCinque e Seicento, in «Bollettino della Società di Studi Valdesi» CXVI (1999), n. 185, pp3-26; per l’area monregalese G. COMINO, Aspetti della dissidenza e della repressione religiosa aPeveragno (XV-XVI secolo), in «Bollettino della Società di Studi Valdesi» 191, 2002, pp.3-26; per Torino G.P. ROMAGNANI, Presenze protestanti a Torino tra Sei e Settecento, in Storia diTorino, V, Dalla città razionale alla crisi dello Stato d’Antico Regime (1730-1798), a cura di G.Ricuperati, Torino, Einaudi, 2002, pp. 423-451.
ripensare – quali, ad esempio, un repertorio delle cariche eccle-siastiche (vescovi, abati, priori), un dizionario delle figure insacris operanti a corte e nelle istituzioni dello Stato, e una det-tagliata mappatura delle circoscrizioni e delle giurisdizioniecclesiastiche (secolari e regolari) del Piemonte.
Tutti questi strumenti, utili se non indispensabili per unproficuo andamento della ricerca, andranno costruiti partendodal materiale di tradizione erudita già in nostro possesso (daivolumi III-VI della Hierarchia catholica all’Italia sacra dell’Ughelli,dalle Chiese d’Italia del Cappelletti al Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica del Moroni, dal Pedemontium sacrum del Meyranesioalla Chiesa in Piemonte del Chiuso, per limitarci alle opere piùnote), da integrare ed arricchire con i già citati recenti studidedicati alle singole realtà locali, nonché a nuove indagini d’ar-chivio.
In tale prospettiva, una prima fase della ricerca non potràprescindere da alcuni fondi archivistici ritenuti irrinunciabili.In particolare:
1) a Torino:in Archivio di Stato di Torino, Corte, l’enorme fondo Mate-
rie ecclesiastiche che già nel XVIII secolo era stato pensato per rac-cogliere «tutto ciò che concerne la corte di Roma ed il gover-no ecclesiastico di questi Stati»129. Esso è strutturato in:
Materie ecclesiastiche per categorie (293 mazzi);Arcivescovadi e vescovadi (64 mazzi);Arcivescovadi e vescovadi stranieri (13 mazzi);Abbazie (500 mazzi);Regolari (494 mazzi);Monache (224 mazzi);Benefizi (326 mazzi);Luoghi pii ed opere pie (mazzi 688);
storia religiosa 213
129 Guida generale degli Archivi di Stato italiani, IV, Archivio di Stato di Torino, Roma, Mini-stero per i beni culturali e ambientali, 1994, pp. 361-641, in part. p. 401.
inoltre la sezione Lettere Ministri, Roma, del fondo Materie politi-che per Rapporto all’Estero, i cui 428 mazzi custodiscono un mate-riale fondamentale per la ricostruzione non solo delle relazionifra la Sede Apostolica e lo Stato sabaudo, ma anche dell’orga-nizzazione ecclesiastica del Piemonte;
in Archivio di Stato di Torino, Camerale, i Bilanci del fondoCasa di Sua Maestà, il fondo Senato di Piemonte (in particolare: Se-rie I, i 121 volumi di Materie Ecclesiastiche; i 19 volumi di Materiegiurisdizionali; i 42 volumi di Benefici ossia decreti per il regio Exequa-tur), il fondo Economato generale dei benefici vacanti;
sarà inoltre utile consultare gli archivi privati di alcune fa-miglie subalpine che ebbero fra i loro esponenti soggetti chepercorsero significative carriere in ambito ecclesiastico, come adesempio i Ferrero, gli Arborio Gattinara, i Radicati, i Roero, iSolaro;
importante appare poi lo studio dei fondi dell’Archivio ci-vico della Città di Torino, in particolare gli Ordinati;
per quanto riguarda gli archivi ecclesiastici, fondamentalesarà il ricorso all’Archivio storico dell’Arcidiocesi di Torino, inparticolare per i fondi Corrispondenza (sez. XI), Clero (sez. XII),Archivi personali dei vescovi e dei vicari generali (sez. XIV), Cause dibeatificazione dei servi di Dio (sez. XVI).
2) a Roma:in Archivio di Stato Vaticano, il fondo Segreteria di Stato, Savoia
(1560-1803), e il fondo Archivio della Nunziatura di Torino, divisoin Feudi del Piemonte (253 volumi, 1561-1863), Corrispondenza eCancelleria (105 buste e 200 volumi, 1602-1860);
sarà inoltre utile consultare i fondi della Congregazione deiVescovi e Regolari, della Dataria Apostolica; della Segreteria di Stato(Cardinali e Principi);
3) in Piemonte:i fondi di alcuni archivi di Stato: ad esempio, i fondi
Corporazioni religiose degli archivi di Stato di Biella e Novara;
214 paolo cozzo
i fondi degli archivi diocesani piemontesi (sulla cui accessi-bilità rimando a considerazioni già espresse), con particolareriferimento ai vescovadi maggiormente rappresentativi, sia perla loro antichità ed ampiezza territoriale (Mondovì, Asti, Ivrea,Vercelli) sia per la loro coincidenza con giurisdizioni politichediverse – almeno originariamente – da quella sabauda (Casale,Saluzzo, Alba, Acqui, Alessandria, Tortona, Novara) sia per ledinamiche che portarono alla loro erezione in età moderna(Fossano, Pinerolo, Susa, Biella, Cuneo);
i fondi degli archivi storici comunali delle principali cittàpiemontesi (in particolare quelle sedi episcopali).
Successivamente la ricerca dovrebbe interessare altri fondi.Innanzitutto quelli conservati negli archivi centrali degli ordinie delle congregazioni religiose più significativi per la storia pie-montese (gesuiti e cappuccini in primo luogo, senza dimenti-care minori osservanti e predicatori, teatini, barnabiti, orato-riani, camaldolesi e foglianti). Particolarmente utile si dovrebbepoi rivelare il fondo «Patetta» nella Biblioteca Apostolica Vati-cana. Inoltre, rimanendo a Roma, si potrebbero valorizzare al-cuni fondi della Biblioteca Vallicelliana e della Biblioteca An-gelica oggi ancora in gran parte inesplorati ma – come fannosupporre alcuni indizi – assai utili.
Un ulteriore, importante contributo per valutare l’immagi-ne e il ruolo assunto dagli ecclesiastici a più stretto contattocon i vertici del potere civile (ad esempio il clero di corte, i ve-scovi e gli arcivescovi, i nunzi pontifici) potrebbe venire dallaconsultazione della corrispondenza dei diplomatici accreditatia Torino, in particolare i rappresentati di altri Stati italiani (laRepubblica di Venezia e il Granducato di Toscana innanzitut-to) e delle principali potenze europee (Francia, Spagna, Impe-ro e Inghilterra). Per questo sarebbe assai utile poter scanda-gliare i fondi degli archivi di Stato di Venezia e Firenze, inFrancia gli Archives des Affaires Étrangères e gli Archives Na-
storia religiosa 215
tionales, in Spagna l’Archivo General de Simancas, in Austrialo Staatsarchiv di Vienna e in Gran Bretagna il Public RecordOffice.
Le indagini su fonti provenienti da ambiti archivistici cosìvasti e variegati dovrebbe garantire l’apporto di nuove testimo-nianze documentarie, il cui impiego potrebbe consentire unasignificativa integrazione del materiale già a disposizione deglistudiosi.
216 paolo cozzo
Actis Caporale, Aldo, 120 n.Ago, Renata, 111 n. Agulhon, Maurice, 155 e n.Ainari, Ottavio, 191 n.Airoldi, Giuseppe, 194 n.Albani, Alessandro (cardinale), 200Alberigo, Giuseppe, 167 n.Alberti, Leandro, 22, 25 n.Aleramici di Saluzzo (dinastia), 24Alfieri, Vittorio, 84 n.Al Kalak, Matteo, 180 n.Allegra, Luciano, 46 e n., 120 e n.,
146 e n., 149 e n., 186Ambrosoli, Mauro, 100 n., 148 n.Amedeo IX di Savoia, duca di Sa-
voia detto il Beato, 201Ancina, Giovenale, 191 n.Anderson, Matthew Smith, 28, 53
n.Andretta, Stefano, 196 n.Angioini (dinastia), 11Antonielli, Livio, 19 n., 32 n., 47Arborio di Gattinara (famiglia),
130, 214Arborio di Gattinara, Giovanni Mer-
curino, 106, 191 n.Arborio Mella (famiglia), 130Arecco, Antonio, 180 n.Artifoni, Enrico, 171 n.Asburgo (dinastia), 71, 125
Assia, Filippo di, 206 n.Assia Kassel, Maurizio di, 206 n.Attanasio, Livio, 61 n.Aubert, Alberto, 211 n.Avogadro (famiglia), 22, 130
Balani, Donatella, 123, 164 n. Balbo (Balbis) Simeone di Rivera,
Giovanni Battista, 200 Baldessano (Baldesano), Guglielmo
24 n., 25Balduini di Santa Margherita, Gio-
van Francesco, 107, 108 n.Barale, Vittorino, 204Barberis, Walter, 12 n., 35 e n., 51
n., 54 e n., 72 e n.Barbero, Alessandro, 22 e n., 24 n.,
55 e n., 77 n., 92 n., 157 e n.,210 n.
Barbero, Amilcare, 210 n.Barletta, Laura, 134 n.Barreiro Rivas, José Luis, 206 n.Bascapè, Carlo, 119, 182 n.Battelli, Giuseppe, 170 n., 178 n.Beatrice di Braganza, duchessa di
Savoia, 108Beccaria, Cesare, 82 n.Bellinazzi, Anna, 47 n.Bellini, Enzo, 81 n.Bellone, Ernesto, 195 n.
Indice dei nomi
Beltrame, Doriano, 106 n. Beltrutti, Giorgio, 75 n.Benanti, Agata, 199 n.Benedetto XIV, papa (Prospero
Lambertini), 191 n., 200Benigno, Francesco, 19 n.Benoist, Pierre, 192 n.Benvenuti, Anna, 206 n.Benzi, Francesco, 107 n. Beraudo di Pralormo, Vincenzo Se-
bastiano, 88 n.Berengo, Marino, 19 e n., 103 e n.,
141Berio, Anna Maria, 75 n.Bernardi, Antonio, 172 n.Bertolotto, Claudio, 191 n.Betri, Maria Luisa, 155 n.Bevilacqua, Piero, 19 n.Bianchi, Paola, 5, 15, 25 n., 27 e n.,
31 n., 32 n., 33 n., 35 n., 36 n.,50 n., 57 n., 59 n., 75 n., 77,86 e n., 92 n., 97 n., 100, 105e n., 107 n., 124, 131, 153 e n.,154 n., 155 n., 156, 157 n.,159 n., 212 n.
Bianco, Furio, 100 n.Biondo, Flavio, 22Bizzocchi, Roberto, 138 e n.Black, Jeremy, 52, 53 e n., 54 n.Bobba, Marc’Antonio, 197Boccalini, Marta, 106 n.Boesch Gajano, Sofia, 205 n.Boggio, Pier Carlo, 195 e n.Bogino di Migliandolo, Giambat-
tista, 68, 81Bolgiani, Franco, 209 n.Bona, Giovanni, 192 e n., 203Bonora, Elena, 191 e n.Bordone, Renato, 99, 100 n., 108
n., 117 n., 131 n.
Borromeo, Agostino, 169 n.Borromeo, Carlo, 119Boschiero, Gelindo, 117 n.Bosio, Gaspare, 182 e n.Botero, Giovanni, 25Botton di Castellamonte, Ugo Vin-
cenzo, 123Boutry, Philippe, 205 n.Brambilla, Elena, 155 n., 211 n.Brancaccio, Nicola, 27 n.Brigaglia, Manlio, 20 n.Briganti, Giuliano, 166 n.Brizio, Paolo, 25Broers, Michael, 101 e n.Bruera, Elisabetta, 194 n.Brugnetta, Gabriele, 106 n. Bulferetti, Luigi, 81 e n., 141 e n.,
148 e n., 150 n., 154Buono, Alessandro, 116Buronzo (famiglia), 130Busolini, Dario, 23 n.
Caffaro, Pietro, 171 n., 182 e n. Caffiero, Marina, 169 n., 192 n.Calzolari, Monica, 47 n.Campello, Bernardino, 195 n.Camurri, Luca Valerio, 81 n.Canavesio, Walter, 193 n.Cappelletti, Giuseppe, 213Capra, Carlo, 109Capuano, Luigi, 205 n.Carassi, Marco, 4Cardini, Franco, 134 n.Cardoza, Anthony, 150 e n., 151 n.Carlo I Stuart, re d’Inghilterra, 70Carlo II, duca di Savoia, 77 n., 93,
116Carlo V d’Asburgo, imperatore, 80,
106, 113Carlo VI d’Asburgo, imperatore, 41
218 indice dei nomi
Carlo XI, re di Svezia, 40Carlo Alberto di Savoia Carignano,
re di Sardegna, 12, 35, 189 n.,199 n.
Carlo Emanuele I, duca di Savoia,25, 37, 44 e n., 58, 72, 75, 77e n., 108 e n., 113, 191 n., 195n., 198 e n., 200, 202, 203,208
Carlo Emanuele II, duca di Savoia,34, 56, 59 n., 81 n., 82 n., 148 n.
Carlo Emanuele III di Savoia, re diSardegna, 77, 113, 126, 200
Carnero, Roberto, 106 n.Carozzi, Carlo, 82 n.Carpanetto, Dino, 123Carpo, Patrizia, 106 n.Carucci, Paola, 177 n., 178 n.Carutti, Domenico, 195 e n., 211 n.Casalis, Goffredo, 115Casanova, Giorgio, 127 n.Casiraghi, Giampiero, 183 e n.Castellani, Luisa, 73 n., 117 n.Castelnuovo, Guido, 22 e n., 55 e
n., 156 e n., 157 e n.Castiglione, Valeriano, 25Castronovo, Valerio, 20 e n.Cavallera, Marina, 123Cavallo, Sandra, 86 e n., 154 n.Cengarle, Federica, 22 n., 156 n.Centini, Massimo, 210 n.Cerutti, Simona, 46 e n., 146 e n.,
154 n.Cervato, Dario, 180 n.Ceva, Alessandro, 191 n.Ceva, Francesco Adriano, 203Chapel di Saint Laurent, Donato, 37Chastel, André, 166 n.Châtellier, Louis, 169 n.
Chiaberto, Silvio, 193 n.Chiomba, Apollinare, 193 e n.Chittolini, Giorgio, 19 n., 22 n.,
24 n., 91 n., 92 n., 115 e n.,117 n., 141, 156 n., 170 n.,173 n., 206 n.
Chiuso, Tommaso, 171, 181 e n.,191 n., 213
Ciasca, Raffaele, 196 n.Claretta, Gaudenzio, 211 n.Clemente VIII, papa (Ippolito Aldo-
brandini), 197 n., 202 n.Cocconito di Montiglio (famiglia),
130Cognasso, Francesco, 109Colombo, Giuseppe, 191 n.Comba, Rinaldo, 24 n., 32 n., 56
n., 98 n., 122 n., 154 n., 161n., 184 n., 188 n.
Comino, Giancarlo, 105 n., 183 n.,212 n.
Condé, Luigi I di Borbone, princi-pe di, 70
Contini, Alessandra, 47 n.Corona, Tobia, 191 n.Corte di Bonvicino, Giuseppe Ame-
deo, 88 n., 107, 108 n.Corvesi, Lazzaro, 105 n.Corvisier, André, 28, 53 n.Cozzo, Paolo, 5, 24 n., 32 n., 105,
119, 123, 127 e n., 156, 167,184 n., 197 n., 198 n., 203 n.,208 n., 210 n., 211 n.
Cracco, Giorgio, 170 n., 172 n.,180 n., 184 e n., 194 n., 206n., 207 n., 210 n.
Cremonini, Cinzia, 126 n.Crivellin, Walter, 154 n.Croce, Benedetto, 9, 52Crosa, Emilio, 141 n.
indice dei nomi 219
Cuaz, Marco, 87 n.Cucchi, Enzo, 81 n.
Dal Pozzo della Cisterna (fami-glia), 130
Damilano, Piero, 191 n.Dao, Ettore, 183 e n.De Benedictis, Angela, 69 n.De la Barrière, Jean, 192Del Carretto (famiglia), 126Del Col, Andrea, 169 n., 170 n.,
211 n.Della Chiesa, Francesco Agostino,
25, 73, 74 n., 137 n.Delle Lanze, Carlo Vittorio Ame-
deo, 204Dell’Oro, Giorgio, 197 n. Del Negro, Pietro, 27 n.Del Rio Barredo, Maria José, 206 n.Denina, Carlo, 123De Pieri, Filippo, 32 n., 211 n.De Rosa, Gabriele, 168 n., 170 n.De Sandre Gasparini, Giuseppina,
183 n.Diez Gil, Ana Ma, 129 n.Dipper, Christoph, 206 n.Disegni, Dario, 4Di Sivo, Michele, 47 n.Ditchfield, Simon, 206 n.Donati, Claudio, 32 n., 47, 100 n.,
123, 178 e n., 187 e n.Donattini, Massimo, 25 n.Donaudi delle Mallere, Ignazio, 123 n.
Einaudi, Giulio, 17Einaudi, Luigi, 61 e n., 82 e n., 139,
143Elliott, John Huxtable, 30 n.Emanuele Filiberto, duca di Savoia,
12, 17, 35, 37, 44 e n., 48, 58,59 n., 68, 72, 75, 77 e n., 93,
102, 108 e n., 111, 113, 140n., 153 n., 154, 189 n., 197 n.,200, 202, 208
Enrico II di Valois-Angoulême, redi Francia, 38
Erba, Achille, 183 e n., 186, 199 n.Este (dinastia), 113Evans, Robert J.W., 126 n.
Falletti di Barolo (famiglia), 143Fantoni, Marcello, 91 n.Fara, Amelio, 110 n.Farnese (dinastia), 153 n.Fasano Guarini, Elena, 20 n., 91 n.,
92 e n., 115 n., 141Federico I di Hoenstaufen, impera-
tore, 182 n.Federico II di Hoenstaufen, impe-
ratore, 80Felice, Costantino, 19 n.Ferrero, Carlo Vincenzo Maria, car-
dinale, 197 e n., 203Ferrero, Guido, 197Ferrero, Pier Francesco, 197Ferrero d’Ormea (famiglia), 32 n.,
74 n., 137 n., 152, 198 n., 214Ferrero d’Ormea, Alessandro Mar-
cello, 74 Ferrero d’Ormea, Carlo Francesco
Vincenzo, 32 n., 68, 74, 81,112 e n., 126, 148 e n., 152,199 n.
Ferrero Fieschi, principi di Masse-rano, 127
Ferrone, Vincenzo, 35 e n., 36Fiaschini, Giulio, 182 n.Filippo II, re di Spagna, 58Filippo IV, re di Spagna, 80Filippo V, re di Spagna, 69Fiorani, Luigi, 170 n., 202 n.
220 indice dei nomi
Firpo, Massimo, 166 e n., 211 n.Fiume, Giovanna, 206 n.Fontana di Cravanzana, Giovanni
Giacomo, 148 e n.Fonzi, Fausto, 195, 196Frajese, Vittorio, 211 n.Francesco I, marchese di Saluzzo,
113Francesco I Sforza, duca di Milano,
91 n.Fratini, Marco, 25 n., 32 n., 73 n.,
98 n., 137 n., 189 n.Friedenburg, Robert von, 206 n.Frigo, Daniela, 111 n., 112 n., 124
n., 196 n. Fubini, Riccardo, 91 n.Fumian, Carlo, 19 n.
Gabotto, Ferdinando, 171Gaddo, Irene, 110 n.Galasso, Giuseppe, 7, 17, 18 e n.,
81, 89 e n., 134 n.Galeani Napione, Gian Francesco,
86 n.Gambi, Lucio, 18, 82 n.Gandolfino da Roreto, 108 n.García Hernán, Enrique, 44 n.Gastaldi, Giacomo, 22, 23Gatti Perrer, Maria Luisa, 210 n.Gazzola, Gian Michele, 182 n.Gemelli, Giuliana, 155 n.Genta, Enrico, 82 e n., 163 n.Gentile, Guido, 110 n.Gentile, Luisa Clotilde, 60 e n., 75
n., 92 n., 138 e n., 153 e n.Geremek, Bronislaw, 174 n.Giannazzo di Pamparato, France-
sco, 120 n.Giannini, Massimo Carlo, 189 n.Giannone, Pietro, 199 n.
Giarrizzo, Giuseppe, 19 n.Gibbs, Graham C., 45 n., 101Giordano, Silvano, 196 n.Giovan Giorgio, marchese del Mon-
ferrato, 113Giuriolo, Elisabetta, 193 n.Glozier, Matthew, 32 n.Gnetti, Donatella, 108 n.Golinelli, Paolo, 206 n.Gonzaga (dinastia), 25, 125, 173 n.Gonzalez Vega, Adela, 129 n.Gooch, George, 28Goria, Federico, 204Gorini, Ernesto, 106 n.Gotor, Miguel, 205 n.Grantaliano, Elvira, 47 n.Grassi di Santa Cristina, Gioachi-
no, 181 e n.Greco, Gaetano, 8 e n., 93 n., 111,
186 n., 188 n.Gregorio XV, papa (Alessandro Lu-
dovisi), 197 n.Gregory, Tullio, 168 n., 170 n.Grendi, Edoardo, 95, 146Grillo, Paolo, 188 n.Griseri, Giuseppe, 182 n., 189 n.Griva, Luigi, 121 n.Gromo di Ternengo, Giovanni Er-
cole, 197 e n.Grosso, Michele, 182 e n.Grozio, Ugo (Huig van Groot), 40Gualdo, Germano, 177 n., 196 n.Guasco, Francesco, 158 e n.Guasco, Maurilio, 180 n., 189 n.Guerci, Luciano, 172 n.Guerin, Giusto, 191 n.Guglielmo, Marcella, 101 n., 175 n.Guglielmotti, Paola, 99, 100 n.Guicciardini, Francesco, 52Guida, Francesco, 159 n.
indice dei nomi 221
Guidobono Cavalchini, Carlo Alber-to, 204
Gullino, Giuseppe, 106 n.Gustavo II, re di Svezia, 40Gustavo IV, re di Svezia, 40
Hacke, Daniela, 179 n.Hanlon, Gregory, 51 e n., 52 e n.Hannover (dinastia), 71Haugwitz, Christian August von, 38Hersche, Peter, 209 n.Howard, Michael, 28
Isaacs, Ann Katherine, 112 n.
Jaitner, Klaus, 197 n.Jalla, Giovanni, 212 n.Jedin, Hubert, 171 e n.Julia, Dominique, 205 n.
Koenigsberger, Helmut G., 30 n.,68 n.
Koller, Alexander, 196 n., 199 n.Kuehn, Thomas, 179 n.
Lambertini, Prospero, cardinale, cfr.Benedetto XIV, papa
Landi, Guido, 7Lapucci, Mario, 206 n.La Tour d’Auvergne, Henri de, du-
ca di Bouillon, 38Lauro, Vincenzo, 200Lepetit, Bernard, 160 n.Le Tellier de Louvois, François-Mi-
chel, 38, 39, 42Leverotti, Franca, 124Levi, Giovanni, 116 n., 120 e n.,
146Levra, Umberto, 113 n., 139 n.Livraghi, Roberto, 199 n.
Lombardi, Giorgio, 4, 5, 7 n., 74 en., 105 n., 144 e n.
Lombardini, Sandro, 99, 100 n.,145
Longo, Pier Giorgio, 186Loriga, Sabina, 36 e n.Lotto, Lorenzo, 166 n.Ludovico I, marchese di Saluzzo,
98 e n.Ludovico II, marchese di Saluzzo,
98 e n.Luigi XI, re di Francia, 91 n.Luigi XIII, re di Francia, 38, 68Luigi XIV, re di Francia, 39, 41,
42, 69, 70Luigi XV, re di Francia, 69Luserna d’Angrogna, Carlo Ame-
deo, 79Lynn, John A., 28
Maffi, Davide, 28 n., 29 n., 44 n.Maggio Serra, Rosanna, 84 n.Maillard de Tournon, Carlo Tom-
maso, 203Mainardi, Aldo, 75 n.Malabaila, Filippo, 73Malatesta, Maria, 155 n.Malerba, Albina, 4Manganelli, Cesare, 110 n.Manno, Antonio, 137, 138, 158 e n.Mano, Livio, 182 n.Mantegna, Andrea, 124 n.Marchiando Pacchiola, Mario, 172 n.Marcozzi, Marco, 108 n.Margotti, Marta, 180 n.Maria Giovanna Battista di Savoia
Nemours, duchessa di Savoia,37, 78 n.
Maria Teresa d’Asburgo, imperatri-ce, 77
222 indice dei nomi
Marini, Lino, 111 n., 141Massabò Ricci, Isabella, 78 n., 82
n., 110 n.Massafra, Angelo, 19 n.Massullo, Gino, 19 n.Mastino, Attilio, 20 n.Mattone, Antonello, 46 e n., 87 n.Mazzarino, Giulio, 70Mazzocca, Fernando, 84 n.McNeill, William H., 28Medici (dinastia), 113, 125Medici, Lorenzo de’, il Magnifico,
91 n.Mellano, Franca Maria, 182 e n.,
186, 191 n.Mellarède, Pierre, 134Menniti Ippolito, Antonio, 178 n.Merlin, Pierpaolo, 17 n., 34 n., 44
e n., 77 n., 81 n., 87 n., 93 n.,96 n., 97 n., 102, 104 n., 123 en., 140 e n., 141 n., 197 n.
Merlini, Ludovico, 200Merlo, Grado Giovanni, 172 n., 184
e n., 188 n., 203 n.Merlotti, Andrea, 5, 12 n., 25 n.,
32 e n., 34 e n., 35 n., 49, 57 n.,59 e n., 73 n., 74 n., 78 n., 83,85 n., 88 n., 100, 105 e n., 107n., 108 n., 116, 137 e n., 142 n.,143 n., 154 n., 155 n., 157 n.,159 n., 198 n., 199 n., 211 n.
Meyranesio, Giuseppe Francesco, 213Miccoli, Giovanni, 170 n., 173 n.Michetti, Raimondo, 205 n.Modulo, Umberto M., 191 n.Molho, Anthony, 24 n., 91 n.Molina, Barbara, 117 n.Monestarolo, Giorgio, 123Mongiano, Elisa, 151 e n., 204 n.Monod, Pierre, 25
Montaldo, Silvano, 139 n.Montanari, Massimo, 19 n., 109Montesquieu, Charles-Louis de Se-
condat de, 70Morandini, Cesare, 148 e n.Moreno, Luigi, 199 n.Moreno, Ottavio, 199 e n.Moroni, Gaetano, 213Mörschel, Tobias, 127 n., 196 n.,
197 n., 205 n.Mortari, Annamaria, 124 n.Moscati, Laura, 121 n.Mostaccio, Silvia, 191 n.Mozzarelli, Cesare, 109, 111 n.,
124 n., 141Muratori, Ludovico Antonio, 82 n.Musi, Aurelio, 91 n., 113 n. Musso, Riccardo, 126 n.Muto, Giovanni, 91 n.
Napoleone I Bonaparte, 70Natale, Vittorio, 73 n.Natta, Enrichetto Virginio, 204Negruzzo, Simona, 167 n., 169 n.Niccoli, Ottavia, 209 n.Nicolas, Jean, 86 n., 138, 139 n.Nordman, Daniel, 122Nubola, Cecilia, 174 n., 175 n.,
177 n.
Oberli, Matthias, 197 n.Onnekink, David, 32 n.Oresko, Robert, 45 e n., 101 n.,
124 n.Orléans (famiglia), 76Orselli, Alba Maria, 206 n.Orsenigo, Riccardo, 182 e n.Ortalli, Gherardo, 101 e n., 115Ortu, Gian Giacomo, 20 n., 24 n.,
93 n., 96 n.
indice dei nomi 223
Osborne, Toby, 197 n.Ossola, Carlo, 122 n., 170 n.
Pagnotti, F., 195 n.Palanque, Jean Rémy, 180 n.Paleologo (dinastia) , 11, 24, 97 e n.Palumbo, Paolo, 123Panero, Francesco, 106 n.Panisse Passis, Pierre-Marie Henri
de 75 n.Paoletti, Paolo, 177 n.Paolin, Giovanna, 169 n.Paolini, Lorenzo, 180 n. Paolo III, papa (Alessandro Farne-
se), 166 n.Paolo V, papa (Camillo Borghese),
196 n., 197Parker, Geoffrey, 28, 52 e n., 58 e n.Parrott, David, 28Pascal, Arturo, 212 n.Paserio, Pietro, 182 e n.Passamonti, Eugenio, 195 n.Pastore, Alessandro, 100 n.Pazè, Piercarlo, 172 n., 189 n. Pazè Beda, Bona, 189 n.Pene Vidari, Gian Savino, 109Pentorio, Isidoro, 191 n.Pepe, Adolfo, 19 n.Perrone di San Martino (famiglia),
81Petralia, Giuseppe, 20 n.Peyronel, Susanna, 211 n.Pezzino, Paolo, 20 n.Piano, Stefano, 210 n.Piano Mortari, Maria Teresa, 177 n.Piazza, Alessandro, 180 n., 190 n.Pieri, Piero, 52Pietro I, zar di Russia, 43Pinelli, Ferdinando, 27 n.Pingone, Emanuele Filiberto, 25
Piossasco (famiglia), 84, 152Piossasco de Feys, Giacomo, 153 n.Pissavino, Paolo, 188 n.Plongeron, Bernard, 180 n.Polissena d’Assia, regina di Sarde-
gna, 77Polonio, Valeria, 183 n.Pontormo, Jacopo Carrucci, detto
il Pontormo, 166 n.Ponziani, Luigi, 19 n.Povero, Chiara, 123, 189 n., 194 n.Prato, Giuseppe, 61 e n., 82 e n.,
119 e n., 139, 143Premoli, Orazio, 191 e n.Prodi, Paolo, 176 n., 177 n., 179
n., 180 n.Prosperi, Adriano, 170 n., 211 n.Puncuh, Dino, 180 n.
Quaglioni, Diego, 179 n.Quazza, Guido, 68 n., 76 n., 82 e
n., 141, 142 e n., 143, 152Quazza, Romolo, 44, 124 n.
Radicati (famiglia), 214Radicati di Passerano, Alberto, 82
n., 172Raffestin, Claude, 122 n.Ragazzoni, Mauro M., 191 n.Ragusa, Elena, 99 n.Ranza, Giovanni Antonio, 106 e n. Rao, Riccardo, 106 n. Rao, Anna Maria, 107 n.Raviola, Blythe Alice, 5, 23, 25 n.,
32 n., 33 e n., 49, 59 e n., 60 en., 88 e n., 89, 91, 97 n., 105,107 n., 108 n., 110 n., 112 n.,121 n., 125 n., 126 n., 130 n.,163 e n., 173 n., 184 n.
Ravizza, Giuseppe, 182
224 indice dei nomi
Reinhard, Wolfgang, 179 n.Riberi, Alfonso Maria, 182 n.Ricardi di Netro, Tomaso, 5, 67, 84
n., 88 n., 120 n., 152, 153 n. Ricardi, Francesca, 210 n.Ricciardi, Mario, 122 n.Richelieu, Armand-Jean Du Plessis,
duca di, 38Ricotti, Ercole, 27 n., 211 n.Ricuperati, Giuseppe, 4, 7, 9, 17
n., 31 n., 34 n., 36 n., 46 n., 61n., 68 e n., 73 n., 81 e n., 93 n.,96 n., 97 n., 102, 104 e n., 107n., 108 n., 109, 112 n., 119 n.,123, 141 n., 161 n., 172 n.,175 n., 199 n., 212 n.
Ridolfi, Maurizio, 19 n.Rigon, Antonio, 183 n.Roero (famiglia), 117, 205 n., 214Roero di Cortanze (famiglia), 130Roero di Cortanze, Ercole Tomma-
so, 125 n.Roero di Pralormo, Giovanni Batti-
sta, 204Roggero, Marina, 86 e n.Romagnani, Gian Paolo, 32 n., 211
n., 212 n.Romano, Giovanni, 78 n., 108 n.,
198 n. Romano, Ruggiero, 174 n.Romeo, Giovanni, 211 n.Rosa, Mario, 8 e n., 93 n., 111 e n.,
169 n., 170 n., 173 n., 178,179 n., 181 n., 186 n., 206 n.
Rosolino, Riccardo, 186 n.Rosso, Claudio, 17 n., 34 e n., 44 e
n., 72, 78 n., 80 n., 81 e n., 93n., 96 n., 97 e n., 102, 103 e n.,104 n., 141 e n., 142
Rosso, Paolo, 191 n.Ruggieri, Giuseppe, 167 n.Rusconi, Roberto, 167 n.
Saccardo, Luigi, 209 n.Sacchetti, Cesare, 181 e n.Saluzzo (famiglia), 11Saluzzo di Paesana (famiglia), 143Salvemini, Biagio, 19 n.San Benedetto il Moro, 206 n.Sangalli, Maurizio, 167 n., 190 n.,
191 n.San Martino di Cardè, Casimiro,
88 n.San Martino di Cardè, Marianna,
88 n.San Maurizio, 201Santacroce, Ottavio, 199 n.Saroglia, Giovanni, 182 e n.Savio, Carlo Fedele, 181 e n., 182
e n.Savoia (dinastia), 11, 12 n., 24, 44
n., 80 n., 97, 127 n., 153 n.,202 n., 207
Savoia, Benedetto Maurizio di, du-ca del Chiablese, 76
Savoia, Emanuele Filiberto di, vice-ré di Sicilia, 80
Savoia, Maurizio di, cardinale, 197e n., 203
Savoia Carignano (principi di), 75,76, 77
Savoia Carignano, Emanuele Fili-berto Amedeo di, 78
Savoia Carignano, Luigi Vittorio di,77
Savoia Carignano, Tomaso I di, 80,141
Savoia Racconigi (famiglia), 75 n.Savoia Soissons (famiglia), 77
indice dei nomi 225
Savoia Soissons, Eugenio di, prin-cipe, 77
Scaglia di Verrua, Alessandro, 197Scandaliato, Isotta, 177 n.Schiera, Pierangelo, 24 n., 91 n.Schilling, Heinz, 71 n.Schutte, Anne Jacobson, 179 n.Scorza Barcellona, Francesco, 205
n.Scott, Hamish M., 45 n., 101 n.Scotti Douglas, Vittorio, 50 n.Seidel Menchi, Silvana, 179 n.Semeria, Giovanni Battista, 181 e n.Sereno, Paola, 122 n.Settia, Aldo A., 97 n., 183 e n.Signorelli, Bruno, 106 n., 154 n.,
189 n.Signorotto, Gianvittorio, 188 n.,
197 n.Silvestrini, Maria Teresa, 107 n.,
173 n., 186Sisi, Carlo, 84 n.Sisto IV, papa (Francesco Della Ro-
vere), 183Soffietti, Isidoro, 80 n.Solaro (famiglia), 73, 214Solaro di Moretta, Agassino, 202Sorella, Vincenzo, 123Spantigati, Carlenrica, 84 n.Stango, Cristina, 77 n., 211 n.Stella, Aldo, 111 n.Stella, Pietro, 178 n.Stoppiglia, Angelo Maria, 191 n.Storrs, Christopher, 45 e n., 82 e
n., 101 e n., 112 n.Stroppa, Sabrina, 192 n.Stumpo, Enrico, 29, 34 e n., 55 e
n., 81 e n., 119 e n., 139 e n.,142 e n., 148
Sturani, Maria Luisa, 135 n.
Symcox, Geoffrey, 17 n., 33 e n., 34e n., 81 n., 93 n., 96 n., 97 n.,101 e n., 102, 104 n., 141 n.
Tabacco, Giuseppe, 71 n., 94Taffini, Camillo, 72Tallett, Frank, 28Tallone, Armando, 68 n.Teodoro I Paleologo, marchese del
Monferrato, 97 n.Tesauro, Emanuele, 25Tiziano, Tiziano Vecellio, 166 n.Tocci, Giovanni, 111 n.Tolomeo, Claudio, 23 Tornielli (famiglia), 128Torre, Angelo, 95 n., 99 e n., 100
n., 131 n., 145 e n., 146, 174n., 179 e n., 186
Torrione, Pietro, 191 n., 204Traniello, Francesco, 180 n.Trevelyan, George Macaulay, 70 n.Trolese, Francesco G.B., 183 n.Tuniz, Dorino, 210 n.Turchini, Angelo, 174 n.Turtas, Raimondo, 180 n.
Ughelli, Ferdinando, 213Uscello, Pietro, 106 n., 189 n.
Vaccaro, Luciano, 210 n.Vasco di Bastia, Francesco Dalmaz-
zo, 172 n.Valperga di Rivara (famiglia), 143Varanini, Gian Maria, 22 n., 156
n., 183 n.Vassallo, Nicola, 183 n.Vauban, Sébastien La Preste de, 39,
42Vauchez, André, 168 n., 170 n.,
206 n.
226 indice dei nomi
Ventura, Angelo, 19 n., 141Venturi, Franco, 82 e n., 113, 172
e n. Verboom, Flamand, 43Verga, Marcello, 111 n., 170 n.Vester, Matthew, 47 e n.Violante, Cinzio, 177 n.Viora, Mario, 83 e n.Visceglia, Maria Antonietta, 111
n., 170 n., 197 n.Visconti (dinastia), 11Vismara, Paola, 191 n.Vittorio Amedeo I, duca di Savoia,
37Vittorio Amedeo II, duca di Sa-
voia, re di Sicilia, infine re diSardegna, 17, 33 e n., 37, 45,53, 68, 79, 80, 86, 96 n., 101n., 103, 111, 126, 134
Vittorio Amedeo III, re di Sarde-gna, 35 n., 78, 86
Vivanti, Corrado, 111 n.Volpe, Gioacchino, 148 n.
Wittelsbach (famiglia), 71Woolf, Stuart John , 141, 142 e n.,
143
Zangheri, Renato, 19 n.Zanzi, Luigi, 210 n.Zanzi, Paolo, 210 n.Zapperi, Roberto, 166 e n.Zardin, Danilo, 188 n., 209 n.Zarri, Claudio, 110 n.Zarri, Gabriella, 179 n.Zito, Gaetano, 179 n.Zucchi, Carlo, 50 n.
indice dei nomi 227