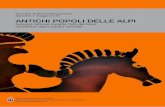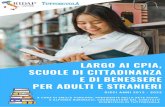Centocinquant’anni di istruzione commerciale in Italia e in Piemonte in a cura di Ester De Fort,...
Transcript of Centocinquant’anni di istruzione commerciale in Italia e in Piemonte in a cura di Ester De Fort,...
Centocinquant’anni di istruzione commerciale in Italia e in Piemonte.
«Stüdia ‘l latin e ‘l grec, se vuoi riuscire nel commercio» un padre consigliava al figlio in una vignetta umoristica di un giornale milanese degli anni Trenta1. La battuta fotografava icasticamente alcuni elementi caratterizzanti nel lungo periodo l’istruzione secondaria nel nostro paese. Il primato a lungo detenuto dall’istruzione classica, certamente. E di riflesso la subalternità culturale rispetto alle classi dirigenti di quei ceti intermedi – non solo naturalmente commercianti – che aspiravano per i propri figli a una collocazione nel settore dei servizi. Ma anche la natura in fondo ibrida dell’istruzione commerciale, un percorso formativo di tipo tecnico ma necessariamente inglobante anche un sapere umanistico, essenziale non solo per l’attività strettamente commerciale – che peraltro divenne un obiettivo presto secondario di questo ordine di scuole – ma anche in vista delle funzioni impiegatizie, fossero esse meramente esecutive o di “concetto”, nel settore pubblico come in quello privato. Ne derivò la tendenza, più o meno accentuata a seconda del periodo storico, a imitare i licei e a differenziarsi dalle scuole professionali e una continua, affannosa, ricerca sul piano didattico del migliore equilibrio possibile fra cultura generale e competenze tecniche specifiche.
L’istruzione commerciale prima dell’istruzione commerciale La pratica dell’istruzione commerciale – ancorché non formalizzata come tale – ha origine
antichissima. Essa può essere fatta risalire quantomeno al basso Medioevo quando con l’espansione dei commerci si diffuse la necessità di una qualche preparazione settoriale che permettesse a commercianti, banchieri, spedizionieri e cambiavalute di governare strumenti contabili e finanziari sempre più sofisticati. Fu così che, contemporaneamente alla comparsa del termine “ragioniere”2, nella Toscana del XIII sec. nacquero le “scuole d’abaco e quaderno”3, le prime che potremmo appunto definire “tecniche”. In luogo delle arti liberali del Trivio e del Quadrivio, vi si trasmettevano conoscenze di carattere pratico, ma necessitanti un grado minimo di formalizzazione che li distinguesse dall’apprendimento per imitazione caratteristico dell’apprendistato. Si trattò in realtà di una innovazione “rivoluzionaria”: in quelle scuole si somministrarono per la prima volta insegnamenti in lingua volgare e si introdussero in Europa l’aritmetica di derivazione arabo-indiana, assai più adatta per registrazioni di crescente complessità rispetto al vecchio abaco greco-romano. Parallelamente, la domanda di tecnici contabili fu alimentata anche dalla contabilità “pubblica” (la più antica “ragioneria di stato” per l’Italia è il genovese Cartulario del Massaro di cui si ha notizia a partire dal 1340). Sempre significativamente in Italia, dal XV secolo fecero la loro comparsa anche i primi manuali di contabilità, il più importante dei quali è senza dubbio la Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalità di Fra Luca Pacioli, ritenuto il sistematizzatore del metodo della partita doppia.
Assieme al tramonto del primato italiano nel campo dell’innovazione contabile, l’età moderna segnò anche l’inizio di un crescente ritardo dell’Italia in quello dell’istruzione “secondaria”, rispetto ai paesi dell’Europa settentrionale. Mentre nel mondo tedesco e nell’Inghilterra dell’incipiente rivoluzione industriale la generale rivalutazione della cultura tecnico-scientifica determinava la nascita delle prime vere e proprie scuole tecniche, fra cui anche quelle a indirizzo commerciale, in Italia – marginalizzate dalla controriforma gesuitica le scuole d’abaco – l’istruzione tecnico-scientifica diveniva appannaggio degli ordini religiosi che la subordinarono a quella classico-retorica, ritenuta più adatta al disciplinamento e all’educazione religiosa dei fanciulli. Erano in particolare ravvisabili nozioni assimilabili all’istruzione
1 A. Santoni Rugiu, La lunga storia della scuola secondaria, Carocci, Roma, 2007; p. 88. 2 Ad introdurlo per primo in volgare fu Bono Giamboni alle fine del Duecento. Il sostantivo ragioniere viene dal latino,
dove in rationem inducere o rationes putare valgono a “calcolare”, mentre il reddere rationem prima ancora del
significato figurato che ancor oggi conserva indicava propriamente il “rendere conto”. Cfr. Maria Gabriella Stassi, La
figura del ragioniere nella letteratura dell’Otto-Novecento, in A. d’Orsi (a cura di), Una scuola, una città. I
centocinquant’anni di vita dell’istituto “Germano Sommellier” di Torino, Torino, 2003; p. 217 e ss. 3 Cfr. F. Melis, Storia della ragioneria, Zuffi, Bologna, 1950, p. 608 e ss.; A. Santoni Rugiu, Storia della scuola
secondaria, cit., 2007; p. 22 e ss.; F. Piseri, Il ‘corpo mercantesco’ tra tardo Medioevo e Rinascimento: formazione e
professionalizzazione, in M. Morandi (a cura di), Formare alle professioni. Commercianti e contabili dalle scuole
d’abaco ad oggi, Franco Angeli, Milano 2013; pp.25-43.
commerciale negli insegnamenti somministrati nei collegi degli oratoriani di San Filippo Neri e dei Padri Somaschi, la cui offerta scolastica rispondeva soprattutto alla domanda di formazione proveniente dagli stati intermedi delle società.
A modificare quest’impostazione non sarebbero valse le aspre critiche rivolte dagli illuministi al modello pedagogico tradizionale, quello codificato nel corso del XVI sec. dalla gesuitica Ratio studiorum, fondato sul primato dell’insegnamento umanistico tradizionale, della teologia e del latino, impartito in scuole confessionali, miranti perlopiù alla formazione delle élite aristocratiche e del clero. Né maggiore ascolto avrebbe incontrato la proposta di una pedagogia alternativa che non prevedesse l’assoluta passività del discente e facesse spazio alla cultura scientifica e tecnica, di cui ora gli illuministi sottolineavano in termini nuovi l’importanza anche per la formazione della personalità. Poco incisivi – con l’eccezione della Lombardia in epoca teresiana e giuseppina4 – si sarebbero infatti rivelati gli interventi in merito praticati dagli antichi stati italiani, incamminatisi molto cautamente lungo la strada di un loro maggior coinvolgimento nel campo dell’istruzione, di cui non si voleva peraltro mettere in dubbio la natura confessionale e il primato su di essa esercitato dalla Chiesa. Un primo mutamento si ebbe solo durante il periodo napoleonico quando si tentò anche in Italia di delineare i primi elementi di un sistema scolastico pubblico, affrancato dall’ingerenza ecclesiastica.5 Si trattò di una innovazione effimera – per mancanza di tempo, risorse e personale adeguato, ma anche di una chiara volontà politica – ma che seminò un’istanza di modernizzazione dell’offerta scolastica destinata laddove incontrò condizioni, economiche e culturali, meno sfavorevoli a dare qualche disorganico frutto già prima dell’Unità. Anche per quanto riguarda l’istruzione tecnica, giacché era urgente sopperire al ruolo un tempo svolto dalle corporazioni di mestiere, la cui funzione nel campo della trasmissione dei diversi saperi professionali era del resto da tempo anacronistica. Così, nel Lombardo-Veneto austriaco e negli stati legati a Vienna (Toscana e Regno delle Due Sicilie) a lato dei primi licei-ginnasi pubblici vennero introdotti corsi settoriali e professionalizzanti rivolti a formare specifiche figure professionali (fra cui i contabili). Sempre in Lombardia – la regione che fin dal Settecento era stata la più interessata dal fenomeno della diffusione a livello locale delle scuole di arte e mestieri rivolte alle classi popolari – nacquero le prime scuole tecniche pubbliche, sul modello delle realschulen austriache e prussiane, a cui si accedeva terminato il ciclo dell’istruzione elementare articolato in sei anni. Fra le materie di insegnamento chimica e meccanica, ma anche lingue straniere e computisteria. E dal 1854 anche “l’arte di tenere ragione”, ossia appunto la moderna “ragioneria”. Analogamente, in Toscana, la legge del 1852 che per la prima volta riordinava l’istruzione nel suo complesso, a fianco dei licei-ginnasi costituiva delle scuole tecniche per quanti volessero “dedicarsi all’agricoltura, al commercio e alle arti”,6 mentre nella Parma di Maria Luisa si riformavano nel 1857 le scuole secondarie, introducendo come materie di insegnamento insieme alla geografia e alla storia patria, le scienze, la pratica commerciale e la lingua francese7.
L’istruzione commerciale nel sistema scolastico casatiano La storiografia ha però privilegiato lo studio delle innovazioni introdotte nel Regno sardo. Per il
loro profilo riformatore, certo, ma soprattutto per il fatto di essere state successivamente estese, con pochi adattamenti alle altre realtà regionali, al resto della penisola. A partire dal biennio 1847-48 e nel “decennio di preparazione”, accompagnato da un vivace dibattito – e in un contesto, quello piemontese, già attraversato da più di una iniziativa locale nel campo dell’istruzione tecnica e professionale –,8 si assistette in Piemonte alla nascita di un moderno sistema d’istruzione pubblico.
4 Il piano di riforma giuseppino solo parzialmente tradotto in realtà prevedeva dopo un ciclo elementare comune
obbligatorio un sistema scolastico secondario articolato in ginnasi-licei con insegnamento del latino e una scuola tecnica
con studio della matematica e delle lingue. 5 Cfr. S. Bucci, La scuola italiana nell’età napoleonica. Il sistema educativo e scolastico francese nel Regno d’Italia,
Bulzoni, 1976, Roma 6 Giuseppe Inzerillo, Storia della politica scolastica in Italia, Editori Riuniti, Roma 1974; p. 31 7 Giuseppe Talamo, La scuola. Dalla legge Casati all’inchiesta del 1864, Giuffré, Milano, 1960; p. 11. 8 Cfr. E. De Fort, La formazione professionale agli albori dell’industrializzazione: l’Ottocento in E. De Fort, S. Musso
(a cura di), Storia della formazione professionale in Piemonte dall’Unità d’Italia all’Unione Europea, Regione Piemonte,
Torino, s.d.
Alla fine del 1847, con l’obiettivo di procedere all’uniformazione delle politiche scolastiche sul territorio del regno, in luogo dell’antico Magistrato della Riforma venne creato il Ministero della Pubblica Istruzione.9 L’anno dopo, grazie ai pieni poteri conferiti al governo in occasione della prima guerra d’Indipendenza, il ministro della Pubblica Istruzione, Carlo Bon Compagni emanava un nuovo Ordinamento dell’amministrazione dell’istruzione pubblica con il quale si articolava l’istruzione pubblica su tre livelli: elementare, secondario e universitario.10 A fianco della scuola “classica”, l’unica abilitante agli studi universitari e dunque l’unica propriamente secondaria, ne veniva introdotta ora anche una “tecnica”, per «preparare all’esercizio di professioni per le quali non è destinato alcuno speciale insegnamento all’Università». In concreto, il ministero si limitò a istituire dei collegi nazionali a Torino11, Genova e Nizza, presso i quali fu creato un corso speciale di cinque anni senza latino che forniva una preparazione tecnica generica12. Finalizzati a offrire un insegnamento di tipo pratico, questi nuovi corsi finirono però con l’andare generalmente deserti, giacché «esisteva una fondata perplessità nell’intraprendere un cammino che, a fronte degli imprecisi esiti professionali, escludeva da quegli sbocchi concreti che erano invece garantiti dalle scuole di latinità, l’accesso cioè all’università o perlomeno agli impieghi»13.
Nel 1856 – visti gli scarsi risultati ottenuti – la scuola tecnica venne ristrutturata dal ministro Lanza in due cicli, uno biennale a carattere generale e uno triennale, specialistico, diviso in indirizzo commerciale e industriale14. Questo impianto venne sostanzialmente ribadito nel 1859 dalla successiva legge Casati15. Promulgata anch’essa grazie ai pieni poteri derivati al governo dallo stato di guerra (era in corso la seconda guerra d’Indipendenza) questa era destinata a rimanere il punto di riferimento normativo per la scuola in Italia fino e per certi versi anche oltre la riforma Gentile del 1923, conferendole i suoi elementi strutturali. La Casati introdusse la distinzione fra scuole tecniche (ciclo inferiore di tre anni) e istituti tecnici (ciclo superiore, sempre di tre anni)16, ora suddivisi in quattro indirizzi: amministrativo-commerciale17, agronomico, chimico e fisico-matematico (l’unico che in virtù del Regolamento dettato dal ministro Mamiani nel 1860, consentisse, limitatamente alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l’accesso all’Università)18.
Si trattava di un insieme di disposizioni che impegnavano sì lo Stato sul fronte dell’istruzione tecnica, ma che si sarebbero rivelate insufficienti a realizzare appieno l’indicazione data autorevolmente da Cavour a non trascurarla se non si voleva «aggravare il disaccordo fra i nuovi bisogni della nostra società e il sistema d’educazione ereditato dai nostri padri»19. Riletture recenti hanno in qualche modo più puntualmente ricostruito il contesto culturale a cui la politica scolastica della classe dirigente liberale va riportata, senza però che il giudizio storiografico sulla legge Casati da tempo ampiamente acquisito ne
9 Cfr. soprattutto Roberto Berardi, Scuola e politica nel Risorgimento. L’istruzione del popolo dalle riforme carlalbertine
alla legge Casati (1840-1859), Paravia, Torino, 1982. 10 Legge del 4 ottobre 1848, n. 819 11 E. De Fort, L’istruzione primaria e secondaria e le scuole tecnico-professionali, in Storia di Torino (1798-1864), a
cusa di U. Levra, Einaudi, Torino 2000; p. 606. 12 Cfr. A. Tonelli, L’istruzione tecnica e professionale di stato nelle strutture e nei programmi da Casati ai giorni nostri,
Giuffré, Milano, 1964; p. 6. 13 E. De Fort, L’istruzione tecnica dal Piemonte preunitario alla riforma Gentile, in Una scuola, una città. I
centocinquant’anni di vita dell’Istituto “Germano Sommeiller” di Torino, a cura di Angelo d’Orsi, ITCS Germano
Sommeiller, 2003, Torino; p. 27. Per ovviare a questo loro sostanziale insuccesso, si dovette successivamente garantire
quanto meno a chi vi avesse studiato l’accesso ai ranghi inferiori della pubblica amministrazione. 14 R.D. 7 settembre 1956 15 R.D. del 13 novembre 1859, n. 3725. 16 In realtà nel successivo regolamento attuativo (Regolamento per le scuole tecniche e gli istituti tecnici, RD 19 settembre
1860) il ministro Mamiani forzò la legge Casati riducendo a due anni il ciclo superiore della scuola tecnica, con esclusione
di quello fisico-matematico la cui durata fu mantenuta in tre anni visto anche che lo stesso Mamiani aveva disposto
abilitasse al proseguimento degli studi. Lo stesso regolamento prescriveva l’apertura di una scuola tecnica in ogni
circondario, mentre per gli istituti tecnici si lasciava una certa discrezione alle autorità locali, che avrebbero dovuto
provvedervi qualora le condizioni dell’economia locale lo richiedessero. Cfr. S. Soldani, L’istruzione tecnica nell’Italia
liberale (1861-1900), in “Studi Storici”, 1, XXII, 1981; pp. 79-117. 17 In questa sezione fra gli insegnamenti era presente una cattedra di computisteria, ma non ancora di ragioneria. 18 R.D. del 15 settembre 1860, n. 4336 19 Cfr. A. Santoni Rugiu, La lunga storia della scuola secondaria, cit.; p.68.
risultasse sostanzialmente modificato20. Anche i limiti e i fattori di intrinseca debolezza della scuola italiana nei primi decenni unitari sono stati ormai ampiamente esplorati. Sia sufficiente qui ricordare che ogni politica nel campo dell’istruzione era di fatto condizionata dalla presenza di un tasso di analfabetismo drammaticamente elevatissimo, soprattutto nel Mezzogiorno, dall’inesistenza di un sistema scolastico in larga parte del paese, nonché dalla difficoltà di reperire e formare un personale adeguato che sostituisse quello di provenienza ecclesiastica. Per tacere delle carenze nel campo dell’edilizia scolastica. Se l’istruzione secondaria rappresentava il «problema più complesso» dal punto di vista politico e culturale, il «problema più grosso»21 e più urgente era quindi quello dell’istruzione elementare. Ma, nonostante la sua importanza in funzione di strumento di socializzazione degli strati popolari ai valori nazionali non sfuggisse certo alle classi dirigenti liberali, si scelse di caricarne l’onere sulle spalle delle amministrazioni locali. Lo stesso accadde per l’istruzione tecnica, avendo stabilito la legge che scuole e istituti tecnici avrebbero dovuto nascere per iniziativa locale ed essere in massima parte finanziate dai comuni22. Contrariamente a quella classica – finanziata dallo Stato che in ogni capoluogo provinciale si impegnava a costruire almeno un ginnasio-liceo – l’istruzione tecnica-professionale doveva infatti vivere del rapporto diretto con il territorio, rispondendo con flessibilità alle istanze di un’economia e di un mercato del lavoro – non lo si dimentichi – all’epoca ancora molto segmentati geograficamente.
Se questo assunto rispondeva alla cultura politica largamente condivisa dalla classe dirigente liberale – per cui il ruolo dello Stato doveva essere limitato, soprattutto in relazione alle concrete dinamiche economiche – e dunque non voleva suonare come un disconoscimento dell’importanza dell’istruzione tecnico-professionale, concretamente, per quanto propriamente concerne l’istruzione secondaria, la Casati risultò come una riconferma del primato della cultura umanistica tradizionale – degli studi letterari e soprattutto del latino – a danno della diffusione di una moderna cultura tecnico-scientifica23. Si finiva – è stato osservato – di riutilizzare il paradigma pedagogico precedente – laicizzandolo e adeguandolo ai tempi – come terreno di unificazione di «un ceto medio altrimenti attraversato da molteplici linee interne di frattura, per provenienza geografica e fortune materiali, per natura sociale e ideologica»24. Si offriva cioè – anche prima della riforma Gentile – un modello culturale che ostentato dalle élite dirigenti era potenzialmente condivisibile anche dai ceti intermedi, con l’effetto di perpetuare nel tempo un pregiudizio favorevole all’istruzione classica anche in chi aspirava a formarsi una professionalità tecnico-scientifica.
Da questo impianto ideologico derivava la natura a “compartimenti stagni” – “duale” o “tripolare” – del sistema scolastico italiano. Classico, tecnico e professionale, così come concepiti dalla Casati, erano infatti fra loro percorsi non comunicanti, destinati il primo alla formazione delle nuove classi dirigenti, il secondo a rispondere alla domanda di qualificazione professionale delle borghesia medio-piccola, il terzo alla preparazione di lavoratori specializzati, in una sempre auspicata, ma mai completamente realizzata, sinergia con il mondo del lavoro. La biforcazione molto precoce dei percorsi scolastici – terminato il ciclo elementare – produceva, come è noto e come peraltro accadeva all’epoca anche nel resto d’Europa, una distorsione classista, avviando agli studi secondari i pochi che vi potevano accedere, non in base al merito o a interessi e predisposizioni, ma in base alla provenienza socio-economica. Tutto ciò si sommava al regime giuridico diverso che caratterizzava l’istruzione classica rispetto a quella professionale, ma per lunghi tratti anche rispetto a quella tecnica, e che ebbe riflessi precisi nel disegnare le competenze degli organi di governo centrale e locale. Un tratto peraltro strutturale – rintracciabile anche a Novecento inoltrato – del sistema scolastico italiano.
20 Cfr. A. Scotto di Luzio, La scuola degli italiani, Il Mulino, Bologna, 2007. 21 C.G. Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia 1859-1914, Giunti, Firenze, 1953; p. 51. Sull’istruzione
secondaria nell’Italia liberale vedi, oltre al qui citato testo di Lacaita (pg. 51-107), anche C.G. Lacaita, M. Fugazza (a
cura di), L’istruzione secondaria nell’Italia unita. 1861-1901, Franco Angeli, Milano, 2013. 22 La legge Casati all’articolo 283 stabiliva che gli istituti tecnici «potranno essere aperti, a misura che il bisogno se ne
farà sentire, nelle città che sono centro di un più notevole movimento industriale e commerciale». Lo stato avrebbe
concorso alle spese solo per una somma pari alla metà degli stipendi dei docenti mentre il resto era a carico dei comuni. 23 Che tale fosse la considerazione dei contemporanei per l’istruzione tecnica lo dimostrava peraltro la necessità avvertita
dal legislatore di vietare nella legge Casati la costituzione di nuovi ginnasi e licei nei centri urbani ancora privi di scuole
tecniche. 24 A. Scotto di Luzio, La scuola degli italiani, cit.; p. 24.
Ne derivava una collocazione poco confortevole per l’istruzione tecnica nell’economia generale del sistema scolastico e un carattere ibrido dal punto di vista didattico. Orientata anch’essa a identificare nella cultura retorico-letteraria l’elemento unificatore della nuova borghesia “nazionale”, e quindi condannata a un sostanziale complesso d’inferiorità verso l’indirizzo classico, era al tempo stesso risospinta – per la logica stessa della sua natura – verso il modello dell’istruzione professionale, peraltro a lungo rimasto indefinito nei suoi contenuti e con cui avrebbe condiviso lunghi tratti di storia. La preoccupazione di offrire agli studenti anche una buona cultura umanistica si sarebbe spesso spinta al punto di sacrificare l’obiettivo di coniugare la specializzazione professionale con una adeguata preparazione generale di tipo tecnico-scientifico. Ne avrebbero fatto le spese soprattutto l’indirizzo fisico-matematico e quello commerciale, per tante ragioni meno assimilabili rispetto agli altri alla formazione professionale.
Si finì così con l’avere nel primo ciclo – quello della scuola media – scuole tecniche che erano dei ginnasi “senza latino”, finalizzati a fornire ai figli della piccola borghesia una cultura generale, prevalentemente umanistica, rivelatasi troppo vasta ed eterogenea per essere realmente propedeutica al proseguimento degli studi negli istituti tecnici. E nel secondo ciclo, istituti tecnici i quali, per parte loro, non riuscirono mai a configurare percorsi effettivamente professionalizzanti. Non sorprende allora constatare come fosse tutt’altro che naturale il passaggio fra i due ordini di scuole: la maggioranza degli studenti degli istituti tecnici erano per lo più provenienti dai ginnasi, spesso preferiti per motivi di prestigio alle scuole tecniche anche da quelle famiglie che non ambivano per i figli agli studi universitari. Parallelamente, chi iscriveva i propri figli alle scuole tecniche non lo faceva in vista della prosecuzione degli studi, ma affinché completassero la propria istruzione di base viste le lacune di quella fornita nel ciclo elementare.
Nei primi decenni post-unitari, al profilo incerto dell’istruzione tecnica avrebbe contribuito anche la continua disaggregazione e riaggregazione dei suoi indirizzi. Essa fu sostanzialmente dovuta al passaggio delle competenze in merito di istruzione tecnica e professionale dal Ministero della Pubblica Istruzione a quello di Agricoltura, Commercio e Industria avvenuto nel 1861 e al tentativo da questo operato negli anni successivi, senza successo, di unificare scuole tecniche e professionali, nell’ottica di una maggiore integrazione fra sistema scolastico e mondo del lavoro25. Nel 1864, con l’obiettivo di creare una scuola per ogni possibile professione, gli indirizzi – ribattezzati ora “scuole speciali” o “scuole riunite” – divennero ben 3126. Per l’istruzione tecnica commerciale erano tre: la scuola speciale di ragioneria, la scuola speciale di commercio e quella riunita di commercio e amministrazione. La riforma durò solo un anno, poi lasciò il posto a una progressiva riaggregazione. Nel 1865 i ricostituiti istituti tecnici-professionali furono divisi in nove sezioni fra cui commercio e amministrazione (tre anni per il titolo di perito commerciale) e ragioneria (tre anni per il titolo di perito ragioniere). Vennero anche introdotte a livello locale delle Giunte di vigilanza con l’obiettivo di promuovere il loro raccordo e soprattutto di facilitarne la capacità di rispondere alle domande di istruzione tecnica del territorio (organizzati su base provinciale i loro membri erano indicati dai consigli provinciale e comunali, dalla camera di commercio e dalla prefettura).
Nel 1871, il ministro Minghetti tornò sostanzialmente allo schema casatiano, abortendo di fatto il tentativo di unificare istruzione professionale e istruzione tecnica. Si allungò di un anno il ciclo della secondaria superiore (diviso in un biennio comune a tutti e in un biennio di specializzazione) e si ridussero a quattro gli indirizzi (“sezioni”) degli istituti ora nuovamente denominati “tecnici”: agraria, industriale, fisico-matematica e commerciale (per quest’ultima era previsto un quinto anno di studio per l’ottenimento del titolo di perito ragioniere)27. Nel 1876, il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Majorana
25 R.D. del 28 novembre 1861, n. 347. Va notato che invece le “scuole tecniche”, ossia il ciclo inferiore continuò ad essere
di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. 26 Cfr. Regio Decreto, 14 agosto 1864, n. 1354, Programmi degli insegnamenti industriali e professionali per gli istituti
tecnici e le scuole speciali dipendenti dal ministero di agricoltura, industria e commercio. Il ministro di Agricoltura,
Industria e Commercio in carica era Giovanni Manna. 27 Nei programmi d’insegnamento definiti nel 1871 risultavano per la sezione commerciale al III e al IV anno 5 ore di
italiano, 2 di geografia, 3 di storia, 2 di francese, 4 di tedesco o inglese, 5 di computisteria, 5 di diritto civile e commerciale,
3 di economia politica, 3 di storia naturale applicata al commercio (laddove effettivamente disponibile la strumentazione
necessaria, altrimenti venivano ampliate le ore a disposizione delle lingue straniere), 6 di disegno ornamentale. Al IV
Calatabiano creò una quinta sezione, quella di agrimensura (per geometri) e ridenominò l’indirizzo commerciale, in sezione di “commercio-ragioneria”, riportandola a quattro anni28. Con questo impianto nel 1878 gli istituti tecnici alla temporanea dissoluzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ritornarono nuovamente in seno al Ministero della Pubblica Istruzione, separandosi così dall’istruzione professionale restituita, all’atto della sua ricostituzione, al dicastero economico29. Da quel momento non vi furono più mutamenti nel loro ordinamento fino alla riforma Gentile30. Si intervenne, invece, nel 1885 sul loro regolamento. La novità più importante per l’indirizzo commerciale fu costituita dalla partizione, che avversata peraltro da una parte dei collegi dei ragionieri31 ebbe vita breve – fu abolita con il regio decreto 2 ottobre 1891, n. 62232 –, del biennio specialistico in una sottosezione di commercio e ragioneria privata e in una sottosezione di amministrazione e ragioneria pubblica33. Conseguenze forse più rilevanti ebbero le modifiche relative all’esame di ammissione agli istituti tecnici cui ora erano sottoposti anche quanti provenivano dalla scuola tecnica la quale peraltro vide la suddivisione dell’ultimo anno di corso in due sezioni parallele, una per l’avviamento agli istituti tecnici, l’altra per il conseguimento della licenza tecnica34.
Non sorprende dunque constatare come in questa prima fase della loro storia gli istituti tecnici abbiano avuto uno scarso successo in termini di iscrizioni. Troppo elitari e selettivi per i ceti intermedi della società italiana (cui pure avrebbero dovuto essere destinati), troppo poco appetibili per le famiglie della buona borghesia, anche di quella imprenditoriale, che per i loro figli continuavano a preferire l’istruzione classica. Nel 1885-’86 risultavano così aperti in tutto il regno solo 73 istituti tecnici – i licei erano già 326 – di cui 46 erano governativi con 5523 iscritti, 19 “pareggiati” con 1480 iscritti, uno non pareggiato con 9 iscritti e 7 privati con 369 iscritti. Su un totale di 7381 alunni, 1078 frequentavano le sezioni di commercio e ragioneria35. Solo nel periodo giolittiano – in ragione anche dello sviluppo
anno all’orario di 38 ore si aggiungevano 3 ore di statistica. Il V anno utile per il conseguimento del titolo di perito
ragioniere era articolato su sole 15 ore settimanali di cui 10 di ragioneria e 5 di diritto amministrativo. 28 Si noti che in quel momento la popolazione scolastica degli istituti tecnici era ancora molto esigua: nell’anno scolastico
1874-75 i 37 istituti tecnici governativi cui si aggiungevano i 33 non governativi presentavano 5495 fra alunni e uditori,
suddivisi in 688 nella sezione agronomica, 557 in quella commerciale, 511 nella fisico-matematica e appena 88 nella
sezione industriale. Peraltro i tre quarti degli iscritti erano concentrati al Nord, e la metà circa nel nord-ovest. Cfr. E.
Morpurgo, L’istruzione tecnica in Italia, Roma, 1875; pp. 78-79. 29 R.D. del 26 dicembre 1877, n. 4220. 30 Prima della riforma Gentile si può segnalare di fatto solo la revisione degli insegnamenti all’interno del ciclo inferiore,
dove nel 1899 vennero introdotti tre indirizzi distinti: agricolo, industriale e commerciale. In quelle commerciali fu
aggiunto a partire dal secondo anno la computisteria, l’inglese e il tedesco e dal terzo la merceologia. Disposto dal ministro
Baccelli, questa ridefinizione in senso professionalizzante delle scuole tecniche si dimostrò un sostanziale fallimento, in
termini di iscrizioni. 31 Cfr. Gianpiero Fumi, L’insegnamento della materie economico-commerciali negli istituti tecnici in C.G. Lacaita, M.
Fugazza (a cura di), L’istruzione secondaria nell’Italia unita. 1861-1901, cit.; pp. 174-209. 32 Il decreto in questione interveniva anche a apportare lievi variazioni ai programmi d’insegnamento per gli istituti tecnici.
Per la sezione di commercio e ragioneria erano previste: al primo anno 6 ore di disegno, 3 di geografia, 6 di lettere italiane,
3 di lingua francese, 6 di matematica, 3 di storia naturale, 3 di storia generale; al secondo anno, 2 di calligrafia, 4 di
computisteria e ragioneria, 3 di geografia, 5 di lettere italiane, 3 di lingua francese, 3 di lingua inglese o tedesca, 2 di
logica ed etica, 5 di matematica, 3 di storia naturale (mineralogia e geologia), 3 di storia generale; al terzo anno, 1 di
calligrafia, 3 di chimica generale, 5 di computisteria e ragioneria, 3 di diritto civile, 3 di economia politica, 5 di fisica
generale, 4 di lettere italiane, 2 di lingua francese, 5 di lingua inglese o tedesca, 2 di storia generale; al quarto anno, 2 di
calligrafia, 9 di computisteria e ragioneria, 4 di diritto commerciale e amministrativo, 4 di scienza finanziaria e statistica,
6 di lettere italiane, 2 di lingua francese, 5 di lingua inglese o tedesca. 33 Cfr. Regio decreto, 21 giugno 1885, n. 3454, Disposizioni regolamentari didattiche, II, Istituti tecnici. 34 Costoro per la verità venivano esaminati solo su quelle materie che non avevano costituito oggetto di studio presso la
scuola tecnica. 35 Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Statistica dell’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico
1885-86, Roma, 1887. L’esame di licenza si presentava piuttosto severo sia nelle scuole tecniche che negli istituti tecnici:
nel 1885-86 nelle scuole tecniche furono licenziati il 72% dei candidati, il 38% a fine corso e il 34% dopo gli esami di
riparazione; negli istituti tecnici il dato era leggermente più basso, 68% di promossi, 33% dopo l’esame di fine corso,
35% dopo quello di riparazione. La percentuale dei bocciati era dunque in genere molto alta (un terzo circa dei candidati),
ma fletteva nella sezione commercio e ragioneria (22,71%). Nel determinare un tasso così alto di respinti all’esame
influiva però l’uso della cosiddetta “istruzione paterna”, il numero cioè ancora assai alto di candidati che si presentavano
all’esame dopo aver condotto studi privati, dei quali circa i 2/3 risultavano respinti. Va infine ricordato che la legge
industriale di inizio secolo – fu colmato il divario che separava in termini di iscrizioni gli istituti tecnici dai licei36.
In questo quadro, la situazione piemontese si presentava come la più avanzata. In alcuni casi già prima della legge Casati, per iniziativa delle amministrazioni locali, in molte delle principali città venne costituito un istituto tecnico. A Torino nel 1852 venne creato il Collegio tecnico-commerciale. Ordinato in istituto industriale e professionale nel 1865, nel 1882 venne intitolato a Germano Sommeiller37. Ad Alessandria il corso speciale voluto dall’amministrazione comunale già nel 1851, divenuto istituto tecnico nel 1856 venne parificato alle scuole governative nel 1864 per intervento di Urbano Rattazzi, divenendo scuola statale nel 1878 con intitolazione a “Leonardo da Vinci”38. A Vercelli (“C.Cavour”) la costituzione dell’istituto risale al 1854. A Casale Monferrato l’istituto tecnico (“Leardi”) nacque nel 1859 grazie al lascito testamentario con cui la contessa Clara Leardi Angeleri di Terzo donò al comune il proprio palazzo e una cospicua somma di denaro affinché vi istituisse una scuola di commercio. L’istituto casalese fu però regificato tardi, solo nel 191139.Ad Asti il futuro Istituto tecnico Giovanni Antonio Giobert venne parificato nel 1864, mentre a Cuneo (dove la preoccupazione principale è dotare la città di una scuola di agrimensori) l’istituto (poi intitolato “F.A. Bonelli”) nacque nel 186540. A Novara (il futuro “Mossotti”) fu creato su iniziativa municipale nel 1861. A Pinerolo invece nel 1867 fu deliberata la costituzione di un istituto tecnico pareggiato (“M. Buniva”) con indirizzo per agrimensori e ragionieri, evoluzione di un precedente istituto commerciale per adulti nato nel 1855.
Per l’insieme di questi motivi, l’identità incerta che si rifletteva anche sulla didattica e sulle stesse materie di insegnamento e la generale prevalenza accordata alla scuola classica – e all’interno di quelle tecniche, alla sezione fisico-matematica (il futuro liceo scientifico da cui si poteva accedere alle facoltà scientifiche e alle Scuole di ingegneria) –, si posero le condizioni per il successo dell’iniziativa privata, più rispondente alle necessità delle economie locali e caratterizzata dalla prevalenza di un metodo d’insegnamento induttivo, e in generale meno teorico. Alla guida di questo processo si posero Camere di commercio, associazioni di categoria o singoli industriali41, interessati all’introduzione di un sistema di studi finalizzato alla formazione di quel personale altamente specializzato che né le scuole statali – per un insegnamento troppo teorico e poco aggiornato – né quelle di arti e mestieri degli istituti caritativi e religiosi erano in grado di perseguire42.
Nel campo dell’istruzione commerciale il fenomeno è presente in forma diffusa quanto meno a partire dall’ultimo quarto dell’Ottocento – ve n’è però traccia nelle regioni economicamente più avanzate anche nel periodo precedente43 – ma divenne più evidente con il nuovo secolo. È il caso delle “scuole di commercio” costituite su iniziativa delle camere di commercio. Il prototipo fu rappresentato da quella creata a Roma agli inizi del Novecento, immediatamente replicata in altri centri della penisola (Feltre,
Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Paternò, Palermo e Napoli fra i primi). La finalità dichiarata di queste scuole era fornire insegnamenti di carattere eminentemente pratico, utili soprattutto per chi non aspirasse necessariamente a un lavoro nella pubblica amministrazione o nel settore creditizio e assicurativo, ma semmai all’attività commerciale: una tipologia di insegnamento trascurato negli istituti statali44. Pertanto, non vi venivano insegnate materie quali diritto commerciale e amministrativo o scienza finanziaria e statistica, ma vi figuravano la merceologia e le esercitazioni merceologiche, la stenografia e la tecnica
prescriveva per gli alunni delle scuole tecniche che volessero iscriversi agli istituti tecnici il parere favorevole del collegio
docenti della scuola tecnica cui si era iscritti: circa il 16% non ottennero quell’anno il certificato di idoneità. 36 A. Santoni Rugiu, La lunga storia della scuola secondaria, cit.; p.61. 37 Cfr. Angelo d’Orsi (a cura di), Una scuola, una città. I 150 anni di vita dell’Istituto Germano Sommeiller di Torino,
cit. 38 Cfr. P. Bonzano, C. Guerci, M. Testa (a cura di), Il Vinci fra memoria e futuro, Alessandria, s.d. 39 Istituto tecnico Leardi, Istituto tecnico Leardi. Primo centenario 1858-1958. Annuario 1958-59, Casale Monferrato,
1960 40 Istituto tecnico Bonelli, Bonelli 130: i centotrentanni dell’istituto tecnico statle F.A. Bonelli, Torino, San Paolo, 1996 41 Come per es. l’imprenditore laniero vicentino, Alessandro Rossi, autore di un phamplet in cui si denunciava l’inutilità
pratica degli insegnamenti offerti negli istituti tecnici statali.A. Rossi, Sulla riforma degli istituti tecnici, Firenze 1977 42 È noto come gli industriali italiani dovevano all’epoca spesso ricorrere a maestranze straniere le produzioni più
qualificate. 43 La prima scuola commerciale privata fu costituita a Milano nel 1816. 44 A. Tonelli, L’istruzione tecnica e professionale di stato, cit.; pp. 78 e ss.
commerciale. Nel 1908, riconosciute con il RD del 22 marzo come scuole pubbliche, dotate di autonomia amministrativa e personalità giuridica, esse vennero poste sotto la vigilanza dello Stato. Più specificamente, in virtù della natura professionale dei loro insegnamenti, sotto quella del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio. Condizione che avrebbe permesso loro di mantenere un’ampia autonomia, anche didattica oltre che giuridica, garanzia di una certa elasticità nell’adeguarsi alle necessità delle diverse realtà locali. Nel 1912 (legge 14 luglio, n. 854 e successivo regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014) si procedette infine al loro riconoscimento come scuole di 2° e di 3° grado. Per quanto attiene l’istruzione commerciale, al 2° grado appartenevano quelle scuole che in tre anni di corso formavano agenti e impiegati di commercio, al 3° quelle che articolate su 4 anni erano abilitate al rilascio del titolo di perito commerciale, ragioniere commerciale, industriale o attuariale a seconda dello specifico indirizzo45. Fu questo il caso del Bona di Biella che nato nel novembre 1913, fu regificato con il D.L. del 24 maggio 1917, conservando le proprie caratteristiche e ottenendo per i suoi diplomati il titolo di ragioniere industriale46; dell’istituto tecnico commerciale “Quintino Sella” di Torino, nato nel 1867 come istituto internazionale di Educazione, convertitosi nel 1905 per intervento del Comune, della Provincia, della Camera di commercio e della cassa di Risparmio torinesi, in scuola di commercio maschile e femminile, regificato due anni dopo e infine convertito in istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile nel 191547; dell’istituto di Bra, poi dedicato a Ernesto Guala, nato come scuola di commercio, poi pareggiata nel 1920 dal Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio.
Si venne così progressivamente costituendo un sistema scolastico tecnico-professionale alternativo – per non dire «antagonista»48 – a quello che faceva capo al Ministero della Pubblica Istruzione, assai più rispondente ai bisogni effettivi di istruzione professionale: nel 1914-15’ alle scuole che facevano capo al Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio risultava iscritto il 41,6% delle popolazione scolastica delle scuole secondarie contro il 10,3% degli istituti tecnici49.
Questo procedere localmente a soddisfare una domanda di istruzione ancora soggetta a forti variazioni regionali si dispiegava parallelamente a un processo di ridefinizione dell’identità professionale del ragioniere che si andava precisando anche in relazione all’evoluzione di altre professioni con cui peraltro non mancarono occasione di conflitto. L’incipiente sviluppo industriale del paese, quanto meno nelle regioni nord-occidentali, l’aumento nel volume dei commerci internazionali, la complessità crescente dei settori creditizio e assicurativo, nonché le esigenze di personale tecnico qualificato avanzate dalla pubblica amministrazione, convergevano infatti a ridisegnarne complessivamente le competenze. Da quell’agglutinarsi di nuove funzioni si fissò un’immagine – perlopiù in negativo – passata dalla letteratura di fine Ottocento alla cultura novecentesca, dal Monssù Travet di Bersezio fino al Fantozzi di Villaggio – che sedimentò nell’immaginario collettivo una serie di cliché sul ragioniere, figura tragica e grottesca insieme, assurto a metafora della spersonalizzazione del lavoro esecutivo50. Al di là di ciò, quel processo di identificazione – cui molto contribuì certo l’istituzione dell’albo dei ragionieri avvenuta nel 190651– contribuì a dare rilevanza al tema dell’istruzione commerciale. Lo testimoniano le vicende del
45 Nel 1919 con la legge del 13 novembre, n. 2431, le scuole commerciali ebbero uno specifico regolamento in gran parte
confermativo delle precedenti disposizioni. 46 Cfr. I. Viglieno (a cura di), I Cinquant’anni dell’istituto tecnico commerciale statale Eugenio Bona di Biella. 1913-
1963, Comitato per la celebrazione del cinquantenario dell’istituto, Torino, 1963. 47 F. De Caria, Una scuola, una città: appunti dall’archivio storico dell’I.T.C. “Quntino Sella”, Torino, 1996; R.
Provveditorato agli studi di Torino, L’istruzione tecnica professionale nella provincia di Torino. Seconda giornata della
tecnica 4 maggio 1941 – XIX, Torino, 1941 48 Cfr. R.S. Di Pol, Scuola e popolo nel riformismo liberale di inizio secolo, Sintagma, Torino, 1996; p. 112. 49 Ivi, p. 115. 50 Su questi aspetti vedi L. Vandelli, Il pubblico impiegato nella rappresentazione letteraria, in L’impiegato allo specchio,
a cura di A.Varni e G. Melis, Rosenberg & Sellier, Torino 2002 51 Nell’ultimo quarto dell’Ottocento, anche in relazione allo sviluppo dell’istruzione commerciale che poneva il problema
del valore del titolo di studio a fini dell’esercizio della professione rispetto a quello della pratica, si moltiplicarono a
livello locale i collegi dei ragionieri, concepiti come associazioni di categoria. Il primo congresso dei ragionieri italiani,
nel 1879, pose il problema di un riconoscimento ufficiale della professione. Bisognò però attendere il 1906 (legge n. 327
del 15 luglio 1906) perché il Parlamento approvasse una legge sull’esercizio della professione di ragioniere, istitutiva
dell’albo dei ragionieri. Cfr. A. Cantagalli, Il ragioniere commercialista: una storia lunga un secolo. 1906-2006, in
«Summa», 223, XXIII.
movimento internazione per l’insegnamento tecnico, industriale e commerciale che incominciò a celebrare i suoi congressi a partire da quello di Bordeaux del 1886. Particolare interesse per il dibattito italiano rivestì il Congresso celebrato a Venezia nel maggio 1899 – accompagnato peraltro da due congressi nazionali degli istituti tecnici e commerciali organizzati entrambi a Torino rispettivamente nel 1898 e nel 1902 – dove se da un lato si sottolinearono i vantaggi della natura ibrida dell’istruzione commerciale praticata in Italia – a mezza via fra le scuole di commercio e un insegnamento genericamente rivolto alla preparazione degli operatori economici – da un altro si denunciarono molte delle carenze di base di un sistema scolastico che privilegiava pur sempre gli studi classici52. Il dibattito nel nostro paese si articolò però soprattutto attorno al conflitto che in quegli anni emerse circa il valore da attribuire al titolo scolastico al fine dell’abilitazione all’esercizio della professione53. Esso si trascinò fino al 1905 quando la legge 15 luglio n. 327 e il successivo regolamento (RD 9 dicembre 1906, n. 7059) stabilirono che per esercitare come ragioniere ed essere iscritti all’albo professionale non fosse sufficiente il diploma di perito commerciale, ma fossero necessari anche due anni di praticantato e il superamento di un esame di abilitazione. Negli stessi anni, si registrava la nascita, dopo quella pionieristica di Venezia (1868), ancora una volta per iniziativa privata, di tre nuove Scuole superiori di Commercio, a Genova (1884), a Bari (1886) e a Milano – la Bocconi – (1902)54. Originariamente miranti non alla formazione di personale esecutivo, ma di capitani di impresa e in secondo ordine di studiosi di economia, esse offrirono ai periti ragionieri la possibilità di continuare gli studi dopo l’ottenimento della licenza. Non diversamente da quanto accaduto con l’espansione dell’istruzione commerciale secondaria, la loro introduzione creò però il problema del valore legale del titolo di studio da esse rilasciato, ponendo le premesse per un ulteriore conflitto circa la definizione delle competenze specifiche della nuova figura del dottore commercialista, e poi della parificazione di queste scuole alle università statali in cui mancava del tutto un indirizzo economico-commerciale. La materia fu riordinata con la già citata legge del 1913 che riconosceva dignità universitaria agli istituti superiori commerciali, pur intervenendo a limitarne l’indipendenza – furono posti sotto la direzione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – e a uniformarne gli insegnamenti.
L’istruzione commerciale in epoca fascista È noto come il fascismo – peraltro non ancora regime – intervenne inizialmente nel campo
dell’istruzione muovendosi in una direzione opposta a quella suggerita dalla crescente importanza che in termini di numero di iscritti l’istruzione tecnica andava assumendo nel sistema scolastico e dalla rilevanza che essa era destinata a giocare in una società come quella italiana che pur contraddittoriamente e con grandi squilibri territoriali aveva ormai acquisito un profilo industriale55. La riforma Gentile56 (RD del 6 maggio 1923, n. 1054) – definita da Mussolini «la più fascista delle riforme» – si configurò infatti come una ulteriore conferma della tradizionale prevalenza accordata dalla scuola italiana alla cultura classica, quale strumento di formazione e di selezione delle classi dirigenti. Ne usciva rafforzata a livello di istruzione secondaria la centralità dei licei, divenuti ora due per effetto della nascita di quello scientifico
52 Si veda – per es. – il discorso tenutovi da Angelo Roncali, direttore della Scuola superiore di commercio di Genova,
che additava all’Italia il modello tedesco, dove l’istruzione commerciale era divenuta uno dei fattori principali di sviluppo
del paese, in quanto rivelatasi una risorsa fondamentale per la conquista dei mercati esteri. Cfr. L’istruzione commerciale
in Italia e particolarmente le scuole superiori di commercio, Genova, 1899; sintetizzato in Considerazioni
sull’insegnamento commerciale in Italia, in “La Stampa”, 22 maggio 1900). 53 Nel 1865 si giunse a un sostanziale compromesso fra quanti sostenevano che il requisito prevalente dovesse essere la
pratica e chi invece voleva far coincidere la licenza scolastica ottenuta con il superamento dell’esame finale
all’abilitazione professionale. Il Regolamento per l’istruzione industriale e professionale dispose che dal 1° aprile 1866
la licenza scolastica divenisse requisito necessario ma non sufficiente per l’esercizio della professione. 54 Nel 1913 venne loro riconosciuta dignità universitaria, nel 1935 si concluse il loro completo processo di integrazione
nel sistema universitario italiano con la loro trasformazione in Facoltà di Economia e Commercio. 55 Nell’anno scolastico 1921-22 gli iscritti agli istituti tecnici erano 36120 (di cui 7354 donne) contro i 77709 dei ginnasi-
licei. 56 Cfr. J. Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime, La Nuova Italia, Firenze, 1994; p. 93 e ss.; S.
Santamaita, Storia della scuola. Dalla scuola al sistema formativo, Bruno Mondadori, Milano, 1999; p. 90 e ss.; A. Scotto
di Luzio, La scuola degli italiani, Il Mulino, 2007; p. 121 e ss.; A. Santoni Rugiu, La lunga storia della scuola secondaria,
cit.; p. 87 e ss.
dalla fusione del precedente indirizzo fisico-matematico degli istituti tecnici con la sezione moderna del liceo istituita nel 1911. Da questo innesto, in realtà, risultò un annacquamento della preparazione scientifica precedentemente offerta negli istituti tecnici giacché ora essa doveva convivere anche con l’obbiettivo di fornire ai discenti una soddisfacente preparazione umanistica classica. La presenza del latino – la caratteristica che maggiormente differenziava i nuovi licei scientifici dalle precedenti sezioni fisico-matematiche degli istituti tecnici – interveniva inoltre a scoraggiare i meno abbienti dall’iscrivervi i propri figli, con l’effetto di precludere loro l’unica via percorribile per accedere agli studi universitari. Inoltre, l’introduzione dell’esame di Stato – la maturità – al termine del ciclo degli studi secondari, oltre a inasprire la selettività degli stessi, permise il pieno riconoscimento del ruolo dell’istruzione privata.
Per comprendere la portata della riforma va però tenuto conto anche dei provvedimenti assunti a monte della scuola secondaria superiore. Si tratta dell’aspetto rivelatosi più problematico della riforma stessa come avrebbe dimostrato quella “politica dei ritocchi” con cui negli anni successivi si cercò di correggerla. Gentile dispose infatti anche la soppressione della scuola tecnica e la sua sostituzione con il corso inferiore quadriennale dell’istituto tecnico e con la scuola complementare. Il primo che presentava ora anche il latino fra le materie di insegnamento – introdotto a beneficio di quanti volessero successivamente iscriversi al liceo scientifico (erano previste più ore di latino che di matematica!) – era dei due l’unico percorso abilitante al proseguimento degli studi. Nello schema gentiliano alla complementare spettava infatti la funzione di “scolmatoio”, ovvero di assorbire quella parte della popolazione scolastica, in genere i ragazzi delle classi sociali più umili, cui la maggiore severità degli studi avrebbe sconsigliato l’iscrizione alla “scuola media”.
Gentile procedette anche alla ristrutturazione dell’istruzione tecnica superiore. Giacché l’istruzione tecnica industriale – avvertita come più prossima alla formazione professionale – fu nuovamente attribuita alle competenze del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio e l’indirizzo agronomico venne soppresso, gli istituti tecnici propriamente detti – rimasti alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione – risultarono ora costituiti dalla sezione commerciale e da quella di agrimensura (per geometri), entrambe della durata di due anni, alle quali si accedeva dopo un biennio comune. Il conseguimento del diploma non abilitava agli studi universitari, a eccezione dell’Università orientale di Napoli e delle Scuole superiori di commercio, nonostante l’allungamento del percorso di studi (per il fatto che la riforma aveva aumentato da 4 a 5 anni il ciclo elementare e da 3 a 4 l’istruzione tecnica inferiore). A livello di materie di insegnamento nel biennio comune erano previste 5 ore di italiano, 5 di storia, 6 di matematica e fisica al primo anno che si riducevano a 5 al secondo, 3 di scienze naturali e geografia, 2 della prima lingua straniera al primo anno, 6 della seconda lingua straniera al 2 anno, 2 di calligrafia al primo anno; per il biennio specializzante invece per quanto riguarda la sezione commerciale erano previste 2 ore di scienze naturali e geografia, 5 ore della seconda lingua straniera al terzo anno e 4 ore al quarto anno, 8 ore di computisteria e ragioneria, 7 ore di istituzioni di diritto al terzo anno che diminuivano a cinque al quarto anno, 2 ore di economia politica al terzo anno che salivano a 4 al quarto anno, 4 ore di scienze finanziarie e statistica al quarto anno, 3 ore di chimica merceologica al terzo. Fra i due bienni vi era dunque un forte stacco. Il primo mirava infatti a fornire quell’istruzione generica in campo tecnico-scientifico che il ciclo scolastico precedente per il profilo maggiormente umanistico-letterario impressogli dalla riforma non era più in grado di garantire, mentre il secondo, puntava esclusivamente su una formazione specialistica.
Infine, gli istituti, che continuarono a essere privi di autonomia amministrativa e personalità giuridica, vennero sottratti al coordinamento che su di essi era stato esercitato dalle Giunte di vigilanza costituite in base alla legge del 1865 il cui compito, come è stato ricordato, era proprio quello di integrare il mondo della scuola con le istituzioni del territorio.
Negli anni successivi, la riforma Gentile subì diverse modifiche, dettate dalla volontà di metter mano alle più evidenti disfunzionalità del sistema scolastico da essa disegnato e dal crescente desiderio del fascismo di fare della scuola uno strumento di politica totalitaria. Nel 1928 – legge del 20 dicembre, n. 3230 – il Ministero della Pubblica Istruzione, retto in quel momento da Giuseppe Belluzzo, riottenne le competenze sull’istruzione tecnico-professionale. Questa inversione di rotta – dettata certo dalla volontà di accentrare in un unico ministero tutto il sistema scolastico, ma anche dal riconoscimento del
valore dell’istruzione tecnica e professionale57 – ebbe per conseguenza il generale riordinamento del ciclo inferiore delle scuole secondarie. Con il decreto del 6 ottobre 1930, convertito in legge il 22 aprile 1932 (n. 490), vennero create le scuole di avviamento professionale, a indirizzo industriale, agrario e commerciale, risultato della fusione della scuola complementare gentiliana con i corsi di avviamento professionale del Ministero dell’Economia Nazionale. La legge del 15 giugno 1931 n. 889 procedeva invece alla riforma delle scuole tecniche secondarie. Essa fu dettata dal desiderio di rinforzare l’istruzione tecnica il cui profilo nella scuola gentiliana era molto sbiadito, con l’obiettivo di offrire alla piccola e media borghesia un’occasione di promozione sociale, un percorso professionalizzante che ne distinguesse nettamente i figli dal proletariato operaio, anche da quello più qualificato. Sotto la denominazione di “nuovo istituto tecnico” confluirono nuovamente assieme gli istituti industriali dipendenti dal Ministero dell’Economia e quelli di agrimensura e commercio-ragioneria dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, nel 1929 divenuto dell’Educazione Nazionale. Nonostante la legge riconoscesse a tutti gli istituti quella personalità giuridica e autonomia amministrativa, nei fatti esse rimasero un privilegio di quelli provenienti dal ministero dell’Economia. La nuova scuola rimaneva articolata su due quadrienni, il primo generale, il secondo suddiviso negli indirizzi agrario, industriale, commerciale, nautico e per geometri. Nel 1933 queste scuole ebbero nuovi programmi di insegnamento, rivisti nel 1936, e dal 1934 nuovi programmi d’esame, anch’essi riformulati nel 1937, con cui – va segnalato – si reintrodussero le materie letterarie e si eliminò quello iato che abbiamo notato caratterizzava nell’impianto gentiliano il passaggio dal primo al secondo biennio58.
Il caso dell’istruzione commerciale è esemplare delle difficoltà di questo nuovo innesto. Il legislatore dispose infatti il mantenimento di due indirizzi, uno, amministrativo, proprio degli istituti già afferenti al Ministero della pubblica istruzione, rivolto soprattutto a chi volesse intraprendere la libera professione o una carriera nell’amministrazione pubblica, l’altro, denominato mercantile, finalizzato a preparare i ragionieri che intendessero impiegarsi nel settore privato (banche, imprese, assicurazioni…) nel quale confluirono gli istituti un tempo dipendenti dal Ministero dell’Economia Nazionale. Una suddivisione però che si stemperava in una leggera difformità dei programmi – relativa sostanzialmente alla differente rilevanza attribuita alla merceologia – e che non aveva conseguenze alcune sul titolo di studio59, mentre l’autonomia didattica riconosciuta ai nuovi istituti tecnici si limitava di fatto alla possibilità
57 Cfr. G. Lombardi, Sviluppo economico ed istruzione tecnica e professionale in T. Tomasi (a cura di), La scuola
secondaria in Italia (1859-1977), Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 290; F. Hazon, Storia della formazione tecnica e
professionale in Italia, Roma, Armando, 1991, p. 87. 58 Inoltre con i nuovi programmi si dispose che il latino non costituisse materia di esame per il passaggio dall’avviamento
all’anno preparatorio presso gli istituti tecnici superiori. In questo modo, si dava la possibilità agli studenti della scuola
di avviamento di poter continuare realmente gli studi. 59 Cfr. Aldo Tonelli, L’istruzione tecnica e professionale di stato nelle strutture e nei programmi da Casati ai giorni
nostri, cit.; p. 202. Le discipline di insegnamento erano le seguenti. Per l’indirizzo amministrativo: 3 ore di lettere italiane,
3 ore di storia i primi due anni, 3 ore di matematica i primi due anni che scendevano a due al terzo anno, 2 ore di scienze
naturali il primo anno, 2 ore di geografia generale ed economica il secondo e il terzo anno che salivano a 3 al quarto anno,
2 ore di chimica e mineralogia il primo anno, 3 ore di merceologia il secondo anno, 2 ore di prima lingua straniera il
primo e il secondo anno, 3 ore di seconda lingua straniera il primo anno che divenivano 4 al secondo, terzo e quarto anno,
3 ore di computisteria e ragioneria al primo, secondo e terzo anno che divenivano 4 al quarto anno, 3 ore di tecnica
commerciale al terzo anno che divenivano 2 al quarto anno, 2 ore di esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale al
terzo e quarto anno, 3 ore di istituzioni di diritto al secondo e al terzo anno che divenivano 4 al quarto anno, 4 ore di
economia politica, scienza delle finanze e statistica al terzo e quarto anno, 2 ore di calligrafia al primo anno. L’indirizzo
mercantile presentava lo stesso impianto sennonché: al primo anno le ore di chimica e merceologia e quelle della prima
lingua straniera erano 3 invece di 2, mentre quelle della seconda lingua straniera erano 4, e al quarto anno le ore di
computisteria e di diritto erano 3 invece di 4, mentre quelle di tecnica commerciale erano tre invece di due. Inoltre la
merceologia era presente al terzo anno con 3 ore e al quattro con 4 ore, contribuendo a innalzare per gli ultimi due anni
di tre ore il monte orario settimanale dell’indirizzo mercantile rispetto a quello commerciale (30 contro 27). Per finire
comuni a tutti e due gli indirizzi l’ora di religione, le due ore di educazione fisica e le 30 ore annuali di cultura militare.
Era previsto come facoltativo l’insegnamento della stenografia (2 ore il primo anno) e della dattilografia (2 ore al secondo
anno). Nell’anno scolastico 1938-39, in alcuni istituti (Roma, Torino, Milano, Genova, Napoli, Palermo, Bari) fa avviata
anche la sperimentazione di una nuova materia: l’“arte del vendere”. Cfr. Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione
generale dell’Ordine superiore tecnico, L’istruzione tecnica commerciale; Fratelli Palombi, Roma, 1942; p. 26.
di optare per lingue straniere diverse da quelle previste a livello ministeriale (francese, inglese e tedesco) in base ai bisogni dell’economia locale60.
A essi andava sommata la possibilità riconosciuta dalla legge del 1931 di avere indirizzi specializzati oltre a quelli previsti, una deroga di cui si avvalse solo l’Eugenio Bona di Biella che con il Regio Decreto del 17 maggio 1937 vide riconosciuta la propria specializzazione industriale «per i commerci e le mansioni amministrative relative alle industrie tessili in generale e alla laniera in particolare»61. In ragione di ciò, i licenziati del Bona ottenevano il titolo di «ragionieri e periti commerciali specializzati per l’amministrazione industriale»62.
La successiva Carta della Scuola voluta da Bottai nel 1939 – il punto indubbiamente più alto di intervento in senso totalitario del fascismo sul mondo della scuola – riguardò le scuole secondarie superiori innanzitutto indirettamente, per effetto degli interventi apportati all’ordinamento della secondaria inferiore – dove fu progettata ma poi non attuata la “scuola media unica” – e a quello dell’Università. In merito a quest’ultima, per quanto a noi qui interessa, la Carta stabilì – previo un quinto anno di studi supplementare – la possibilità per i periti ragionieri di accedere alle “nuove” facoltà di Economia e Commercio63, di Scienze statistiche, demografiche e attuariali e – in quest’ultimo caso con esame di ammissione – a quelle di Scienze politiche. Contemporaneamente si procedette al riordinamento dell’istruzione professionale il cui coordinamento fu ora destinato ad appositi enti dipendenti dal Ministero del Lavoro (per il commercio l’Ente nazionale fascista per l’addestramento dei lavoratori del commercio, ENFALC). Peraltro occorre ricordare che negli anni del fascismo si acuì il conflitto che circa le reciproche attribuzioni professionali opponeva i ragionieri dai dottori in economia e commercio e che nel 1929 il regime tentò di comporre con la stesura di due diversi regolamenti professionali64.
L’esiguità del lasso temporale che divise queste innovazioni normative dall’inizio della Seconda guerra mondiale non consente un bilancio effettivo del tentativo operato negli ultimi anni Trenta dal fascismo di valorizzare maggiormente l’istruzione tecnica, in nome della quale peraltro dal 1940 si iniziò a celebrare nelle scuole, sempre su decisione di Bottai, ogni 2 giugno, la giornata nazionale della tecnica. È soprattutto dubbio che gli interventi voluti da Bottai in coerenza con l’ideologia corporativa, abbiano effettivamente sanato, come invece affermava la propaganda, «quel divorzio fra Scuola e vita» che aveva caratterizzato l’istruzione tecnica nel passato. Le “sperimentazioni” avviate in tal senso a partire dall’anno scolastico 1938-39 non paiono giudicabili come l’avvio di quella virtuosa integrazione fra il mondo della scuola e quello del lavoro prevista dalla Carta della Scuola65. Per conseguire un tale obiettivo, mancavano
60 Se ne avvalse proprio il Bona per mantenere l’insegnamento della lingua spagnola. 61 Cfr. Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione generale dell’Ordine superiore tecnico, L’istruzione tecnica
commerciale; Fratelli Palombi, Roma, 1942; p. 29. 62 È da notare che il Bona in conseguenza di questa sua specificità aveva anche dei programmi differenziati. Oltre a tutte
le materie degli istituti a indirizzo mercantile, il Bona «presentava corsi speciali di tecnologia industriale tessile con
elementi di fisica tecnica, di merceologia tecnica per analisi di fibre, di tessuti ecc., nonché di ragioneria e di tecnica
amministrativa delle aziende industriali; mentre nelle trattazioni di diritto e di economia viene specialmente sviluppata la
parte riguardante la legislazione del lavoro e la legislazione sociale e corporativa. L’insegnamento di queste discipline è
opportunamente integrato da esercitazioni di laboratorio e di avvale del sussidio di gabinetti largamente dotati (di
tecnologia e provi natura dei tessuti, di merceologia, di chimica, fisica e scienze naturali, di ragioneria e di tecnica
commerciale ed amministrativa delle aziende tessili, di geografia generale ed economica), di biblioteche speciali, di tre
musei (di merceologia, di tecnologia tessile e di storia naturale), di modernissimi impianti scientifici e cinematografici e
di macchine calcolatrici. Dal 1931 è annesso all’istituto un osservatorio meteorologico, che studia, fra l’altro, l’influenza
delle variazioni climatiche in rapporto con l’industria e con le condizioni generali della regione e che dipende dal R.
Ufficio di meteorologia e di geofisica di Roma». Cfr. Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione generale
dell’Ordine superiore tecnico, L’istruzione tecnica commerciale; Fratelli Palombi, Roma, 1942; pp. 29-30. 63 Esse erano state costituite nel 1935 dal ministro De Vecchi portando a termine quel processo di integrazione delle
Scuole superiori di commercio avviatosi come si è detto nel 1913. Mentre le scuole di Genova, Venezia e Bari vennero
annesse alle locali università, divenendo pubbliche, la Bocconi di Milano, delle quattro indubbiamente la più prestigiosa,
rimase privata. 64 Regio decreto 28 marzo 1929, n. 588. 65 Sulla valenza didattica di quelle esperienze è lecito infatti avere dubbi. A leggere le pubblicazioni ufficiali esse parvero
frutto di una certa improvvisazione e orientate piuttosto a finalità propandistiche. Gli alunni del settore commerciale più
che a contatto con gli ambienti in cui avrebbero presumibilmente dovuto occuparsi una volta conseguito il diploma,
finirono perlopiù per svolgere attività manuali che richiedevano una bassa qualificazione.
peraltro spesso personale, strumenti e locali idonei e una reale capacità di coinvolgimento del mondo dell’impresa. Senza contare che nel caso specifico dei futuri ragionieri perdurava la convivenza con i geometri con cui si condividevano non solo gli spazi fisici, ma anche il personale amministrativo, sovente sprovvisto – a partire dai presidi – di competenze tecniche. Rimane allora il dubbio che la ragguardevole – ma certo non ancora spettacolare e inferiore a quella dei licei – crescita conosciuta dall’istruzione commerciale fra il 1930-31 e il 1940-41 – il numero di scuole passò da 128 a 156, la popolazione scolastica crebbe da 40948 alunni a 68599 – fosse, come in fondo avverrà anche successivamente, più il frutto di una pressione esterna al mondo della scuola, in ragione della maggiore disponibilità di posti di lavoro nel settore terziario, che della efficacia delle politiche incentivanti adottate66.
L’età repubblicana: il difficile passaggio dalla scuola di élite a quella di massa
È significativo notare come per la scuola italiana il passaggio dal fascismo alla democrazia sia
avvenuto sostanzialmente sotto il segno della continuità con il passato. La Repubblica tardò a intervenire in materia scolastica e anche quando ciò accadde lo fece per lungo tempo solo con interventi settoriali, talvolta presentati – pure se relativi a questioni di rilievo – come “temporanei” o “sperimentali”, assunti nell’attesa di mai realizzate riforme complessive. È un dato che appare paradossale se si pensa alle funzioni che la scuola nella nuova Italia democratica avrebbe dovuto esercitare, secondo quanto prescritto anche dal dettato costituzionale67, ma che diviene ancor più stridente quando si rifletta sulla profondità e sull’ampiezza delle trasformazioni sociali ed economiche con cui quella scuola – da lì ad appena un decennio – avrebbe dovuto confrontarsi. Si può dire così che quella della scuola italiana negli anni del “miracolo economico” e del passaggio dalla scuola di élite a quella di massa, sia stata per un lungo tratto – almeno fino agli anni Settanta – più la storia di una diffusa resistenza – anche dall’interno del mondo scolastico dove pure non mancarono qua e là importanti fermenti di innovazione – che di una sollecita risposta alle istanze, sul piano didattico-pedagogico, organizzativo e culturale, poste dalla modernizzazione in corso della società italiana68.
Si pensi solo – per quanto attiene ciò che a noi qui maggiormente interessa – che bisognò attendere il 1961 (DPR 30 settembre 1961, n. 1222) perché venissero finalmente aggiornati i programmi scolastici della scuola secondaria superiore, sostituendo quelli introdotti dal fascismo negli anni Trenta. Peraltro – è stato notato – nel caso degli istituti tecnici il maggior sforzo di revisione si concentrò soprattutto sulle materie letterarie (italiano, storia ed educazione civica)69. Nel procedere all’aggiornamento dei programmi in ambito tecnico-scientifico si razionalizzò la distribuzione delle materie durante il quinquennio, con l’obiettivo di concentrare quelle tecniche e propedeutiche nei primi due anni e quelle professionalizzanti nel successivo triennio70. Per ciò che riguarda la ragioneria, si procedette all’estensione della matematica al quinto anno, comprensiva anche della statistica metodologica precedentemente insegnata dal professore di diritto ed economia, alla divisione di queste ultime due in insegnamenti separati e della ragioneria dalla computisteria, tecnica commerciale, trasporti e dogane. Vennero potenziate le esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale, per le quali era previsto l’uso della macchine calcolatrici e resa obbligatoria, giacché ritenuta propedeutica all’uso delle stesse, lo
66Se guardiamo al Piemonte, incontriamo regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri a
Alessandria (Leonardo Da Vinci), ad Asti (Giovanni Antonio Giobert), a Casale Monferrato (Leardi), a Cuneo (Francesco
Andrea Bonelli), a Novara (Ottavio Fabrizio Mossotti), a Pinerolo (Michele Buniva), a Torino (Germano Sommellier), a
Vercelli (Cavour); e regi istituti tecnici a indirizzo mercantile a Biella (Eugenio Bona), a Bra, a Nizza Monferrato (nato
nel 1936), a Torino (Quintino Sella).
67 Da questo punto di vista è significativo che si dovette attendere il 1958 per l’introduzione dell’educazione civica. 68 Sulla mancata riforma della scuola superiore e un confronto con le principali esperienze di riforma avviate invece in
Europa cfr. L. Benedusi (a cura di), La non decisione politica: la scuola secondaria tra riforma e non riforma, il caso
italiano a confronto con altre esperienze europee, La Nuova Italia, Firenze, 1989. 69 A. Santoni Rugiu, La lunga storia della scuola secondaria, cit.; p. 139. 70 S. Musso, L’istruzione tecnica tra la riforma Gentile e i problemi dell’oggi, in Angelo d’Orsi (a cura di), Una scuola,
una città. I 150 anni di vita dell’Istituto “Germano Sommeiller” di Torino, cit.; p. 49.
studio della dattilografia. Nell’indirizzo mercantile vennero infine incrementate a sette ore la chimica e la merceologia71.
Peraltro, nel 1954, con la legge 31 luglio, n.609, erano stati creati nel quadro dell’istruzione commerciale l’indirizzo per il commercio estero e quello per il turismo (nato dalla trasformazione dell’istituto professionale per il turismo). Essi divennero successivamente istituti a parte, l’istituto per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (legge 13 luglio 1965, n. 884) e quello per il turismo (DPR 14 marzo 1966)72.
Il cambiamento naturalmente più evidente fu la straordinaria crescita quantitativa della popolazione scolastica, iniziatosi già negli anni Cinquanta. Senza tener conto di essa apparirebbero del tutto incomprensibili le trasformazioni che il mondo della scuola conobbe nei due decenni successivi. A partire dal modo in cui gli allievi – ora anche nella secondaria sempre più spesso provenienti da ceti sociali un tempo esclusi dall’istruzione superiore – concepivano lo stare a scuola e dalle aspettative che nutrivano verso di essa.
È allora utile gettare uno sguardo alle statistiche dell’istruzione elaborate dall’istituto nazionale di statistica. Per ricostruire sinteticamente l’evoluzione della popolazione scolastica degli istituti tecnici commerciali nel secondo dopoguerra si prendano in esame alcuni anni – ad intervallo decennale – il 1951-52, il 1961-62, il 1971-72, 1981-82 e il 1991-9273. Un arco temporale di quarant’anni lungo il quale si può dire si sia pienamente consumata, dispiegandosi in tutti i suoi effetti, la transizione della scuola secondaria alla dimensione di massa. La scelta del periodo cronologico non è arbitraria, né dovuta a una periodizzazione in qualche modo esterna alla storia della scuola: l’anno scolastico 1991-’92 è infatti il punto culminante nel trend di crescita della popolazione scolastica della secondaria superiore, dopo il quale si registra una significativa inversione di tendenza e successivamente una sostanziale stabilizzazione della popolazione scolastica sui livelli medi degli anni Ottanta74.
Fra il 1951-52 e il 1991-92 gli iscritti alla secondaria passarono da poco più di 300.000 a circa due milioni e ottocentomila. A sostenere questa intensa crescita – esponenziale negli anni Sessanta e Settanta, meno accelerata negli Ottanta – fu una domanda storicamente inedita di istruzione superiore che intrecciandosi con fenomeni di natura fra loro anche molto diversa, intervenne in pochi anni a scardinare un equilibrio che a grandi linee risaliva alla riforma Gentile. Lo dimostra il mutare nel corso del quarantennio di tutti i principali indicatori statistici relativi alla scuola secondaria, nella direzione, peraltro, di un sostanziale riequilibrio nei rapporti fra i generi e fra le aree geografiche. Nel 1991-’92 la componente femminile, sebbene non distribuita in maniera omogenea fra i vari ordini di scuola, aveva ormai uguagliato quella maschile. Le ragazze erano infatti il 49,9% del totale degli iscritti. A livello territoriale, invece, il Mezzogiorno – complice l’esaurirsi dei fenomeni migratori e una popolazione giovanile proporzionalmente più elevata – colmava – almeno in numeri assoluti non nel tasso di scolarità – uno storico gap rispetto al Settentrione: sud e isole (39,6%) avevano ora un peso sulla popolazione scolastica secondaria superiore simile a quello del nord (40,4%). Questa rivoluzione della demografia scolastica si accompagnava al ribaltamento dei tradizionali rapporti di forza numerici fra ordini di scuole: se all’inizio del periodo considerato i licei e gli istituti tecnici avevano grosso modo la stessa popolazione scolastica (rispettivamente 120.067 iscritti contro 125.752), quarant’anni dopo i secondi presentavano una popolazione scolastica quasi doppia rispetto ai primi: 1.285.731 iscritti contro 747.86875.
71 A. Tonelli, cit; p. 268 72 F. Hazon, Storia della formazione tecnica e professionale in Italia, cit.; p. 113 73 La scelta non suoni arbitraria. Essa è orientata dal voler condurre un confronto con i dati più aggiornati disponibili
relativi al 2011/12, ma anche dal fatto che il 1961-62 è l’ultimo anno scolastico prima dell’introduzione della media unica.
I dati riportati sono tratti dalle serie statistiche dell’ISTAT dedicate alla scuola, ossia dai volumi dell’Annuario statistico
dell’istruzione italiana (1950-1971) poi ridenominato Annuario statistico dell’istruzione (1972-1986) e infine Statistiche
dell’istruzione. 74 Per effetto della diminuzione della popolazione giovanile e contemporaneamente del costante aumento del tasso di
scolarità nelle classi di età 14-19. 75 In realtà sia per quanto riguarda il rapporto fra i generi che per quanto riguarda quello fra istruzione tecnica e licei il
riequilibrio poteva già dirsi in gran parte compiuto all’inizio degli anni Ottanta. Nel 1981-82 le donne erano già il 49,1%
della popolazione scolastica delle superiori mentre il rapporto fra iscritti ai tecnici (1.0186.379) e iscritti ai licei (550.572)
era già all’incirca di 2 a 1.
È questo il quadro in cui va letta l’evoluzione a livello statistico dell’istruzione tecnica commerciale. Essa rivela alcune peculiarità di fondo che rafforzano l’immagine della “ragioneria” come ordine di scuola per certi versi “anfibio” nel sistema scolastico italiano. Come vedremo, alcune sue caratteristiche – in particolare la precoce e più intensa femminilizzazione – la avvicinano infatti piuttosto al mondo dei licei che all’insieme degli altri istituti tecnici, da cui l’indirizzo commerciale peraltro si distingue anche per l’andamento peculiare della crescita della sua popolazione scolastica. È istruttivo al proposito il confronto con gli istituti tecnici industriali, che per qualche tempo gli contesero il primato delle iscrizioni all’interno dell’istruzione tecnica secondaria. Nel 1951-’52 l’indirizzo commerciale con i suoi 64.388 studenti raccoglieva il 51,2% delle iscrizioni agli istituti tecnici contro il 20,3% di quello industriale. Quarant’anni dopo, nel 1991-92 gli iscritti a ragioneria erano 658.757 pari al 51,2% del totale dei tecnici mentre quelli all’istituto industriale (322.000) erano circa il 25%. La popolazione scolastica si era in tutti e due i casi pressoché moltiplicata per dieci, pertanto le reciproche proporzioni ma anche il loro peso relativo rispetto all’insieme degli istituti tecnici, erano rimasti all’incirca invariati. In realtà, se si verifica l’andamento anno per anno si può notare come ragioneria e istituti industriali abbiano curve di crescita molto differenti che è agevole peraltro mettere in relazione con le trasformazioni conosciute dall’economia italiana lungo il quarantennio 1951-1991 e – forse più propriamente – con il modificarsi in relazione di queste, di aspirazioni individuali e strategie famigliari. Negli anni Cinquanta e nei primi Sessanta, quelli del “miracolo economico”, la popolazione scolastica degli istituti tecnici industriali conobbe infatti una crescita enormemente più rapida rispetto all’indirizzo commerciale. Nel 1961-62 gli iscritti a ragioneria pur cresciuti di una volta e mezza – erano ora 159.273 – arretravano proporzionalmente di circa 10 punti (al 40,3%) sul totale della popolazione scolastica degli istituti tecnici, mentre gli industriali salivano al 36,2%. Dieci anni dopo nel 1971-72 gli istituti tecnici industriali raccoglievano una proporzione molto simile di iscritti – 37% circa – mentre ragioneria scendeva al 36% pur essendo cresciuta la sua popolazione scolastica del 60%, a 254.216 individui. Nei due decenni successivi iniziava invece la contrazione dell’indirizzo industriale – anche in numeri assoluti – e si verificava una decisa ripresa della ragioneria. Nel 1981-82 gli iscritti agli istituti commerciali erano 534.844. Essi rappresentavano il 49,2% sul totale degli iscritti agli istituti tecnici, quasi il doppio degli iscritti all’indirizzo industriale (la cui quota sul totale era ora del 25,7%) e il 21,8% rispetto alla popolazione complessiva della scuola secondaria. Mentre questa era aumentata del 47% (ormai si aggirava attorno ai 2 milioni e mezzo) gli iscritti a ragioneria erano dunque cresciuti del 110%. Era certo l’effetto della crescita del peso del terziario nella creazione di nuovi posti di lavoro e della parallela crisi dell’industria – e del lavoro di fabbrica – come modello – anche valoriale – di riferimento. E dell’aspettativa diffusa che nella transizione a un’economia post-industriale – trainata dal terziario avanzato legato soprattutto allo sviluppo del settore privato – la formazione impartita negli istituti tecnici commerciali – meno specialistica e orientata anche all’acquisizione di competenze relazionali – fosse più adeguata di altre. Anche in prospettiva di un successivo completamento degli studi a livello universitario. Si avvertivano ormai pienamente – infatti – a questa altezza gli effetti della liberalizzazione degli accessi all’università disposti nel 1968. Ma certo era anche il prodotto di quel riequilibrio territoriale e di genere che si è detto allora in corso. Nel 1951-52 il nord raccoglieva ancora più della metà degli iscritti agli istituti tecnici commerciali (53,5%) contro circa un quarto (25,2%) del sud e delle isole. La forbice si ridusse notevolmente nel 1961-62 (nord 42,5% e sud 34,3%) e continuò progressivamente a contrarsi – dopo la lieve inversione di tendenza del 1971-72 (nord 43,9% e sud 33,4%) – nel 1981-82 (nord 41,9%, sud 37,7%) e nel 1991-92 (nord 40,4% e sud 39,6%).
Fu però in particolare la crescita del tasso di femminilizzazione della secondaria superiore a premiare la ragioneria, da sempre all’interno dei “tecnici” caratterizzata da una maggiore presenza femminile. Nel 1951-52 frequentavano la ragioneria pressoché tutte le ragazze iscritte agli istituti tecnici, 19111 su 19243. Erano in termini percentuali il 29,6% della popolazione scolastica dei “commerciali” (al liceo classico il dato si attestava a circa il 35%). Dieci anni dopo, le ragazze erano salite al 37,4%: una ragazza su cinque fra quante frequentavano le secondarie superiori risultava allora iscritta a ragioneria.76
76 A ragioneria erano iscritte quell’anno 59507 ragazze su un totale complessivo per la secondaria di 302.931. Il tasso di
presenza femminile di ragioneria era inferiore solo a quello dell’istituto magistrale dove le ragazze erano l’87% ed e a
quello del classico (41%).
Nel 1971-72’ la componente femminile era divenuta ormai maggioritaria, il 53%,77 in linea con quanto accaduto nel liceo classico (dove le ragazze erano il 56%). Il dato si stabilizzò negli anni successivi, divenendo sostanzialmente strutturale: le ragazze erano il 57% degli iscritti sia nel 1981-82 che nel 1991-92. Una accentuata e precoce femminilizzazione caratterizzava anche il corpo docente: le insegnanti nel 1991-92 erano nettamente maggioritarie, il 62%, contro una media relativa alla secondaria superiore nel suo complesso del 55%, ma erano già il 40% nel 1951-52.
La tendenza alla femminilizzazione si era manifestata prima al nord. Nel 1951-52 le ragazze erano il 41% in Piemonte, il 39% in Emilia-Romagna, il 35% in Lombardia, il 30% in Lazio, ma solo il 17% in Campania e il 14% in Sicilia e Puglia. Vent’anni dopo, se in Piemonte la componente femminile si attestava al 56% e in Lazio aveva superato il 60%, Campania e Sicilia con il 51% avevano già un tasso di femminilizzazione della popolazione scolastica di ragioneria più alto di Lombardia (48%) e Veneto (35%). Nei due decenni successivi la componente femminile sul totale della popolazione scolastica degli istituti commerciali assumeva però caratteristiche di stabilità e omogeneità su tutto il territorio nazionale. In Lombardia era del 55% nel 1981-82 e del 57% nel 1991-92, in Veneto del 55% nel 1981-82 e del 58% nel 1991-92, in Lazio del 56% nel 1981-82 e del 55% nel 1991-92, in Campania del 53% nel 1981-82 e del 54% nel 1991-92, in Sicilia del 55% nel 1981-82 come nel 1991-92. Faceva eccezione proprio il caso piemontese, dove il tasso di femminilizzazione della popolazione scolastica degli istituti commerciali si presentava come strutturalmente più alto che nel resto del paese: le ragazze erano infatti il 63,2% nel 1981-82 e il 65,5% nel 1991-92.
Questa peculiarità piemontese trova spiegazione in un’altra tendenza di lungo periodo che caratterizzò la ragioneria nel nostro contesto regionale: la minor crescita delle iscrizioni agli istituti tecnici commerciali rispetto al dato nazionale. Gli iscritti a ragioneria salirono infatti da 6535 nel 1951-52 a 11.727 (+79%) nel 1961-62, a 16.987 nel 1971-72 (+44%), a 32.776 nel 1981-82 (+92%), per scendere a 32.354 nel 1991-92 (-1,3%)78. La popolazione finale – quella del 1991-92 – era “solo” cinque volte maggiore rispetto a quella iniziale, mentre a livello nazionale si era – come detto – decuplicata. Era l’effetto della maggior tenuta sul territorio piemontese degli istituti tecnici industriali che nel 1991-92 avevano una popolazione scolastica assai vicina a quella dei commerciali (32.102 iscritti, un dato proporzionalmente doppio rispetto a quello nazionale). Dovuta al prestigio che l’istruzione tecnica industriale aveva acquisito in Piemonte e alla vocazione ancora a lungo prevalentemente manifatturiera – imperniata sul modello fordista e sul ruolo, anche simbolico, della grande impresa – del suo tessuto economico, essa aveva per effetto di sottrarre potenziali studenti all’indirizzo commerciale, squilibrandone a favore della componente femminile – ancora largamente sottorappresentata negli industriali – la popolazione scolastica. Nella vita della scuola, questi numeri si tradussero in un bisogno crescente di locali e attrezzature, cui l’edilizia scolastica stette dietro con grandi difficoltà, che condizionarono l’attività scolastica dagli anni della ricostruzione – i danni agli edifici scolastici causati dal conflitto furono enormi79 – fino agli anni Settanta. Nel corso dei Sessanta non era per esempio così insolito per gli istituti dover organizzare gli orari delle lezioni su due turni, mattutino e pomeridiano, cui in molti casi la sera si aggiungevano i corsi per gli studenti-lavoratori80.
Era dunque nel contesto di un inedito processo di crescita che si tornò a discutere a metà degli anni Sessanta di riforma della scuola secondaria, un provvedimento atteso dall’opinione pubblica anche in seguito all’introduzione della media unica disposta nel 1962. L’attenzione per questo tema si accentuò negli anni della contestazione studentesca – che come è noto si estese dalle università prima ai licei e poi agli istituti tecnici –, quando si aprì – secondo una logica quasi emergenziale – la stagione di provvedimenti parziali in materia scolastica. Fra tutti, vanno segnalate la riforma della maturità (DL 15
77 Negli altri istituti tecnici la presenza femminile è ancora limitata. La media è del 25%. 78 Contemporaneamente, il numero degli istituti sul territorio passava – considerate anche le scuole private – da 30 nel
1951-52 a 58 nel 1971-72, a 87 nel 1981-82. 79 A Torino risultarono distrutti o parzialmente distrutti 31 edifici scolastici – fra cui l’istituto tecnico Gennaro Sommellier
–, per un totale di 744 aule distrutte e 1422 sinistrate. Cfr. F. Cereja, La crisi della scuola tradizionale e l’avvento della
scuola di massa, in Storia di Torino. VII, Eianudi, Torino, 1998; p. 765. 80 Nell’anno scolastico 1961-62 nel solo Piemonte, secondo le statistiche ISTAT, per quanto riguarda gli istituti tecnici
commerciali e per geometri mancavano 43 aule per soddisfare il fabbisogno di locali della popolazione scolastica.
febbraio 1969, n.9) e la liberalizzazione degli accessi all’università (10 dicembre 1969, n. 910). Quest’ultima soprattutto ebbe importanti conseguenze, giacché l’assenza di restrizioni e canali obbligatori per l’iscrizione all’università fu fra i fattori che indussero un numero crescente di diplomati degli istituti tecnici alla prosecuzione degli studi, attribuendo sempre di più agli stessi istituti una funzione di orientamento prima esclusiva dei licei, con importanti implicazioni per la didattica, nel senso dell’uniformazione dei distinti curricula81. Si trattava di una tendenza peraltro in linea con le dinamiche del mercato del lavoro nel settore dei servizi e che trovava una corrispondenza nel maggior livello di qualificazione ora richiesto anche a ragionieri e dottori commercialisti, i quali peraltro con l’introduzione dell’obbligatorietà della dichiarazione dei redditi, con la legge Vanoni nel 1951, avevano visto notevolmente crescere le opportunità di lavoro come liberi professionisti.
Queste innovazioni sembrarono soprattutto rafforzare la posizione di chi sosteneva l’ipotesi della scuola comprensiva, integrata e unitaria, con cui si sarebbe dovuta superare la tradizionale tripartizione (licei-istituti tecnici-istruzione professionale) caratterizzante il sistema scolastico italiano e che avrebbe dovuto facilitare – anche dal punto di vista didattico – la connessione fra programmi e metodi della media superiore e inferiore. La proposta fatta propria dal ministro Misasi in occasione del convegno di Frascati nel maggio 1970 avrebbe acceso la contrapposizione fra chi voleva riformare la secondaria e innalzare l’obbligo scolastico al fine di abolire la precoce differenziazione – alla fine della terza media – dei percorsi e chi invece vi vedeva il rischio di una dequalificazione della scuola. La rigidezza delle posizioni politiche e degli orientamenti culturali in merito da parte di tutti gli attori sociali coinvolti – non solo i partiti, ma anche le forze sindacali – determinarono però il fallimento di ogni progetto di riforma – da quelle elaborate dalla commissione presieduta da Oddo Biasini a quella presieduta da Brocca – nonostante la ricerca evidente di una linea di compromesso fra le diverse istanze emerse nel corso degli anni.
Nella vita della scuola secondaria, innovazioni importanti, ancorché molto limitate, furono comunque introdotte a partire dagli anni Settanta, dal Ministero e prevalentemente per via amministrativa. Ad avviare questo processo furono i decreti delegati con cui nel 1974 si cercò di venire parzialmente incontro alle istanze di rinnovamento della scuola emerse nel “lungo Sessantotto”, avanzate ora non solo dal movimento studentesco, ma anche da un corpo docenti – molto cresciuto di numero e in cui era in corso il ricambio generazionale – ora fortemente sindacalizzato. Ci si mosse in particolare nella direzione di una maggiore collegialità della scuola: si istituirono gli organi di autogoverno degli istituti e le relative rappresentanze, si riconobbe e si regolamentò il diritto all’assemblea studentesca, si ampliò l’autonomia didattica dei docenti in base al principio costituzionale della libertà dell’insegnamento, si sancì il diritto/dovere all’aggiornamento del corpo docente e quello alla sperimentazione. Si tentò anche – ma fu l’intervento nel complesso meno efficace – con l’introduzione dei distretti scolastici di avviare un processo di decentralizzazione della scuola, coinvolgendo in essa anche le realtà del territorio. Infine fu riconosciuta alla Pubblica Istruzione la facoltà di istituire nuovi indirizzi scolastici “sperimentali” e quello di qualificare come tali quelle scuole che in base alla legge del 1931 presentavano delle “iniziative di differenziazione didattica”. Ne sarebbero derivate negli anni Ottanta, che peraltro registrano un affievolirsi del dibattito in merito alla riforma complessiva della scuola secondaria, per via amministrativa e volontà ministeriale alcune importanti innovazioni. Per quanto concerne l’indirizzo tecnico commerciale va soprattutto segnalato il DPR 31 luglio 1981, n. 725 che istituiva l’indirizzo per ragionieri periti commerciali e programmatori – poi riformulato all’inizio degli anni Novanta con il progetto Mercurio – finalizzato a fornire al perito ragioniere capacità gestionali in un campo, quello
81 Una ricerca sociologica commissionata dall’assessorato all’istruzione della provincia di Torino all’Istituto di statistica
dell’Università degli Studi di Torino, Dopo il liceo scientifico e l’istituto tecnico commerciale. Sbocchi professionali e
riflessioni sul percorso di studi dei diplomati in provincia di Torino (1981-1985), (Franco Angeli, Milano, 1990)
evidenziava come quindici anni dopo il 22% dei periti commerciali diplomatisi a Torino fra il 1981 e il 1985 avessero
proseguito gli studi all’università, contro il76% dei maturati al liceo scientifico. Solo il 39% approdava a Economia e
Commercio. Forte era l’opzione per gli studi di informatica e di diritto. La ricerca peraltro confermava come a iscriversi
a ragioneria fossero in misura maggiore studenti di estrazione operaia (35% contro il 12% dei liceali) e generalmente
ragazzi i cui genitori erano privi di un titolo di studio universitario o di secondaria superiore. Per quanto riguardava invece
gli sbocchi lavorativi, solo il 40% dei diplomati veniva assorbito dal settore creditizio e assicurativo, trovando la
maggioranza collocazione – dopo un periodo di inoccupazione di circa sette-otto mesi – in una pluralità di occupazioni
diverse, tutte nel ramo dei servizi.
dell’informatica, la cui diffusione stava rivoluzionando il profilo professionale degli operatori economici. Più in generale, proprio lo iato evidente fra le competenze richieste da un mercato del lavoro che fra anni Ottanta e Novanta nel settore del terziario avanzato conobbe una rapidissima evoluzione, e le conoscenze dispensate dalla scuola82, resero non più procrastinabile una revisione dei programmi. Essa trovò forma prima nel progetto sperimentale IGEA e poi nel decreto ministeriale del 31 gennaio 1996, n. 12283 con cui si volle non solo aggiornare i programmi, ma soprattutto le metodologie d’insegnamento, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi non più soltanto contenuti, ma di far loro acquisire competenze e abilità utili per il loro inserimento nel mondo del lavoro (problem solving, capacità relazionali e linguistiche, predisposizione alla formazione continua, eccetera).
L’istruzione tecnica commerciale nel tempo della “scuola sospesa” Nell’ormai lontano 1997 Giulio Ferroni descrivendo lo stato di malessere dei sistemi scolastici
nei paesi sviluppati ricorreva all’immagine della «scuola sospesa»84. Sospesa, a suo dire, fra i nuovi compiti educativi e formativi che le venivano affidati in un contesto sociale in sempre più rapida evoluzione e l’evidente disgregazione cui l’andavano sottoponendo una serie di fenomeni fra loro anche molto diversi, ma convergenti nello svuotarla di autorità, con grave danno del prestigio degli insegnanti. Erano gli effetti dei processi di globalizzazione in corso e della diffusione di nuovi mezzi di informazione e comunicazione, dell’emergere di altre agenzie educative concorrenti e più in generale dell’egemonia culturale del mercato, responsabile di svilire tutto ciò che non appare direttamente funzionale al circuito della produzione e del consumo. Era andato così infranto per Ferroni quel «rapporto virtuoso» fra cultura, sviluppo economico e democrazia che aveva caratterizzato la scuola nella seconda metà del Novecento in tutti i paesi sviluppati. E si era invece aperta un’epoca segnata dalla difficoltà crescente nel tenere assieme gli elementi di quella equazione, visto l’emergere di esigenze progressivamente divergenti. Da un lato la necessità di una scuola «per l’economia» in grado di fornire quel «capitale umano», dotato non solo di conoscenze adeguate, ma soprattutto delle competenze metodologiche e delle attitudini comportamentali richieste dal mercato, e divenuto nel contesto di un’economia fattasi “immateriale” (almeno in Occidente) la principale risorsa strategica per lo sviluppo; dall’altro quella di una «scuola civile» che sapesse educare alla cittadinanza in società segnate da una pervasiva crisi di valori, e al tempo stesso sempre più complesse, multiculturali e multireligiose, e in cui la scuola finiva con lo svolgere una funzione essenziale di mediazione e integrazione culturale.
L’ultimo quindicennio si è incaricato di convalidare la diagnosi di Ferroni. In Italia la crisi del sistema politico nei primi anni Novanta, il venir meno dei partiti e delle relative culture politiche che per cinquant’anni avevano innervato le istituzioni repubblicane, e la sua accidentata e precaria ricomposizione attorno a un modello tendenzialmente bipolare, ma caratterizzato da una contrapposizione politica di una asprezza sconosciuta nel resto d’Europa, non è stato estranea al susseguirsi di più di un intervento legislativo di riordino generale delle istituzioni scolastiche cui si è assistito negli ultimi quindici anni. Al di là del giudizio che può essere espresso nel merito e del bilancio delle reazioni, spesso contrastanti, che essi hanno suscitato nella società italiana, è indubbio che con questi interventi si è chiusa una lunga fase di storia repubblicana caratterizzata, nonostante le divergenze, dalla ricerca in materia scolastica di un
82 Dalla ricerca Dopo il liceo scientifico e l’istituto tecnico commerciale. Sbocchi professionali e riflessioni sul percorso
di studi dei diplomati in provincia di Torino (1981-1985), emergeva come i ragazzi dopo le loro prime esperienze
lavorative sviluppassero un giudizio fortemente negativo in merito all’istruzione ricevuta, rivelatasi fortemente
inadeguata rispetto alle competenze richieste nell’ambiente di lavoro. In particolare, essi lamentavano l’eccessivo peso
delle materie letterarie e la scarsa qualità dell’insegnamento delle lingue straniere e dell’informatica. 83 Le principali innovazioni riguardavano la suddivisione delle discipline fra area comune e area di indirizzo, l’aumento
delle ore settimanali di insegnamento con l’obiettivo di espandere quelle dedicate alle attività di laboratorio, l’inserimento
nel biennio della materia “diritto ed economia” in luogo dell’educazione civica, l’accorpamento dell’insegnamento di
Ragioneria e di Tecnica nell’insegnamento di Economia Aziendale, la riformulazione del programma di matematica in
funzione dell’insegnamento dell’informatica, l’istituzione delle discipline “scienze della materia” e “scienze della natura”
per l’insegnamento integrato delle discipline scientifiche, l’istituzione di una area operativa denominata “trattamento testi
e dati” per l’acquisizione delle abilità necessaria al lavoro in ambienti sempre più informatizzati. 84 G. Ferroni, La scuola sospesa. Istruzione, cultura e illusioni della riforma, Einaudi, Torino, 1997.
ampio consenso fra le forze politiche e sociali, anche oltre i confini dell’area governativa, e se ne è aperta invece una in cui la scuola è oggetto di un accesa contrapposizione fra orientamenti culturali fra loro non conciliabili, che nel mediare fra le due esigenze – «scuola per l’economia», «scuola civile» di cui peraltro, soprattutto per la seconda, hanno dato declinazioni contrastanti – hanno ordini di priorità differenti. L’affastellarsi di riforme scolastiche che ha caratterizzato questi ultimi quindici anni non è però solo il corollario dell’alternanza di governo in un sistema politico in cui prevalgono logiche divisive – si veda la ripresa del conflitto attorno alla dicotomia pubblico-privato –, ma anche la misura delle peculiari difficoltà che la scuola italiana – con i suoi anacronismi, in primo luogo quelli relativi al rapporto fra cultura generale/cultura tecnico-professionale – ha conosciuto nell’adeguarsi ai mutati bisogni di istruzione di questi ultimi anni. Né va dimenticato lo stimolo che al processo riformatore – costituendone forse l’unica vera cornice unitaria nella direzione del lifelong learning e dell’armonizzazione dei sistemi formativi europei e dell’omologazione degli strumenti di valutazione – è stata data dalle istituzioni europee, in particolare a partire dalle Raccomandazioni del Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000 85.
Alla fine – provvisoria – di questo tortuoso e contraddittorio percorso riformatore, tre appiano le innovazioni di maggiore portata, considerabili come acquisite e ormai probabilmente irreversibili. La prima è l’innalzamento dell’obbligo scolastico e formativo, attualmente a 16 anni. La seconda è l’adozione del principio dell’autonomia scolastica introdotta dalla legge Bassanini sulle semplificazioni amministrative, 15 marzo 1997, n. 59, e attuata con uno specifico regolamento (DPR 8 marzo 1998, n.275), che riconosce alle singole istituzioni scolastiche la facoltà di adeguare l’offerta formativa al proprio contesto locale, conferendo loro personalità giuridica e ampi margini di libertà in campo didattico-pedagogico e organizzativo-gestionale. In una prospettiva di lungo periodo, rispetto alla politica di rigido accentramento delle funzioni di governo della scuola tradizionalmente seguita dal Ministero della Pubblica Istruzione, si tratta di una rivoluzione copernicana giacché realizzava – in coerenza con la riforma della pubblica amministrazione e la revisione del Titolo V della carta costituzionale – il passaggio a un sistema dell’istruzione policentrico (Stato, Regioni, Enti locali, singole scuole). La terza è di tipo didattico-pedagogico ed è rappresentata dalla centralità assunta dalla personalizzazione dei percorsi di insegnamento e di apprendimento – visti anche come garanzia della qualità dell’insegnamento e rimedio alla presunta tendenza livellatrice di cui alcuni accusano la scuola pubblica – e dagli strumenti di certificazione e rilevazione della qualità della stessa, in termini di competenze e abilità. In particolare, l’introduzione del portfolio e della personalizzazione dei percorsi scolastici disposta dalla riforma Moratti – la legge 12 marzo 2003, n. 53 – rispondeva sia alla necessità di adeguare l’Italia alle indicazioni europee in materia di standardizzazione delle certificazioni scolastiche, sia a quella di consentire delle passerelle fra i vari ordini di scuola all’interno della istruzione superiore. Si riteneva così di superare l’ormai anacronistica configurazione a “canne d’organo” della scuola secondaria superiore italiana, permettendo un facile passaggio da un ordine di scuola a un altro, con l’obiettivo di limitare la dispersione scolastica, in Italia ancora molto alta.
In realtà, proprio nel caso della secondaria, il sistema politico non è riuscito a produrre una riforma durevole, nonostante fosse quella più attesa e necessaria giacché inevasa nel precedente cinquantennio repubblicano. Nell’ultimo quindicennio – almeno sulla carta – sono state sperimentate tutte le soluzioni possibili per superarne alcuni degli anacronismi più evidenti, a partire – appunto – dalla sua natura a “compartimenti stagni”.86 La riforma Berlinguer-De Mauro prodotta dalla stagione dei governi di centro-sinistra aveva provato a superare le difficoltà attraverso la liceizzazione dell’intera istruzione secondaria. La legge 10 febbraio 2000 n. 30 di riforma dei cicli scolastici, destinata a non essere applicata, prevedeva per quanto attiene la secondaria superiore l’unificazione dei vari ordini di scuole in
85 Cfr. Commissione Europea, Libro verde sulla dimensione europea dell’educazione; Id. Libro bianco sulla crescita,
competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo; Id. Insegnare ad apprendere. Verso
una società conoscitiva. E successivamente le Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 18
dicembre 2006 sulle Competenze chiave dell’apprendimento permanente e la Raccomandazione del 23 aprile 2008 sul
Quadro europeo delle qualifiche dell’apprendimento permanente. 86 Cfr. A.E. Briguglio, Dal Ministro Berlinguer alla riforma Gelmini: note cursorie per riflettere sugli itinerari della
formazione e dell’istruzione in Italia, in «Quaderni di Intercultura», III, 2011; G. Malizia, C. Nanni, Il sistema educativo
italiano di istruzione e formazione. Le sfide della società della conoscenza e della società della globalizzazione, LAS,
Roma, 2010.
un unico liceo dove dopo un biennio comune – con cui veniva assolto l’obbligo scolastico innalzato a 15 anni – chi non avesse optato per la formazione professionale di competenza regionale, avrebbe potuto scegliere fra 40 diversi indirizzi, articolati su quattro aree (classico-umanistica, scientifica, tecnico-tecnologica, artistico-musicale).
La successiva riforma Moratti invece interveniva a riarticolare il ciclo della secondaria in licei – di durata quinquennale – e istituti tecnici e professionali – quadriennali con la possibilità di un anno integrativo per poter accedere all’università. La nuova strutturazione87 – che si voleva a riscatto dell’istruzione professionale ricompresa nell’istruzione secondaria attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione professionale (IFTS) – vedeva i licei articolati in otto indirizzi: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. L’intero sistema scolastico avrebbe dovuto presentare – anche a garanzia dell’effettiva percorribilità delle passerelle fra un ordine di scuola e l’altro – un forte grado di integrazione e complementarietà. Anche per questo motivo, la legge disponeva pure per i licei l’obbligatorietà degli stage formativi e a “competenze trasversali” da effettuarsi con il supporto delle regioni.
Sulla riforma Moratti, si sarebbe successivamente abbattuta la politica del “cacciavite”, fatta di interventi settoriali e specifici, del ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, nel governo di centro-sinistra nato dalla vittoria dell’Unione guidata da Romano Prodi alle elezioni del 2006. Nel caso della secondaria Fioroni avrebbe disposto la sospensione della sperimentazione dei nuovi cicli scolastici (oltre che la riformulazione degli esami di maturità e la reintroduzione di quelli di riparazione)88.
Infine, la legge attualmente vigente voluta dal ministro Mariastella Gelmini89, incaricato del ministero della pubblica istruzione nel governo Berlusconi IV, con cui la strutturazione della secondaria superiore – entrata in atto il 1° settembre 2012 – è sostanzialmente ritornata alla tradizionale configurazione tripartita: licei-istituti tecnici-formazione professionale. Non senza un suo generale aggiornamento e riordino, però, mirante, anche per ragioni di razionalizzazione della spesa, innanzitutto all’accorpamento di indirizzi e specializzazioni enormemente cresciuti negli anni precedenti. Per gli istituti tecnici – definiti dalla legge «scuole dell’innovazione» – si è passati da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori (Settore economico e Settore Tecnologico) e 11 indirizzi e si è disposto una ristrutturazione del quinquennio di studi in tre cicli distinti: un primo biennio con materie comuni a tutti gli indirizzi, un secondo biennio con materie dell’indirizzo scelto, un ultimo anno professionalizzante caratterizzato da stage e tirocini a stretto contatto con il mondo del lavoro. L’orario precedentemente articolato su 36 ore da 50 minuti è divenuto di 32 ore effettive, mentre sono state intensificate le ore di laboratorio (246 nel biennio e 891 nel triennio)90. Per quanto attiene nello specifico la vecchia “ragioneria”,91 nella riforma Gelmini essa – insieme all’istituto per il turismo – è andata a costituire uno dei due indirizzi – quello in amministrazione, finanza e marketing – del settore economico dell’Istituto tecnico, a sua volta articolato in due sotto indirizzi: sistemi informativi aziendali e relazioni internazionali per il marketing.
È indubbiamente difficile, con gli strumenti dello storico, tentare un bilancio dei riflessi sull’istruzione commerciale dei provvedimenti assunti negli ultimi anni. Se si guardano le statistiche si può però agevolmente notare come in questi venti anni, segnati peraltro dall’aumento del tasso di scolarità nella fascia di età corrispondente alla secondaria che ha parzialmente limitato l’impatto della decrescita della popolazione giovanile, la demografia scolastica sia in certi rapporti rimasta sostanzialmente immutata.
87 Cfr. D.Lgs. 226/2005, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n.53 88 Fioroni ha disposto (legge 1/2007) il ritorno all’esame di maturità così come era stato introdotto da Berlinguer. In luogo
di una commissione composta da soli docenti interni, come stabilito dalla legge Finaziaria 2001-2002, si è così ritornati
a commissioni miste (3 docenti interni e 3 esterni). 89 Legge 6 agosto 2008, n. 133 e Legge 30 ottobre 2008, n.169. 90 Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici ai
sensi dell’arti. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 91 Al momento della riforma Gelmini l’istituto tecnico commerciale era diviso in diversi indirizzi, oltre al Mercurio e
all’IGEA che abbiamo citato, essi erano l’indirizzo in “Attività gestionali, indirizzo amministrazione e controllo” e quello
in “Attività gestionali, indirizzo comunicazione e marketing”.
Gli iscritti agli istituti tecnici commerciali erano nel 2011-12 420.435, il 16,7% circa della popolazione scolastica della secondaria (2.521.609) e il 49,5% rispetto ai soli istituti tecnici (848629), proporzioni dunque molto simili a quelle del 1991-92. Anche la distribuzione geografica (Nord 41,42%, Sud 41,4%, Centro 17,18%) e la composizione per sesso (49,9% il tasso di femminilizzazione) non si discostavano dal dato di venti anni prima. Il quadro regionale non era diverso. Il Piemonte continuava, seppur in forma meno accentuata, a costituire una anomalia rispetto al dato nazionale, sia per un numero di iscritti – 22.658 iscritti – minore in proporzione al totale dei tecnici (40,9%), sia per un tasso di femminilizzazione invece leggermente più alto (54,7%). Si trattava di scostamenti rispetto ai valori generali che trovano come per il passato una corrispondenza nei numeri degli iscritti agli istituti tecnici industriali (24.525) che nella nostra regione continuavano a essere assai più numerosi (44,3% sul totale degli istituti tecnici) che a livello nazionale (32,5%).
Al di là della rilevanza ai fini della scelta del percorso di studi dei provvedimenti di riforma assunti in questi anni o della forza di inerzia di opzioni culturali e professionali di lungo periodo, va conclusivamente sottolineato come il “ragioniere” continui a essere comunque una figura appetibile sul mercato del lavoro. L’ultima rilevazione di Unioncamere sulle prospettive occupazionali per indirizzo di studio collocava il diploma a indirizzo amministrativo-commerciale al primo posto fra i titoli di studio di istruzione secondaria richiesti dalle imprese italiane, stimando in 40.000 le assunzioni per questa figura professionale nel 201292. E a conferma del carattere sempre più relazionale da essa assunto, indicava fra le competenze più richieste, al pari della flessibilità e adattabilità, la capacità di gestire i rapporti con i clienti e di comunicare efficacemente, sia per iscritto, sia oralmente.
92 Nel 2008 le assunzione in cui era richiesto questo diploma erano state però stimate in 111 mila. Sistema informativo
Excelsior, Gli sbocchi professionali dei diplomati nelle imprese italiane per il 2012, Unioncamere, Roma, 2012; p. 45 e
ss.