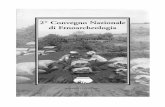Un'officina di bronzista e la produzione di ottone e di specchi a Mediolanum nel I-II secolo d.C....
-
Upload
multiagent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Un'officina di bronzista e la produzione di ottone e di specchi a Mediolanum nel I-II secolo d.C....
ACTA MINERARIA ET METALLURGICAStudi in onore di Marco Tizzoni
a cura di
COSTANZA CUCINI
Comune di Bergamo
4
Periodico di Archeologia del Civico Museo Archeologico di Bergamofondato da Stefania Casini
Tutti i diritti riservatiComune di Bergamo, Museo Archeologico
La responsabilità di quanto riportato nel testo, nonché di eventuali errori e omissioni,rimane esclusivamente degli Autori.
Autorizzazione del Tribunale di Bergamo, n. 32 del 27.11.1993
Direttore responsabile: Stefania Casini
Segreteria di redazione: Cristina Longhi
Sede: Civico Museo Ar cheologico di Bergamo, piazza Cittadella 9, 24129 BergamoProprietà: Comune di BergamoStampato da: Grafo s.r.l, Palazza go, Bergamo - novembre 2012
ISSN: 1127-2155
205
Un’officina di bronzista e la produzione di ottone e dispecchi a Mediolanum nel I-II secolo d.C.
Anna Ceresa Mori - Costanza Cucini
Lo scavo archeologico
Come è noto, in età romana la zona che si estendeva ai lati dell’attuale corso di Porta Romana,era, come in genere i suburbi di Mediolanum, caratterizzata da un assetto misto e polifunzionale, incui coesistevano insediamenti residenziali, artigianali e necropoli. Il tracciato dell’attuale corso diPorta Romana riprende quello dell’importante direttrice di collegamento con la capitale, realizzatacome strada glareata alla fine del I secolo a.C. e monumentalizzata in epoca tardo imperiale conporticati sui lati, conclusi da un arco quadrifronte1.
Parti di complessi residenziali suburbani di buon livello, rinvenute fortuitamente o duranteindagini sistematiche, attestano nel I secolo d.C. un utilizzo a scopo residenziale di prestigio dellaprima fascia del suburbio, entro l’attuale cerchia dei Navigli, fenomeno che si riscontrafrequentemente negli scavi milanesi2. Si tratta della domus di cui rimaneva un vano pavimentato incocciopesto decorato con tessere bianche e nere rinvenuto in via Calderon de la Barca3, del vanodi un edificio individuato in corso di Porta Romana 2, in prossimità della via porticata4, e infinedei resti di edificio residenziale parzialmente messi in luce davanti alla Basilica di S. Nazaro5, conpavimento in opus signinum, pareti e soffitto affrescati, in un primo tempo erroneamente interpretaticome tomba o sacello funerario. Già per altre zone del suburbio è stato osservato che gli abitatistabili, che sorgono inizialmente lungo la principale via in uscita dalla città, in questo caso la stradaverso Roma, danno l’avvio ad una successiva espansione degli insediamenti negli spazi marginalidi risulta tra un asse di collegamento e l’altro.6
Per quanto riguarda l’utilizzo dell’area a scopo funerario, le necropoli rinvenute recentementenell’area dell’attuale Policlinico di via Francesco Sforza, databili tra il I e il II secolo d.C.7, e più asud in corso di Porta Romana 478 e via Madre Cabrini9, sembrano confermare una vocazionefuneraria di quest’area già a partire dall’inizio dell’epoca imperiale, come suggerivano i ritrovamentieffettuati in passato al Polic linico, in via Vaina10, via dei Pellegrini11 e via della Commenda12. Ilsuburbio sudorientale gravitante intorno all’asse di collegamento con Roma risulta propriocaratterizzato, allo stato attuale delle ricerche, dalla concentrazione delle necropoli, che qui iniziano
Notiz ie Archeologiche Bergomensi, 20, 2012, pp. 205-224ISSN: 1127-2155
1) Sulla zona, e sui rinvenimenti relativi alla via porticata romana siveda: CAPORUSSO 1991. Sul tema dei suburbi valide osservazionisi trovano in ORTALLI 1997; sui suburbi di Mediolanum: SENACHIESA 2000, CERESA MORI 2004, CORTESE 2005.
2) A titolo di esempio, si possono citar e i casi di via Cesare Cor renti24 (CERESA MORI 2004), via Puccini (Dal cantiere alla storia. Loscavo di via Puccini a Milano 1997) e via Cappuccio 13 (CERESAMORI-WHITE 1992-93). Lo scavo di via Cappuccio 8-10, ancorainedito, ha restituito reper ti pertinenti alla stessa domus , chedocumentano l’ampia estensione di tale complesso residenziale.
3) DAVID 1996, pp. 68-70.
4) CAPORUSSO 1991, p. 248, pp. 297-309.
5) DE CAPITANI D’ARZAGO 1942, pp. 68-81;CAPORUSSO 1991, pp. 248-249; PAGANI 2006.
6) Sul tema dell’occupazione del suburbio mediolanense si v eda:CORTESE 2005 con bibliografia.
7) BOLLA 1988, pp. 73-100. Gli scavi condotti nello stessosito tra il 2008 e il 2011, ancora inediti, hanno messo in luceuna ricca e vasta necropoli riferibile al I-II secolo d.C.
8) CONSONNI 1999-00.
9) CONSONNI 2008-09.
10) BOLLA 1988, pp. 120-121.
11) BOLLA 1988, pp.119-122.
12) BOLLA 1988, pp. 100-115.
206
già in epoca augustea13, come risulta dai ritrovamenti più recenti, che forniscono un tassello mancantenella ricostruzione della Bolla14.
Più suscettibile di approfondimenti e ricco di novità, perché porta un nuovo contributo alle conoscenzesulle attività produttive della città, trascurate in passato, è il capitolo riguardante gli insediamenti acarattere artigianale, che a partire dall’età augustea, forse allontanati dal centro della città in conseguenzadella sua monumentalizzazione15, si alternavano nel suburbio a quelli residenziali e alle necropoli.
Il controllo sistematico dei cantieri edilizi, l’adozione di rigorose metodologie stratigrafichenelle indagini archeologiche e le analisi dei reperti riferibili alle attività metallurgiche hanno apertonuovi orizzonti di ricerca e permesso di delineare un quadro, sia pure ancora frammentario elacunoso, di un settore poco conosciuto della vita economica di Mediolanum. Dall’analisi che seguesi può cogliere l’avanzato livello tecnologico raggiunto dagli artigiani cittadini. Per quest’area inparticolare, hanno fornito reperti interessanti gli scavi di via Rugabella 16, piazza Erculea17 e,recentemente, quello che si è svolto in corso di Porta Romana 2018 che viene qui presentato.
Lo scavo ha interessato un’area di 100 mq nel secondo cortile di uno stabile del secolo XIXche si affaccia sul Corso di Porta Romana, e ha messo in luce strutture abitative e artigianali diepoca romana relative a un isolato prospiciente l’importante direttrice stradale che dal centro dellacittà si dirigeva verso Roma. Grazie ad un uso prolungato dell’area come giardino, che avevaimpedito l’asportazione degli strati relativi ai periodi più antichi di occupazione del sito, la stratigrafiasi presentava ben conservata.
I livelli precedenti l’insediamento, a matrice ghiaiosa mista a sabbia, con tracce lamellari dicolore rosso-bruno, vengono incisi, presumibilmente in epoca tardo repubblicana, da un fossatocon andamento est ovest, largo m 4,50 e profondo circa m 2 (fig. 1); la pendenza del fondoindicava il suo scorrimento verso ovest. La sponda nord del fossato era delimitata da palificazioni,di cui rimanevano tracce in negativo; la sponda sud era invece rinforzata da una cortina murariaindagata per un tratto di m 10,25, costituita da un nucleo in conglomerato di ciottoli con paramentodi ciottoli sul lato settentrionale, poggiante su tre filari regolari di laterizi sesquipedali legati damalta. Il primo riempimento d’uso conservato sul fondo del canale è databile al I secolo d.C.;entro tale secolo è inquadrabile cronologicamente anche un successivo livello d’uso del fossato,che conteneva un asse di Vespasiano della zecca di Roma del 71 d.C. Tracce di una fitta e profondapalificazione sembrano indicare che fosse stato realizzato uno sbarramento per contenere il deflussodelle acque verso occidente. Si assiste poi ad un progressivo reinterro del fossato, che rimane inuso probabilmente fino all’inizio del II secolo d.C., quando viene definitivamente colmato conriporti di materiale proveniente dalla demolizione di edifici, tra cui si segnalano frammenti dipavimenti a mosaico bianchi e neri, di pavimento in cocciopesto rubricato, di intonaci dipinti, dueantefisse fittili a palmette, un frammento di statuetta fittile dell’inizio del I sec. d.C. con testa dicavallo che presenta tracce di invetriatura (INVERNIZZI 2012, p. 77). Il muro che ne costituivala sponda rimane probabilmente ancora in funzione, forse come recinzione di un cortile o diun’area aperta pavimentata in ghiaia.
La parte ovest dell’area viene occupata da un edificio, indagato solo per una piccola parte sulmargine ovest dello scavo, mentre ad est viene installato un grande deposito di anfore per ladeumidificazione del suolo, forse per un utilizzo dell’area per attività artigianali a cielo aperto.Anche l’attività di bonifica dei terreni con depositi di anfore, che precede gli insediamenti, siriscontra molto frequentemente nei suburbi, a causa della ricchezza di acque superficiali edell’umidità del suolo. La buca, di forma irregolare, era profonda circa m 2 e il riempimentoconsisteva complessivamente in 60 anfore disposte su tre livelli. Le tipologie di anfore riconosciute:di tipo Lamboglia 2, Dressel 6A, 6B, 2/4, 7/11, Camulodunum 184, con alto orlo “ad imbuto”, edell’Egeo orientale, suggeriscono per il deposito una datazione tra il I e l’inizio del II secolo d.C.
13) BOLLA 1988, pp. 15-17, osserva che sembra trattarsi per lopiù di tombe di un ceto sociale di non elevate possibilità economiche equesto potrebbe spiegare la loro ubicaz ione in maggior e o minor misuraarretrata rispetto al fronte della strada principale (riser vato a monumentifunerari di un certo livello?).
14) BOLLA 1988, p. 16.
15) CORTESE 2005, p. 267.
16) CAPORUSSO 1991, pp. 311-330.
17) CAPORUSSO-BLOCKLEY 1992-93.
18) CONSONNI 2008-09. I dati desunti dalla relazione di scavodi Delfina Consonni sono stati sottoposti a revisione per quantoriguarda la cronologia delle fasi.
208
I contenitori erano posti generalmente in verticale, con la bocca verso il basso e tre fori nellaparte inferiore della parete verso il puntale. Le tre anfore del terzo livello erano invece collocate dipiatto. Il riempimento della buca conteneva anche numerosi frammenti ceramici, coerenti con unadatazione del drenaggio alla fine del I secolo d.C.- inizio II, e scorie vetrose e ferrose.
Nella parte sud-est dell’area viene steso uno strato che comprende scarti di lavorazione pertinentia crogioli e a matrici per la produzione di appliques in bronzo, frammenti di mosaico, scorie eframmenti ceramici.
Si sono individuate fondazioni “a strati” relative ai muri perimetrali di un vano pertinente ad unedificio modesto, solo parzialmente indagato, con sviluppo a sud ovest, poggianti su un impiantodrenante databile come il precedente, costituito da anfore di tipo Lamboglia 2, Dressel 2/4 e conalto orlo a imbuto, Dressel 6A e 6B, adagiate orizzontalmente, addossate e in alcuni casi con ilpuntale inserito nella bocca dell’anfora successiva. Le fondazioni “a strati” , una tipologia frequentea Milano soprattutto tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.19, erano costituite da strati alternati di limoe frammenti ceramici, ciottoli e frammenti laterizi. Era conservato un tratto dell’alzato del murosoprastante, in corsi regolari di frammenti laterizi, ceramici e ciottoli, legati da malta poco tenace.Poiché alle strutture era addossato un piano di calpestio esterno all’edificio, che conteneva frammentilaterizi e ceramici, scorie ferrose, una matrice fittile e una moneta di Nerone (54-69 d.C.), il complessopuò essere datato tra la seconda metà del I secolo d.C., e l’inizio del II. In un secondo tempol’edificio viene ampliato ad est, con l’aggiunta di un vano, di cui è stato indagato un tratto di murosimile ai precedenti.
La fase successiva, riferibile, in base ad un preliminare esame dei reperti, al II secolo d.C., vedel’abbandono e la demolizione dell’edificio, su cui si impostano due canalette che utilizzano i restidelle murature come piano di appoggio. Il condotto nord sud aveva spallette in corsi di frammentilaterizi, ciottoli, ceramica e limo, quello che lo incrociava ad angolo acuto conservava solo untratto di spalletta in laterizi. Nell’area sud viene steso uno strato di livellamento che contenevaanch’esso scorie e scarti ferrosi. Successivamente le strutture, probabilmente nel III secolo d.C.,vengono asportate, con interventi di rasatura e livellamento delle superfici che preparano il terrenoper una nuova fase edilizia.
Essa interessa tutta l’area di scavo e vede la costruzione di un edificio a più vani, di cui siconservavano alcuni tratti di murature e pavimenti con orientamento nord- sud. Il muro dicontenimento del fossato della seconda fase continua ad essere in uso come confine tra la partenord e quella sud. Nella parte sud si sono individuati due lacerti di murature poco consistenti, inframmenti di mattoni e ciottoli legati da terra, forse pertinenti a recinzioni o a edifici a carattereproduttivo. A nord era conservata una porzione di un complesso abitativo di buon livello, di cui sisono individuati resti di tre ambienti delimitati da muri perpendicolari tra loro. Il vano est presentavaun pavimento cementizio con lastrine di marmo allettate in uno strato di malta bianca, condistribuzione irregolare, su una preparazione in cocciopesto rossastro. Il muro con andamentonord sud, che lo delimitava sul lato ovest, era costituito da frammenti di laterizi e coppi e materialiedilizi di reimpiego tra cui un basolo stradale, disposti senza regolarità, legati da abbondante maltadi colore giallastro. Perpendicolare a questo muro era un lacerto di fondazione realizzato contecnica simile al precedente, legato da malta di colore bianco grigio, la cui trincea di spoliazioneproseguiva verso ovest, dove erano resti di altri due vani, un piccolo ambiente rettangolare nordsud e un secondo pavimentato con malta e ghiaia, separati da due muri paralleli, di cui rimanevanolacerti in frammenti di laterizi, tavelloni e ciottoli legati da malta. A sud era un piccolo tratto dicondotto fognario in laterizi, ciottoli e tavelloni. Questa fase edilizia sembra indicare un nuovoperiodo di sviluppo di questo settore sudorientale del suburbio, da mettersi in relazione con lacreazione, attorno alla metà del IV secolo, della grande strada porticata verso Roma, ricalcatadall’attuale corso di Porta Romana.
Le fasi successive, dall’epoca tardoantica al Medioevo, vedono il progressivo abbandono delcomplesso edilizio, che viene poi coperto con interri per l’utilizzo dell’area come terreno di coltivo,fino al cortile pavimentato della palazzina attuale, realizzata attorno alla metà del secolo XIX.
19) Su questa tipologia edilizia si veda: CERESA MORI 2010,p. 98, nota 12, con bibliografia.
210
Un confronto tra la sequenza stratigrafica del sito e quelle degli scavi condotti nella vicina viaRugabella nel 1987 e in piazza Erculea nel 1992, mostra sostanziali punti di contatto nei contestiindagati. Il fossato rinvenuto in corso di Porta Romana 20 è probabilmente la continuazioneverso est di quello emerso in piazza Erculea, con lo stesso orientamento est ovest e una larghezzainferiore (fig. 2). Sia in via Rugabella sia in piazza Erculea si registrano la colmatura dei fossati e larealizzazione di edifici nel I secolo d.C. In piazza Erculea i primi edif ici vengono demoliti per farposto ad un’officina metallurgica, a cui nel corso del I secolo d.C. se ne sostituisce un’altra per lalavorazione del bronzo. Gli strati di livellamento contenenti scorie ferrose, crogioli per la fusionedell’ottone e matrici per la lavorazione di appliques di bronzo rinvenuti in corso di Porta Romana20 potrebbero quindi provenire proprio dalla vicina area artigianale di piazza Erculeaconfermandone l’attività nel corso del I secolo d.C. In tutte e tre le aree si registra inoltre unacessazione delle attività edilizie nella seconda metà del III secolo d.C. in concomitanza con unasituazione di spopolamento del suburbio che sembra regredire nel secolo seguente, ed èprobabilmente da collegarsi alle invasioni degli Alamanni. La ripresa dell’edilizia residenziale dibuon livello, legata alla monumentalizzazione dell’asse di collegamento con Roma intorno allametà del IV secolo, è stata riscontrata solo negli scavi di via Rugabella e corso di Porta Romana 20,ma non è documentata nello scavo di piazza Erculea, area che risulta in abbandono anche dopo ilIII secolo d.C.
La chiusura delle officine metallurgiche nel corso del I secolo d.C., sostituite in piazza Erculeadall’edilizia residenziale, è un dato importante, che testimonia l’espansione dell’abitato nel suburbiooltre le mura, documentato in varie zone della città, nella massima fase di sviluppo economico edemograf ico di Mediolanum. In tale fase, probabilmente, gli impianti artigianali decentrati nellaprima fascia del suburbio subirono un ulteriore spostamento verso l’esterno, per non creare disturboagli insediamenti residenziali suburbani.
A.C.M.
Fig. 3: Andamento dei fossati rinvenuti in piazza Erculea e Corso di Porta Romana 20.
211
Lo studio degli scarti metallurgici
Come ha illustrato A. Ceresa Mori, lo scavo archeologico condotto a Milano in c.so di PortaRomana, 20 ha restituito contesti stratigrafici riferibili a due distinti scarichi di scarti della lavorazionedei metalli20. Nella parte S-E dell’area di scavo furono depositati residui della fusione del rame esue leghe, mentre nella parte O vennero scaricate scorie della lavorazione del ferro; in entrambi icasi, siamo di fronte a materiali in seconda giacitura. La cronologia più probabile per la formazionedei due scarichi è la fine del I secolo d.C.-inizio II. In questa sede ci soffermeremo esclusivamente sulcomplesso di scarti relativi alla lavorazione di manufatti in leghe di rame: si tratta di un insieme moltoomogeneo e coerente, costituito da frammenti di matrici, di crogioli e di ugelli, oltre che frammentimetallici, senza dubbio pertinenti all’attività di una medesima bottega. Se ne dà qui di seguito unapreliminare disamina, mentre è in preparazione un’edizione completa corredata di ampie analisimetallografiche.
Le olle-crogiolo. I crogioli utilizzati dall’officina milanese sono molto peculiari, dato che sitratta di olle in ceramica comune rivestite di argilla.
Le olle sono realizzate a tornio veloce in un impasto grezzo nerastro, con fitto smagrante biancomedio (dimensioni fino a 4x3 mm) a spigoli vivi, che sembra poco refrattario; esse mostrano forme,formati e repertorio decorativo standardizzati (fig. 4:1-6). Tutte hanno il bordo estroflesso, che formaun lieve spigolo esterno con la parete, una sorta di leggera risega sopra la spalla; l’orlo è appena ingrossato,arrotondato o sagomato; il corpo è ovoide, il fondo piatto. I recipienti sono decorati sulla spalla per lopiù a pettine, con solcature parallele dritte o ondulate; alcuni esemplari mostrano decorazioni a rotella,altri alla barbotina o a unghiate oblique parallele, oppure file di cerchietti incavati decrescenti. Mentrel’altezza sembra stimabile intorno a 15-18 cm, il diametro interno dell’orlo varia tra 11 e 14,5 cm, quellodel fondo si aggira attorno a10-11 cm, lo spessore della parete è in genere sottile, tra 0,4 e 0,8 cm, mapuò giungere fino a 1,3 cm. In media la capacità di questi recipienti era modesta.
Queste olle, prodotte in serie, venivano appositamente ricoperte esternamente e spesso ancheinternamente da uno strato di argilla abbastanza depurata, con raro smagrante bianco, e piuttostoliquida (spessore esterno cm 2-3) per essere utilizzate come crogioli. Lo spesso rivestimento,anche se apparentemente grossolano, era fatto aderire con cura al recipiente; esso ricopriva l’interovaso esternamente e continuava sulla superf icie interna dell’olla come una sorta di ingobbiogrossolano, ma sottile, fino a coprire il fondo. In alcuni esemplari esso risulta molto spesso anchesul fondo interno (fino a 2,2 cm): lo spessore totale del fondo dei recipienti giungeva dunquevicino a 5 cm. Questo strato di rivestimento era applicato con le dita (si notano talvolta i segni deipolpastrelli), ma più spesso veniva fatto aderire con l’ausilio di una stecca. Veniva così realizzatauna sorta di nuova olla di spessore molto maggiore (fra 2,5 e 5 cm), sormontata da un grosso orloarrotondato foggiato a mano, irregolare, innalzato di circa 3 cm rispetto a quello di partenza.Questo nuovo bordo veniva foggiato in forma trilobata; in alcuni esemplari (fig. 4:8-9) lo si osservasull’orlo esterno, dove l’argilla è stata modellata rozzamente al di sopra dell’olla rivestita. La capacitàinterna dei recipienti così ottenuti risulta nel complesso analoga o di poco inferiore a quella dell’olladi ceramica comune, infatti l’aumento di volume ottenuto rialzando il bordo è in parte neutralizzatodall’ispessimento interno. Varia invece considerevolmente il diametro dell’orlo e del collo interno,che risultano decisamente inferiori a quelli originari (cm 9,2-10,2), come anche il fondo, mentrel’altezza può giungere a 21 cm. Nel complesso si ottenevano quindi recipienti più profondi,piriformi, con collo più alto e imboccatura più stretta, dotata di un versatoio; il loro diametrointerno era più piccolo in rapporto all’altezza e la loro forma risultava più chiusa. Non si notanoprese o manici, e nemmeno segni lasciati dagli utensili – pinze o tenaglie – con i quali i crogiolidovevano essere maneggiati21. L’imboccatura stretta serviva a ridurre le perdite di calore e ad
20) Fase V, Periodo I, US 158-159 e 182; si veda la relazionepreliminare dello scavo in CONSONNI-PAGANI 2008-09. Peruna prima notizia sui materiali metallurgici CUCINI 2008-09.In questa sede si sono riprese e approfondite le analisi al SEMdegli scarti della metallurgia, e si è ampliato lo studio di matricie crogioli. Desidero ringraziare la dott.ssa Annalisa Majorano,
della Società Lombarda di Archeologia, che con grande efficienzae disponibilità ha favorito in ogni modo la disamina dei materiali.
21) Questo è un tr atto comune ai crogioli antichi, è raro trovaretr acce di utensili su questa classe di manufatti, BAYLEY-REHREN 2007, p. 47.
212
evitare il più possibile l’ossidazione della carica, che causa la perdita di metallo.Il rivestimento esterno era realizzato in modo molto accurato e preciso, tanto che in alcuni
esemplari costituisce un tutt’uno indistinguibile dall’olla di partenza; esso risulta molto indurito equasi del tutto stracotto e vetrificato, deformato dal forte calore a cui venne esposto direttamente.Forse per la sua natura – argilla molto depurata, con pochi inclusi vegetali, fatta aderire piuttostoliquida – questo rivestimento tende a cuocere con fessurazioni e ritiri. Ciò ha dato origine aconseguenze diverse: talvolta, come si è detto, esso è inscindibile dall’olla che riveste, quasiconcrezionato e fuso su di essa, ma nella maggior parte dei casi ha finito col non aderire veramenteal corpo del vaso e a distaccarsene dopo l’utilizzo conservandone però una dettagliata impronta innegativo. Tanto precisa è questa “stampa” in negativo che ricalca con assoluta fedeltà la decorazionedella spalla dell’olla (fig. 4:7, 10). Evidentemente il diverso coefficiente di dilatazione al calore delrivestimento refrattario rispetto all’olla ha causato questo distacco; inoltre le numerose fratturefresche e antiche mostrano che era piuttosto fragile.
Le proprietà fisiche sopra descritte – forma, misura, struttura ceramica, versatoio ecc. – sonostrettamente correlate fra loro e alla funzione tecnica dei crogioli, cioè la resistenza al peso delmetallo che dovevano contenere ad alta temperatura e allo shock termico; inoltre questi recipientidovevano essere abbastanza piccoli da essere manipolati con facilità, dovevano favorire unriscaldamento veloce delle leghe impiegate e permetterne il controllo, evitando la riossidazionedel metallo liquido22. A queste caratteristiche dei recipienti va aggiunto il fatto che il rivestimentoesterno risulta in genere completamente vetrificato e bolloso, con impronte di carbone in pezzifino a 4x7 cm (fig. 6); questa vetrificazione mostra che i recipienti erano posti in un focolare etalvolta ricoperti interamente di brace ardente. All’interno dei recipienti si notano talvoltaincrostazioni metalliche, o qualche sferula di rame e sue leghe. All’esterno compaiono in moltiesemplari le consuete vetrificazioni dai colori vivaci che di solito contraddistinguono i crogioli permetalli, ad esempio le macchie rosse e verdi-azzurre di rame; qualche colatura metallica è rilevabilesul bordo in corrispondenza del versatoio.
Altri esemplari non recano invece traccia di macchie e gocciolature metalliche: questo potrebbeessere un indizio del loro impiego nella produzione di ottone per cementazione. Un’ulterioreprova in questa direzione è che molte olle-crogiolo non recano alcuna traccia all’interno dellacarica metallica: sono assenti incrostazioni e scorificazioni, sembra che ci sia stata poca interazionetra la parete interna dei recipienti e la carica metallica che contenevano23.
Si segnala inoltre la presenza di alcuni frammenti di coperchi con presa apicale cilindriforme,anch’essi ricoperti da un rivestimento in argilla vetrificato.
Non è questa la prima attestazione a Milano di olle-crogiolo: nello scavo di piazza Erculea,vicina e quasi contigua al contesto archeologico di c.so di Porta Romana 20, sono emersi frammentidel rivestimento in argilla recante la netta impronta delle olle; in questo caso i recipienti eranodotati di coperchio24. Dato che inizialmente sembrava trattarsi di esemplari isolati, si era ipotizzatoche le olle-crogiolo fossero un espediente o un ripiego di qualche artigiano che avesse utilizzatoquesto escamotage non disponendo di crogioli veri e propri. È ormai evidente, invece, che le officinedei bronzisti milanesi avevano adottato questa soluzione su ampia scala, perché essa rispondevabene alle loro esigenze funzionali. In ogni caso, è certo che le olle non vennero in origine realizzatea questo scopo, poiché altrimenti non recherebbero alcuna decorazione sulla spalla. Queste olle-crogiolo erano comunque prodotte in serie, anche se il rivestimento esterno era foggiatoindividualmente25, con caratteristiche standardizzate per i laboratori di bronzisti dell’anticaMediolanum.
In epoca romana sono noti alcuni esempi simili – ma non proprio uguali – di crogioli scaldatidal basso in cui, al recipiente a pareti sottili, era aggiunto uno strato esterno di argilla, uno “stratosacrificale”26 isolante ma comunque conduttore, che aveva la funzione di distribuire il calore
22) Per tutto ciò BAYLEY-REHREN 2007, pp. 46-47.
23) BAYLEY-REHREN 2007, p. 50.
24) In corso di studio da parte di Marco Tizzoni. Per lo scavosi veda CAPORUSSO-BLOCKLEY 1992-93.
25) REHREN 1999, pp. 254-255.
26) BAYLEY-REHREN 2007, p. 50: sacrificial layer; si veda anchela fig. 3:g.
213
Fig. 4: 1-10) Olle-crogiolo per la produzione di ottone; 11,13) matrici di specchi; 12) matrice non identificata(rid. 1:3; dis. C. Cucini).
214
uniformemente, ridurre lo shock termico e sigillare le eventuali crepe che si potevano formaredurante l’uso. Questi crogioli conservavano bene il metallo liquefatto, eliminando le perdite emantenendo la struttura integra. Se ne conoscono esempi in Britannia a Colchester e a Canterbury27,in Germania a Nida-Heddenheim presso Francoforte sul Meno e a Ladenburg-Neckar, soprattuttoin relazione alla produzione di ottone28. Un po’ diversi e di dimensioni maggiori sono i crogioli daottone della Gallia transalpina 29. Nel caso in esame, la presenza di un versatoio è dovuta allanecessità di colare il metallo liquido in forme.
A che cosa servivano le olle-crogiolo milanesi? La forma e l’insieme delle caratteristiche di alcune diesse rimanda al processo di produzione dell’ottone per cementazione. L’attestazione di esemplari colversatoio indica che, una volta portato a termine il processo, si alzava la temperatura del focolare perfondere e dunque omogeneizzare la carica metallica. Dopo di che il metallo liquido era gettato in forme.Questo poteva interessare anche il riciclaggio di rottami di oggetti in varie leghe di rame, come adesempio bronzi ternari: l’officina milanese lavorava anche bronzo e leghe di rame piuttosto eterogenee.
Gli ugelli. Per quanto concerne i pochissimi frammenti di ugelli recuperati, essi erano realizzati inargilla depurata rosso arancio, con raro f ine smagrante di colore bianco, fortemente indurita dal calore.Dato che venivano introdotti all’interno del focolare per insufflare aria ed alimentare la combustione,essi risultano fortemente concotti e vetrificati all’esterno, sono deformati e recano colature di metallocon ampie zone ossidate di carbonati di rame; spesso vi aderiscono scorie, frustoli centimetrici dicarbone e ghiaino. Anche questa classe di manufatti risulta estremamente frammentaria. Uno dei pochiesemplari ricostruibili (fig. 5:1) è sub-cilindrico (diametro cm 9,5), sembrerebbe con un unico canale diinsufflaggio (diametro cm 2,6); esternamente è rivestito da una spessa incrostazione di scoria evetrificazione (spessore medio 2 cm).
Le matrici. Il complesso di scarti dell’officina di bronzista comprendeva numerosi frammentidi matrici, che ci forniscono informazioni sulle tecniche di fusione, sui metodi di lavorazione esugli standard tecnico-professionali degli artigiani milanesi.
Le numerose matrici risultano ascrivibili a oggetti di produzione seriale, di un repertorio piuttostolimitato. In genere, sono realizzate con argilla piuttosto depurata rosso-arancio, con poco smagrante evacuoli forse lasciati da inclusi vegetali; all’interno essa è ben lisciata e ha assunto un colore grigiastro alcontatto col metallo fuso. È evidente che quest’ultimo strato interno, che conserva la forma precisa eaccurata dell’oggetto da realizzare, era foggiato con l’ausilio di un modello; viste le analogie anche incontesti più tardi, si potrebbe pensare a modelli in piombo30, che tuttavia non sono stati rinvenuti.Invece il resto della matrice era modellato a mano, si notano le impronte lasciate dalle dita dei lavoranti.
Gli scarti risultano molto frammentati ed incompleti, pochissime matrici sono state rinvenutepressoché integre; questo indica che dopo la fusione esse erano rotte per recuperare l’oggetto, inoltredovevano risultare molto fragili e questo può aver comportato ulteriori frammentazioni dopo chevennero gettate via. Non è certo che si rompessero di frequente per le alte temperature a cui eranosottoposte: pochi frammenti recano metallo fuso aderente o infiltrato nelle fratture, solo raramente sinotano esemplari fortemente deformati dal calore, vetrificati, con colature metalliche sulle pareti.Nonostante l’assenza di abbondante smagrante vegetale o di chamotte, che avrebbero reso l’impasto piùresistente alle contrazioni e alla pressione esercitata dal passaggio di aria e gas durante il getto di metallofuso, le matrici sembrano aver sopportato bene lo stress termico31. Il fatto che si tratti di materialesempre incompleto, non ricomponibile, può suggerire inoltre che una notevole quantità di scarti venisseportata via e scaricata anche altrove per essere usata come riempimento, analogamente a quanto avvenutonel contesto in esame.
L’estrema frammentarietà delle matrici impedisce spesso di stabilire se fossero a una o duevalve, tuttavia si possono fare alcune considerazioni.
27) BAYLEY 1984.
28) BACHMANN 1976; ZWICKER et Al. 1985, p. 107. Ingenerale per la produzione di ottone nella Germania r omanaREHREN 1999-a.
29) PICON et Al. 1995.
30) Come avveniva, ad esempio, nell’ergasterion della Cr ypta Balbia Roma, RICCI 1997, p. 239.
31) Anc he se il contesto è di epoca diversa, si v edano leosservazioni in LAMM 1991.
215
Una delle produzioni attestate è quella di specchi. Sono state rinvenute numerose matrici (figg.4:11, 13 e 5:2-4, 6) relative alla fabbricazione di specchi rotondi e quadrangolari; mentre non sipossono ricostruire le dimensioni di questi ultimi, le matrici per specchi subcircolari mostrano undiametro interno abbastanza regolare compreso fra 6,5 e 11 cm. Esse hanno un bordo rialzato di1,5-3,5 mm, talvolta un po’ inclinato, mal conservato, sembrerebbe largo 0,7-1,2 cm, mentre laparte rotonda è piatta, perfettamente liscia, senza asperità di sorta. Sul bordo di un esemplare sinota un canale di colata (larghezza 1,5 cm). Anche le matrici per specchi quadrangolari hanno ilbordo appena inclinato; una di esse sembra riferibile ad uno specchio leggermente bombato. Lematrici per specchi rotondi mostrano sulla faccia esterna una sorta di bugna sporgente di 1,5 cm,pressoché in corrispondenza del canale di colata. Talvolta si notano sgocciolature o inclusioni di metalloinfiltrato nelle crepe delle matrici, o addirittura qualche porzione della lega metallica sulla parte pianadello specchio; in questi casi è possibile che il prodotto realizzato risultasse compromesso o danneggiato.
Non sembrano invece riferibili alla produzione di specchi numerose matrici simili alle precedenti,ma di dimensioni più piccole, con un incavo rettilineo molto regolare, profondo 1,5-4 mm, a paretileggermente svasate (figg. 4:12 e 5:5). L’oggetto prodotto doveva risultare una lamina con un cordolosporgente su un lato. Si segnalano inoltre numerose matrici pertinenti ad appliques per mobilio (fig. 5:7).
Per quanto concerne gli specchi in bronzo, sebbene non siano stati trovati frammenti o scartidel prodotto finale, tuttavia questi oggetti di produzione seriale sono piuttosto diffusi nei contestitombali della Lombardia dal I sec. a.C. agli inizi del II sec. d.C.32. Gli specchi mostrano generalmentespessori ridotti o ridottissimi (1-2,5 mm) della lamina di bronzo che li costituisce e sono ascrivibilia due tipi principali: quelli più dozzinali che sono lisci e lucidati da un solo lato con bordo inclinatoverso di esso, mentre l’altro lato è grezzo33; e quelli più raffinati, che hanno entrambe le faccelucidate e riflettenti, con bordo perpendicolare e che erano quindi montati con una cornice chepermetteva l’utilizzo sui due lati. Inoltre vi sono specchi piatti e specchi bombati.
Con gli scarti di c.so di Porta Romana, 20 siamo in presenza della prima attestazione di bottegheproduttrici di questa classe di materiali nella Lombardia romana; non deve stupire che esse sitrovassero a Mediolanum, il centro economicamente più importante e vitale della zona.
Fig. 5: 1) Ugello. Matrici: 2-4, 6) per specchi; 5) non identificata; 7) per applique (rid. 1:3; dis . C. Cucini).
32) Specchi romani compaiono nei cor redi funerari celtici delletombe tardo La Tène da tabili tr a il 120 e il 25 a.C., si vedal’esemplare da Misano di Gera d’Adda (BG), TIZZONI 1981,pp. 6, 10 n. 24, e fig. 3:e.
33) Davide Bruni, Gli specchi r omani della provincia di Pavia, tesi dilaurea, Università Sta tale di Milano, a.a. 2010-11, relatore pr of.F. Slavazzi.
216
I crogioli-matrice monouso e la fabbricazione degli specchi romani. Uno degli argomentidi tecnologia antica più dibattuti è, tradizionalmente, quello del modo di realizzazione degli specchi.Il rinvenimento in c.so di Porta Romana 20 di matrici e di peculiari crogioli monouso apporta unnuovo contributo alla soluzione del problema.
Se si osservano frammenti di specchi romani si nota di solito, in sezione, una struttura metallicastratificata costituita da uno strato rosso rame interno e due strati esterni biancastri34.
Le poche analisi finora effettuate mostrano che la lega impiegata negli specchi romani era unbronzo ternario ad alto contenuto di piombo e stagno. Mentre la struttura metallica della partecentrale è una lega Cu-Sn ben cristallizzata, sulle superfici si formava una fase uniforme ä-Cu31 Sn8finissima e omogenea, dove sono dispersi piccoli globuli di piombo (insolubile nella lega Cu-Sn allostato liquido). Questa fase tenace, protettiva e resistente alla corrosione, è rivestita da un sottile film dicassiterite amorfa (SnO2)
35. L’eutectoide ä-Cu31 Sn8 si forma alla temperatura di 520°C.Fra gli scarti recuperati in c.so di Porta Romana 20, si segnala un peculiare esemplare, rinvenuto
quasi integro, interpretabile come crogiolo-matrice monouso (figg. 7-8). Esso è realizzato in argilla,con raro e f ine smagrante bianco, che con l’esposizione al calore è diventata di colore grigio scuro.Ha un corpo centrale ovoide da cui sporge su un margine una protuberanza cilindriforme (lunghezza
Fig. 6: Olle-crogiolo per la produzione di ottone (foto C. Cucini).
34) Lo studio è in corso.
35) È noto che gli specchi, sia etruschi, sia di epoca r omana,sono pr evalentemente studiati dal punto di vista storico-artisticoper il loro r eper torio decorativo o come oggetti di lusso. Fra
gli studi tecnologi si segnalano quello di LEONI-PANSERI1956-57 e più recentemente CRADDOCK 1986 e INGO etAl. 2006. Gli specchi analizza ti mostrano un alto contenuto di Sn(23-24%) e di Pb (8-10%), contengono inoltre poco Zn e Fe.
217
totale cm 10; larghezza max cm 8,2; spessoremax cm 6,6). Su una faccia si osserva la presenzadi una bugna, una protuberanza analoga a quellaosservata sull’esterno delle matrici per specchi,che sporge di circa cm 1,5. Sul bordo oppostoalla protuberanza cilindrica si nota un’aperturairregolare, come un ampio foro di sfiato; sempresu questo lato si nota inoltre l’impronta lasciatada un utensile (tenaglie o pinze) con cui ilcrogiolo fu maneggiato. Su di un bordo, l’argillarisulta deformata e vetrificata.
Si trattava, è evidente, di un pezzo difettosoche venne scartato dopo l’esposizione al fuocoe per questo motivo ci è giunto quasi intatto: sela fusione fosse andata a buon fine, sarebbe statorotto in pezzi per recuperare l’oggetto realizzato.Invece la probabile presenza di una crepa su diun lato fece sì che all’inizio del processo il gas sviluppato durante la fusione trovasse lì uno sfiatoper sfogare: oltre al vapore, dovette uscire anche il metallo, che venne recuperato dopo l’espulsione.Date le piccole dimensioni, non si tratta necessariamente di un crogiolo per specchi, ma forse perrealizzare un oggetto più piccolo, anche se di forma simile. È verosimile che altri frammentirecuperati in c.so di Porta Romana, 20 siano riferibili ad altri esemplari di questo tipo, ma relativialla fabbricazione di specchi circolari. Vedremo di seguito che possiamo definire, a ragion veduta,questi peculiari oggetti come “crogioli-matrice monouso”.
Per comprendere ed interpretare correttamente questi nuovi dati archeologici, un apportorisolutivo viene dall’osservazione del procedimento tuttora in uso presso la manifattura tradizionaledi specchi di Aranmula, un villaggio nella valle del fiume Pampa nello stato di Kerala, presso lapunta meridionale dell’India. Questi famosi specchi vengono ancora oggi prodotti, secondotradizioni metallurgiche e culturali molto antiche36, da una sola famiglia allargata che da secoli sitramanda gelosamente il segreto di generazione in generazione. Si può quindi tentare unaricostruzione del procedimento, rileggendo i dati archeologici milanesi alla luce di quelli disponibilisugli specchi di Aranmula. Per comodità, faremo riferimento alla realizzazione di uno specchiocircolare.
Si preparava una matrice a due valve utilizzando argilla rossa non molto depurata, con smagrantevegetale, che veniva accuratamente lisciata sulle facce interne. Una delle due valve aveva un bordorialzato di pochi millimetri, in modo da ottenere uno spessore interno che sarebbe stato riempitodal metallo; in questo bordo era predisposta una piccola apertura rettangolare, il canale di colata,e presso di esso era realizzata una bugna sporgente. Le due valve venivano quindi sovrapposte eaccuratamente rivestite tutto intorno con argilla piuttosto bagnata, che le sigillava; si aveva cura diinserire, in corrispondenza dell’unica apertura esistente nel bordo, quella del canale di colata, unpezzetto cilindrico di stagno che doveva risultare un poco sporgente all’esterno del rivestimentoargilloso sigillante. Si otteneva così una specie di disco bombato che veniva fatto essiccare. Unavolta che l’argilla era essiccata, si applicava sul bordo, in corrispondenza del pezzetto di stagno, un
Fig. 7: Crogiolo monouso (foto C. Cucini).
36) Secondo la leggenda legata al tempio di Ar anmula, ottofamiglie di artigiani esperti nelle arti minori furono por tate nelXVI-XVIII secolo, da un persona ggio di rang o reale, dalconfinante distretto di Tirunelveli (l’antica Sankar ankoil, nellostato di Tamil Nadu, nell’India meridionale) al tempio diParthasarathy ad Aranmula. Questi abili artigiani scoprirono laproprietà riflettente di una speciale lega metallica, ma non nerivelar ono mai l’esatta composizione. La lega fu perfezionataulterior mente dalle ultime generazioni di ar tigiani, ma è tuttoraprotetta dal segreto; secondo un’altr a versione della leggenda,il procedimento impiegato non avrebbe subito modif iche nelcorso dei secoli. A dif ferenza degli specchi al mercurio, in cuil’immagine si rif lette dallo strato di f ondo dove è applicato il
mercurio stesso, negli specchi di Aranmula l’immagine è riflessadalla superficie superiore del metallo rif lettente, senza alcunadistorsione . Per evidenti motivi commerciali e di segretoindustriale , tutto il materiale infor mat ivo pub blicitariodisponibile anche sul web sug li specchi di Aranmula è elusivo esfuggente sui dati concreti, ad esempio sull’effettiva legaimpiegata: talvolta si parla di una le ga di Cu e Sn con altri metallisegreti, altre volte di una lega di Cu, Sn, Pb e Ag; altrove siaccenna al f atto che si tratta di un bronz o gettato ad altocontenuto di Sn – 33 %. Inoltr e i video non mostrano tutte lefasi della lavorazione e danno solo infor mazioni parziali etalvolta inesatte o imprecise, che devono essere integrate eassunte criticamente, con molta cautela.
218
cilindretto sporgente di argilla bagnata che venivafoggiato a formare una piccola cavità cilindrica,una sorta di robusto imbuto corrispondente alcanale di colata: il crogiolo. Questo veniva riempitocon pezzetti di metalli diversi o di una lega giàpreparata, e poi coperto e sigillato con strati diargilla bagnata alternati a pezzetti di fine tessutoanch’esso molto bagnato. Il tutto era infineaccuratamente lisciato: il risultato era una sorta di“borr accia” piatta in argilla, con una bugnasporgente, dotata sul bordo di una protuberanza“a panettone”, ermeticamente chiusa su ogni lato.
Per la fusione, si utilizzava un focolare diriscaldo aperto, alimentato a carbone di legna; lafiamma era tenuta piuttosto alta37 . La matrice-crogiolo veniva posta in questo focolare “a testain giù”, cioè con in basso il crogiolo cilindricosporgente38; esso era completamente immerso nellebraci ardenti, mentre il corpo della matrice-crogioloera lambito dalle f iamme. La bugna sporgenteesterna fungeva da gancio per fermare in verticalesul bordo superiore del focolare la matrice-
crogiolo. Ben presto essa diventava incandescente, soprattutto nella parte in basso. Dai diversicolori che l’argilla assume nella manifattura di Aranmula con l’esposizione al calore, possiamostabilire che il crogiolo giunge alla temperatura di circa 900°C (giallo splendente), la parte centralegiunge a circa 800°C, mentre in alto la parte relativamente più fredda giunge a 650-700°C (rosso).In queste condizioni, il metallo nel crogiolo si liquefa. La matrice-crogiolo veniva raddrizzata “atesta in su” in modo che il metallo liquefatto scendesse a riempire la cavità e poi recuperata condelle pinze; una volta raffreddata aveva assunto un colore rosso-arancio ed era fatta a pezzi conun martello, a partire dal crogiolo cilindrico. Qui restava una certa quantità di metallo fuso39 che siraffreddava in forma di una specie di bottone; essa era recuperata e rotta in pezzi per essereriutilizzata. Si recuperava lo specchio, che era poi lucidato a lungo e levigato su un panno morbido40.
Questo “sistema sigillato” descritto si basa essenzialmente su un fattore: la presenza di acquanell’argilla e nelle stoffe molto bagnate utilizzate per sigillare il crogiolo. Con l’esposizione al fortecalore, nella base interna del crogiolo si forma vapore acqueo, che si dilata e si espande: si raggiungecosì la pressione necessaria a spingere il metallo liquefatto verso l’alto, a riempire la matrice.
Evidentemente il cilindretto di stagno inserito nel canale di colata è il primo metallo a fondere:lo stagno ha un basso punto di fusione (231,9°C) e viene quindi “spalmato” sulle pareti internedella matrice41. La lega di rame, stagno e piombo viene poi spinta nella matrice rivestita di questosottile strato di stagno.
Si tratta in effetti di una fusione piuttosto semplice, dato che il prodotto ottenuto è una piccolalamina circolare o quadrangolare42. Siamo di fronte ad una pressofusione ottenuta in un “sistemasigillato”, sebbene l’argilla del rivestimento contenente inclusi vegetali dovesse risultare un po’
Fig. 8: Crogiolo monouso(rid. 1:3; dis. C. Cucini).
37) Ad Aranmula il focolare è in mattoni refrattari non legati, masolo accosta ti, quindi suscettibile di essere allargato o alzato/abbassato a seconda delle esigenze. L’informazione, data nel sitodella manifattura di Aranmula, che il focolare oper erebbe a circa400°C, vicino al punto di fusione dell’ottone, risulta evidentementeerrata; si veda il testo cor rispondente alle note 26-27.
38) È evidente l’analogia con i condensatori per la fabbricazionedell’ossido di zinco, TIZZONI 2004.
39) Nel processo impiegato ad Ar anmula, pur con g randeattenzione, si ha la perdita di almeno il 40 % del metallo.
40) Ad Aranmula la levigatura a mano procede per almeno uno-duegiorni ed è effettuata con un panno di juta immerso in una mistura dipolvere di argilla bruciata e oli speciali. Nei video promozionali si vedecomunque l’impiego di carta abrasiva industriale molto fine.
41) È priva di fondamento la teoria di INGO et Al. pp. 614-615secondo la quale lo strato esterno arricchito in stagno si formerebbeper essudazione, a causa di fenomeni di segregazione inversa dellostagno avvenuti dur ante il raffreddamento.
42) Ben diver sa quindi dalla complessa realizzazione, adesempio, di statue o anche di figurine a cera perduta.
219
porosa e permettere quindi un certo sfiato dei gas: ciò causava talvolta la formazione di crepe e lematrici-crogiolo esplodevano, come nel caso suddetto.
Le leghe utilizzate: bronzo e ottone. L’impiego di minerali di zinco in età romana è bennoto dalle fonti antiche43. La prima – e finora unica – prova archeologica della lavorazione diquesto metallo a scopo farmaceutico nell’Impero Romano è stata rinvenuta proprio qui a Mediolanumda Marco Tizzoni, grazie al recupero di numerosi condensatori per la produzione dell’ossido dizinco negli scavi di via Conca del Naviglio44, in un contesto del I sec. d.C. Anche in c.so di PortaRomana, 20 è stato rinvenuto un frammento isolato di condensatore, mentre altri esemplariprovengono dallo scavo di via De Amicis45.
L’ottone, una lega di rame e zinco, era molto usato nell’Impero Romano non solo nelle emissionimonetali, ma anche in ornamenti ed insegne militari; la sua produzione regolare iniziò nel I sec.a.C. e raggiunse il suo massimo sviluppo nel I sec. d.C., quando era fabbricato su larga scala con unprocesso controllato e standardizzato46 .
Poiché il punto di fusione (circa 417°C) e di ebollizione (fra 913 e 917°C) dello zinco sonomolto bassi, il procedimento ottimale per legar lo al rame non era la fusione, bensì la cementazione.Essa consiste nella reazione fra un solido – il rame metallico – e una fase di vapore – lo zinco - erichiede un costante controllo della temperatura e della pressione. Si tratta di un processoendotermico condotto in condizioni riducenti con un apporto costante di calore.
In pratica, la produzione di ottone per cementazione consisteva nel riscaldare insieme, in uncrogiolo sigillato, pezzi di rame metallico, minerale di zinco e carbone alla temperatura di 900-1000°C affinché i vapori di zinco si diffondessero nel rame47; a caldo, gli atomi di zinco vengonocosì lentamente assorbiti fra le maglie reticolari della massa di rame metallico formando l’ottone.Il rame doveva essere in lamine sottili finemente spezzettate, con una superficie più ampia rispettoal volume; i crogioli erano lutati in modo da evitare tutti gli agenti ossidanti e l’evaporazione dellozinco. Essi erano portati a 900-950°C, al di sotto della temperatura di fusione del rame (1083°C);a questo scopo era sufficiente un focolare di riscaldo, non c’era bisogno di un forno specifico.Poiché lo zinco penetrava solo negli strati superf iciali del rame, bisognava ripetere più voltel’operazione; era inoltre necessario mantenere la temperatura al di sotto dei 1000°C e non lasciarei crogioli troppo a lungo nel focolare48. All’interno dei crogioli per la produzione di ottone percementazione non c’era dunque liquefazione, e non si formava alcuna scoria o lega liquida. Questospiega perché essi non recano incrostazioni metalliche o scorie aderenti.
A Mediolanum, olle-crogiolo analoghe a quelle sopra descritte, dotate di un coperchio sigillato,per la cementazione dell’ottone sono emerse come si è detto dagli scavi in piazza Erculea; lapresenza di alcuni frammenti di coperchi rivestiti di argilla dal contesto in esame autorizza a ritenereche il processo avesse luogo anche qui. La tappa successiva nella catena operativa della produzionedi ottone era la fusione della lega ottenuta in un altro crogiolo, privo di coperchio, per omogeneizzarlae poterla gettare in forme: è a questa fase che va riferita la maggior parte dei crogioli da corso diPorta Romana qui esaminati. Infatti la presenza di un versatoio sembra indicare che l’officina cheli utilizzava fondeva assieme i vari pezzi di ottone e lo gettava poi liquido nelle matrici per appliquesdi mobilio e piccoli oggetti ornamentali.
I pochi resti metallici dell’officina milanese consistono in gocce e ammassi di metallo inglobatidagli ugelli, in dispersioni di goccioline e filamenti all’interno delle parti alterate degli ugelli stessi,
43) TIZZONI 1996. A questo studio si rimanda per il migliorecompendio delle fonti antiche, medievali e rinascimentaliriguardanti lo zinco, i suoi minerali e i suoi impieghi, pp. 111-115.
44) TIZZONI 1996 e 2004. CERESA MORI 2004.
45) Lo scavo, diretto da A. Cer esa Mori, è in corso dipubblicazione.
46) Sebbene nota dalle fonti antiche, l’e videnza archeologica
della produzione di ottone in età romana si ha tuttavia solodal 1984, BAYLEY 1984 e 1990. REHREN 2007, pp. 50-51.
47) Per tutto ciò che segue BAYLEY 1984, p. 42; TIZZONI1996, p. 112; REHREN 1999, pp. 252-253.
48) Altrimenti l’assorbimento di zinco nel metallo diminuisceproporzionalmente alla diminuzione della pressione del vaporenel crogiolo e lo zinco evapora dalla f ase solida, ZWICKER etAl. 1985, p. 107.
220
o in incrostazioni più consistenti e colature di lega metallica aderenti alle pareti di qualche frammentodi matrice e di olla.
Una colatura metallica rinvenuta su un frammento di matrice è stata analizzata al SEM 49 ed harivelato di essere costituita da grandi cristalli a forma di stella e da rare sferule metalliche in unamatrice vetrosa. I cristalli a stella (fig. 9:a, b, c) sono un silicato complesso di Ca, Fe, Mg, Zn e Al;appartengono al gruppo dei pirosseni calcici, in particolare alla serie del diopside-hedenbergite ,che formano delle complete sequenze di soluzioni solide tra CaMgSi2O6 e CaFeSi2O6, in cui può esserepresente anche una piccola quantità (meno del 10 %) di alluminio (fig. 10). L’analisi composizionale diuna sferula metallica (fig. 9:d) ha rivelato la presenza di due distinte fasi: la più chiara è costituita da Pb,quella grigia da cuprite; il vetro che circonda la sferula è composto prevalentemente da Si e Al, a cuiseguono Fe, Zn, Ca e in minor percentuale K, Pb, Mg e P. Un’altra sferula metallica (fig. 9:e) è compostada Cu e Pb; l’alone grigio di fondo è costituito da Si e Al, a cui seguono Fe, Zn, Ca, K, Cu, Pb e Mg.Infine in una piccola geode si osservano cristalli cubici di cuprite (fig. 9:f).
L’analisi ha evidenziato l’alto tenore in zinco della colatura metallica (fra il 5.06 e 8.62 %).Evidentemente in questo caso siamo in presenza dei resti della fabbricazione di oggetti in ottone.L’aggiunta di piombo aumentava la fluidità della lega e ne abbassava il punto di fusione.
Le stesse olle-crogiolo erano utilizzate anche per fondere leghe di rame per getti, nelle quali ilpiombo costituiva un componente costante. Al microscopio metallografico, un frammento diugello ha rivelato la presenza di gocce e ammassi metallici incorporati nell’argilla, nonché relitti diimpurità di solfuri; si sono osservati cuprite, piombo metallico, stagno e rame. Come già osservatoin altri casi, sembra che l’argilla abbia assorbito in momenti diversi i singoli componenti della legaseparandoli, forse a causa del diverso punto di liquefazione dei metalli che la componevano. Sitrattava di un bronzo ternario del tipo usato per getti (Cu-Pb-Sn); dato che abbassa il punto difusione della lega rispetto al sistema binario Cu-Sn, il piombo veniva aggiunto intenzionalmentenei bronzi antichi, soprattutto per fare getti in forme come nell’atelier in esame. Inoltre il piomborende il metallo molto liquido e fluido, permettendo di riempire bene le matrici evitando laformazione di bolle, che avrebbero comportato lo scarto dei pezzi ottenuti. Nel complesso, leimpurità presenti e l’eterogeneità della lega impiegata fanno pensare al riciclaggio di rottami dibronzo e di ottone per la produzione di appliques di mobilio50, di f igurine votive e simili.
Per quanto concerne la provenienza delle materie prime impiegate nell’officina mediolanense,come abbiamo detto nel processo di cementazione lo zinco era introdotto sotto forma di mineralegrezzo; ciò sembra confermato anche dalla presenza di impurità di ferro e piombo (fig. 10).Ricorderemo che nelle Alpi Lombarde sono situati importanti giacimenti minerari di zinco in cuisono associati minerali di piombo, argento, rame e ferro. Come ha rilevato per primo MarcoTizzoni51, i grandi giacimenti zinciferi lombardi si trovano tutti in provincia di Bergamo nellaValle del Riso (diramazione laterale della Val Seriana), dove furono scoperte miniere antiche:l’attestazione archeologica della lavorazione su ampia scala di minerale di zinco nella Milano romanaindica che all’epoca essi erano intensamente coltivati e sfruttati52. Ciò trova conferma in Plinio ilVecchio53, secondo il quale la cadmea era stata ritrovata nunc et in Bergomatium agro extrema parteItaliae. Il rame è presente nelle Alpi lombarde, per quanto in giacimenti di modesta entità chefurono oggetto di coltivazione almeno dalla prima età del Ferro54. Per quanto concerne laprovenienza delle materie prime minerali impiegate nella Cisalpina romana, si tratta dunque, ancorauna volta, di sfatare luoghi comuni sclerotizzati: le Alpi lombarde fornivano ampiamente il metalloper le botteghe di bronzisti e di produzione di ottone del Nord Italia.
49) Ring razio la prof.ssa Mariapia Riccardi che ha messo adisposizione il Microscopio Elettronico a Scansione (SEM)dell’Università di Pavia.
50) Una applique br onzea per mobilio fu rinvenuta nello scavocondotto davanti alla basilica di S. Nazaro in Brolo da DECAPITANI D’ARZAGO 1942, figg. 13-14.
51) TIZZONI 1996, pp. 116-117.
52) Sembra lo gico pensare alle miniere ber gamasche per la
provenienza dello zinco lavorato a Milano: la Valle del Risodista meno di 60 km in linea d’aria dalla città. Vanno esclusi igiacimenti della Sardegna, di pari ricchezza ma troppo lontani,mentre i giacimenti del Varesotto, del Trentino-Alto Adige, delPiemonte e della Toscana sono scarsamente importanti.
53) Naturalis Historia, XXXIV, 2.
54) Si veda in questo stesso volume il contributo di chi scrivecon M.P. Riccardi, B. Messiga e G. Reba y.
221
Fig. 9: Lega metallica al microscopio elettronico a scansione (SEM): a) cristalli di pirosseni; b) cristalli di pirosseni,par ticolare; c) cristalli di pirosseni, particolare; d) sferula metallica; e) sferula metallica con alone grigio di fondo; f)
geode con cristalli di cuprite.
222
Conclusioni
Lo scavo di c.so di Porta Romana, 20 ha permesso di delineare e chiarire numerose problematicherelative alle produzioni artigianali metallurgiche della città romana. Innanzitutto abbiamo qui laprima attestazione della produzione di ottone a Mediolanum: oltre alla Britannia, alla Germania ealla Gallia transalpina, anche la Cisalpina deve essere annoverata fra le zone produttrici di questa legametallica nel I sec. d.C. Il contesto analizzato apre ampi scenari sulla circolazione delle materie prime, inparticolare i minerali di zinco, di cui si conosceva già l’impiego nella città romana a scopi farmaceutici;ma l’attestazione della produzione su ampia scala di ottone muta senza dubbio i termini della questione.
Abbiamo inoltre la prima evidenza a Milano dell’esistenza di officine che fabbricavano arredibronzei e specchi. E qui lo scenario si fa ancora più suggestivo per quanto concerne il trasferimentodi tecnologie su amplissimo raggio. Già per quanto concerne i condensatori per la produzione diossido di zinco l’unico confronto possibile è con una tecnologia documentata in India55 .L’attestazione della produzione di specchi con un processo tecnologico che si è conservato, quasiinalterato, fino ai giorni nostri proprio nell’India meridionale non può certo essere casuale.
Negli ultimi anni, scavi archeologici, studi e mostre hanno evidenziato la forte presenzacommerciale dei Romani nella punta meridionale dell’India. Sappiamo da Strabone (Geografia II.5.12)che dopo la conquista romana dell’Egitto i porti sul Mar Rosso, usati dall’età tolemaica come baseper le tratte con l’India, vennero sviluppati e potenziati: in età augustea ogni anno salpavano finoa 120 navi romane da Myos Hormos verso l’India, sfruttando i monsoni. I porti di Karachi, Muzirise Arikamedu, sulla punta meridionale dell’India erano i centri principali del commercio di prodotti
Fig. 10: Tabella delle analisi chimiche .
55) TIZZONI 2004.
223
di lusso56. È evidente che fra gli apporti culturali e gli scambi dobbiamo annoverare anche il trasferimentodi tecnologie, come quella per la produzione di specchi, dell’ottone e di composti farmaceutici57.
Milano si attesta dunque come un importante centro di produzione metallurgica nella Cisalpinaromana58. Mentre si deve pensare ad una specializzazione tecnica alta per la produzione dell’ottone,più scadente sembra il livello della bronzistica. Non deve stupire l’impianto di un’officina del tipodi quella qui esaminata per l’ampia clientela cisalpina: essa andava a soddisfare la richiesta crescentenei centri urbani delle élite locali via via che assorbivano il modello romano.
C.C.T.
Anna Ceresa MoriSoprintendenza per iBeni Archeologici della LombardiaVia De Amicis 11I-20123 [email protected]
Summary
A bronze smelting laboratory and brass and mirrors production in 1st-2nd century AD Mediolanum. Presentday Corso di Porta Romana in Milan was the south-eastern suburbium of the roman town c lose to the road leading toRome. Being a multifunctional area here there were good quality private houses, necropolises and work-shops. Recentarchaeological excavations a t Policlinico, Corso di Porta Romana 47 and via Madre Cabrini have confirmed that therewere burial areas as suggested by old finds. The excavations near the Basilica of Saint Nazarus, in via Calderon de laBarca and for the third line of the underground have shown examples of private houses. In Corso di Porta Romana 20new and interesting data about metallurgical production in Milan have been discovered. Here the remains of ametallurgical work-shop were found. Amongst the finds there are cooking pots turned crucibles by the application ofa thick layer of clay on their outer surface, clay moulds and scraps of a copper and zinc alloy. This brass was made andused for the casting of small objects and furniture appliqués. The zinc ore reached Milan from the once rich depositsin Riso Valley (Bergamo) which are quoted by Pliny the Elder. The find of clay moulds for rectangular and roundmirrors and of a peculiar type of crucible-moulds has allowed the Authors to understand the technology used. It canbe compared with the technology still in use in Southern India (Kerala) for the making of the Aranmula mir rors. Recentexcavations in Kerala have shown that there was an intense trade between this region and Rome. Since zinc oxide making in1st century AD Milan was quite similar to the traditional Indian process, long distance technological exchanges are suggested.
Riferimenti bibliografici
BACHMANN H.-G.
56) Muz iris, presente nella Tabula Peutingeriana, oggi Kodungallur,è una città portuale dello stato di Kerala, tr a i maggiori centri dicommercio con l’impero romano, scavata negli ultimi anni. Lavicina città di Pattanam ha restituito ingenti quantità di moneteromane e innumerevoli lotti di anfore. Arikamedu, presso l’odiernaPondicherry, è stata oggetto di recenti scavi che hanno restituitovasellame e importazioni r omane del I sec. d.C. La mostra dimonete d’oro e antichità romane tenutasi nel 2011 presso il R.I.Museo Governativo di Egmore ha cominciato a ricostruire la storiadei contatti tra l’impero romano e l’India. Secondo alcuni studiosi,la forte presenza commerciale romana autorizzerebbe ad ipotizzare
Costanza CuciniMetallogenesi s .a.sVia Pria Forà 4I-20127 Milano
la presenza di piccole comunità stabilite lungo le costemeridionali dell’India, con tr asferimenti di artigiani ed ar tisti.
57) L’India ha enormi giacimenti di b lenda e conserva tuttorauna fiorente tradizione bronzistica e di produzione di ottoneper statuaria e oggettistica, di altissima qualità artigianale.
58) Altri impianti per la produzione di piccoli oggetti in bronzosono attestati a Verona, Industria e Brescia, mentre si ipotizzala presenza di officine simili in Emilia; per tutto ciòGIACOBELLO 2005, p. 121, con riferimenti bibliografici.
1976 Crucibles from a Roman settlement in Germany, inHistorical Metallurgy, 10/1, pp. 34-35.
BAYLEY J.1984 Roman brass-making in Britain, in Historical
Metallurgy, 18/1, pp. 42-43.1990 The Pr oduction of brass in antiquity with par ticular
refer ence to Roman Britain, in P.T. CRADDOCK(ed.), 2000 Years of Zinc and Brass, British MuseumOccasional Paper, 50, London, pp. 7-27.
BAYLEY J.-REHREN T.2007 Towards a functional and typological classification of crucibles,
in S. LA NIECE-D. HOOK-P. CRADDOCK
(eds.), Metals and Mines. Studies in Archaeometallurgy,London, pp. 46-55.
BOLLA M.1988 Le necropoli romane di Milano, RASMI, suppl. V.
CAPORUSSO D.1991 La zona di corso di Porta Romana in età romana e
medie vale, in Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbanaa Milano durante la costr uzione della linea 3 dellaMetr opolitana 1982-1990, Milano, pp. 237-261.
CAPORUSSO D.-BLOCKLEY P.1992-93 Milano. Piazza Erculea. Scavo pluristratificato, in
Not. Sopr. Ar ch. Lombardia, pp. 121-123.
224
CERESA MORI A.2004-a Il suburbio sudoccidentale in età r omana, in CERESA
MORI 2004-b, pp. 50-53.2004-b L’anfiteatro di Milano e il suo quartiere. Percorso storico-
ar cheologico nel suburbio sudoccidentale, Milano.2010 Dal Foro romano all’Ambrosiana: dati archeologici sulle
dinamiche di trasformazione di un settor e urbanomilanese , in Studia Ambrosiana , Saggi e ricerche suAmbrogio e l’età tardoantica, 4, pp. 91-113.
CERESA MORI A.-WHITE N.1992-93 Milano . Via Cappuccio 13. Sondaggi presso le mura
massimianee, in NSAL, pp.117-119.
CONSONNI D.1999-00 Milano. Corso di Porta Romana 47, in NSAL, pp.
177-179.2008-09 Milano. Via Madre Cabrini - corso di Porta Romana.
Indagini ar cheologiche, in NSAL, pp.163-170.
CONSONNI D.-PAGANI C.2008-09 Milano, corso di Porta Romana 20. Sca vi nel suburbio
sud-orientale , in NSAL , pp. 170-177.
CORTESE C.2005 L’ar ea dell’Università Cattolica nell’ambito delle
trasformazioni del suburbio di Mediolanum tra I secoloa.C. e III secolo d.C., in M.P. ROSSIGNANI-M.SANNAZARO-G. LEGROTTAGLIE (a c. di), Lasignora del sar cofago. Una sepoltura di rango nella necropolidell’Università Cattolica, Milano, pp. 264-272.
CRADDOCK P.T.1986 The metallurgy of Etruscan Bronze, in Studi Etruschi,
LII, pp. 211-271.
CUCINI C.2008-09 Milano, corso di Porta Romana 20. Gli scarti delle
pr oduzioni metallur giche, in NSAL, pp. 178-179.
Dal cantiere alla storia1997 A. CERESA MORI (a c. di), Dal cantiere alla storia.
Lo sca vo di via Puccini a Milano, Milano.
DAVID M.1996 I pavimenti decorati di Milano antica. I secolo a.C.-VI
secolo d.C. , RASMI, suppl. XVI.
DE CAPITANI D’ARZAGO A.1942 La zona di Por ta Romana dal Se veso all’”Arco
romano”, Milano.
GIACOBELLO F.2005 Portalucerne r omani in bronzo dall’Italia Settentrionale,
in F. SLAVAZZI (a c. di), Arredi di lusso di etàromana. Da Roma alla Cisal pina, Flos Italiae, 6,Firenze, pp. 119-130.
INGO G.M.-PLESCIA P.-ANGELINI E.-RICCUCCIC.-DE CARO T.2006 Bronze r oman mirrors: the secret of brightness , in
Applied Physics A, 83, pp. 611-615.
INVERNIZZI R.2012 Cavallino, in A. CERESA MORI-C. LAMBRUGO-
F. SLAVAZZI (a c. di), L’infanz ia e il gioco nel mondo
antico, Materiali della collezione Sambon diMilano, Milano, p. 77.
LAMM K.1991 Early Medie val Metalworking on Helgö in central
Sweden , in W.A. ODDY (ed.), Aspects of EarlyMetallurgy, BM Occasional Paper, 17, pp. 97-116.
LEONI M.-PANSERI C.1956-57 Esame di specchi bronzei, ritrovati in se polcreti r omani
dell’alta Lombardia del I e II sec. d.C., in Sibrium,III, pp. 179-184.
ORTALLI J.1997 Assetto topografico caratteri funzionali dei suburbia
cispadani, in Studi in onore di Nereo Alfieri,Ferrara, pp. 105-124.
PAGANI C.2006 Un frammento di intonaco dipinto con uccellino da vecchi
scavi in piazza S. Nazar o a Milano: alcune riflessioni,in RASMI, 3, pp. 81-88.
PICON M.-LE NEZET CELESTIN M.-DESBAT A.1995 Un type particulier de grands récipients en terre réfractair e
utilizés pour la fabrication du laiton par cementation,Société Française d’Etude de la CéramiqueAntique en Gaule, Actes du Congrès de Rouen,pp. 207-215.
REHREN T.1999-a “The same… but differ ent”: A juxtaposition of Roman
and Medieval brass making in Central Europe, inS.M.M. YOUNG-A.M. POLLARD-P. BUDD-R.A. IXER (eds.), Metals in Antiquity, BAR, 792,pp. 252-257.
1999-b Small size, lar ge scale: Roman brass production inGermania Inferior, in Journal of ArchaeologicalScience, 26, pp. 1083-1087.
SENA CHIESA G.2000 Suburbia: paesag gi di confine tra città e campagna, in
Milano tra l’età repubblicana e l’età augustea, Atti delConvegno di Studi (26-27 marzo 1999), Milano,pp. 35-54.
TIZZONI M.1981 La cultura tardo La Tène in Lombardia, in Studi
Archeologici, I, Bergamo, pp. 3-41.1996 Condensatori per la produzione dell’ossido di zinco da Conca
del Naviglio a Milano, in NAB, 4, pp. 111-120.2004 Un laboratorio farmaceutico nella Milano r omana? in
CERESA MORI 2004-b, pp. 74-76.
WEISGERBER G.2007 Roman brass and lead ingots from the w estern
Mediter ranean, in Metals and Mines. Studies inArchaeometallurg y, London, pp. 148-158.
ZWICKER U.-GREINER H.-HOFMANN K.-H.-REITHINGER M.1985 Smelting , Refining and Alloying of Copper and Copper
Alloys in Crucible Furnaces during Prehistoric up toRoman Times, in P.T. CRADDOCK-M.J.HUGUES (eds.), Furnaces and Smelting Technolo gyin Antiquity, London, pp. 103-115.