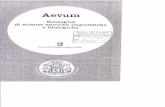Interferenze francesi nella produzione dei codici di lusso a Pavia sullo scadere del Trecento e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Interferenze francesi nella produzione dei codici di lusso a Pavia sullo scadere del Trecento e...
Arte medievalePeriodico annualeIV serie - anno V, 2015 - ISNN 0393-7267© Sapienza Università di Roma
Direttore responsabileMarina Righetti
Direzione, RedazioneDipartimento di Storia dell’arte e SpettacoloSapienza Università di RomaP.le Aldo Moro, 5 - 00185 RomaTel. 0039 06 49913409-49913949 e-mail: [email protected]
I testi proposti per la pubblicazione dovranno essere redatti secondo le norme adottate nella rivista e consultabili nel suo sito. Essi dovranno essere inviati, completi di corredo illustrativo (immagini in .tif o .jpg ad alta risoluzione di 300 dpi in un formato adatto alla leggibilità) e riassunto, per essere sottoposti all’approvazione del Comitato Scientifico al seguente indirizzo: [email protected] La rivista, impegnandosi a garantire in ogni fase il principio di terzietà della valutazione, adotta le vigenti procedure internazionali di peer review, con l’invio di ciascun contributo pervenuto, in forma anonima, a due revisori anch’essi anonimi. Il collegio stabile dei revisori scientifici della rivista, che si avvale di studiosi internazionali esperti nei diversi ambiti della storia dell’arte medievale, può essere di volta in volta integrato con ulteriori valutatori qualora ciò sia ritenuto utile o necessario per la revisione di contributi di argomento o taglio particolare. La Direzione della rivista conserva, sotto garanzia di assoluta riservatezza, la documentazione relativa al processo di valutazione, e si impegna a pubblicare con cadenza regolare sulla rivista stessa l’elenco dei valutatori che hanno collaborato nel biennio precedente.
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 241/2002 del 23/05/2002
In copertina: Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 214r, particolare.
DistribuzioneSilvana EditorialeVia de’ Lavoratori, 7820092 Cinisello Balsamo, MilanoTel. 02.453951.01Fax 02.453951.51www.silvanaeditoriale.it
Direzione editoriale Dario Cimorelli
Coordinamento e graficaPiero Giussani
Stampa e rilegatura Grafiche AuroraVerona
Finito di stampare nel gennaio 2016
Comitato promotore
F. Avril, B. Brenk, F. Bucher, A. Cadei, W. Cahn, V.H. Elbern,H. Fillitz, M.M. Gauthier, C. Gnudi, L. Grodecki, J. Hubert, E. Kitzinger,
L. Pressouyre, M. Righetti, A.M. Romanini, W. Sauerländer, L. Seidel,P. Skubiszewski, H. Torp, J. White, D. Whitehouse
Comitato direttivo
M. Righetti, A.M. D’Achille, A. Iacobini, A. Tomei
Comitato scientifico
F. Aceto, M. Andaloro, F. Avril, X. Barral i Altet, M. Bonfioli, G. Bonsanti, B. Brenk, C.A. Bruzelius, S. Casartelli Novelli, M. D’Onofrio, J. Durand, V.H. Elbern, F. Gandolfo,
A. Guiglia, H.L. Kessler, J. Mitchell, E. Neri, G. Orofino, A. Peroni, P.F. Pistilli, P. Piva, F. Pomarici, A.C. Quintavalle, R. Recht, S. Romano, A. Segagni,
H. Torp, G. Valenzano, G. Wolf
Redazione
R. Cerone, A. Cosma, C. D’Alberto, B. Forti, M.T. Gigliozzi, F. Manzari, S. Moretti, M.R. Rinaldi, E. Scungio
Anvur: A
MATERIALI
277 Il mosaico trasformato: un pavimento di una villa tardoantica nella Toscana costiera Elisabetta Giorgi, Enrico Zanini
NOTIZIE E RECENSIONI
297 Ricordo di Italo Furlan Enrico Zanini
300 Ricordo di Enrico Castelnuovo Fabrizio Crivello
302 J.-B.-L.-G. Séroux d’Agincourt e la storia dell’arte intorno al 1800 Convegno internazionale di studi Roma, Accademia di Francia - Villa Medici, 23-24 settembre 2014 Ilaria Sgarbozza
303 Anna Delle Foglie, La cappella Caracciolo del Sole a San Giovanni a Carbonara Milano, Jaca Book, 2011 Gaetano Curzi
304 Richard Hodges, Sarah Leppard, John Mitchell, San Vincenzo Maggiore and its Workshops London, British School at Rome, 2011 Carmine Comunale
305 Decretales pictae. Le miniature nei manoscritti delle Decretali di Gregorio IX (Liber Extra) Atti del colloquio internazionale tenuto all’Istituto Storico Germanico, Roma 2010, Roma, Università degli Studi Roma Tre, 2012 Lola Massolo
307 Inés Monteira Arias, El enemigo imaginado. La escultura románica hispana y la lucha contra el Islam Toulouse, CNRS – Université de Toulouse-le Mirail Gaetano Curzi
308 Gaetano Curzi, Santa Maria del Casale a Brindisi. Arte, politica e culto nel Salento angioino Roma, Gangemi Editore, 2013 Simona Moretti
310 Pintar fa mil anys. Els colors i l’ofici del pintor romànic dir. M. Castiñeiras, J. Verdaguer Universitat Autònoma de Barcelona, 2014 Marco Rossi
CRITICA
9 The Milan Five-Part Diptych as a Manifestation of Orthodoxy Zuzana Frantová
27 «In summo montis cacumine»: il monastero di S. Silvestro al Soratte Elisabetta Scungio
59 Architettura dell’età ottoniana in Italia: il deambulatorio e il culto delle reliquie Carlo Tosco
87 Oxford, Magdalen College, MS. Gr. 3: Artistic Practice, Byzantine Drawings and Mobility in Mediterranean Painting around 1200 Manuel Castiñeiras
101 «Iustitia, maiestas, curialitas». Oldrado da Tresseno e il suo ritratto equestre nel broletto di Milano Saverio Lomartire
137 Un portale abruzzese dimenticato Francesco Gandolfo
153 S. Nicola di Trisulti: un insediamento certosino femminile? Valeria Danesi
165 Presenze cistercensi ad Amalfi: il caso controverso dell’abbazia di S. Pietro a Toczolo Nicola Caroppo
183 «Inexpugnabile est». Pierre D’Agincourt, il presidio di Ripa di Corno e la città di Leonessa Roberta Cerone
197 Cimabue reconsidered Joseph Polzer
225 Un’ulteriore traccia per l’attività a Brescia del Maestro di Santa Anastasia e della sua bottega: l’urna del giudice Corrado Fogolini Massimo Medica
235 Interferenze francesi nella produzione dei codici di lusso a Pavia sullo scadere del Trecento e qualche apertura sul primo Michelino da Besozzo Roberta Delmoro
261 Le affinità di Dufourny Maria Giulia Aurigemma
SommArio
235
in Ciel d’Oro, sotto la committenza degli Ere-mitani Agostiniani, risultavano già abbelliti di numerose opere di pittura e di preziosi arredi liturgici.8 L’esistenza e l’intensa attività di uno scriptorium nel monastero ci è nota grazie a un miniatore, probabilmente anche capo bottega e impresario, il monaco Pietro da Pavia, auto-ritrattosi nell’atto di miniare un capolettera, in un prezioso codice pavese datato 1389 che esa-mineremo meglio oltre, la Naturalis Historia di Plinio (Milano, Biblioteca Ambro siana, ms. E 24 Inf.). Grazie al suo programma decorativo, molto ricco e vario, questo manoscritto ha per-messo di ricostruirvi attorno un corpus di codici miniati dalle caratteristiche affini.9 Il giovane Michelino da Besozzo, già introdotto nel giro della committenza eremitana entro il 1388, tra lo scadere degli anni ottanta e nel corso degli anni novanta del Trecento, poté collaborare ai suoi esordi di miniatore con Pietro da Pavia. Uno dei committenti più interessanti e colti, in relazione con questo preciso ambiente, nonché tramite culturale certo tra Parigi e Pavia, fu lo sventurato secretarius di Gian Galeazzo Viscon-ti, il cremonese Pasquino de Cappelli. Pasqui-no, già cancelliere di Galeazzo II e collezionista bibliofilo, seguace di Petrarca, amico di Coluc-cio Salutati e di Giovanni Manzini della Motta da Fivizzano, possedeva una notevole quantità di manoscritti, che confluirono nella biblioteca del castello di Pavia allorquando venne a mor-te, condannato dal duca, per presunto tradi-mento.10 Tale collezione contava diversi codici acquistati a Parigi, dove il Cappelli si trovava in missione diplomatica nel 1383.11 Elisabeth Pellegrin identificò, grazie alle iscrizioni appo-ste nei fogli di guardia dallo stesso Pasquino, alcuni dei libri acquistati nella capitale france-se, oggi conservati alla Biblio thèque nationale de France.12 Si tratta in particolare dei mano-scritti latin 100 e latin 394, che nell’inventario del 1426 corrispondevano rispettivamente al «Job glosatus copertus corio albo irsuto», pro-veniente dall’abbazia di Vauluisant (XIII-XIV secolo), diocesi di Sens, e al «Iosue libri et libri
Nel corso degli ultimi tre lustri del XIV secolo, la presenza a Pavia di letterati e umanisti, di diplomatici della corte
viscontea (in città a partire dal 1360) e di ap-passionati bibliofili, di professori di teologia, di diritto e di medicina, docenti presso lo Studium Generale, fondato, su concessione imperiale, da Galeazzo II Visconti nel 1361,1 favorì, assieme alla committenza viscontea e alla circolazione di manoscritti e di oggetti di oreficeria francese, la fioritura di una produzione di codici di lusso che si caratterizzò per stringenti affinità com-positive, decorative e iconografiche con i codici miniati prodotti in Francia nella seconda metà del Trecento, da dove diversi esemplari docu-mentati erano approdati in città.2 Entro questo particolare clima culturale, raffinato dai sog-giorni di Francesco Petrarca e permeato di in-tensi scambi con l’Oltralpe francese, potenziati col doppio matrimonio dei Visconti con la casa reale dei Valois,3 vanno rintracciati gli esordi del pittore e miniatore Michelino de Molinari da Besozzo, i cui natali credo siano da ricondurre alla stessa Pavia, come mi pare suggerisca l’u-manista Uberto Decembrio, che, chiamandolo con note affettuose «Michelem papiensem», ci informa di averlo conosciuto fin da fanciullino – «puerulum novi» – quando, prima ancora di saper parlare, già stupiva l’ambiente di corte di-segnando uccellini e piccoli animali.4 La prima attività nota dai documenti di que-sto artista, elogiato dalle fonti contemporanee come uno dei massimi pittori del suo tempo,5 si pone, come già noto agli studi, nell’ambito della committenza del monastero agostiniano pavese di S. Pietro in Ciel d’Oro. Qui, a par-tire dal mese di gennaio del 1388, Michelino si apprestava a principiare sotto i porticati del secondo chiostro del monastero, su commissio-ne del priore, il monaco Bonifacio Botticella,6 e con la collaborazione del pittore Ambrogino, le perdute Storie di san Nicola da Tolentino e di sant’Agostino disposte in numerosi riquadri.7 All’aprirsi degli anni novanta del Trecento, gli edifici del monastero e della chiesa di S. Pietro
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento e qualche apertura
sul prImo mIchelIno da Besozzo
Roberta Delmoro
236
RobeRta DelmoRo
«Dominus Franc. Petrarca rerum familiarum copertus corio rubeo ad modum parisinum».14 Il volume, molto probabilmente copiato e miniato a Parigi, è in gotica libraria francese. L’explicit del codice presenta l’iscrizione «Jo(hannes) legit
regum glosati coperti corio albo levi».13 A Pavia Pasquino ebbe per le mani il manoscritto latin 8568 (Bibliothèque nationale de France), l’E-pistolarium de rebus familiaribus di Francesco Petrarca, descritto nell’inventario visconteo:
1. Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 8568, f. 148v(© Bibliothèque nationale de France).
237
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
2. Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 8568, f. 158v, particolare(© Bibliothèque nationale de France).
rando l’ipotesi di un ingresso del codice nella collezione del secretarius, confluita in seguito nella biblioteca di Gian Galeazzo Visconti.16 L’iscrizione del Manzini apposta nel gennaio del 1388 documenta la presenza a Pavia di que-sto manoscritto nel corso dell’anno precedente la datazione della Naturalis Historia, facendo dell’Epistolarium di Petrarca un più che proba-bile modello di riferimento per i libri di lusso realizzati per Pasquino a Pavia.17 Il testo è com-posto su due colonne e si apre con un fronte-spizio miniato a piena pagina con bordure (che ricorrono per i capilettera di tutto il codice) co-stituite, nel tipico gusto francese, da asticciole dorate lungo le quali si adagiano sottili tralci di
complete 1388 23 februarii hora 4a». A f. 290v, la firma «Jo(hannes). m. scripsit. 1388. 4 . jan-nuarii. Papie» è da sciogliere con ogni proba-bilità come Iohannes Manzinus, ossia Giovanni Manzini della Motta da Fivizzano, precettore a Pavia del figlio di Pasquino de Cappelli, Mel-chiorre. Questa iscrizione si trova sotto una preghiera alla Vergine di Petrarca e identifica la calligrafia dal ductus gotico puntuto più ricor-rente nelle numerose postille stese dal Manzini stesso.15 Una seconda calligrafia negli appunti a latere, se confrontata con il ductus calligrafico delle note di acquisto di Pasquino registrate nei volumi francesi, può ragionevolmente identi-ficarsi con quella di Pasquino stesso, corrobo-
238
RobeRta DelmoRo
vite da cui si dipartono rami riccamente foglia-ti. Il capolettera O a f. 1r accoglie la figura di Francesco Petrarca, effigiato come poeta laure-ato. Le foglie puntute e vibranti di vite, alter-nate color rosa, blu profondo e oro, lumeggiate a biacca sulle punte (secondo un gusto in voga a Parigi nella seconda metà del Trecento e che andava arricchendosi e complicandosi nel corso del nono decennio del secolo)18 e i quattro dra-ghi fantastici à bas de page del frontespizio che prendono vita dai tralci stessi, intrecciando sim-metricamente i loro colli, sono caratteristiche proprie dello stile decorativo francese, adottate, come vedremo a breve, nello scriptorium eremi-tano pavese.19 Ogni libro si apre con capilettera e bordure sempre vari pur nell’impostazione ricorrente. Dalle bordure prendono forma le figure dei draghi fantastici multicolori dalle cui code e fauci fuoriescono morbide volute di rami di vite [1-2]. Il ductus dei capilettera, campito di rosa e di blu alternati, reca decorazioni ge-
3. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 1r, particolare(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/ De Agostini Picture Library).
4. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 332r, particolare(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/ De Agostini Picture Library).
239
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
Pietro da Pavia sullo scadere degli anni ottanta del Trecento, come vedremo, sono impostati, similmente a questo, con le impaginature estre-mamente curate, col testo disposto generalmen-te su due colonne, con lunghi capilettera filigra-nati blu e rossi raffinatissimi e molto elaborati,
ometriche a biacca, mentre all’interno la deco-razione è generalmente a volute di rami e foglie di vite su oro, anche qui con teste di drago che possono spuntare dagli intrecci dei rami, con le tipiche foglie alternate blu e rosse, lumeggiate a biacca. I codici pavesi prodotti nella bottega di
5. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 73r(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/ De Agostini Picture Library).
240
RobeRta DelmoRo
un’asta dorata lungo la quale si intrecciano steli vegetali, similmente a quanto accade nei codici tardo trecenteschi parigini (salvo che qui non sono le foglie di vite rampicante a decorare l’a-sta, e anche i bordi laterali dell’incorniciatura sono decorati con fantasie floreali, popolati da un uccello immaginario e da putto armato di scudo e di lancia). Il capolettera I di «Iuxta sen-tentiam (…)» è abitato da un drago multicolore, a lato vi germogliano foglie di acanto blu e rosa, secondo un tòpos decorativo ricorrente nelle bordure e nei capilettera miniati nella bottega di Pietro da Pavia [5, 6, 14, 15]. Il capolettera D che inizia l’expositio della seconda parte, a f. 32r, presenta il ductus campito di rosa, decorato a biacca, con all’interno tralci intrecciati blu e verdi di vite dalle foglie puntute e vibranti rosse e blu, su fondo oro e rilevate a biacca in pun-ta, secondo il gusto parigino. Sopra e sotto si dispiegano tuttavia morbidi steli fioriti (diver-si dalle aste verticali francesi) e un drago fan-tastico. Questo codice, in particolare, presenta la serie di capilettera che iniziano le particulae (capilettera P, come l’iniziale di Pasquino) de-corati con motivi geometrici elaboratissimi, sempre vari, dipinti su oro, ai quali mise mano, credo, Pietro in persona e dove mi pare sia as-sente (ancora) la partecipazione di Michelino da Besozzo. L’attento geometrismo e il prezio-sismo che caratterizzano queste P, veri e propri esercizi compositivi, il cui schematismo, pur nel ripetersi di certe idee, scioglierà col tempo le forme decorative proprie della bottega di Pie-
bordure e capilettera miniati là dove c’è l’expli-cit di un libro e l’incipit del libro successivo. Per Cappelli collaborarono, nell’ambito ago-stiniano di S. Pietro in Ciel d’Oro, il monaco Pietro da Pavia e il copista di origine tedesca, già operoso a Verona, Armanno di Germania (Armannus de Alemania). Il Petri de Padua (o Petri de Abano), Commentarius in Libro Aristo-telis de problematibus (Parigi, Biblio thèque na-tionale de France, latin 6541), dove Armanno si firmò a f. 275v,20 è l’esemplare forse più fedele ai modelli francesi nella serie dei codici miniati ri-conducibili alla figura di Pietro da Pavia, e non credo sia un caso che proprio Pasquino ne fosse il committente. Il frontespizio (f. 1r) presenta la pagina scandita da un’incorniciatura piutto-sto ordinata e simmetrica: in mezzo si dispone
6. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 141r(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/ De Agostini Picture Library).
7. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 96v, particolare(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/ De Agostini Picture Library).
241
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
a f. 275v è estremamente elaborata, come an-che l’incipit del libro, e la presenza delle lettere maiuscole decorate a china ne fanno un capo-lavoro di perizia tecnica.22 Pur nell’ispirazione ai modelli francesi, si ravvisa già una varietà e un’attenzione all’elemento fantastico, caratteri-stiche che ritorneranno, sempre più accentuate, negli ulteriori codici riconducibili alla bottega di Pietro da Pavia, tanto da costituirne un tratto originale e inconfondibile.23
La Naturalis Historia (ms. E 24 Inf.), che sotto
tro da Pavia in fantasiose varianti floreali, cre-do ne collochino la realizzazione anteriormente al 1389, cioè prima della datazione del codice della Naturalis Historia dell’Ambrosiana (ms. E 24 Inf.) e del coinvolgimento sicuramente do-cumentato del giovane magister Michelino nella committenza agostiniana del monastero (1388). Il Commentarius è il solo, peraltro, ad aver con-servato le armi, le imprese, il motto del secre-tarius e il nome «Pasquinus» alle iniziali dei ff. 164v, 191v, 226r e 241r.21 La firma «Armannus»
8. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 214r,particolare(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/ De Agostini Picture Library).
9. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 214r,particolare(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana/ De Agostini Picture Library).
10. Pavia, castello visconteo sforzesco, sala ‘a dominabus’, particolare(© foto Fiorenzo Cantalupi).
11. New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M.944, f. 40r, particolare, (da Eisler, Corbett, Das Gebetbuch des Michelino da Besozzo).
242
RobeRta DelmoRo
alle imprese sovrapposte ai ff. 1r e 266v del con-te Giovanni Bolognino Attendolo, castellano di Pavia, rivela ancora, a f. 266r, l’impronta lascia-ta nella pergamena della sua probabile origina-ria appartenenza a Pasquino de Cappel li, è stata ricondotta dalla Pellegrin, su base paleografica, al copista Armanno.24 Anche a questo codice, dunque, Armanno e Pietro da Pavia poterono collaborare per un medesimo committente: Pa-squino. Il frontespizio complica l’inquadratura tipica francese con bordure costituite da intrec-ci di fantasie floreali con l’inserzione di cornici quadrilobate, popolate di animali fantastici, an-ticipando di circa un decennio soluzioni com-positive che si incontrano nelle Grandes Heures du duc de Berry (Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 919, f. 41r) dato che potrebbe indicare una circolazione di manoscritti pavesi presso i Valois [3].25
12. Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 6069T, f. 24r, particolare(© Bibliothèquenationale de France).
13. Milano, Biblioteca Ambrosiana, E 124 Inf, f. 214r (foto Silvia Bianca Tosatti).
243
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
14. Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 6069T, f. 42v(© Bibliothèquenationale de France).
244
RobeRta DelmoRo
15. Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 6069T, f. 49v, particolare(© Bibliothèquenationale de France).
16. Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 6069T, f. 1r, particolare(© Bibliothèquenationale de France).
245
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
iniziali del Cappelli e delle particulae del suo Commentarius), credo a volerci indicare il suo ruolo di artefice e ideatore dei grandi capilettera dalle complesse decorazioni del codice, firman-dosi a caratteri rossi lungo il ductus dorato della
Qui, come anticipato, Pietro da Pavia si è ritrat-to col saio scuro dei monaci agostiniani eremi-tani, realizzato a tratteggio fittissimo, intento a dipingere di rosso minio un grande capolettera P (come la sua iniziale e curiosamente come le
17. Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.XIV.1, f. 1r(© Istituzione della Biblioteca Malatestiana).
246
RobeRta DelmoRo
M onciale di «Metallorum quibus (...)» che apre a f. 332r il libro XXXV, sulla pittura e i colo-ri: «frater Petrus de Papia me fecit», con la data a caratteri arabici generalmente letta come un «1389» [4].26 Al programma decorativo di questo codice, par-ticolarmente ricco e vario, presero parte diversi miniatori. L’incipit di ogni libro si apre con un capolettera e con una bordura che dispiegano
247
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
francesi si propone a tema come una vite ram-picante intrecciata dove à bas de page un con-tadino si appresta a tagliare un ramo ricco di grappoli [6]. Anche nella Naturalis Historia le bordure presentano una varietà ben modulata di temi ornamentali floreali: campanule, foglie di quercia, fiori di cardo, foglie di acanto. Si
motivi ornamentali sempre diversi, scelti in rela-zione all’argomento del capitolo che iniziano, o al contenuto di uno dei capitoli seguenti.27 [5-8] La suddivisione degli spazi riserva posto anche qui ad elaborati capilettera filigranati. [8] I mo-delli francesi ispirano le bordure vegetali, sem-pre popolate, similmente a quelle parigine, di animali fantastici, di uccelli delle più disparate specie e putti, di draghi multicolori dalle teste e i colli color minio e dalle cui code e lingue fuoriescono rami fioriti (tanto ingannevoli da tradire forse anche una partecipazione di mi-niatori giunti da Parigi). [5] L’esempio francese, tuttavia, non è imitato pedissequamente ma è rielaborato con arguzia e originalità, nella deco-razione stilizzata vegetale e floreale multiforme e multicolore, che ai rossi cupi e ai blu profondi in uso nelle botteghe parigine privilegia i rosa pallidi, il blu luminoso e intenso, il verde chiaro e naturalmente l’oro (tutti colori che ritornano, anche a decenni di distanza, nelle miniature di Michelino da Besozzo). La A di «Animalia quae terrestria hic appellavimus» a f. 96v è de-corata con l’immagine di un Pescatore, un sog-getto iconografico tratto dalle raffigurazioni dei Mesi e dei Tacuina sanitatis.28 [7] Similmente, la E di «Externe arbores indocilesque (...)», che inizia il Liber quartusdecimus. Capitulum pri-mum, de arboribus fructiferis, a f. 141r, ospita un uomo che spilla vino da una botte; l’asta della bordura, volutamente ispirata, qui, ai modelli
Pagina a fronte:
18. Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.XIV.1, f. 1r, particolare(© Istituzione della Biblioteca Malatestiana).
19. New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M.944, f. 75v, particolare (da eisler, Corbett, Das Gebetbuch des Michelino da Besozzo).
20. Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.XIV.1, f. 29v, particolare(© Istituzione della Biblioteca Malatestiana).
21. Pavia, castello visconteo sforzesco, decorazione a ‘nemeobliemia’(© foto Fiorenzo Cantalupi).
22. Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.XIV.1, f. 1r, particolare(© Istituzione della Biblioteca Malatestiana).
23. Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.XIV.1, f. 1r, particolare(© Istituzione della Biblioteca Malatestiana).
248
RobeRta DelmoRo
24. Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 111, f. 3r,particolare (foto Autore).
25. Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 111, f. 15r,particolare (foto Autore).
26. Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 111, f. 4v,particolare (foto Autore).
27. Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 111, f. 28r,particolare (foto Autore).
28. Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 5888, f. 1r, particolare(© Bibliothèque nationale de France).
249
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
intuisce, sfogliando questi manoscritti, che chi collaborava alla copiatura e alla realizzazione dei testi, dei capilettera e delle bordure, seguiva uno schema ben preciso e predefinito, che tra la fine degli anni ottanta e gli anni novanta del Trecento rifletteva probabilmente l’ideazione di Pietro da Pavia, in relazione a ben precise ri-chieste o esigenze, anche di tipo iconografico, da parte della committenza. Tra Pietro da Pavia e il giovane Michelino da Besozzo nacque, forse proprio in occasione della realizzazione di que-sto particolare codice, una collaborazione. A f. 214r, al capolettera I dell’incipit del libro XXI con le spiegazioni di Plinio sulle corone floreali «In hortis seri et coronamenta Cato iussit (...)», una minuscola damigella (alta cm 3,5) seduta su di un prato fiorito di diverse specie botaniche, è raffigurata nell’atto di intrecciare collane di rose, elegantemente acconciata con una ghir-landa di rose rosse e bianche [8-9] secondo una moda in voga nell’Antichità ma anche, in quei precisi anni, tra le damigelle di corte del conte di Virtù, raffigurate, entro il 1393, nella sala a dominabus del castello visconteo [10].29 Questa damigella che orna il capolettera I composto come fosse una doppia corolla di fiori dai petali multicolori che si schiudono morbidamente – con una soluzione compositiva che sarà simil-mente impiegata da Michelino da Besozzo nel capolettera I di «Invocat te trinitas (...)» del ben più tardo Libro di Preghiere già di Collezione Bodmer (New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M.944 [11]) – raffigura l’Intrecciatrice di corone di Pausìa, citata nella narrazione del te-sto di Plinio. Nel dipinto greco, secondo quanto narra l’autore latino, Pausìa avrebbe raffigura-to l’amata fioraia Glìcera, intenta a intrecciare ghirlande di fiori di diverso colore e profumo.30 Il miniatore interpreta così lo spunto pliniano e, come a fingersi Pausìa, allude a uno dei di-pinti più celebri dell’Antichità. Esaminando sia la composizione della figura femminile ingi-nocchiata a terra, col capo chino, il volto leg-germente proteso di tre quarti, le labbra di una lieve carnosità (sebbene davvero minuscole) ap-prezzabili grazie a una macrofotografia scattata a luce radente di questo dettaglio,31 [13] sia la sensibilità pittorica dell’abito bianco ombreg-giato in modo cangiante, con macchioline di inchiostro acquerellato blu in punta di pennel-lo, quasi a sperimentare l’uso del colore, questo dettaglio si presenta di notevole spessore stilisti-co e credo possa prudentemente individuare la mano di un giovanissimo Michelino da Besozzo,
dalle forme ancora acerbe e profondamente de-bitrici della cultura figurativa lombarda di cui fu portavoce, alla fine del Trecento, Giovannino de Grassi.32 Il Liber rerum memorandarum di Francesco Pe-trarca (Parigi, Bibliotèque nationale de France, latin 6069T), sempre probabilmente realizzato per Pasquino,33 credo sia di poco successivo la Naturalis Historia, e, pur nella similitudine con cui sono concepite l’impaginazione, il ductus della gotica libraria (non si tratta tuttavia qui del copista Armanno) e la fantasia decorativa, che minia i capilettera ad apertura di libro, cam-piti di rosa e di blu, ispirata anche qui al model-lo francese (ricorre spesso l’impiego delle foglie di vite vibranti e puntute, e dei draghi fantastici dalle code vegetali, particolarmente ai ff. 1r, 10r, 24r, 42v, 49v), [12, 14] si distingue dalla prima per una qualità sempre molto sostenuta nella realizzazione delle miniature, particolarmente apprezzabile là dove, nel decorare alcune bor-dure, si è scelto di ricorrere a modelli figurativi impiegati anche nella Naturalis Historia. Diver-samente da questa, tuttavia, le miniature à bas de page non sono a tema col contenuto dei testi, bensì probabilmente rispecchiano il gusto del committente. Si confrontino, a questo proposi-to, il Contadino che recide il tralcio di vite a f. 24r (dove si apre il Liber tertius, de sollertia) [6, 12], il Pescatore di f. 49v (a capolettera S che apre il Tractatus de sopniis) [7, 15] il Bevitore di vino a f. 42v (à bas de page della bordura che orna l’incipit del Liber quartus, Appius Clau-dius) [14], col Bevitore quasi identicamente fi-gurato nell’incipit del Liber vigesimustertius, a f. 232r della Naturalis Historia.34 Si individuano, in questo particolare codice, tre miniatori prin-cipali. Uno è operoso ad alcune bordure e capi-lettera, là dove si dispiegano delle foglie di acan-to particolarmente fitte e carnose, il cui chiaro-scuro è ottenuto con un uso particolarmente vibrante del colore, rosa tenero e blu brillante [15-16]. Tali bordure presentano una flessuosi-tà e una rigogliosità in generale più accentuate rispetto alle bordure del Plinio dell’Ambrosia-na, similmente ai due capilettera I, a f. 214r e a f. 223r, incipit del Liber vigesimussecundus nella Naturalis Historia. [8-9, 15-16] Credo che per bellezza e originalità, questi dettagli botanici, di così vibrante freschezza, si possano prudente-mente riferire a un giovane Michelino da Besoz-zo. [11, 15, 16] Il secondo miniatore all’opera è presumibilmente Pietro da Pavia stesso, che raffigura quasi certamente il Bevitore a f. 42v
250
RobeRta DelmoRo
codice che reca in basso sul frontespizio il suo stemma, fasciato di nero e d’oro.37 La stessa studiosa identifica inoltre lo stemma di destra (molto rovinato per la verità ma che si presenta in effetti d’oro al castello di rosso) con quello della famiglia Martignoni.38 [17] Qui le forme decorative, generalmente ordinate da Pietro da Pavia in schemi più rigidi, si sciolgono in fanta-sie di cornici floreali sempre più naturalistiche e morbide, disponendo testo e bordure all’inizio dei cinque libri del trattato in modo affine al frontespizio della Bibbia con glosse di Nicolas de Lyre, donata da Jean de Berry all’antipapa Clemente VII (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 50, f. 1r).39 Una serie di fregi vegetali (qui sempre vari e simil-mente popolati di animali fantastici e di draghi come quelli parigini) germinano dal capolettera al centro del foglio, inquadrandone l’incipit e il testo, realizzato a caratteri di formato maggiore, e proseguendo nell’iniziale della prima glossa a incorniciare il foglio a latere (ff. 29v, 55r, 87v e 113v). Simil mente accade per la decorazione dei capilettera (in tutto 67) che iniziano i capitoli di ciascun libro, dove le flessuose cornici vegetali e floreali inquadrano al centro del foglio il testo, similmente agli incipit dei libri.40 Questo tipo di mise en page, in uso particolarmente nei testi di diritto canonico e di diritto civile prodotti a Bologna a partire dalla fine del XIII secolo,41 potrebbe corroborare l’appartenenza del codi-ce al giurista bolognese Baldo degli Ubaldi, che poteva gradire un’impaginazione affine a libri già in suo possesso. Fu probabilmente Miche-lino l’ideatore e autore di parte delle cornici floreali del De Consolatione (penso ad esempio ai ff. 29r, 55r, 66v), nonché di buona parte del frontespizio. Qui si dispiegano infatti elementi ornamentali che il pittore avrà modo di rielabo-rare e di reimpiegare nel corso della sua lunga carriera, con un’attenzione sempre molto viva al dato naturalistico, vegetale e animale, con un repertorio floreale che attinge per l’appunto a questi esempi. I bellissimi animali che popolano le bordure, particolarmente i tre conigli che ne rosicchiano i fiori in cima al foglio [18], le cui pellicce sono ottenute per tratteggi incrociati fittissimi, credo si possano confrontare molto bene con i dettagli degli uccelli o della cesta di vimini del contadino miniati nel Liber rerum memorandarum, individuando forse anche qui un intervento di quel miniatore molto raffinato e colto, già collaboratore di Pietro da Pavia e probabilmente di Michelino da Besozzo al Pe-
dell’incipit Liber quartus, ben confrontabile sia col suo autoritratto a f. 332r, sia con l’identico Bevitore a f. 232r della Naturalis Historia. [4, 14] Un terzo miniatore, raffinatissimo, è quel-lo maggiormente operoso alle figurine umane e agli animali che animano le bordure, e si pone in un rapporto di stretta collaborazione col mi-niatore delle bordure a foglie di acanto, come si osserva bene nel frontespizio, dove gli autori dell’Antichità, miniati con la sensibilità narrati-va propria di un pittore di capitula, sono colti in pose vivaci, nell’atto di leggere, di scrivere e di meditare, adagiati sulle volute delle morbide fo-glie che si aprono come corolle a ospitarli. [16] Similmente sono dipinte anche le figure ai ff. 1r, 10r, 24r, e così i numerosi uccelli dalle specie anche esotiche che si incontrano posati in cima alle bordure, colti con tale attenzione al dato naturalistico da tradire anche qui l’ispirazione ai modelli francesi.35 [12, 14] Prossimo alla cul-tura figurativa e alla sensibilità stilistica di un Giovannino e di un Salomone de Grassi, que-sto miniatore fa un uso particolare della tecnica a tratteggio fitto, similmente, ma con maggior spessore stilistico, all’esecuzione del saio agosti-niano (come si osserva però solo a luce radente) nell’autoritratto di Pietro da Pavia, tecnica che pare abbia ispirato anche il giovane Michelino da Besozzo [13, 25]. Si potrebbe forse pensa-re, nel tentativo di avanzare una prudentissima proposta di identificazione, a un possibile in-gresso nella bottega di Pietro da Pavia, assieme a Michelino, di maestro Ambrogino (Ambrogio dell’Acqua?), collega di Michelino nel 1388 all’impresa pittorica delle Storie di sant’Ago-stino e san Nicola da Tolentino realizzate sotto i porticati del secondo chiostro del monastero agostiniano, e già forse collaboratore del padre di Michelino stesso, Antonio.36
Il codice miniato riconducibile allo scriptorium agostiniano che meglio manifesta quanto Mi-chelino stesse sperimentando e maturando via via maggiormente la propria vena interpretativa stilistica, evidenziando al contempo il ruolo di collaborazione sempre più alla pari col mona-co Pietro da Pavia, è il Boezio, De Consolatione Philosophiae (Cesena, Biblioteca Malatestiana, ms. D.XIV.1), che Giuliana Algeri ricondu-ce prudentemente, sulla base di uno dei due stemmi galeati à bas de page del frontespizio, al giurista bolognese Baldo degli Ubaldi, auto-re del Commentarius in usus feudorum offerto a Gian Galeazzo Visconti nel 1393 (Parigi, Bi-bliothèque nationale de France, latin 11727),
251
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
29. La Ferté-Milon, castello, Incoronazione della Vergine (foto Autore).
trarca di Parigi. [13, 15, 18] In questo codice si riconosce il repertorio iconografico che veniva impiegato per le decorazioni in fieri nelle sale del castello visconteo, il cantiere pavese più illu-stre a quelle date, come i nemeobliemia, le viole del pensiero, particolarmente gradite a Gian Galeazzo Visconti come documentano gli elen-chi dei suoi gioielli e la sala cosiddetta ‘a viollis’ [19, 21], o i conigli che adornavano la camera ‘de li donelliti’.42 Similmente alla decorazione di un Libro di Preghiere (in collezione priva-ta) commissionato da Gian Galeazzo Visconti, reso noto per la prima volta da Kay Sutton,43 si intravede anche nel De Consolatione quella sperimentazione ‘botanica’ che porterà Miche-lino, forse poco prima del 1420, alle estreme e originalissime composizioni che costituiscono il suo capolavoro, pervenuto in uno stato fram-mentario, il Libro di Preghiere già in Collezione Martin Bodmer (New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M.944).44 [17, 11, 19] Proprio per-ché affine sia nelle dimensioni sia nella tipologia
decorativa alle bordure del Libro di Preghiere di Gian Galeazzo,45 ritengo sia più che ragione-vole ricondurre questo meraviglioso codice, per la straordinaria ricchezza delle miniature che lo impreziosiscono, all’ambito ducale, seppur oggi non vi compaiano più stemmi e imprese a causa probabilmente della dispersione di più di metà dei fogli che lo componevano. Il gusto decora-tivo in voga dal 1415 ca, che privilegiava le bor-dure floreali con la ripetizione modulare dei fio-ri delle singole specie botaniche, dalle più am-pie dimensioni e cangianti nel colore, rispetto alle bordure ‘miste’ con i fiori più piccoli, sull’e-sempio della bottega di Pietro da Pavia, credo giustifichi una datazione delle miniature del Bodmer tra il 1415 e il 1420 ca. Rispetto alle fi-gurine snelle, dalle vesti aderenti e dai panneggi ‘sciolti’ miniate entro il 1403 nel sant’Agostino in cattedra del primo volume del Commento ai Salmi appartenuto al teologo agostiniano Marco Gallina (Città del Vaticano, Biblioteca Apostoli-ca Vaticana,Vat. lat. 451, f. 1r), e al frontespizio
252
RobeRta DelmoRo
13, 22]. Molto interessanti si pongono, a que-sto proposito, anche i confronti tra i personag-gi miniati attorno alla Ruota della Fortuna e le figure che illustrano i Mesi del Libro d’Ore di Avignone (Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 111),50 miniato senza dubbio da Michelino, [23-26] forse su commissione di una badessa, o per la destinazione di un monastero femminile (di ambito quasi certamente pavese) come mi pare suggerisca una preghiera inserita in basso sulla pagina, a f. 126r, in scrittura gotica libra-ria del primo Quattrocento.51 Gli stemmi che compaiono sotto al capolettera dell’«Incipit Officium Beate Marie Virginis» (a f. 28r) e che individuano i committenti o i destinatari del codice, non sono ancora stati del tutto identi-ficati.52 [27] La figura femminile che illustra il Mese di Aprile, a f. 4v, reggendo due steli di viole del pensiero e che, similmente alla Dama intrecciatrice di corolle del codice dell’Ambro-siana, è acconciata con una corona di fiori sul capo, permette la datazione del manoscritto in-torno all’anno 1400 [9, 26]. La pellanda stretta in vita, dalle maniche larghissime che si aprono a ricadere fluenti fin quasi a terra, e il colletto alto, è identica infatti a quella indossata dalla figura femminile reggente le insegne viscontee, miniata nel Cicerone, De Natura Deorum (Pari-gi, Bibliothèque nationale de France, latin 6340, f. 11v), quando il codice entrò nelle collezioni di Gian Galeazzo, entro probabilmente il 1402. Anche i calzari dalle punte lunghissime di que-sta dama che personifica l’amore cortese, vestita di verde smeraldo, come un’elegantissima dami-gella viscontea, sono tipici di questi anni, come mostrano gli affreschi dei de Veris a S. Maria dei Ghirli a Campione, datati 1400. La raffigu-razione del Mese di Novembre, con la scena del banchetto, permette di osservare quanto fosse varia e sperimentale, e ancora debitrice dell’am-bito di Pietro da Pavia, la tecnica di stesura pit-torica di Michelino, che fa uso qui (similmente all’impiego molto acquerellato del colore in tut-to il codice, dove prevalgono i verde chiaro, gli azzurri intensi e brillanti, i rosa antichi, il viola) di un fitto tratteggio verticale, come si osserva molto bene anche nel Marcius Cornator [24-25].Il capolavoro assoluto di Michelino a Pavia è tuttavia il frontespizio miniato nel 1403 dell’E-logio funebre di Gian Galeazzo Visconti di Pie-tro da Castelletto, il testo composto e recitato dal monaco agostiniano di S. Pietro in Ciel d’Oro in occasione dei funerali del primo duca di Milano, scomparso improvvisamente il 3 set-
dell’Elogio Funebre di Gian Galeazzo Visconti (Parigi, Bibliotèque nationale de France, latin 5888, f. 1r), del 1403, [28] i volumi dei pan-neggi delle figure che ornano a piena pagina il codice si dilatano e si complicano in numerose pieghe arrotondate, con un’attenzione maturata a contatto con gli scultori impegnati per il can-tiere del duomo di Milano (penso in particolare a Jacopino da Tradate e a Matteo Raverti), dove Michelino è documentato sicuramente operoso come pittore a partire dall’estate del 1418.46 [19] Credo pertanto, anche in virtù del tono delle orazioni molto emozionale, che il codice di New York possa identificarsi con quel «librum unum orationum et devotionum nostrarum figuris et iminiaturis solemniter decoratum» citato in un registro di decreti ducali, che Giovanni Porcelli, docente di scrittura a Milano – documentato in relazione con Michelino da Besozzo nell’ambi-to della Fabbri ca del duomo – aveva scritto di sua mano e fatto miniare sontuosamente entro il giugno del 1419, per donarlo al duca Filippo Maria Visconti, ottenendo in cambio, per sé e suo figlio, l’immunità dal pagamento di dazi, pedaggi, gabelle, ecc.47
La critica si è lungamente confrontata sul fron-tespizio del Boezio di Cesena, sottraendo o re-stituendo, al corpus di Michelino, la scena del Boezio malato tra le muse, composta nel capo-lettera D, e la ruota della fortuna miniata à bas de page, oggi generalmente accolte come opere di mano di Michelino da Besozzo [17, 23].48 In effetti è assai probabile che qui abbia operato il giovane pittore, come osservato attentamen-te, per la prima volta, da Liana Castelfranchi. Si tratterebbe, naturalmente, di un Michelino ancora acerbo, seguace dello stile figurativo più à la page in Lombardia tra gli anni ottan-ta e novanta del Trecento – ben rappresentato all’epoca dal caposcuola, Giovannino de Grassi – ma già incline a un originalissimo languore, come mostra, secondo me molto bene, un det-taglio che ho fatto scattare attraverso una lente di ingrandimento e a luce lievemente radente, dove si possono apprezzare le faccine già tonde delle muse, dalle espressioni incantate e dalle boccucce lumeggiate e un po’ aperte, tipiche di Michelino.49 [22] Un confronto tra questo dettaglio e quello dell’intrecciatrice di rose del Plinio dell’Ambrosiana corrobora a mio vedere la probabile paternità micheliniana anche per il capolettera milanese, considerato naturalmente un intervallo cronologico di circa un lustro che separerebbe la realizzazione dei due codici [9,
253
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
tembre del 1402 (Parigi, Bibliothèque nationa-le de France, latin 5888, f. 1r). Qui Michelino esprime a pieno la sua straordinaria e delicata vena inventiva, in uno stile ormai maturo che scioglie le forme e i volumi in materia come di cera colata e smaltata, dai colori delicati e bril-lanti,53 dove gli spunti decorativi vegetali delle bordure, già ampiamente sperimentati nella bottega di Pietro da Pavia, si trasformano in fio-ri quadrilobi dorati che, al pari di finestre aperte sulla pagina del codice, ospitano, alternati allo stemma visconteo, languidi profeti con cartigli che vi si affacciano a commentare la scena. [28] I riferimenti iconografici alla cultura francese sono precisi e, diremmo quasi, commoventi. Come ha osservato Paul Durrieu, circa un se-colo fa, la composizione adottata da Michelino nell’illustrazione dell’Elogio Funebre, col Gian Galeazzo inginocchiato ai piedi della Vergine col Bambino a ricevere la corona, accompagna-to da angeli guerrieri reggi insegne, riprende un modello compositivo francese, in uso nell’ico-
nografia dell’Incoronazione della Vergine.54 [29] Gian Galeazzo, non avendo potuto assurgere al trono sulla terra, viene incoronato in cielo (al pari della stessa Vergine) con la corona dalle dodici stelle descritta nell’Apocalisse XII, corri-spondenti alle Dodici Virtù, finemente personi-ficate nella miniatura.55 La cultura raffinatissima di questo pittore, maturata in ambito pavese, riflette ormai l’immagine di potere di una corte internazionale che si era preparata ad assurgere a regno, gareggiando, quanto a sfarzo e raffina-tezza, con le corti dei Valois, come illustrano ancora i lussuosi pezzi di oreficeria a smalti en ronde bosse minuziosamente descritti negli in-ventari e negli elenchi, che costituirono parte della dote di Valentina Visconti e dei gioielli appartenuti a Gian Galeazzo, e come manife-stano tuttora le imprese sorte dai due cantieri fondati dal primo duca, la cattedrale di Milano e la certosa di Pavia, concepita come mausoleo visconteo al pari della chartreuse de Champmol per i duchi di Borgogna.
NOTE
Il presente articolo espone alcune proposte attributive che avevo presentato al Convegno Internazionale di Storia della Miniatura (a cui non è seguita la pubblicazione degli Atti) tenutosi presso l’Università degli Studi della Calabria (Ar-cavacata di Rende, 16 maggio 2006), con una relazione dal titolo “Una miniatura per il giovane Michelino da Besozzo” e più ampie ricerche sugli scambi artistici tra la Lombardia e la Francia nel tardo Medioevo, approfondite nell’ambito del Mémoire di D.E.A: “Echanges artistiques entre France et Lombardie à la fin du Moyen Âge” (Université de Paris IV Sorbonne, proff. Fabienne Joubert, Dany Sandron, a.a. 2003-2004). Nell’occasione di licenziare questo saggio, desi-dero ringraziare vivamente: il prof. Antonio Iacobini, Ma-rie-Hélène Tesnière (Conservateur générale au département des Manuscrits, Paris, Bibliothèque nationale de France), Karine Kleine (Conservatrice responsable des fonds patrimo-niaux, Bibliothèque municipale d’Avignon, Livrée Ceccano), la prof.ssa Francesca Manzari e il prof. Carlo Maspoli.
1 Lo Studium Generale pavese veniva fondato il 13 aprile del 1361, quando, su sollecitazione del Podestà, del Capita-no e dei Sapienti di Pavia, Galeazzo II otteneva il consenso dall’imperatore Carlo IV di Boemia. A partire dal 27 otto-bre dello stesso anno era d’obbligo, da parte degli studenti del dominio, iscriversi presso l’Università di Pavia. Cfr. R. maIocchI, Codice Diplomatico dell’Univer sità di Pavia, I (1361-1400), Pavia 1905, doc. 1, pp. 7-9, doc. 2, p. 9; E. roveda, Le Istituzioni e la società in età visconteo-sforzesca, in Storia di Pavia. Dal libero Comune alla fine del principato indipendente 1024-1535. Società, istituzioni, religione nelle età del Comune e della Signoria, III. 1, Milano 1992, pp. 44-115: 56, n. 8.2 Sulla produzione dei codici miniati a Pavia tra la fine del Trecento e l’aprirsi del Quattrocento rinvio particolarmen-te a: P. toesca, Di alcuni miniatori lombardi della fine del Trecento, «L’Arte», X (1907), pp. 184-196; Id., Le minia-
ture dell’elogio funebre di Gian Galeazzo Visconti. (Parigi, Bibli. Nat.: ms. lat. 5888), «Rassegna d’Arte», X (1910), pp. 156-158; p. durrIeu, Michelino da Besozzo et les rela-tions entre l’art italien et l’art français à l’époque du règne de Charles VI, «Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», XXXVIII (1911), 2, pp. 1-29; P. toesca, La pittura e la miniatura nella Lombardia. Dai più antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Milano 1912, pp. 517-519; F. avrIl, Dix siècles d’enluminure italienne, Pa-ris 1984, pp. 102-108; K. sutton, Giangaleazzo Visconti as Patron. A Prayer Book illuminated by Pietro da Pavia, «Apollo», CXXXVII (1993), pp. 89-96; G. algerI, Il De Consolatione Philosophiae della Biblioteca Malatestiana e la miniatura a Pavia alla fine del Trecento, in Libraria Domini. I manoscritti della Biblioteca Malatestiana, testi e decorazio-ni, «Atti del Convegno, Cesena 1989», a cura di F. Lollini e P. Lucchi, Bologna 1995, pp. 323-337; ead., Un Boccaccio pavese del 1401 e qualche nota per Michelino da Besozzo, «Arte Lombarda», CXVI (1996), 1, pp. 42-50; L. castel-franchI, La formazione e gli esordi di Michelino da Besoz-zo miniatore, «Prospettiva», LXXXIII-LXXXIV (1996), pp. 116-127; F. lollInI, Michelino da Besozzo e bottega di Pietro da Pavia, Boezio, De consolatione Philosophiae con commentario attribuito a Nicolas Triveth, in Fioritura tardo-gotica nelle Marche (cat. della mostra, Urbino, Palazzo Du-cale, 25 luglio-25 ottobre 1998), a cura di P. Dal Poggetto, Milano 1998, pp. 101-102; M. rossI, Giovannino de Grassi. La corte e la cattedrale, Cinisello Balsamo 1996, pp. 10-12; Id., Pietro da Pavia e il Plinio dell’Ambrosiana: miniatura tardogotica e cultura scientifica del mondo classico, in Il co-dice miniato laico: rapporto tra testo e immagine, «Atti del IV congresso di Storia della Miniatura, Cortona 1992», a cura di M. Ceccanti, «Rivista di storia della miniatura», I-II (1996-1997), pp. 231-238; M. BollatI, Libri per i Visconti: committenza a corte tra Galeazzo II e Filippo Maria Viscon-ti, in Lombardia Gotica e Tardogotica. Arte e architettura, a cura di M. Rossi, Milano 2005, pp. 189-293: 191-196. Sulle suggestioni tecniche esercitate dall’oreficeria sulla miniatu-
254
RobeRta DelmoRo
ra, e particolarmente degli smalti en ronde bosse rinvio a M. meIss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Late Fourtheenth Century and the Patronage of the Duke, I, London 1967, pp. 143-146 e A. de marchI, Interferenze possibili tra oreficeria e pittura nel Nord Italia, prima e dopo Gentile da Fabriano, «Annali della Scuola Normale Supe-riore di Pisa», IV (2003), 15, pp. 6-47: 31-33. 3 Grazie alla politica filo-francese attentamente tessuta da Galeazzo II Visconti, al figlio di questi, Gian Galeazzo, era andata in sposa, nel 1360, l’ultima figlia del re di Francia Giovanni II il buono e di Bona di Lussemburgo, Isabella di Valois. Gian Galeazzo assurgeva così a cognato del fu-turo re di Francia Carlo V, di Luigi duca d’Anjou, di Jean duca di Berry, di Filippo l’Ardito duca di Borgogna, tutti committenti d’arte raffinatissimi. La presenza a corte del-la principessa francese aveva naturalmente incrementato l’importazione di manufatti artistici parigini. Valentina Vi-sconti, figlia primogenita di Gian Galeazzo e di Isabella di Valois, andò sposa, nel giugno del 1387, del cugino Luigi di Turenna, poi duca d’Orléans, fratello del re di Francia Carlo VI. La strepitosa dote che accompagnava Valentina a Parigi, che ammontava a 400.000 fiorini, contava diverse collane costituite di pezzi d’oro smaltati «albo et rubeo» os-sia en ronde bosse di fattura e gusto squisitamente francesi (oltre naturalmente a oggetti liturgici, abiti e argenteria). Anche i gioielli appartenuti a Gian Galeazzo Visconti, de-scritti nei due noti elenchi Borromeo, erano in buona parte costituiti da sfarzosi esemplari di oreficeria a smalti a rilievo bianchi e rossi (rinvio particolarmente a P.G. pIsonI-m.p. zanoBonI, I gioielli di Gian Galezzo Visconti, «Archivo Sto-rico Lombardo», CXXI (1995), pp. 333-388). I codici fran-cesi registrati nell’inventario della biblioteca del castello visconteo di Pavia, redatto nel 1426 su interessamento del terzo duca di Milano, Filippo Maria Visconti, risultavano una novantina circa. Ciò ci aiuta a comprendere il grado di osmosi culturale tra la Francia e la Lombardia viscontea e particolarmente tra Parigi, sede della corte regale francese, nonché sede universitaria, e Pavia, corte privilegiata dei Visconti nell’età di Galeazzo II e di Gian Galeazzo e sede dello Studium. Alcuni di questi codici sono stati individua-ti da Elisabeth Pellegrin e si conservano alla Bibliothèque nationale de France: il sant’Agostino, La cité de Dieu, tra-duzione francese di Raoul de Presles, donato a Carlo V di Valois (français 170); il Nicolas de Lyre, Postilla litteraris in vetus testamentum, descritto nell’inventario del 1426 «Nicolaus de Lira cum parabolis Salomonis (sic) ecclesiasticis cantica Isaia cum aliis prophetis (…)» con l’iscrizione a f. 336v «Actum Parisius anno Domini M CCC XXXX III, Ka-lendas Aprilis (…)» e alla fine del volume la nota «De Pavye au Roy Loys XII» (latin 461). Vanno inoltre tenuti presente i due Libri d’Ore documentati, acquistati a Parigi da Bian-ca di Savoia (moglie di Galeazzo II) per sé e per la nuora Isabella di Valois, e i codici in lingua francese appartenu-ti a Bianca di Savoia custoditi anch’essi alla Bibliothèque nationale de France: l’Evangeliorum expositiones (français 187), il Miroers de l’ame (latin 5562), e il Thesaurus paupe-rum in gallico di Brunetto Latini (français 1110), dono di Gian Galeazzo alla madre Bianca di Savoia (E. pellegrIn, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan au XVe siècle, Paris 1955, pp. 115, 126, 141, 175-176; rossI, La biblioteca di Pavia e i rapporti con la Francia, pp. 10-12). Non dimentichiamo infine quanto fossero stati determi-nanti, per gli scambi culturali più in generale tra Francia e Italia, il tentativo di Luigi I e di Luigi II d’Anjou di porsi sul trono di Napoli e la dominazione del re di Francia su Genova, dal 1395. Lo stesso Luigi d’Orléans, attraverso le nozze con Valentina Visconti, aspirava alla creazione di un regno a sud delle Alpi, esercitando il proprio dominio su Asti (rinvio a durrIeu, Michelino da Besozzo, pp. 4-5). 4 «Michaelem papiensem nostri temporis pictorem eximium,
puerulum novi, quem ad artem illam adeo natura formave-rat, ut prius quam loqui inciperet, aviculas et minutas ani-malium formas ita subtiliter et proprie disegnabat, ut illius artis periti artifices mirarentur» (uBerto decemBrIo, De re publica, Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms B 123 Sup., f. 80r). Michelino era figlio di Antonio de Molinari da Besoz-zo, il patronimico del pittore si evince da alcuni documenti, tra cui quello importante relativo alla mayestas in corso di esecuzione nel 1438, forse un’ancona di non grandi dimen-sioni, dipinta, destinata all’altare di S. Galdino nella chiesa milanese di S. Tecla (Milano, Archivio di Stato, Rogiti Ca-merali, cart. 206, Notaio Beltramino Carcano, ff. 93-94. Per la trascrizione del documento, compiuta da Jessica Gritti, rinvio a M. rossI, Una maestà di Michelino da Besozzo per Santa Tecla, in Arte e storia di Lombardia. Scritti in memo-ria di Grazioso Sironi, Città di Castello 2006, pp. 31-36). L’associazione almeno in un caso del nome del padre di Michelino all’appellativo magister (Milano, Archivio di Sta-to, Fondo Notarile, Atti dei Notai di Milano, filza 374, doc. 1435-05-3) ha ispirato a Carlo Cairati l’ipotesi suggestiva che il padre Antonio de Molinari da Besozzo potesse coin-cidere con quel «magister Antonius pictor» menzionato nel Liber expensarum degli Agostiniani di S. Pietro in Ciel d’O-ro come pittore ed esperto nella fabbricazione e riparazio-ne di vetrate, il quale lavorava, come ha verificato lo stesso studioso sui giornali della fabbrica, con la collaborazione di un socio e del figlio. Cairati segnala inoltre che nel 1359 un Antonio da Besozzo si iscriveva alla matricola degli Orefici di Pavia e che, nel 1373, era canepario della Scuo-la di S. Eligio (C. caIratI, Il polittico trecentesco, ancona dell’altar maggiore: ipotesi e problemi, in San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, mausoleo e santuario di Agostino e Boezio. Materiali antichi e problemi attuali, «Atti del Secondo Con-vegno storico artistico, Pavia, 27 febbraio 2010», a cura di M.T. Mazzilli Savini, Pavia 2013, pp. 330-351: 334-335 e n. 32, 343-344; per i documenti relativi all’orefice Antonio da Besozzo: P. venturellI, Esmailée à la façon de Milan. Smalti nel Ducato di Milano da Bernabò Visconti a Ludovi-co il Moro, Venezia 2008, p. 134; ead., «Con bel smalto e oro». Oreficerie del Ducato di Milano tra Visconti e Sforza, in Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano (cat. della mostra, Milano, Museo Diocesano, 30 settembre 2011-29 gennaio 2012), Cinisello Balsamo 2011, pp. 31-61: 53, n. 25). 5 Nella lettera che accompagna la descrizione delle carte da gioco allegoriche miniate da Michelino per Filippo Maria Visconti e inviate nel 1449 in Francia dal veneziano Jaco-po Antonio Marcello alla regina Isabella di Lorena, prima moglie di Renato d’Anjou (servite probabilmente per il gioco dei Trionfi e sontuosamente decorate, composte di 16 figure divise in 4 ordini), Marcello paragona Michelino a Policleto (Parigi, Bibliothque nationale de France, latin 8745, f. 2v). A f. 39r di una raccolta di ricette sulla pittu-ra compilata tra Parigi e l’Italia settentrionale da Giovan-ni Alcherio, tra il 1398 e il 1411, e ricopiata a Parigi nel 1431 dal notaio, umanista e bibliofilo Jean Lebègue (Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 6741), si registra la descrizione che di Michelino diede l’Alcherio: «pictor excellentissimus inter omnes pictores mundi». Agente ar-tistico milanese e tramite certo tra il cantiere del duomo di Milano e Parigi, l’Alcherio fu una figura preziosissima, in contatto con diversi miniatori attivi a Parigi, quali Ja-cques Coene, Jean Mignot e Antoine de Compiègne. Al-cherio aveva incontrato Michelino a Venezia, nel maggio del 1410, e nell’occasione si era fatto dare dal pittore una preziosa ricetta onde ottenere l’azzurro oltremare. Dopo la visita a Michelino, Giovanni Alcherio faceva ritorno a Parigi, entro la fine del 1410, dove frequentava Pietro di Sacco da Verona, mercante di libri e bibliotecario delle col-lezioni del duca Jean de Berry (durrIeu, Michelino da Be-
255
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
sozzo, pp. 12-13; meIss, French Painting, pp. 63-66; per una ricostruzione della biografia dell’Alcherio e una disamina del suo trattato: S.B. tosattI, Trattati medievali di tecniche artistiche, Milano 2007, pp. 129-148; mi permetto di rinvia-re inoltre, per questi argomenti, ad autori forse meno noti ma non meno preziosi: G. D’adda, Une famille d’artistes lombards au XIV et au XV siècle. Les Besozzo, «L’Art», II (1882), p. 81; A. De champeaux, Les relations du duc de Berry avec l’art italien, «Gazette de Beaux Arts», II (1888), pp. 409-415; A. de champeaux, p. gauchery, Les travaux d’art éxécutés pour Jean de France, duc de Berry, avec une étude biographique sur les artistes employés par ce prince, Paris 1894; M.G. zappa, Michelino da Besozzo miniatore, «L’Arte», VI (1910), pp. 443-449).6 Professore di Teologia presso lo Studium e personaggio tenuto in grande stima da Bianca di Savoia Visconti, poi-ché testimone al suo testamento (R. maIocchI, Codex di-plomaticus Ord. E. S. Augustini Papiae, Pavia 1905, docc. LXXXV-LXXXVI-LXXXVII, XCVII, pp. 141-143, 153).7 Marco Albertario ha proposto di identificare questo mae-stro Ambrogino col pittore Ambrogio dell’Acqua, al quale nel 1405 venne commissionato, da testamento di Luchina de Surigiis, un ciclo di affreschi in S. Maria Nuova (M. alBertarIo, Pittura a Pavia (1359-1525), in Storia di Pavia, III.3, Milano 1996, p. 878). Tale Ambrogino è registrato nel Liber expensarum degli Agostiniani di S. Pietro in Ciel d’O-ro come collaboratore di maestro Antonio (di cui si perdo-no le tracce nel Liber dal 1387), indizio che corrobora la cauta ipotesi di Cairati (anche alla luce di una continuità, nella collaborazione, coi Molinari da Besozzo) di identi-ficare magister Antonius col padre di Michelino (caIratI, Il polittico trecentesco, pp. 333-335). Michelino firmò e datò nell’agosto del 1394 l’ancona che ornava anticamente l’altare di S. Nicola da Tolentino nella chiesa eremitano-a-gostiniana pavese della S. Mostiola, opera commissionata dalla famiglia degli Orsi da Pescia. Le decorazioni pittori-che del secondo chiostro di S. Pietro in Ciel d’Oro erano ancora apprezzabili al tempo di Romualdo Ghisoni (morto alla fine del XVII secolo) il quale ne lasciò un’attenta de-scrizione nella sua Flavia Papia Sacra in un passo citato dal Maiocchi. Le registrazioni delle spese per il compimento del ciclo pittorico del secondo chiostro, dalle trascrizioni del Liber expensarum pubblicate da Maiocchi, partono dal 4 di gennaio, quando si consegnava la sabbia per la stesu-ra degli intonaci. Le successive spese per la realizzazione delle pitture sono registrate da marzo, quando si fabbri-cavano i ponteggi, al mese di novembre, quando, il giorno 25, Michelino e Ambrogino venivano saldati per una parte di pagamento e venivano forniti loro ulteriori soldi «pro ovis pro coloribus» (maIocchI, Codex diplomaticus, I, doc. LXXXVIII, pp. 143-144, n. 1, doc. CX, p. 200; cfr. caIratI, Il polittico trecentesco, pp. 333-335 e fig. 2, 349).8 A officiare nella chiesa vi erano sia i monaci agostiniani, sia i canonici (similmente al caso di S. Ambrogio di Milano, dove convivevano benedettini e canonici). Mi limito a se-gnalare qui, oltre al ciclo che adornava il secondo chiostro del monastero, la decorazione pittorica dell’abside della chiesa, fatta eseguire dagli Agostiniani onde onorare la se-poltura di Galeazzo II Visconti, la «maiestatem magnam» posta sopra l’altare maggiore importata da Venezia e due frontali d’argento dorati e smaltati, destinati anch’essi all’altare maggiore, di cui uno importato da Genova (ma-IocchI, Codex diplomaticus, 1905, doc. XCIX, p. 161). Per l’ancona che decorava l’altare maggiore, ricostruita nella sua fisionomia, il cui scomparto centrale è stato identificato da Ugo Bicchi e da Adriano Peroni nella tavola veneziana col sant’Agostino in trono dei Musei Civici di Pavia, rinvio da ultimo, con bibliografia in merito, a caIratI, Il polittico trecentesco, pp. 330-351.9 Il corpus noto agli studi conta, oltre al menzionato codice
dell’Ambrosiana: il cesare, Commentaria de bello Gallico (Leida, University Library, ms. BPL 16A), con testo data-to 1385; il BoezIo, De Consolatione Philosophiae (Cesena, Biblioteca Malatestiana, ms. D.XIV.1); il BoccaccIo, De mulieribus claris e De montibus, fluminibus, fontibus, silvis, lacubus et maribus (Copenaghen, Kongelige Bibliothek, ms. Gl. Kgl. S. 2092); il pIetro da padova, Commentarius in Libro Aristotelis de problematibus (Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 6541); il petrarca, Liber rerum memorandarum (Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 6069T); il seneca, Ludus de morte Claudii, Epistole, Tragoedie (Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 8717, f. 57r), l’Historia Troiana (Torino, Biblioteca Nazio-nale, K. 13) e un Libro di Preghiere appartenuto a Gian Galeazzo Visconti in collezione privata. 10 Coluccio Salutati, autore di una celebre epistola indiriz-zata al Cappelli nel 1392, ce lo descrive come un illuminato protettore delle lettere, seguace della filosofia politica cice-roniana promossa da Petrarca alla corte dei Visconti, e lo paragona, nella sua sfortunata sorte, a Callistene; «uomo di sottilissimo ingegno» come lo definì il Corio, Pasquino fu murato vivo nel castello nel 1398, probabilmente vittima di una trama del signore di Mantova, in relazione alla scon-fitta delle truppe viscontee nella campagna militare contro Mantova nell’estate del 1397. Per un profilo biografico di Cappelli rinvio a D.M. Bueno de mesquIta, s.v. Cappelli, Pasquino de’, in Dizionario biografico degli Italiani, XVIII, Roma 1975, pp. 727-730; per gli interessi umanistici del-lo stesso: E. garIn, La cultura milanese nella prima metà del XV secolo, in Storia di Milano, VI, Milano 1955, pp. 545-608: 547; A. vIscardI, m. vItale, Orientamenti e svol-gimenti della cultura milanese del sec. XIV attestati dalla composizione della biblioteca del castello di Pavia, in La cul-tura milanese nel secolo XIV, in Storia di Milano, V, Milano 1955, pp. 592-593.11 In relazione probabilmente alla spedizione di Luigi d’Anjou nel Regno (Bueno de mesquIta, Cappelli, p. 727). 12 I codici della biblioteca viscontea di Pavia entrarono nelle collezioni del re di Francia Luigi XII, confluendo nel 1499 nella librairie del castello de Blois (cfr. avrIl, Dix siècles, p. 89). 13 pellegrIn, La Bibliothèque des Visconti, p. 221. Nel la-tin 100, Job glossatus, sul secondo foglio di guardia (Ar) parzialmente reciso in alto a sinistra si legge l’iscrizione (di mano di Cappelli stesso): «Iste librus est Pasquini de Ca-pellis emptus Parisius MCCCLXXXIII». Sopra in calligrafia gotica corsiva probabilmente francese (quasi illeggibile) il precedente proprietario ha apposto un’iscrizione «rectus est qui (…)»; egli stesso ha appuntato diverse note nel libro. Sullo stesso foglio di guardia, al verso, in basso a sinistra, con altra calligrafia, «Vallis Luc(is)». Dalla moda nel capo-lettera D che si incontra a f. 3r si direbbe un manoscritto della fine del XIII secolo. Il latin 394, è parte dell’Antico Testamento comprendente i Libri di Giosuè, dei Giudici, di Ruth e dei Re, accompagnati dalla glossa ordinaria e prece-duti a f. 1r dal prologo di san Gerolamo al quale corrispon-de l’incipit indicato. Similmente al precedente manoscritto anche questo reca sul foglio di guardia la medesima iscri-zione di mano di Cappelli: «Iste liber est Pasquini de Capel-lis emptus Parisius MCCCLXXXIII» (cfr. pellegrIn, La Bi-bliothèque des Visconti, p. 204). Sul verso dell’ultimo foglio in calligrafia italiana della fine XIV-XV secolo (non però quella di Pasquino) «Iosue iudicum et libri regum glosati». Il latin 100, che si può datare, credo, alla fine del XIII seco-lo, presenta solo due capilettera miniati in tutto il volume, a f. 1r e a f. 3r, tipicamente francesi, incorniciati d’oro, con il ductus campito di colore, alternato blu e rosa e con deco-razioni a biacca. Molto elaborati si presentano i capilettera filigranati blu e rossi. Il latin 394, a f. 88r nel capolettera I del Libro dei Re, «In diebus (…)» presenta la scena, in
256
RobeRta DelmoRo
basso, della raccolta del grano, ispirata alle scene legate ai Mesi (Giugno e Luglio), alle quali proprio i codici miniati nello scriptorium di Pietro da Pavia furono, come vedre-mo, particolarmente attenti. Questi due codici francesi, di dimensioni piuttosto ampie (che corrispondono all’incirca a quelle della Naturalis Historia dell’Ambrosiana, ms. E 24 Inf., lussuoso codice pavese che, come esamineremo più attentamente oltre, fu commissionato appunto da Pasquino de Cappelli), dalle pagine di pergamena bianchissime coi capilettera filigranati blu e rossi (anche queste caratteristi-che che presenteranno gli stessi codici commissionati in seguito da Pasquino) si direbbero provenire da un mede-simo scriptorium, probabilmente riconducibile all’abbazia di Valuisant.14 pellegrIn, La Bibliothèque des Visconti, pp. 119-120. Non concordo invece sull’identificazione del BoccaccIo, De montibus, fluminibus, fontibus, silvis, lacubus et mari-bus, codice francese custodito a Roma (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Reg. Lat. 1477) quale manoscritto appartenuto a Pasquino (rossI, Giovannino de Grassi, 1996, pp. 9-10, fig. 3). Lo stemma a f. 14r, grattato e su cui campeggia, sovrapposta, una vipera, a sua volta grat-tata, era fasciato di sei pezzi di rosso (cinabro) e di nero, come i capilettera filigranati che si incontrano nel codice (i colori dello stemma di Cappelli sono invece argento e rosso minio) e manca il tipico cappello che lo sormonta, proprio di Cappelli appunto. Lo stemma era inoltre presentato da due leoni seduti affrontati che, anche qui, non rinviano alle imprese araldiche adottate dal secretarius visconteo (per l’araldica di Pasquino cfr. oltre nel testo e particolarmente la n. 21). In alto sulla pagina una figurina che indossa un cappello dal lungo pennacchio regge in mano un cappuccio a cono con in cima una palla dorata, fasciato di rosso e d’o-ro, probabile ulteriore impresa del proprietario e verosimil-mente anche committente del manoscritto. Il rosso e l’oro erano i colori della casa reale inglese e Lionello d’Anversa, duca di Clarence, figlio di Edoardo III d’Inghilterra, aveva sposato nel giugno del 1368 Violante Visconti, sorella di Gian Galeazzo. In alto sul foglio quelle che possono sem-brare una numerazione della pagina, «L» e «I», disposte a lato della figurina centrale, si possono credo interpretare come delle iniziali «L I» che, per l’impresa dei leoni che vi si associano sullo stesso foglio, non escludo possano allude-re al nome del committente, Lion o Lionellus (cfr. a questo proposito l’iscrizione in cima al frontespizio della Bibbia di Carlo V, Parigi, Bibliothèque de l’Arsenal, ms. 5212, f. 1r). Mancherebbe inoltre la nota di Cappelli dell’acquisto del volume a Parigi, come si riscontra nei codici acquista-ti durante il viaggio del 1383. Segnalo infine che a f. 28v c’è una postilla appuntata in gotica libraria dalla calligrafia puntuta tardo trecentesca molto diversa rispetto a quella ben riconoscibile, dal ductus più tondeggiante e ordinato, in minuscola notarile, di Pasquino.15 Seguace dell’ideale politico di Gian Galeazzo Visconti (Giovanni Manzini della Motta da Fivizzano fu inoltre giu-reconsulto, podestà e capitano della Repubblica di Pisa) egli alternava ‘la penna e la spada’, come aveva da scriver-ne Benedetto Gambacorti, e aveva postillato il codice in questione (cfr. a questo proposito la nota di Manzini stesso nel ms. Vat. lat. 11507 a f. 84r. Si veda: F. novatI, Chi è il postillatore del codice Parigino?, in F. Petrarca e la Lombar-dia, Milano 1904, pp. 179-192; V. rossI, Il codice Paris. lat. 8568 e il testo delle “Familiari”, in Scritti di critica letteraria, II, Firenze 1930, pp. 93-107; garIn, La cultura milanese, p. 549, n. 1). 16 Caratteri similmente gotici (in minuscola notarile) dal ductus ordinato e tondeggiante, attribuibili a Pasquino, ri-corrono anche nelle annotazioni a latere della stessa Natu-ralis Historia (cfr. rossI, Pietro da Pavia, p. 231).17 Altro manoscritto francese presente a Pavia era il volumi-
nosissimo Artistotele, Ethiques, Economiques et Politiques (Parigi, Bibliothèque nationale de France, français 204), traduzione in francese di Nicolas de Oresme, dedicata a Carlo V di Valois, descritto nell’inventario della biblioteca del castello: «Aristotilis philosophia moralis in galico cum figura unius doctoris in principio habentis ante se unum li-brum voluminis magni et grossi coperti corio rubeo sculpto» (pellegrIn, La Bibliothèque des Visconti, A 202, p. 118). Questo codice si pone come ulteriore possibile modello parigino per la produzione di codici di lusso locale. Sotto all’explicit, a f. 584v, reca in scrittura gotica corsiva francese del XVI secolo «Pavye y au Roy Louis XII». Qui mancano i capilettera filigranati. Tipiche si presentano le decorazioni coi capilettera miniati dai quali fuoriescono foglie di vite dorate, blu e rosso cupo. I capilettera sono tipici france-si, campiti di rosa scuro o di blu profondo con decorazio-ni geometriche a biacca, e ospitano all’interno, su fondo oro, immagini di draghi o foglie di vite intrecciate. A lato i testi sono incorniciati dalle tipiche aste verticali dorate dalle quali fuoriescono tralci di vite sinuosi, dalle foglie blu, rosse e oro; bellissimi si presentano i numerosi draghi dalle ali blu e rosse, figurati sulle bordure, dalle cui bocche fuoriescono tralci di vite, o le cui code si trasformano in rami fogliati, come si osserva ad esempio a f. 149r. Nei blu particolarmente corposi, negli abiti fluenti che si osservano nelle miniature del codice, negli sfondi à ramages, questo manoscritto potrebbe costituire uno degli esemplari che ispirarono parte del repertorio decorativo e della scioltezza stilistica di Michelino da Besozzo. Sul gusto diremmo à la page, di un collezionista e committente coltissimo quale fu Pasquino, dovette esercitare una notevole influenza la fre-quentazione della corte viscontea, improntata dalla cultura francese, dove si conservavano nella biblioteca numerosi testi pregiati, quali il sant’agostIno, De la cité de Dieu contre les païens, traduzione di Raoul de Praelles, donato a Carlo V di Valois (Parigi, Bibliothèque nationale de Fran-ce, français 170-171), dove a ff. 6r, 19r del primo volume la raffigurazione di due personaggi dal sapore intensamente visconteo (forse gli stessi Galeazzo II e Gian Galeazzo?), inginocchiati in adorazione dei santi Pietro e Paolo, è di mano quasi certamente di un miniatore francese (cfr. anche a f. 2r del secondo volume il ritratto forse di Galeazzo II inginocchiato ai piedi della croce).18 Basti qui rammentare esempi quali la Bible de Jean de Sy (Parigi, Bibliothèque nationale de France, français 15397), Les grandes Chroniques de France de Charles V (Parigi, Bi-bliothèque nationale de France, français 2813), il Psautier de Jean de Berry (Parigi, Bibliothèque nationale de France, français 13091).19 Giuliana Algeri ha identificato la produzione di un se-condo scriptorium a Pavia, che si distingue da quello ere-mitano-agostiniano per l’adozione di formule decorative più propriamente lombarde, ispirate a modelli bolognesi, quali le foglie di acanto che si dispiegano in volute carnose e morbide, a decorazione di capilettera e bordure. A questo scriptorium, legato alla corte viscontea e allo Studium, la studiosa riconduce la realizzazione del sant’Agostino, Com-mento ai Salmi (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati cana,Vat. lat. 451), appartenuto all’agostiniano docente di Teologia Marco Gallina, miniato nei due frontespizi e all’iniziale di f. 1v da Michelino da Besozzo, entro il 1403; così anche il Valerio Massimo (Parigi, Bibliothèque natio-nale de France, latin 5840), proveniente dalla Biblioteca viscontea, e il Seneca, Tragoedie (Parigi, Bibliothèque na-tionale de France, latin 8028), compiuto nel 1403 per Ago-stino Fazardi, anch’esso in antico nelle collezioni viscontee, e a cui la studiosa affianca la decorazione di un foglio, par-te di un registro frammentario di lettere viscontee datate 1378-1394 (Pavia, Archivio Storico Civico, ms. A.II.141, si veda algerI, Il De Consolatione Philosophiae, pp. 328-332).
257
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
Al minatore del Seneca di Parigi, François Avril attribuisce, oltre alla decorazione del Valerio Massimo, anche un Pe-trarca (Venezia, Biblioteca Marciana, cod. lat. 86 [2593]; avrIl, Dix siècles, pp. 105-106). È tuttavia possibile che Pavia ospitasse un terzo scriptorium, anch’esso in relazio-ne con i Visconti e particolarmente con lo Studium, dove mi pare possano aver operato, più che miniatori lombardi ispirati ai modelli francesi, miniatori propriamente france-si, forse giunti da Parigi attraverso i contatti istaurati tra le università, le corti e il cantiere del duomo di Milano, come credo suggeriscano le decorazioni in gusto assolutamente francese dei frontespizi del Commentarius in usus feudo-rum (Parigi, Bibliothèque nationale de France, latin 11727) offerto nel 1393 dal giurista bolognese, docente di legge, Baldo degli Ubaldi a Gian Galeazzo Visconti, e il Jean de mandevIlle, Romans (Milano, Biblioteca Trivulziana, ms. 816), non a caso già creduto di origine francese (avrIl, Dix siècles, p. 104; cfr. anche le osservazioni in merito di alge-rI, Il De Consolatione Philosophiae, p. 333).20 Cfr. E. pellegrIn, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan. Supplément, Paris 1969, p. 15, fig. 11.21 A f. 164v, all’explicit XIIII particula, sequitu XV, l’iniziale P di «Propter quid diametri (…)» reca l’impresa galeata con in cima un animale fantastico dal corpo d’aquila e dalla te-sta di drago dalla cui bocca fuoriesce il motto di Cappelli su di un cartiglio: «serpentis astutia colombe simplicitas». Sia la parte argentata dello stemma (fasciato di 6 pezzi d’argento e di rosso e il cappello d’argento in cima), sia il cappel-lo sono sottilmente profilati a biacca. Lo stemma a f. 226r entro il capolettera D «determinatis» traspare abbastanza bene sul retro della pergamena e si vede nettamente il rosso minio dello stemma, che traspare come rosato. Qui la scelta di inquadrare lo stemma entro una corona di ali di aquila, altra impresa di Pasquino, assieme alla testa di drago e all’a-nimale fantastico per metà drago e per metà aquila, si ispira probabilmente all’illustrazione della «Descriptio ventorum secundum Aristorilem», a f. 226v. A f. 241r lo stemma gale-ato con l’impresa ha lasciato sul verso del foglio l’impronta scura dell’argento ossidato, che si distingue molto bene, e anche qui il rosso traspare come rosato. Il codice si apre con lo stemma visconteo miniato sul verso del terzo foglio di guardia; si tratta di uno stemma molto grande dove la vipera blu con una testa di drago (peraltro simile a quel-le dei draghi miniati nello stesso codice) campeggia sullo scudo argentato. 22 «Armannus copiasset utique legalius nisi exemplaris mala fraude preventus» (Cfr. pellegrIn, La Bibliothèque des Vi-sconti, A.179, p. 111). Nella firma filigranata le lettere, in parte dipinte di giallo, si scandiscono entro un’incornicia-tura a china bruna geometrica e a minuscole decorazioni vegetali, ricchissima e ramagiata (cfr. ibid., p. 15, fig. 11).23 Davvero ogni capolettera è diverso dall’altro e non si ri-pete mai l’elemento decorativo interno delle foglie di vite intrecciate, come spesso ricorre nei codici importati da Pa-rigi, ma, per esempio, si incontrano fantasie con foglie di quercia, fiori di cardi, campanule, foglie di acanto stilizzate, elementi floreali geometrici entro sfondi quadrettati a rom-bi (come la P a f. 283r e la P a f. 285v), sempre diversamen-te composti, di colore rosa antico, rosso, verde e blu con rialzi a biacca e ombreggiature con stesure di colore più intenso (capilettera P ai ff. 226v, 239r, 221r, 283r).24 Il codice si apre con due fogli di guardia cartacei inseriti successivamente, con scrittura seicentesca: «Plinii naturalis historia libri XXXVII Codex magna diligentia conscriptus a Fratre Petro de Papia anni 1382 [aggiunto in soprascritto con altra calligrafia «vel potius 1389»] ut videri poterit in fronte libri X*XV [*X cancellato] olim comitis Io(hannis) Attendoli Bolognini ut ex stemmate initio codici et initio li-bri XXVI». Scrittura in inchiostro nero a latere: «in fronte et in calce, quos (…) integro possessioni et in utroque loco».
Sotto: «Felicibus auspiciis Illustrissimi Cardinali Federi-ci Borromei Archiepiscopi Mediolani, Olgiatus vidit anno 1603». A f. 266r si vede in basso il retro dello stemma ori-ginario. Sopra questo è stato miniato a f. 266v (come a f. 1r) lo stemma dei Bolognino Attendolo, d’azzurro al leone d’oro con la mela cotogna. Le iniziali apposte riconducono al conte Giovanni Bolognino Attendolo, castellano di Pavia dal 1465 (cfr. R. maIocchI, Codice diplomatico artistico di Pavia dal 1330 al 1550, I, Pavia 1937, doc. 39, p. 12; pel-legrIn, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan. Supplément, p. 15; rossI, Pietro da Pavia, p. 231).25 Non improbabile se consideriamo ad esempio una figu-ra itinerante quale fu quella di Pietro di Sacco da Verona, studente alla Sorbona nel 1397, documentato in quell’anno in occasione di pagamenti per due codici francesi venduti a Luigi d’Orléans, un Tito Livio e un Boccaccio, e forse iden-tificabile con quel «uno bachalari» che accompagnava, as-sieme al pittore Jacques Coene e aiuti, l’ingegnere Johannes Campaniosus nationis Normaniae e Jean Mignot a Milano, chiamati dall’Alcherio per il cantiere della cattedrale nell’a-prile del 1399 (Annali della Fabbrica del Duomo di Milano dall’origine fino al presente, I, Milano 1877, doc. 13 aprile, p. 194, doc. 20 luglio, p. 197; Annali della Fabbrica del Duo-mo di Milano, Appendici, I, Milano 1883, doc. settembre, p. 246); in seguito bibliotecario delle collezioni di libri del duca di Berry (cfr. la n. 5).26 Desidero annotare qui un’osservazione che generalmente è sfuggita alla critica, e cioè che la data apposta da Pietro da Pavia era stata letta, in un primo tempo, nel foglio di guardia seicentesco del codice aggiunto in età borromaica (allorquando il manoscritto entrò a far parte della biblio-teca del cardinale Federico Borromeo), «1382», quindi corretta in soprascrittura «(vel potius 1389)». Come sug-gerito nel foglio di guardia, infatti, non è molto precisa la lettura della data, che si dà ormai per scontata come un 1389, manca completamente infatti la chiusura dell’oc-chiello del 9 in cifra arabica, il segno è aperto come rivela anche un’osservazione alla lampada di Wood, che eviden-zia il solco nella pergamena, e l’inchiostro prosegue per un breve tratto creando una minuscola asticciola verticale dove in origine avrebbe potuto inserirsi il ductus di un’asta orizzontale, perduta, a raffigurare un 2. La data come la firma è a inchiostro rosso apposta sull’oro che in alcune parti, come l’asta verticale dell’1, è quasi completamente caduto. Certo è che se si trattasse di un 2 anziché di un 9 sarebbe da rivoluzionare tutta la cronologia dei manoscrit-ti e, questo, in particolare, sarebbe addirittura anteceden-te l’arrivo dei codici parigini acquistati dal Capelli! Cosa, credo, improbabile. 27 Ad esempio nell’incipit del Liber secundus, «in quo conti-netur de nostro mundo et de celestibus et aeriis ac terrestri-bus», il capolettera raffigura il Dio Padre entro una man-dorla azzurra raggiata, sostenuto da due angeli. A f. 84v, all’incipit del Liber octavus, la N di «Ne reliqua transeamus animalia et primus terrestria», presenta al suo interno di-versi animali che si affacciano fantasticamente alle volute vegetali stilizzate, su fondo oro, un leone, una capra e un coniglio che si rifugia in una tana. La bordura è costituita per la metà inferiore da un drago verde con la coda che fiorisce a fiori multicolori stilizzati dai morbidi petali, e che minaccia una scimmia dentro una voluta di una foglia di acanto rossa. In cima alla bordura un topolino minuscolo rosicchia una fogliolina bianca. La S dell’incipit del Liber decimus, «de natura avium et volatilium. Sequitur natura avium (…)» è rosa e a forma di uccello acquatico, decorata con all’interno uccelli, un nibbio reale e probabilmente un merlo posato su di un nido, entro racemi fioriti su oro. Da qui iniziano a comparire i capilettera decorati con le attività umane ispirate alle raffigurazioni dei Mesi e dei Mestieri nei Tacuina sanitatis. A f. 177v l’incipit del Liber decimu-
258
RobeRta DelmoRo
soctavus, «de agricoltura capitulum primum» presenta un capolettera Q decorato con un contadino che semina su di un campo arato; a f. 193v a capolettera S dell’incipit del Liber nonusdecimus è raffigurata la Lavorazione del lino. La figura femminile, impegnata nella pettinatura del lino, su di un setaccio appuntito, è molto prossima stilisticamen-te a Giovannino de Grassi (cfr. rossI, Pietro da Pavia, pp. 232-235). 28 Come mostrano, ad esempio, i confronti con l’Historia Plantarum (Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 459) e il Mese di febbraio, miniato da Michelino da Besozzo, nel Libro d’Ore di Avignone (Avignone, Bibliothèque Muni-cipale, Ms. 111). Cfr. rossI, Pietro da Pavia, pp. 232-233.29 Per la datazione della decorazione di questa sala rinvio a D. vIcInI, Nota sulla decorazione trecentesca del castello di Pavia al tempo di Gian Galeazzo Visconti, in Itinerari d’arte in Lombardia dal XIII al XX secolo. Scritti offerti a Maria Teresa Binaghi Olivari, Milano 1998, pp. 31-36: 33-34. L’ntrecciatrice di rose proviene dagli erbari tardo tre-centeschi, come si osserva nel Theatrum Sanitatis (Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 4182, ff. 38r, 54v); essa veste una moda altolocata femminile in voga in quei precisi anni (l’abito è primaverile, dall’ampia scollatura arroton-data), dove sui biondi capelli raccolti in due bande sopra il capo, fermati da fasce o da fiori, si potevano adagia-re anche elaborati copricapi intrecciati con perle, zaffiri e balassi (rubini), i cosiddetti zardini, come registra ad esempio il zardino che contava ben 31 balassi, 108 perle grosse e 896 perle più piccole (per la somma di 1.506 fio-rini d’oro) del lussuosissimo inventario della dote di Eli-sabetta Visconti, duchessa di Baviera, figlia di Bernabò, fatto redigere da Gian Galeazzo Visconti proprio nella sala a dominabus del castello, nel gennaio del 1396, con l’ammontare del costo dei singoli pezzi (Milano, Archivio di Stato, Rogiti Camerali, 216, notaio Catelano Cristiani, doc. 1396-01-26).30 «Arborum enim ramis coronari in sacris certaminibus mos erat primum, postea variari coeptum mixtura versicolori florum, quae invicem odores coloresque accenderet. Sicyone ingenio Pausiae pictoris atque Glyceare coronariae dilectae admodum illi, cum opera eius pictura imitaretur, illa pro-vocans variaret, essetque certamen artis ac naturae, quales etiam nunc extant artificis illius tabellae atque in primis appellata Stephaneplocos qua pinxit ipsam (…)» (plInII, Naturalis Historia, Liber XXI, III, ed. consultata, Pisa 1984-1987, p. 792).31 Foto gentilmente prestatami per questi studi dalla prof.ssa Silvia Bianca Tosatti.32 Basti confrontare la composizione della damigella ingi-nocchiata con la figura femminile inginocchiata ad acca-rezzare il cane dell’alfabeto monocromo del Taccuino di Schizzi di Giovannino de Grassi (Bergamo, Biblioteca An-gelo Mai, Cassaf. 1.21, f. 26r) e con la Madonna che cuce della Rocchetta di Campomorto. L’attribuzione di questo capolettera a Michelino è stata parte dell’argomento che ho portato al convegno di Arcavacata di Rende (16 maggio 2006) e mi pare che la damigella sia stilisticamente l’unica figura a lui riferibile di tutto il codice. Cfr. anche le osserva-zioni in merito allo stesso capolettera di BollatI, Libri per i Visconti, p. 196.33 Nel manoscritto si incontrano diverse note appuntate a latere del testo da chi ha letto il codice (particolarmente ai ff. 2r, 3r e 3v). A f. 7v è possibile credo riconoscere nelle annotazioni «Apuleius» e «Que scripsit Plato» la calligrafia di Pasquino. Bellissima e molto elegante si presenta anche qui la realizzazione delle pagine con il testo disposto su due colonne, composte con lunghissimi ed elaboratissimi capilettera filigranati, similmente agli esemplari francesi, come se ne incontrano anche nella Naturalis Historia e nel Commentarius.
34 Ossia la P di «Peracta cerealium». L’uomo, seduto entro una radura, ai piedi di una vite con un grappolo di uva bionda, sorseggia del vino rosso. Innanzi a lui sono dipinte due ampolline con vino bianco e rosso.35 Mi limito a riportare qui celebri esempi quali le Petites Heures de Jean de Berry (Parigi o Bourges), Parigi, Bi-bliothèque nationale de France, latin 18014, e la Bibbia offerta da Jean de Berry all’antipapa Clemente VII (Parigi e Bourges), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-cana, Vat. lat. 50 e 51.36 Se l’ipotesi fosse corretta si potrebbe pensare a un pitto-re più anziano di Michelino da Besozzo, e, probabilmente, stilisticamente più prossimo alla maniera di Giovannino de Grassi, alla quale non fu insensibile lo stesso Michelino ai suoi esordi. Per la proposta di Marco Albertario di ricono-scere in magister Ambroginus il pittore Ambrogio dell’Ac-qua e per l’ipotesi di Cairati di riconoscere in magister An-tonius il padre di Michelino da Besozzo rinvio alle nn. 4 e 7.37 Baldo era stato chiamato a insegnare allo Studium di Pa-via nel 1390. Il frontespizio di questo codice, di gusto par-ticolarmente parigino nei complessi tralci di vite intrecciati che ne costituiscono le bordure, è stato miniato probabil-mente, come dicevamo, in un ulteriore scriptorium in rela-zione con l’università pavese dove forse operavano artisti francesi, cfr. la n. 19.38 algerI, Il De Consolatione Philosophiae, p. 325; pro-posta accolta anche da Fabrizio Lollini, che suggerisce di vedere in un esponente della nobile casata milanese dei Martignoni il possibile committente e donatore del codi-ce a Baldo degli Ubaldi (lollInI, Michelino da Besozzo e bottega, p. 101).39 Cfr. F. avrIl, Bible avec gloses de Nicolas de Lyre, offerte par Jean de Berry à l’antipape Clément VII, in Paris 1400. Les arts sous Charles VI (cat. de l’exposition, Musée du Louvre, 22 mars-12 juillet 2004), sous la direction de É. Taburet-Delohaye, Paris 2004, p. 109.40 algerI, Il De Consolatione Philosophiae, pp. 324-325.41 Ibid.42 Rinvio a vIcInI, Nota sulla decorazione trecentesca, p. 32; R. delmoro, Per gli affreschi perduti della «salla grande dale caze» del Castello Visconteo di Pavia: modelli decorativi del tardo Trecento, «Arte Lombarda», n.s., CXLVI-CXLVIII (2006), 1-3, pp. 63-72: 64.43 sutton, Giangaleazzo Visconti as Patron, pp. 89-96.44 Il Libro di Preghiere, costituito attualmente di 95 fogli, di cui 22 recano decorazioni a piena pagina, era già nella collezione di Martin Bodmer di Coligny (Ginevra), ed è pervenuto alla Pierpont Morgan Library di New York ac-quistato nel 1970. L’allora direttore, William Voelkle, ne compì un esame dettagliato, elencando le parti conservate, come si presentano attualmente disposte, e ricostruendone la probabile fisionomia antica, facendo inoltre un elenco di tutte le miniature a piena pagina che il codice dove-va presentare, incluse quelle mancanti, circa 25 (<http://www.corsair.morganlibrary.org/msdescr/BBM0944a.pdf>). Il manoscritto è stato segnalato per la prima volta da Otto Pächt e pubblicato con un’indagine storico artistica che oggi definiremmo ‘pionieristica’ da Rosy Schilling, che lo datava all’aprirsi del Quattrocento, in relazione col Libro d’Ore di Avignone (Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 111), considerato a ragione dalla studiosa precedente. Una disamina critica del codice Bodmer, con un’attenzio-ne particolare ai rapporti di Michelino con la miniatura francese, si deve a Liana Castelfranchi, che, diversamente dalla datazione proposta nel catalogo della mostra di Mi-lano del 1958 (Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, cat. della mostra, Milano, Palazzo Reale, aprile-giugno 1958, a cura di R. Longhi, Milano 1958, p. 54), che lo collocava tra il secondo e il terzo decennio del Quattrocento, ac-coglieva la proposta della Schilling, anticipandone la re-
259
Interferenze francesI nella produzIone deI codIcI dI lusso a pavIa sullo scadere del trecento
alizzazione al 1405 ca (accolta da Luisa Cogliati Arano). Una cronologia invece posticipata del Bodmer rispetto alla decorazione di Michelino del foglio 15r delle Episto-le di San Gerolamo (Londra, The British Library, Egerton Ms. 3266), codice appartenuto a un membro della fami-glia Cornaro/Corner e datato 1414 (ff. 2v e 324v), è stata avanzata recentemente da Milvia Bollati. Per le vicende critiche qui brevemente esposte e ulteriore bibliografia in merito: O. pächt, Early Italian Nature Studies and Earlier Calendar Landscape, «Journal of the Warburg Courtauld Institutes», XIII (1950), pp. 13-47; R. schIllIng, Ein Ge-betbuch des Michelino da Besozzo, «Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst», VIII (1957), pp. 65-80; r. cIprIanI, Libro d’Ore, in Arte Lombarda, p. 57; D. sellIn, Michelino da Besozzo (Univ. of Pennsylvania, PhD), Ann Arbor 1968, pp. 102-109; L. castelfranchI vegas, Il Libro d’Ore Bod-mer di Michelino da Besozzo e i rapporti tra miniatura fran-cese e miniatura lombarda agli inizi del Quattrocento, in Etudes d’art français offertes à Charles Sterling, Paris 1975, pp. 91-103; C.T. eIsler, p. corBett, Das Gebetbuch des Michelino da Besozzo, München 1981 (fac-simile); L. co-glIatI arano, Libro d’Ore, in Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento (cat. della mostra, Milano, Palazzo Reale, 1988), a cura di M. Boskovits, Milano 1988, pp. 96-99; K. mcdonald, Et Verbum Caro factum est: the Prayer-Book of Michelino da Besozzo, in Medieval Texts anf Images. Stu-dies of Manuscripts from the Middle Ages, edited by M. Manion and B.J. Muir, Sidney 1991, pp. 201-206; sutton, Giangaleazzo Visconti as Patron, p. 94; f. manzarI, Tipolo-gie di strumenti devozionali nella Lombardia del Trecento. I libri d’ore lombardi e l’Offiziolo Visconti, in Il Libro d’Ore Visconti. Commentario al codice, a cura di M. Bollati, Mo-dena 2003, pp. 51-217; M. BollatI, Michelino da Besozzo. Epistole e altre opere di San Gerolamo, in Gentile da Fa-briano e l’altro Rinascimento (cat. della mostra, Fabriano, Spedale di Santa Maria del Buon Gesù, 21 aprile - 23 lu-glio 2006), a cura di L. Laureati e L. Mochi Onori, Milano 2006, p. 172. 45 Il Libro di Preghiere appartenuto a Gian Galeazzo Vi-sconti misura cm 15 x cm 11,2 mentre il Bodmer misura cm 17 x cm 12 (sutton, Giangaleazzo Visconti as Patron, pp. 92-95).46 Annali della Fabbrica, Appendici, I, p. 319, doc. del 31 agosto 1418. A chiarire la datazione del Libro di Preghie-re di New York credo siano esemplari anche alcuni casi decorativi parietali, quali le cornici floreali a gigli bianchi ombreggiati di blu adottate da Franceschino Zavattari, seguace milanese di Michelino, per ornare l’Annunciazio-ne anticamente dipinta sull’arcone trasverso della navata centrale del duomo di Monza (1420-1422 ca), dettagli che non a caso avevano ispirato alla stessa Liana Castelfranchi un’attribuzione a Michelino da Besozzo e una datazione che poteva coincidere col rientro documentato del maestro nel cantiere del duomo di Milano, entro il 1418 ca (per le vicende monzesi, e bibliografia in merito, rinvio da ultimo a R. delmoro, «Assai annose pitture co’risalti di stucchi indorati». L’Annunciazione dell’arco traverso del Duomo di Monza: un contributo agli Zavattari, «Arte Lombarda», CLXIV-CLXV (2012), 1-2, pp. 99-124). 47 «Filippus M. etc. Cum Magister Iohannes de Porcellis docens scribere in hac nostra Civitate Mediolani pro nobis et uso nostro scripserit et nobis gratis et liberaliter dederit librum unum orationum et devotionum nostrarum figuris et iminiaturis solemniter decoratum; ipsumque pro scripto-re nostro in facto dicti libri quam deinceps in aliis operibus nostris adhibenda cura et labore nostre liberalitatis et gra-tie munere premiare, tenore presentium dictum magistrum Iohannem et universa bona sua immunem facimus et exemp-tum, ac immunia pariter et exempta et a quibuslibet taleis taxis (…) Datiis, pedagiis, gabellis et imbotaturis nostris du-
mtaxtat exceptis (…) in quorum etc. Dat. Mediolani die XVI Iunii MCCCCXVIIII duodecma indicione», G. P. BognettI, Per la storia dello Stato visconteo. Un registro di Decreti, del-la cancelleria di Filippo Maria Visconti, e un trattato segre-to con Alfonso d’Aragona, «Archivio Storico Lombardo», LIV (1927), pp. 237-357: doc. 180, pp. 322-323. Giovan-ni Porcelli, figlio di Alberto Porcelli (scriba e fornitore di libri per i Visconti e in rapporti con l’agente del duomo di Milano, Giovanni Alcherio), possedeva una scuola di scrittura a Milano, proseguita dal figlio di lui Albertolo. I suoi rapporti con Michelino da Besozzo sono documentati negli Annali della Fabbrica del Duomo, allorquando, il 27 agosto del 1421, Maffiolo della Rama da Cremona venne saldato di 334 lire imperiali e 8 soldi per la realizzazione di 22 quadretti di vetrate per le finestre absidali, stimate 15 lire e 4 soldi a campo dai periti: frate Giovanni de Cidriano dell’ordine dei Predicatori, frate Tommaso dell’ordine de-gli Umiliati di Brera, maestro Giovanni Porcelli e maestro Michelino da Besozzo pittore (Annali della Fabbrica del Duomo di Milano, Appendici, II, Milano 1885, p. 4). 48 La Schilling non vedeva il capolettera e la ruota della fortuna come opere di Michelino da Besozzo. La prima at-tribuzione (forse suggerita inizialmente da un’osservazione dello stesso Toesca), poi generalmente accolta dalla critica si deve a Liana Castelfranchi (castelfranchI, La formazio-ne e gli esordi, pp. 121, 123; rinvio in proposito anche a lollInI, Michelino da Besozzo e bottega, pp. 101-102; Bol-latI, Michelino da Besozzo, p. 172).49 Presentai questo dettaglio per la prima volta al Convegno Internazionale di Storia della Miniatura di Arcavacata di Rende (16 maggio 2006); prestai in seguito questa foto al prof. Marco Rossi, che l’ha mostrata in occasione del con-vegno di Losanna L’artista girovago, maggio 2011, pubbli-cata dallo stesso in M. rossI, Giusto a Milano e altre presen-ze non lombarde nella formazione di Giovannino de Grassi, in L’artista girovago. Forestieri, avventurieri, emigranti e missionari nell’arte del Trecento in Italia del Nord, «Atti del Convegno di Studi, Université de Losanne, maggio 2011», a cura di S. Romano e D. Cerutti, Roma 2012, pp. 307-333: 333, fig. 16. 50 Questo manoscritto, appartenuto al notaio Léon Gautier di Vaison e donato alla biblioteca nel 1842, fu restituito per la prima volta alla mano di Michelino da Otto Pächt nel 1950; per le vicende critiche rinvio particolarmente a: pächt, Early Italian Nature Studies, pp. 31-44; schIllIng, Ein Gebetbuch, pp. 65-80; cIprIanI, Libro d’Ore, in Arte Lombarda, pp. 54-55; castelfranchI vegas, Il Libro d’O-re Bodmer, p. 95; coglIatI arano, Libro d’Ore, in Arte in Lombardia, pp. 96-99; algerI, Il De Consolatione Philo-sophiae, pp. 332-333; E. moench, Livre d’Heures, in Les Manuscrits à peinture de la Bibliothèque Municipale d’Avi-gnon. XIème – XVIème siècles, Avignon 2000, pp. 63-66; manzarI, Tipologie di strumenti, pp. 129-131. 51 La preghiera è introdotta dall’iscrizione «Oremus pro ministro nostro et abbatissa nostra (…)». Nel manoscritto sono introdotte alcune preghiere scritte in caratteri corsi-vi, tra cui il Salve Regina, ai ff. 25r e 28r; nelle preghiere alla Vergine si incontra aggiunta ripetutamente in caratteri corsivi la parola «domina» (vedi in particolare f. 131r). A f. 18r si legge sotto un’iscrizione a caratteri corsivi credo cin-quecenteschi la firma «Andree de Guilhiormide», ripetuta anche in basso e su un foglio successivo, a inchiostro bru-no, il nome di un possibile antico proprietario del codice. 52 Lo stemma di destra, inquartato nel primo e nel quarto fasciato di sei pezzi d’oro e di nero, nel secondo e nel terzo di rosso a una stella a otto raggi d’oro, potrebbe forse fi-gurare lo stemma dei de Gay o dei Martinengo, inquartato con lo stemma dei Gonzaga o dei Golzati o dei da Zeva (faccio notare che anche lo stemma di Baldo degli Ubal-di appariva così). Secondo la Castelfranchi vi si individua
260
RobeRta DelmoRo
lo stemma della famiglia Guidobono Cavalchini (castel-franchI, La fermezza e gli esordi, p. 126, n. 10). Lo stemma di sinistra si presenta invece d’oro e di rosso alla croce di sant’Andrea d’argento, accantonata da quattro botti ritte: in capo e in punta rosse e ai lati d’oro cerchiate di nero.53 Parimenti al sant’Agostino in cattedra del Commento della Vaticana, opera verosimilmente coeva, come si evin-ce dalla disposizione compositiva della scena, dall’uso dei colori delicatamente cangianti, dalla resa fluida e sciolta dei volumi delle figure e dei panneggi, dettagli che si abbinano ad uno sfondo di colore saturo, qui verde scuro, complica-to con decorazioni d’oro à ramages di gusto squisitamente francese. 54 Durrieu cita ad esempio gli affreschi della cripta della chiesa di Saint-Bonnet-le-Château, in antico nel Bour-bonnais, e l’Incoronazione della Vergine scolpita sopra il portale d’ingresso del castello di La Ferté-Milon, per Luigi d’Orléans, genero di Gian Galeazzo, entro il 1407 [29]. Lo studioso osserva inoltre l’affinità compositiva (naturalmen-te non stilistica) che lega il frontespizio dell’Elogio Funebre all’Incoronazione della Vergine miniata dai fratelli Lim-bourg nelle Très Riches Heures del duca di Berry (Chantilly,
Musée Condé, ms. 65, f. 60v), così come al frontespizio di una Legende dorée (Parigi, Bibliothèque nationale de Fran-ce, français 242, il cui testo scritto è datato 1402) miniata da un artista ugualmente settentrionale, verosimilmente un Néerlandais, il cosiddetto, poi, Maestro dell’Incoronazio-ne, intorno al 1402-1403 (durrIeu, Michelino da Besozzo, pp. 22-23; M. meIss, French Painting in the Time of Jean de Berry. The Boucicaut Master, London 1968, pp. 63-64; F. avrIl, L’afflux des enlumineurs étrangers vers 1400, in Paris 1400, pp. 262-263, fig. 75). La stessa composizione iconografica, circolata in Italia nel corso del Quattrocento, si ritrova d’altra parte nell’Incoronazione della Vergine di Beato Angelico al Louvre, proveniente dalla chiesa conven-tuale di S. Domenico di Fiesole.55 «(…) in capite eius corona stellarum duodecim, que sunt duodecim virtutes» (Parigi, Bibliothèque nationale de Fran-ce, latin 5888, f. 1r). Le Virtù, corrispondenti a tre stel-le per ogni raggio della corona, sono: Fede, Speranza e Carità, disposte sul raggio frontale, Giustizia, Fortezza e Temperanza sul raggio destro, Prudenza, Pietà e Clemenza sul raggio sinistro e Magnificenza, Intelligenza e Umiltà sul raggio posteriore.
french Interferences In the productIon of luxury manuscrIpts at pavIa at the end of the fourteenth century and some contrIButIons
on the early style of mIchelIno da Besozzo
Roberta Delmoro
The particular political and cultural climate that emerged in Pavia after 1360-1361, with the establishing of the Visconti court, the building of the Castello and the founding of the Studium, stimulated an intense production of luxury co-dices characterized, in a number of cases, by deliberate compositional and decorative affi-nities with French – and especially Parisian – illuminated manuscripts of the second half of the fourteenth century. The scriptorium in Pa-
via best known to scholars, thanks to a corpus of manuscripts which can be attributed to it, is that of the Augustinian monastery of S. Pietro in Ciel d’Oro. Here, cooperating with the scrip-torium, probably at the time he was working on the commissioned decoration of the second cloister of the monastery, the young Michelino da Besozzo had the opportunity of learning the art of illumination. This article attempts to defi-ne the characteristics of the painter’s early style.




































![Lo sguardo malinconico sullo spazio-evento: elegia del paesaggio dipinto [su Biamonti e Morlotti]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633172dd576b626f850cf17a/lo-sguardo-malinconico-sullo-spazio-evento-elegia-del-paesaggio-dipinto-su-biamonti.jpg)