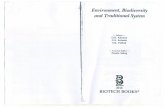Carboni G, Anzidei A.P. 2013 - L'eneolitico recente e finale nel Lazio centro-meridionale: una...
-
Upload
wwwuniroma1 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Carboni G, Anzidei A.P. 2013 - L'eneolitico recente e finale nel Lazio centro-meridionale: una...
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
a cura diDaniela Cocchi Genick
CRONOLOGIA ASSOLUTA E RELATIVA DELL’ETÀ DEL RAME IN ITALIA
Atti dell’Incontro di StudiUniversità di Verona, 25 giugno 2013
PREISTORIA E PROTOSTORIA
Volume primo
PREISTORIA E PROTOSTORIA
DIRETTORE
Daniela Cocchi Genick
COmITATO SCIEnTIfICO
Diego Angelucci, Alessandra Aspes, Paolo Bellintani, Maria Bernabò Brea, Paola Cassola Guida, Maurizio Cattani, Angiolo Del Lucchese, Raffaele C. de Marinis, Filippo M. Gambari, Stefano Grimaldi, Alessandro Guidi, Giovanni Leonardi, Roberto Maggi, Franco Marzatico, Emanuela Montagnari, Fabio Negrino, Nuccia Negroni Catacchio, Franco Nicolis, Annaluisa Pedrotti, Marco Peresani, Andrea Pessina, Luciano Salzani, Elisabetta Starnini, Giuliana Steffè, Maurizio Tosi, Marica Venturino
Copyright© by QuiEdit s.n.c.Via S. Francesco, 7 – 37129 Verona, Italywww.quiedit.ite-mail: [email protected] I – Anno 2013ISBN: 978-88-6464-248-2Finito di stampare nel mese di dicembre 2013
La riproduzione per uso personale, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, è con-sentita esclusivamente nei limiti del 15%.
91
GIOvAnnI CARbOnI(1) - AnnA PAOlA AnzIDEI(2)
L’Eneolitico recente e finale nel Lazio centro-meridionale: una puntualizzazione sullo sviluppo e la durata di alcuni aspetti
culturali sulla base delle più recenti datazioni radiometriche
RIASSunTO
Viene presentato un quadro cronologico relativo alle facies di Laterza e di Ortucchio del Lazio centro-meridionale basato su datazioni radiometriche di campioni organici di vita breve. La facies di Laterza è documentata in questo territorio fin dalla sua fase più antica. In un momen-to evoluto di tale aspetto, a seguito di contatti con genti portatrici della cultura del Bicchiere Campaniforme, si assiste ad un sostanziale cambiamento nella produzione ceramica che darà origine alla facies di Ortucchio. I caratteri della cultura materiale, uniti alle datazioni radiocar-boniche, hanno permesso di suddividere quest’ultimo aspetto in quattro fasi senza nette cesu-re tra l’una e l’altra, che si collocano tutte all’interno del III millennio a.C. Dall’analisi dei dati si giunge alla conclusione che la facies di Ortucchio presenta i suoi caratteri formativi nell’area laziale e la cultura materiale così come identificata nel Fucino risulta appartenere ad un mo-mento avanzato della facies stessa. In base ai dati esposti si propone pertanto di definire come “facies della ceramica a pettine trascinato” quella che fino ad oggi è stata identificata come “facies di Ortucchio”.
AbSTRACT
This research presents the chronological framework of the Laterza and Ortucchio facies in South-Central Latium based on radiometric dates on short-lived organic samples. The Later-za facies is documented in this territory since its earliest phase. In a later moment, after con-tacts with people belonging to the Bell Beaker culture, there is a significant change in the ce-ramic production originating the Ortucchio facies. The features of the material culture, togeth-er with the radiocarbon dates, allowed to divide this latter facies in four phases, all within the 3rd millennium BC, without clear interruptions between them. From the analysis of the data it is possible to conclude that the Ortucchio facies presents its formative features in the Latium area and the material culture identified in the Fucino belongs to an advanced phase of this same facies. On the basis of the above mentioned information we therefore propose to define as “dragged comb ware facies” the one that so far has been identified as “Ortucchio facies”.
Parole chiave: Eneolitico, Laterza, Ortucchio, Campaniforme, pettine trascinato. Keywords: Eneolithic, Laterza, Ortucchio, Bell Beaker, dragged comb.
Viene presentata in questa sede un’anticipazione dei dati relativi ad un arco cro-nologico compreso tra la metà e la fine del III millennio a.C. riferibili alle facies di La-terza e Ortucchio, identificate nel territorio di Roma ed in alcune aree confinanti a seguito di indagini archeologiche effettuate negli ultimi decenni. È infatti in corso di
(1) Dipartimento Scienze dell’Antichità - Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma; tel. 06/49913924; e-mail: [email protected](2) Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Piazza delle Finanze 1, 00185 Roma; tel. 06/47788327; e-mail: [email protected]
92
preparazione una pubblicazione definitiva di carattere interdisciplinare atta a rico-struire lo sviluppo delle comunità neo-eneolitiche che si sono avvicendate nell’area romana tra il VI e il III millennio a.C.
Il quadro cronologico ricostruito in base alle datazioni radiometriche già note è stato integrato con nuove datazioni effettuate per gli insediamenti di Osteria del Cu-rato-Via Cinquefrondi, Torre della Chiesaccia 1-abitato, Valle dei Morti e Casetta Mi-stici, che inquadrano la presenza di un aspetto antico di Laterza in un periodo com-preso tra il 2820 e il 2620 a.C. (tab. I) e di un aspetto Ortucchio che si sviluppa tra il 2670 e il 2130 a. C. (tab. II, fig. 6). Tutte le datazioni sono state effettuate su taxa ar-borei di vita breve (cariossidi, ossa umane e animali) e riportate nel testo con la cali-brazione ad 1σ.
Nella carta di distribuzione dei siti Laterza compresi tra Roma e la valle del Sacco (fig. 1) questi appaiono concentrati per la quasi totalità nella parte S-SE del suburbio romano. L’aspetto di Laterza è presente sin dalle sue fasi più antiche a Piscina di Tor-re Spaccata (Bietti Sestieri e Gianni 1984, 1988; Carboni e Ragni 1984) la cui datazio-ne è compresa tra il 2820-2620 a.C. (Anzidei et alii 2007) (fig. 2), a Osteria del Cura-to-Via Cinquefrondi datata tra il 2780-2620 a.C. (Anzidei et alii 2007) (fig. 3) e a Ca-setta Mistici datata tra il 2760-2620 a.C. (fig. 4). Gli aspetti ceramici che caratterizzano questo periodo trovano stretti confronti, sia per quanto riguarda le forme che la de-corazione, con i complessi più antichi documentati in Puglia nei tagli basali della tom-ba 3 del sito eponimo (Biancofiore 1967; Cocchi Genick 2007), nelle tombe di Luce-ra, loc. Vaccherella (tomba H2, 4114±45 BP cal. 1σ a 2700-2580 a.C. e tomba H1, 4044±45 BP cal. 1σ a 2630-2480 a.C.) (Tunzi Sisto e Monaco 2010, 2011), e sul ver-sante tirrenico in Campania, nelle tombe 1 e 5 della necropoli presso il tempio di Ce-rere a Paestum (Albore Livadie et alii 2011), a Pontecagnano (D’Agostino 1964) e nel-le capanne 1 e 3 dall’abitato di Carinaro, Polo Calzaturiero (La Forgia et alii 2007).
Tab. I - Date radiocarboniche relative alla fase antica di Laterza del territorio di Roma.
LOCALITÀ CAMPIONE N.Lab. DATA BP CAL. 1σ CAL. 2σ
Piscina di Torre Spaccataarea 43, elem. 13
cariosside di Triticum dicoccum Schübl.
LTL992A 4192±45 2820-2740 2900-2620
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - tomba 1 osso umano LTL968A 4141±60 2780-2620 2890-2570
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - tomba 19 osso umano LTL977A 4139±70 2780-2620 2900-2560
Casetta Mistici - US 212 (fossa) tibia dx di Bos sp. LTL3478A 4135±35 2760-2620 2880-2580Piscina di Torre Spaccatatomba 2 osso umano LTL994A 4130±40 2760-2620 2880-2580
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - base US 4 osso umano LTL1410A 4129±45 2760-2620 2880-2570
Torre della Chiesaccia 2necropoli - tomba 4, ind. B osso umano LTL3486A 4129±45 2760-2620 2880-2570
Atmosferic data from Reimer et alii (2004); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r.5 sd:12 prob usp [chron]
93
Fig. 1 - Distribuzione dei siti di facies Laterza nel Lazio centrale: 1. Maccarese, sito H; 2. Torrino; 3. Casale Massima; 4. Torre della Chiesaccia 2-necropoli; 5. Fosso della Mola; 6. Piscina di Torre Spaccata; 7. Osteria del Curato-Stazione Anagnina; 8. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi; 9. Unità Anagnina; 10. Casetta Mistici; 11. Pantano Borghese; 12. Fosso Mole di Corcolle-Via di Poli km 24,500; 13. Selva dei Muli.
Nella fase di passaggio tra gli aspetti Laterza e Ortucchio si assiste ad un lento cambiamento nelle produzioni artigianali senza evidenti trasformazioni nell’econo-mia e nelle strategie di insediamento da un lato e nelle tradizioni funerarie dall’altro. Accanto ad una continuità di occupazione dei precedenti insediamenti si ha un incre-mento di piccoli siti nelle aree limitrofe e nella zona sub-costiera (fig. 5).
Nel sito di Ortucchio, localizzato nella conca del Fucino e che ha dato nome al-l’omonima facies (Radmilli 1977; Cremonesi 1985; Radi 1988), è presente un solo mo-mento riferibile ad una fase evoluta di tale aspetto, di cui manca pertanto un legame diretto con manifestazioni precedenti e la cui unica datazione C14 disponibile (Fi-32 - 4070±180 BP cal. 1σ 2900-2300 a.C.) (Skeates 1994) presenta un margine di errore troppo ampio che non permette di cogliere la sua precisa collocazione cronologica. Le numerose scoperte effettuate nel territorio di Roma permettono quindi di chiarire quali siano state le articolazioni interne di questo aspetto culturale, da quella formati-va a quella finale.
Per comprendere l’evoluzione delle produzioni artigianali di questa facies si è tenu-to conto delle fasce cronologiche fornite dalle numerose datazioni radiocarboniche. Ne è derivata una suddivisione di comodo in quattro fasi (fig. 6) che ci ha permesso di valutare l’evoluzione degli stili ceramici. La presenza di una certa fluidità nel pas-saggio tra le fasi, con una sovrapposizione nei momenti di passaggio, evidenzia la compattezza di questo aspetto culturale nell’arco del suo intero sviluppo.
94
Fig. 2 - Materiali di facies Laterza dal sito di Piscina di Torre Spaccata (Roma) (da Bietti Sestieri e Gianni 1984; Carboni e Ragni 1984) (scala in cm).
Sia nella sua fase formativa che in quelle successive deve avere avuto un ruolo im-portante il contatto con genti portatrici del Bicchiere Campaniforme che hanno me-diato e introdotto nuovi modelli e nuove tecnologie nell’ambito della produzione ce-ramica, inserendosi in un ambiente artigianale caratterizzato dagli aspetti evoluti della locale facies di Laterza.
95
Fig. 3 - Materiali di facies Laterza dal sito di Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Roma) (disegni di G. Carboni) (scala in cm).
96
Fig. 4 - Materiali di facies Laterza dal sito di Casetta Mistici (Roma) (disegni di G. Carboni) (scala in cm).
Per quanto riguarda il territorio laziale una certa confusione è stata fatta per una definizione di facies con materiali decorati ad imitazione dei prodotti campaniformi, in quanto ceramiche con decori a bande tratteggiate, a volte rinvenute in pochi o sin-goli frammenti, sono state riferite ad un momento evoluto del Campaniforme che è stato attribuito al Bronzo antico (BA I) (Guidi 1979; Di Gennaro e Pacciarelli 1996;
97
Fig. 5 - Distribuzione dei siti di facies Ortucchio nel Lazio centrale: 1. Caolino di S. Severa; 2. Vaccina; 3. Ceri; 4. Palidoro; 5. Roma-S. Omobono; 6. Roma-Via Sacra; 7. Casale Massima; 8. Tor Pagnotta; 9. Torre della Chiesaccia 2-abitato; 10. Torre della Chiesaccia 1-abitato; 11. Tenuta della Selcetta 1; 12. Trigoria-Via R. de Zerbi; 13. Via di Porta Medaglia-cava di tufo; 14. Quarto delle Tortorelle; 15. Fosso del Diavolo; 16. Colle degli Impiccati; 17. Tenuta Quadraro-via Lucrezia Romana; 18. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi; 19. Gregna S. Andrea; 20. Osteria del Curato-Via Polistena; 21. Osteria del Curato-stazione Anagnina; 22. Piscina di Torre Spaccata-Fosso del Pratone; 23. Quadrato di Torre Spaccata; 24. Casale di Torre Spaccata; 25. Tenuta di Torre Nova; 26. Vermicino, Via di Vigne S. Matteo; 27. Casetta Mistici; 28. Casale Benzone; 29. Casale del Cavaliere; 30. Tavernucole; 31. Fosso del Cupo; 32. Grotta Polesini; 33. Porta Neola; 34. Valle dei Morti; 35. Selciatella; 36. Grotta Vittorio Vecchi.
Iaia et alii 2005; Angle e Guidi 2007). Purtroppo tutti gli elementi utilizzati per questa scansione crono-tipologica provengono da situazioni dubbie e principalmente da rin-venimenti di superficie dove mancano del tutto associazioni certe, in particolar modo con prodotti campaniformi “originali”, e datazioni radiocarboniche affidabili. Ora molti siti riferibili alla facies di Ortucchio, indagati estensivamente nel territorio di Roma, dispongono di datazioni radiocarboniche attendibili e di associazioni sicure di materiali sia campaniformi “originali” che di imitazione, riferibili principalmente alle prime due fasi della nostra scansione cronologica. Per questi prodotti si propone di utilizzare il termine “pseudo-campaniforme” in quanto appartengono a momenti antichi dello sviluppo della facies di Ortucchio e contemporanei al Campaniforme classico.
Appare chiara la differenza tra le ceramiche campaniformi “originali” (fig. 7) e quelle prodotte localmente (fig. 8). Le prime presentano superfici di colore rosso- arancio mentre quelle locali hanno sempre superfici di colore variante dal bruno- nerastro al nero.
Anche le forme dei vasi sono differenziate; i caratteri delle ceramiche campanifor-mi sono sempre ben codificati mentre i prodotti locali hanno una tipologia che non trova un collegamento diretto con il Campaniforme. L’unico elemento che le acco-
98
Fig. 6 - Plot delle datazioni della facies di Ortucchio suddivisa per fasi.
muna è la banda campita da tratti obliqui a pettine impresso, ma con schemi decora-tivi diversificati (fig. 8).
In alcuni siti attribuibili alle singole fasi sono stati recuperati, associati a ceramiche della facies di Ortucchio, frammenti di vasi campaniformi “originali” con la tipica su-perficie rosso-arancio così come si rinvengono nelle aree di maggiore diffusione del bicchiere campaniforme. Nel sito di Quadrato di Torre Spaccata, datato alla fase più antica (Fase I), sono stati identificati frammenti di tre vasi: due riferibili al Campani-forme interamente cordato (AOC) (fig. 7.2,3) ed uno allo stile “internazionale” (fig. 7.1). Questi frammenti pur provenienti dall’area sbancata dell’insediamento, limitata a pochi mq, sono inquadrabili cronologicamente per la presenza nel sito di un unico livello eneolitico riferibile alla fase iniziale della facies di Ortucchio (Anzidei e Carboni 1995, 2007). Dall’abitato di Torre della Chiesaccia 1, ascrivibile alla Fase II, proven-gono frammenti di due vasi, un bicchiere (fig. 7.4) e una ciotola carenata (fig. 7.5), de-corati nello stile da noi definito di “Torre Crognola” (Pennacchioni 1977, 1979) e che
99
fa parte di uno stile caratteristico che si ritrova sia in Sardegna nella tomba 9 di Locci Santus (CA) (Ferrarese Ceruti 1985, motivo 88 e fig. C20, C23, C25 a destra; Atzeni 1996, fig. 4.1-4) che nel Sud della Francia.
Per quanto riguarda la Francia questo stile appartiene alla fase 2 (orizzonte di tran-sizione dello sviluppo del Campaniforme locale); è datato nel sito di La Balance pres-so Avignone tra il 2870-2490 a.C. (4100±120 BP) (Guilaine et alii 2001, pp. 233-234, fig. 2) e trova una corrispondenza diretta con la datazione della nostra fase II.
Mentre nei siti riferibili alla fase III non sono documentati materiali campanifor-mi “originali” (fig. 7), nell’abitato di Casetta Mistici attribuibile alla fase IV sono stati raccolti due frammenti, uno di scodella emisferica (cuenco) (fig. 7.6) ed uno di bicchie-re (fig. 7.7), decorati con tecniche differenziate. Mentre il primo frammento rientra in quelle forme classiche facenti parte del set campaniforme (Strahm 1998), il secondo, riferibile ad un collo di bicchiere, presenta una decorazione a risparmio a pasticche
Tab. II - Date radiocarboniche relative alla facies di Ortucchio del Lazio centro-settentrionale e della conca del Fucino.
LOCALITÀ CAMPIONE N.Lab. DATA BP CAL. 1σ CAL. 2σCasale del Cavaliere (Roma) carbone di ? GrA-7112 4160±70 2820-2660 2900-2570Villaggio di Ortucchio (AQ) ? Fi-32 4070±180 2900-2300 3100-2000Quadrato di Torre Spaccata (Roma) sett. C, capanna 1 carbone di Buxus sp. OxA-9827 4070±40 2670-2560 2700-2480
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - US 895 carbone di Alnus sp. LTL989A 4055±35 2630-2550 2680-2460
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - tomba 27 osso umano LTL980A 4030±65 2640-2460 2900-2300
Torre della Chiesaccia-abitatoUS 32, tgl. VI
carbone di Prunus sp. LTL3593A 4011±50 2580-2470 2680-2400
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - US 221 carbone di Phillyrea sp. LTL1412A 4000±45 2580-2470 2640-2430
Torre della Chiesaccia-abitato - US 32, tgl. VI carbone di Ulmus sp. LTL3592A 3996±40 2570-2515 2630-2450
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - US 2362
cariosside di Triticum dicoccum Schübl. LTL987A 3992±40 2570-2515 2630-2450
Torre della Chiesacciaabitato US 41
carbone di Quercus sp. (anello esterno) LTL3591A 3989±40 2570-2515 2620-2430
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - tomba 5 osso umano LTL972A 3989±55 2580-2450 2700-2300
Valle dei Morti spatola in osso di Bos sp. LTL4814A 3938±45 2490-2340 2500-2290
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - US 215
cotiledone di Vicia faba L. LTL990A 3935±60 2500-2330 2580-2270
Osteria del CuratoVia Cinquefrondi - tomba 25 osso umano LTL979A 3930±65 2490-2290 2580-2200
Casetta Mistici - (q. BH 36) calcagno di Bos sp. LTL3492A 3803±60 2350-2130 2470-2120Luni-Tre Erici (VT) - str. 8 carbone di ? ? 3800±80 2350-2130 2470-2020Fontanile di Raim (VT) - tomba 2 osso umano LTL4196A 3799±35 2290-2190 2350-2130
Casetta Mistici - US 1021 carbone di Buxus sempervirens sp. LTL4812A 3770±50 2290-2130 2350-2030
Casetta Mistici - US 30 astragalo di Bos sp. LTL3476A 3766±35 2210-2131 2300-2120Atmosferic data from Reimer et alii (2004); OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r.5 sd:12 prob usp [chron]
100
ovali ravvicinate e file di lievi nervature con impressioni ottenute con l’ausilio di vari punzoni. Decorazioni simili si ritrovano solo in contesti tardo-campaniformi del cen-tro-Europa ed in particolare su alcuni bicchieri definiti “pot beaker” del sito di Older-boorn in Olanda (Fokkens 1998; Butter e Fokkens 2005).
Alla medesima fase possono essere assimilati due bicchieri campaniformi: il pri-mo, proveniente dalla tomba 2 di Fontanile di Raim (VT) (Petitti et alii 2002, fig. 2. 1) (fig. 9.1), ha una datazione radiometrica (2290-2190 a.C.) che rientra nella nostra fase IV; il secondo, rinvenuto in località Serpentana presso il villaggio di Ortucchio (An-
Fig. 7 - Tipologia e stili delle ceramiche campaniformi “originali” provenienti dal territorio di Roma rinvenute associate a materiali della facies di Ortucchio inserite all’interno delle singole fasi cronologiche: 1-3. Quadraro di Torre Spaccata (Roma); 4-5. Torre della Chiesaccia 1 (Roma); 6-7. Casetta Mistici (Roma) (disegni di G. Carboni).
101
geli et alii 2011a, tav. 1; 2011b) (fig. 9.2), non è datato ma è identico per forma e de-corazione a quello di Fontanile di Raim.
Fig. 8 - Tipologia e stili delle ceramiche “pseudo-campaniformi” provenienti dal territorio di Roma rinvenute associate a materiali campaniformi “originali” 1. Casale del Cavaliere; 2. Casetta Mistici; 3-5,11,14-15. Tenuta Quadraro-via Lucrezia Romana; 6-7. Tenuta della Selcetta 1; 8. Casale Massima; 9-10. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (riempimento cella della tomba 11); 12-13. Torre della Chiesaccia 1-abitato (disegni di G. Carboni).
102
Fig. 9 - 1. bicchiere campaniforme dalla tomba 2 di Fontanile di Raim (VT); 2. bicchiere campaniforme da loc. Serpentana presso Rio di Lecce (AQ) (disegni rielaborati da G. Carboni: 1. da Petitti et alii 2002; 2. da Angeli et alii 2011a) (scale in cm).
La facies di Laterza è attestata nel territorio di Roma ed in altri complessi sia abita-tivi che funerari distribuiti nel territorio laziale fin dalla sua fase più antica. Alcuni di questi insediamenti, come Piscina di Torre Spaccata (Bietti Sestieri e Gianni 1984, 1988) e Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Anzidei et alii 2007), continuano ad es-sere frequentati anche in un momento evoluto della facies mentre l’occupazione di al-tri siti come Quadrato di Torre Spaccata (Anzidei e Carboni 1995, 2007) inizia solo a partire da questo periodo. Proprio in questi due ultimi insediamenti (Osteria del Cu-rato-Via Cinquefrondi e Quadrato di Torre Spaccata) si coglie lo sviluppo e la trasfor-mazione delle produzioni ceramiche. Accanto ad alcuni elementi legati alla preceden-te tradizione Laterza se ne affiancano di nuovi, sia formali che tecnologici, legati a contatti con genti portatrici del Bicchiere Campaniforme che caratterizzeranno la struttura di base della facies di Ortucchio. La durata di questo periodo non sembra es-sere molto estesa nel tempo (ca. 120 anni - 2670-2550 a.C.) (fig. 6) e parte della sua produzione ceramica subisce una rapida trasformazione collegandosi direttamente a quella della successiva fase II.
Per le forme ceramiche di tradizione Laterza si assiste alla scomparsa delle scodel-le con orlo sopraelevato, delle patere con decoro inciso a tratti radiali e non, delle taz-ze con anse a nastro sopraelevato sormontate da bottone e della decorazione all’in-terno dei vasi. Vi è una forte riduzione della ceramica a squame ed una progressiva diminuzione dei boccali-attingitoio fino alla loro scomparsa.
In questo periodo di transizione Laterza/Ortucchio (Fase I) (figg. 10, 11) conti-nuano ad essere presenti alcune forme vascolari della vecchia tradizione Laterza come le ciotole emisferiche, le olle e le ollette ovoidi, in cui vi è una netta prevalenza di decori a motivi geometrici che vengono realizzati con un rudimentale pettine tra-scinato a larghe e rade punte o a pettine con punte strette ed ordinate. Per l’esecuzio-ne di tali motivi decorativi è stato ipotizzato che gli stessi venissero realizzati, come accertato dalle indagini tecnologiche e sperimentali sulla produzione delle ceramiche,
103
con pettini fissi e “mobili”, mediante l’incisione con più asticelle in legno o in osso ad estremità acuminate legate insieme o tenute strette in una mano. Nell’esecuzione del tratto queste ultime non formano linee parallele omogenee ma spesso si sovrappon-gono o sono divergenti. Continua ad essere utilizzata la tecnica dell’incisione e dei punti impressi, limitata a pochi tipi di ornato.
In genere in questa fase nei decori dei vasi vi è una prevalenza di motivi longitu-dinali, angolari, a zig-zag, a bande contrapposte ad “X” o a losanghe, delimitati nella parte superiore, poco al disotto dell’orlo, da una banda a pettine trascinato o da una o due linee ad incisione o a solcatura (fig. 10.1,15).
La fase II è quella più attestata in tutto il territorio laziale; la si ritrova diffusa in molti siti dell’area romana e dell’Etruria meridionale ed è datata tra il 2580 e il 2470 a.C. (fig. 6).
Il sito di Casale del Cavaliere (Boccuccia et alii 2000), il primo ad essere stato indi-viduato nel territorio romano, presenta una datazione troppo alta, dovuta molto pro-babilmente all’effetto old wood del campione utilizzato e non determinato a livello spe-cifico (GrA-7112 - 4160±70 BP, cal. 1σ 2780-2654 a.C.), in rapporto allo stile della produzione ceramica che si inserisce nell’ambito della fase II.
Nella medesima fase rientra pienamente l’abitato di Torre della Chiesaccia 1, che, oltre ad aver restituito frammenti di due vasi campaniformi nello stile “Torre Crognola” associati a materiali decorati a pettine trascinato ed impresso tipico della produzione artigianale di Ortucchio, ha fornito tre date radiocarboniche ottenute su taxa arborei di vita breve che risultano essere tutte uguali (LTL3593A - 4011±50 BP, cal. 1σ 2580-2470 a.C.; LTL3592A - 3996±40 BP, cal. 1σ 2570-2515 a.C.; LTL3591A - 3989±40 BP, cal. 1σ 2570-2515 a.C.). Datazioni identiche si hanno per i livelli riferibili alla me-desima fase di Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (LTL1412A - 4000±45 BP, cal. 1σ 2580-2470 a.C.; LTL987A - 3992±40 BP, cal. 1σ 2570-2515 a.C.; LTL972A - 3989±55 BP, cal. 1σ 2580-2450 a.C.).
Continuano ad essere presenti alcuni elementi decorativi che richiamano la fase precedente. A questi si aggiungono motivi a pettine trascinato con ornati di tipo me-topale (Torre della Chiesaccia 1, fig. 12.8), Palidoro (Del Fattore 2007) e Trigoria-Via R. de Zerbi, fig. 12.6) e fasci orizzontali da cui pendono stretti triangoli (Torre della Chiesaccia 1, fig. 12.12). Lo stesso motivo realizzato a bande tratteggiate proviene da via Lucrezia Romana (fig. 12.14) e non mancano altri esempi dall’Etruria Meridiona-le. La ceramica a squame è quasi completamente assente e, dove rinvenuta, si limita ad uno o due frammenti (fig. 13.8). Uno degli elementi che caratterizza questa fase è la frequente presenza di una risega alla sommità della spalla di tazze, orcioli ed ollette (figg. 12.1,9,10,14,19; 13.11) e di orli ispessiti o variamente sagomati (figg. 12.15; 13.10). Ad essa possono essere attribuiti, oltre ai siti sopra citati, quelli di Lucrezia Romana (Iaia et alii 2005) e di Palidoro (Del Fattore 2007), anche se quest’ultimo so-lamente per l’orciolo deposto in prossimità di alcune ossa umane e rinvenuto duran-te gli scavi Chiappella del 1956 (Chiappella 1956, p. 263; 1965, p. 307). Questo manu-fatto al momento degli scavi fu datato erroneamente all’età del Bronzo (“Appennini-co finale”) e successivamente, negli anni ’70, all’età del Ferro (esposizione tempora-nea al Museo Preistorico ed Etnografico L. Pigorini di Roma), non essendo noti a
104
Fig. 10 - Fase I, periodo di transizione Laterza/Ortucchio: 1, 3, 5-10, 12, 14-20. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Roma); 2, 4, 11, 13. Quadrato di Torre Spaccata (Roma) (disegni di G. Carboni) (1:3).
105
Fig. 11 - Fase I, periodo di transizione Laterza/Ortucchio: 1, 2, 4, 5, 8, 9. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Roma); 3, 6, 7. Quadrato di Torre Spaccata (Roma) (disegni di G. Carboni) (1:4).
106
quell’epoca dati relativi alle forme ceramiche e alle decorazioni di questo particolare aspetto dell’Eneolitico finale. A seguito di un recente studio effettuato da F.R. Del Fattore (2007) sui materiali provenienti dai livelli attribuiti da R. Peroni al Bronzo an-tico (Peroni 1965, 1971), questi risultano essere tutti inquadrabili in un momento an-tico dello sviluppo della facies di Ortucchio compresi tra le fasi I e II.
Mentre nell’area romana la fase II è ben attestata e si presenta con caratteristiche consolidate, si assiste ad un espansione verso N di siti riferibili ad Ortucchio. Poco più a S, lungo la Via Casilina, ad una distanza di pochi chilometri dai siti romani, è sta-to recentemente indagato a Pantano Borghese un abitato pluristratificato riferibile alla facies di Laterza (fig. 14) i cui livelli più alti (fase IV della scansione interna del sito) han-no fornito alcune date radiocarboniche, effettuate sia su cariossidi che su ossa umane, che collocano la locale facies di Laterza tra il 2570 e il 2460 a.C. (Angle e Mancini 2010; Angle et alii 2011, 2012 ). Queste date sono praticamente identiche a quelle della fase II di Ortucchio presente nel territorio di Roma (2580-2470 a. C.) (fig. 6).
Dall’analisi della cultura materiale rinvenuta a Pantano Borghese si evidenziano ceramiche che presentano particolarità morfologiche, decorazioni incise e a squame, riferibili ad una fase evoluta di Laterza, che in questo sito mantiene intatta la sua in-tegrità culturale e in cui è completamente assente materiale ascrivibile alla fase II di Ortucchio dell’area romana. Un altro sito che si può collegare a quello di Pantano Borghese potrebbe essere quello di Fosso Mole di Corcolle che ha restituito lo stesso tipo di cultura materiale (Anzidei e Bietti Sestieri 1980).
La presenza di questi due siti mette in risalto la persistenza di comunità di facies Laterza ai margini di un territorio in cui si è già formato e consolidato l’aspetto di Or-tucchio. Sembra quindi intravedersi in quest’area una sorta di confine culturale in cui l’assenza di contatti con gruppi campaniformi non ha permesso di instaurare quel processo di trasformazione che ha coinvolto i gruppi della stessa facies dislocati poco più a N. Il resto del Lazio meridionale sembra infatti conservare aspetti legati sola-mente alla tradizione Laterza.
Con la fase III, che si colloca tra il 2500 e il 2290 a.C. (fig. 6), si coglie quell’aspetto caratteristico della facies così come è stato identificato nel sito eponimo (figg. 15, 16).
Nell’area romana il sito di Valle dei Morti, datato a 2490-2340 a.C. (tab. II), risulta essere un complesso omogeneo i cui materiali sia nelle forme vascolari che nei deco-ri a pettine trascinato ed impresso trovano strette corrispondenze con i materiali del villaggio di Ortucchio (Radmilli 1977; Cremonesi 1985; Radi 1988; Ialongo 2007). Permangono ancora pochi elementi della tradizione Laterza, come alcune sopraele-vazioni sugli orli, mentre le squame sono del tutto assenti. Scompaiono le spalle ca-renate tipiche della fase II mentre continua ad essere presente la larga presa nastrifor-me allungata con estremità insellata che risulta essere uno degli elementi caratteriz-zanti questa facies.
Nel sito di Osteria del Curato-Via Cinquefrondi continuano forme e decorazioni che si ricollegano direttamente alle fasi precedenti da cui si distinguono per l’uso di pettini fissi rispetto ai pettini mobili utilizzati nella prima fase (fig. 15.14,18).
Come si evince dalla carta di distribuzione dei siti (fig. 17), l’area di diffusione del-la facies di Ortucchio occupa le zone costiere e sub-costiere del Lazio centro-setten-
107
Fig. 12 - Fase II della facies di Ortucchio: 1, 2, 8, 10, 12, 17. Torre della Chiesaccia-abitato (Roma); 3, 5, 6. Trigoria-Via R. de Zerbi (Roma); 4, 7, 11, 14, 15. Tenuta Quadraro-Lucrezia Romana (Roma); 9, 16, 19. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Roma); 13, 18. Casale del Cavaliere (Roma) (disegni di G. Carboni) (1:3).
108
Fig. 13 - Fase II della facies di Ortucchio: 1. Casale del Cavaliere (Roma); 2, 5, 6, 9, 10. Torre della Chiesaccia1-abitato (Roma); 3, 4, 7, 11. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Roma); 8. Trigoria-Via R. de Zerbi (Roma) (disegni di G. Carboni) (1:3).
trionale. Solo durante la terza fase si assiste ad un’espansione dei siti verso SE sino ad arrivare all’enclave posta nella conca del Fucino e limitata ad Ortucchio e al territorio circostante; il resto del Fucino sembra esserne escluso.
Con l’ultima fase (Fase IV) questo aspetto, oltre ad essere attestato nell’area di maggiore diffusione lungo il versante tirrenico ed ancora nella conca del Fucino, si espande verso S nella Campania come documentato dai rinvenimenti di Gricigna-
109
Fig. 14 - Carta di distribuzione dei siti di facies Ortucchio divisi per fasi e dei siti coevi alla fase II con elementi di tradizione Laterza (carta elaborata da G. Carboni).
no-US Navy (Salerno e Marino 2011) ed Afragola (Nava et alii 2007). Il resto del La-zio meridionale non sembra essere interessato da queste presenze.
Questa fase, datata tra il 2350 e il 2130 a.C. (fig. 6), coglie il momento finale della facies (fig. 18). Continuano ad essere presenti ceramiche decorate mediante l’uso del pettine trascinato ed impresso combinato insieme, a volte con schemi molto artico-lati. Il sito di Casetta Mistici è il più rappresentativo di questo particolare momento e i decori qui individuati trovano stretti confronti con quelli dell’orciolo della tomba 14, blocco 1 di Gricignano-US Navy (Salerno e Marino 2011, fig. 1.4) (fig. 19A) e di al-cuni manufatti provenienti da Afragola (NA), saggio 8121-8131, rinvenuti associati a materiali tardo Laterza (Nava et alii 2007, fig. 5C ) (fig. 19B).
Questi due siti sono stati sigillati dall’eruzione Flegrea 1 (3820±50 BP, cal. 1σ 2350-2191 a.C.) per Gricignano-US Navy (Fugazzola et alii 2007) e dall’ultima eruzio-ne degli Astroni (III-7) datata tra il 2230-2130 a.C. (R-713α - 3760±50 BP, cal. 1σ 2230-2130 a.C.) (Alessio et alii 1973) per quanto riguarda Afragola. Data l’evidente somiglianza tra i materiali dei due siti e quelli laziali la corrispondenza cronologica dovrebbe essere inclusa all’interno delle oscillazioni standard tra le datazioni radio-carboniche della nostra fase IV e delle eruzioni vulcaniche che hanno sigillato i depo-siti campani.
Come abbiamo illustrato precedentemente, l’aspetto di Ortucchio, documentato nel Lazio centrale, presenta nel tempo una compattezza culturale con piccole diffe-renziazioni tra fase e fase che si colgono soprattutto in alcune forme vascolari e nella
110
Fig. 15 - Fase III della facies di Ortucchio: 1-12, 15-17, 19-23, 25. Valle dei Morti (Roma); 13, 14, 18, 24. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Roma) (disegni di G. Carboni) (1:3).
111
Fig. 16 - Fase III della facies di Ortucchio: 1, 3, 5-9. Valle dei Morti (Roma); 2, 4, 10. Osteria del Curato-Via Cinquefrondi (Roma) (disegni di G. Carboni) (1:3).
112
Fig. 17 - Area di distribuzione della facies di Ortucchio nel Lazio (fasi I-IV), nella conca del Fucino (fase III-IV) e della Campania (fase IV) (carta elaborata da G. Carboni).
loro decorazione. Dalla ricca intelaiatura cronologica ricostruita in base alle numero-se datazioni radiocarboniche effettuate per i siti romani è stato possibile inquadrarlo interamente nell’ambito dell’Eneolitico. Il sito che ha restituito la sequenza cronolo-gica e culturale più completa è quello di Osteria del Curato-Via Cinquefrondi in cui si può cogliere la formazione di quest’aspetto come diretta evoluzione della locale fa-cies di Laterza. Alla fase più antica pienamente Laterza ne segue infatti un’altra in cui i suoi caratteri evoluti sono in commistione con nuovi elementi decorativi mediati dal contatto con genti campaniformi e caratterizzati dall’uso del pettine trascinato e im-presso (fase I di Ortucchio), che si evolverà ulteriormente nelle fasi successive (fasi II e III).
Con l’ultima fase (IV), documentata solo a Casetta Mistici, si conclude questo ci-clo culturale che raggiunge la fine del III millennio a.C. rimanendo nell’ambito della tradizione eneolitica.
Il Bronzo Antico, come documentato nel Lazio, compare solo all’inizio del II mil-lennio a.C.. In particolare a Casetta Mistici al livello riferibile alla più recente facies di Ortucchio segue uno iato temporale documentato da un strato sterile al di sotto di un livello ascrivibile al Bronzo Antico che è stato datato tra il 2030 e il 1870 a.C. (LTL 3482A - 3614±45 BP, cal. 1σ 2030-1910 a.C.; LTL2409A - 3567±50 BP, cal. 1σ 1980-1870 a.C.).
Da quanto è stato precedentemente esposto l’aspetto di Ortucchio, che ha preso il nome dal sito in cui è stato per la prima volta identificato, si presenta nel Fucino in una forma già pienamente strutturata, che non trova alcun antecedente in quell’area.
113
Fig. 18 - Fase IV della facies di Ortucchio: 1-7, 9-16, 18-20. Casetta Mistici (Roma); 8, 17. Casale Massima (Roma) (disegni di G. Carboni) (1:3).
114
Diversamente, nel territorio romano e precisamente nella zona compresa tra Osteria del Curato e Torre Spaccata nel settore SE del suburbio, si colgono gli elementi for-mativi di questa facies che nasce direttamente dall’evoluzione di alcuni aspetti Laterza, con passaggi graduali senza nette cesure.
In considerazione della sua diffusione essenzialmente sul versante tirrenico, da cui si estende verso il Fucino e verso la Campania, sarebbe opportuno non continuare ad usare la definizione di “facies di Ortucchio”, che alla luce delle nuove scoperte sarebbe fuorviante, ma quella di “facies della ceramica a pettine trascinato”.
Dalle numerose datazioni effettuate si sono potuti inquadrare in forma più preci-sa nell’ambito dell’Eneolitico alcuni aspetti ceramici precedentemente inseriti nell’am-
Fig. 19 - A. orciolo dalla tomba 14, blocco 1 di Gricignano-US Navy (da Salerno e Marino 2011); B. frammenti ceramici provenienti da Afragola (NA), saggio 8121-8131 (da Nava et alii 2007).
115
Fig. 20 - Romanina (Roma), tomba 23: A. veduta della tomba a grotticella in corso di scavo; B. vasi biconici decorati a stralucido (corredo) (disegni di G. Carboni) (1:3).
bito del Bronzo Antico senza alcun valido supporto di datazioni radiometriche. La tradizione culturale eneolitica nelle sue molteplici espressioni arriva quindi alla fine del III millennio a.C.
Questo è ulteriormente documentato nella necropoli rinaldoniana della Romani-na ubicata a breve distanza da Quadrato di Torre Spaccata ed Osteria del Curato-Via Cinquefrondi, che è caratterizzata dalla presenza nei corredi di numerosi vasi, soprat-tutto biconici, con decorazione a stralucido. La datazione più recente ottenuta dall’uni co inumato della tomba 23 (fig. 20A), raggiunge la fine del III millennio (LT-L2408A - 3717±50 BP, cal. 1σ 2150-2030 a.C.) (Anzidei et alii 2011). Trattandosi di
116
una sepoltura individuale, è possibile inquadrare cronologicamente anche il corredo ceramico, che presenta elementi interamente caratterizzanti la facies di Rinaldone sia nella tipologia che nella decorazione (fig. 20B).
Sia gli aspetti di abitato della “facies della ceramica a pettine trascinato” che quelli fune-rari di Rinaldone sono inquadrabili pertanto nell’ambito delle ultime manifestazioni eneolitiche dell’Italia centrale mentre il Bronzo Antico è caratterizzato da una serie di sostanziali cambiamenti tra cui quelli nella produzione ceramica, nella metallurgia (lega rame-stagno e comparsa dei ripostigli) e nel rituale funerario (Petitti et alii 2012) che si diffondono nel nostro territorio solo a partire dal II millennio a. C.
RIfERImEnTI bIblIOGRAfICI
AlbORE LIvADIE C., ARCuRI f., nAPOlI G. 2011, Vecchi scavi, nuove conferme: riesame della necropoli di facies Laterza presso il tempio di Cerere (Paestum, Salerno), AttiIIPP XLIII, pp. 329-334.
AlESSIO m., bEllA f., ImPROTA S., bElluOmInI G., CORTESI C., TuRI F. 1973, University of Rome C-14 dates IX, Radiocarbon 13, pp. 395-411.
AnGElI l., fAbbRI C., vEnTuRA O. 2011a, Elementi campaniformi in località Serpentana di Ortucchio (AQ), in AA.vv., Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità, Atti del III Convegno di Archeologia in ricordo di W. Cianciusi, Avezzano, pp. 570-572.
AnGElI l., fAbbRI C., RADI G. 2011b, Nuovi elementi campaniformi nella piana del Fucino (L’Aquila), AttiIIPP XLIII, pp. 515-517.
AnGlE M. , GuIDI A. 2007, L’antica e media età del bronzo nel Lazio meridionale, AttiIIPP XL, I, pp. 147-178.
AnGlE M. , mAnCInI D. 2010, Pantano Borghese: un insediamento preistorico ai margini della palude, in EGIDI R., fIlIPPI f., mARTOnE S., a cura di, Archeologia e infrastrutture, il tracciato fondamentale della linea C della metropolitana di Roma: prime indagini archeologiche, BdA, vol. spec., pp. 293-314.
AnGlE M., CATRACChIA f., CAvAzzuTI C., GIACCIO b., mAlORGIO m., mAnCInI D., muTRI G., PInO uRìA b., TAGlIACOzzO A. 2011, Pantano Borghese (Montecompatri, Roma). Un insediamento preistorico nel territorio gabino, in GhInI G., a cura di, Lazio e Sabina 7, Atti del Convegno, Roma, pp. 189-201.
AnGlE M., AlTAmuRA f., bRIllI m., CATRACChIA f., CAvAzzuTI C., mAnCInI D., OTTATI A., PInO uRìA b., RICkARDS O., SCORRAnO G., SEbASTIAnI A., TAGlIACOzzO A. 2012, Seppelli-menti: tombe e fosse rituali nel sito preistorico di Pantano Borghese (Montecompatri, Roma), in GhInI G., a cura di, Lazio e Sabina 8, Atti del Convegno, Roma, pp. 215-229.
AnzIDEI A. P., BIETTI SESTIERI A.M. 1980, Rinvenimenti preistorici nel territorio di Roma, QuadAEI, 4, pp. 21-27.
AnzIDEI A.P., CARbOnI G., a cura di, 1995, L’insediamento preistorico di Quadrato di Torre Spaccata (Roma) e osservazioni su alcuni aspetti tardo neolitici ed eneolitici dell’Italia centrale, Origini XIX, pp. 55-325.
AnzIDEI A.P., CARbOnI G. 2007, Il villaggio neo-eneolitico di Quadrato di Torre Spaccata (Roma): nuo-vi dati dagli scavi del Giubileo 2000, AttiIIPP XL, II, pp. 421-435.
AnzIDEI A.P., CARbOnI G., CASTAGnA M.A., CElAnT A., CIAnCA M., EGIDI R., fAvORITO S., fu-nICIEllO R., GIORDAnO G., mAlvOnE M., TAGlIACOzzO A. 2007, L’abitato eneolitico di Osteria
117
del Curato-via Cinquefrondi: nuovi dati sulle facies archeologiche di Laterza e Ortucchio nel territorio di Roma, AttiIIPP XL, II, pp. 477-508.
AnzIDEI A.P., CARbOnI G., CARbOnI L., CASTAGnA M. A., CATAlAnO P., EGIDI R., lEmORInI C., mAlvOnE M., SPADOnI D. 2011, Il gruppo Roma-Colli Albani della facies di Rinaldone: organizza-zione spaziale, rituali e cultura materiale nelle necropoli di Lucrezia Romana e Romanina (Roma), Atti IIPP XLIII, pp. 297-307.
Atti ViAreggio - COCChI GEnICk D., a cura di, 1996, L’Antica età del Bronzo in Italia, Atti del Congresso, Firenze.
ATzEnI E. 1996, La cultura del Vaso Campaniforme e la facies di Bonnanaro nel bronzo antico sardo, in Atti Viareggio, pp. 397-411.
bIAnCOfIORE F. 1967, La necropoli eneolitica di Laterza, origini e sviluppo dei gruppi “protoappenninici” in Apulia, Origini I, pp. 195-300.
bIETTI SESTIERI A.M., GIAnnI A. 1984, L’insediamento eneolitico di Piscina di Torre Spaccata. La cam-pagna di scavo - relazione preliminare, in Territorio di Roma, pp. 142-154.
bIETTI SESTIERI A.M., GIAnnI A. 1988, L’insediamento eneolitico di Piscina di Torre Spaccata (Roma), RassA 7, pp. 580-582.
bOCCuCCIA P., CARbOnI G., GIOIA P., REmOTTI E. 2000, Il sito di Casale del Cavaliere (Lunghezza - RM) e l’eneolitico dell’Italia centrale: problemi di inquadramento cronologico e culturale alla luce della re-cente datazione radiometrica, in SIlvESTRInI M., a cura di, Recenti acquisizioni, problemi e prospettive della ricerca sull’Eneolitico dell’Italia centrale, Atti dell’Incontro di Studio, Ancona, pp. 231-247.
buTTER J., fOkkEnS h. 2005, From stone to bronze technology and material culture, in lOuwE kOOI-JmAnS l.P., vAn DEn bROEkE P.w., fOkkEnS h., vAn GIJn A.l., eds., The prehistory of the Netherlands, 1, Amsterdam, pp. 371-399.
CARbOnI G., RAGnI E. 1984, Ricognizioni di superficie F. 25 N, in Territorio di Roma, pp. 47-63.ChIAPPEllA G. v. 1956, Scavo nel giacimento paleolitico superiore di Palidoro (Roma), Quaternaria III,
pp. 263-264.ChIAPPEllA G. 1965, Gli scavi nel giacimento di Palidoro (Roma), Quaternaria VII, pp. 307-308.COCChI GEnICk D. 2007, Considerazioni sulle presenze Laterza nei siti tirrenici, AttiIIPP XL, II, pp.
437-459.CREmOnESI G. 1985, Note su nuovi insediamenti dell’età dei metalli nella piana del Fucino, in lIvERAnI
m., PAlmIERI A., PEROnI R., a cura di, Studi di Paletnologia in onore di S. M. Puglisi, Roma, pp. 791-804.
D’AGOSTInO B. 1964, Di alcuni rinvenimenti preistorici a Pontecagnano (Salerno), BPI 73, pp. 89-108.DEl fATTORE F. 2007, La definizione dell’Antica età del Bronzo in Etruria meridionale attraverso l’analisi
dei materiali e del territorio, Tesi di Dottorato di Ricerca presso L’Università degli Studi di Pisa.DI GEnnARO F., PACCIAREllI M. 1996, Lo stile Luni Tre Erici - Norchia, in Atti Viareggio, pp. 574-575.FERRARESE CERuTI M. L. 1985, La cultura del vaso campaniforme. Il primo bronzo, in AA.vv., Ichnus-
sa, la Sardegna dalle origini all’età classica, Milano, pp. LV-LXVI.fOkkEnS h. 1998, Drowned Landscape. The occupation of the western part of the Frisian-Drentian Pla-
teau, 4000 BC - AD 500, Assen.fuGAzzOlA DElPInO m.A., SAlERnO A., TIné v. 2007, Villaggi e necropoli dell’area “Centro Com-
merciale” di Gricignano d’Aversa - US Navy (Caserta), AttiIIPP XL, II, pp. 521-537.GuIDI A. 1979, Nuovi dati sulla problematica dell’antica età del Bronzo nel Lazio, QuadAEI 3, pp.
129-138.
118
GuIlAInE J., ClAuSTRE f., lEmERCIER O., SAbATIER P. 2001, Campaniformes et environnement culturel en France méditerranéenne, in nICOlIS F., ed., Bell Beaker today, Proceedings of the Internatio-nal Colloquium, Trento, pp. 229-275.
IAIA C., bARbARO B., fAvORITO S. 2005, L’insediamento dell’Antica età del Bronzo della Tenuta Qua-draro-via Lucrezia Romana (Roma). Dati preliminari per un inquadramento culturale e cronologico, Papers in Italian Archaeology VI, I, B.A.R., Int. Ser. 1452 (I), pp. 449-456.
IAlOnGO n. 2007, Il Fucino nella protostoria, in PEROnI R., a cura di, Grandi contesti e problemi della protostoria italiana 10, Firenze.
lA fORGIA E., bOEnzI G., vISCIOnE M. 2007, Un insediamento dell’eneolitico finale a Carinaro: dati preliminari sugli scavi condotti all’interno del Polo Calzaturiero, AttiIIPP XL, pp. 623-626.
nAvA m.l., GIAmPAOlA D., lA fORGIA E., bOEnzI G. 2007, Tra Clanis e il Sebeto: nuovi dati sull’oc-cupazione della piana campana tra il Neolitico e l’età del Bronzo, AttiIIPP XL, I, pp. 101-126.
PEnnACChIOnI M. 1977, Torre Crognola, in D’ERCOlE v., PEnnACChIOnI M., a cura di, Vulci, Rin-venimenti di superficie d’epoca preistorica, Quad. GAR 7, Roma.
PEnnACChIOnI M. 1979, Nuovi dati e precisazioni sull’insediamento preistorico di Torre Crognola (Vulci - Viterbo), AttiSocTosc 86, pp. 415-433.
PEROnI R. 1965, Significato degli scavi nel deposito a ceramiche di Palidoro, Quaternaria VII, pp. 309-311.
PEROnI R. 1971, L’età del Bronzo nella Penisola italiana, I. L’antica età del Bronzo, Firenze.PETITTI P., nEGROnI CATACChIO n., COnTI A.m., lEmORInI C., PERSIAnI C. 2002, La necropoli
eneolitica del Fontanile di Raim. Nuovi dati dalla campagna di scavo 1998, AttiPPE V, 2, pp. 545-568.
PETITTI P., PERSIAnI C., COnTI A.m. 2012, Il passaggio dall’Eneolitico all’età del bronzo sul versante medio-tirrenico della penisola italiana. Problemi e prospettive, AttiPPE X, 1, pp. 299-328.
RADI G. 1988, L’eneolitico in Abruzzo, RassA 7, pp. 370-377.RADmIllI A. M. 1977, Storia dell’Abruzzo dalle origini all’età del bronzo, Pisa.SAlERnO A., mARInO P. 2011, La necropoli dell’area “Forum” di Gricignano di Aversa (Caserta), US
Navy: composizione e articolazione dei contesti tombali di facies Laterza, AttiIIPP XLIII, pp. 323-327.
SkEATES R. 1994, A radiocarbon date-list for prehistoric Italy (c. 46.400 BP - 2450 BP/400 cal. BC), in SkEATES R., whITEhAuSE R., eds., Radiocarbon Dating and Italian Prehistory, Archaeological Monographs of the British School at Rome 8, London.
STRAhm C. 1998, Il bicchiere campaniforme: fenomeno e cultura, in nICOlIS f., mOTTES E., a cura di, Simbolo ed Enigma, Trento, pp. 21-44.
territorio di romA - bIETTI SESTIERI A. m., a cura di, 1984, Preistoria e Protostoria nel Territorio di Roma, L.S.A. 3, Roma.
TunzI SISTO A.m., mOnACO A. 2010, Vaccarella - Masseria Fragella (Lucera - FG): sepolture eneoli-tiche di facies Laterza, AttiDaunia 30, pp. 127-136.
TunzI SISTO A.m., mOnACO A. 2011, Le sepolture di facies Laterza in località Vaccherella (Lucera, FG), AttiIIPP XLIII, pp. 761-766.