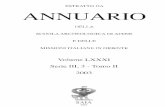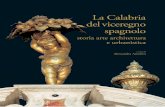Area di vegetazione e campo di idoneità ecologica del castagno in Calabria
ISCA SULLO IONIO (CALABRIA - ITALIA): SCAVI IN LOC. ZAGAGLIE
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ISCA SULLO IONIO (CALABRIA - ITALIA): SCAVI IN LOC. ZAGAGLIE
LRCW 4 Late Roman Coarse Wares,
Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean Archaeology and archaeometry
The Mediterranean: a market without frontiers
Edited by
Natalia Poulou-Papadimitriou, Eleni Nodarou and Vassilis Kilikoglou
BAR International Series 2616 (I)2014
Volume I
Published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological ReportsGordon House276 Banbury RoadOxford OX2 [email protected]
BAR S2616 (I)
LRCW 4 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and archaeometry. The Mediterranean: a market without frontiers. Volume I.
© Archaeopress and the individual authors 2014
Cover illustration: Early Byzantine amphora from Pseira, Crete (photo by C. Papanikolopoulos; graphic design by K. Peppas).
ISBN 978 1 4073 1251 4 (complete set of two volumes) 978 1 4073 1249 1 (this volume) 978 1 4073 1250 7 (volume II)
Printed in England by Information Press, Oxford
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd122 Banbury RoadOxfordOX2 7BPEnglandwww.hadrianbooks.co.uk
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
1013
ISCA SULLO IONIO (CALABRIA - ITALIA): SCAVI IN LOC. ZAGAGLIE
MARIA TERESA IANNELLI1, FRANCESCO ANTONIO CUTERI2, GIUSEPPE HYERACI3,
PASQUALE SALAMIDA3
1Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria; [email protected]
2Università Mediterranea di Reggio Calabria; [email protected] 3Collaboratori Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria; [email protected];
[email protected] In the site of Zagaglie, located in the district of Isca sullo Ionio (Catanzaro, Italy), a limited part of a larger roman villa pars rustica has been investigated in the course of several archaeological excavations that specified the period of use of the site from the 1st to the 5th centuries AD. Clear evidences of a permanent and structured settlement date between the end of the 1st century BC and the beginning of the 1st century AD. A building with walls in opus caementicium and a nearby structure of considerable thickness, probably a wall of fence, were erected. A few metallurgical slags come from the layers below the foundation levels of the structures of the first period. In the middle of the 2nd century AD the building was partially transformed, while at the end of the same century the small investigated area was temporally abandoned. During the 3rd century AD the site was re-occupied. Useful building materials were re-used from the collapsed structures and three rooms built in a mixed technique (a basement in dry masonry and walls in perishable materials, clay or wood) were added to the existing ones. In room 3 two round-shaped traces on the ground were interpreted as related to a wooden torcularium. Outside room 2 a ditch filled with coal was found. This evidence, although limited, suggests intensive activity in the area between the 3rd and the 4th century AD. In the middle of the 4th century AD the use of the site seems to have changed. Although the phase of reuse of the building seems limited, a fair amount of pottery from various parts of the Mediterranean (Africa, east Aegean) has been discovered along with coins and a seal ring bearing the representation of a ship. KEYWORDS: CALABRIA, SCOLACIUM, ISCA SULLO IONIO, PARS RUSTICA, TORCULARIUM, AFRICAN
POTTERY, EASTERN POTTERY, SEAL 1. IL MEDIO IONIO CALABRESE NELLA TARDA ANTICHITA
Il territorio litoraneo compreso tra Scolacium e Locri è oggetto da anni di scavi e ricerche da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Diversi contributi scientifici hanno approfondito la conoscenza in merito a vari aspetti della tarda antichità, definendone un quadro oltremodo articolato (Noyé 2005; Iannelli, Cuteri, 2007). Dal punto di vista topografico è stato evidenziato un progressivo modificarsi delle dinamiche insediative strettamente legato alle vicissitudini politiche ed economiche di quei secoli (Grelle, Volpe, 1999; Vera 2005). Nelle campagne si assiste, a partire dal III secolo, a un processo di trasformazione che si manifesta nel progressivo abbandono di alcune ville a favore di altre. Queste, che assumono i connotati architettonici delle villae-preatoria, sottintendono diverse forme di gestione del territorio e della risorsa umana (Sfameni 2005; Vera 1999, 288). Accanto alle ville, in campagna, è documenta la presenza, dalla fine del III secolo, di nuclei vicani segnalati prevalentemente da aree di necropoli (Cuteri, Iannelli 2000; Cuteri, Rotundo 2001; Aisa et al. 2003). Tali nuclei, che anticipano una forma di popolamento ampiamente documentata dalla fine della tarda antichità, costituiscono, secondo un modello comune alle aree
bizantine, la forma più frequente di popolamento prima della rinascita urbana propria dell’età medio-bizantina (Martin, Noyé 2005).
I contributi più recenti hanno messo in evidenza un quadro economico fortemente diversificato che tiene conto della tipologia degli insediamenti e della qualità del rapporto con quanti detengono il potere. Così, mentre per Reggio e Crotone, più strettamente legate all’autorità imperiale, si è evidenziato il sussistere di consolidati vettori commerciali con l’oriente, per le altre aree si assiste ad un più duraturo rapporto con le regioni nordafricane (Cuteri, Salamida 2010).
Con la fine dell’impero l’avvento del potere religioso sembra aver avuto un ruolo determinante nelle trasformazioni del paesaggio sia urbano che rurale. La presenza vescovile risulta essere il fattore che maggiormente ha contribuito al mantenimento e alla continuità del nucleo urbano, determinandone altresì le sue trasformazioni, come attestato a Scolacium e a Locri (Raimondo 2005; Lebole Di Gangi 1991). Da un punto di vista economico, il potere religioso influenza i traffici commerciali in virtù del tradizionale legame con le regioni dell’Africa settentrionale, come evidenziato dal netto prevalere del vasellame africano su quello orientale. Rimane sostanzialmente invariato il quadro relativo alla viabilità, come rimane invariato il quadro insediativo ad
LRCW4
1014
essa legato. Occorre tuttavia, a nostro avviso, riconsiderare per questo periodo il ruolo svolto dalle stationes, le quali sembrano assumere, attraverso un lento cambiamento, la connotazione di vici, pur nella continuità del funzionamento del sistema fiscale.
2. LO SCAVO
Lo scavo, localizzato nella marina di Isca sullo Ionio (CZ), in loc. Zagaglie, si è reso necessario a seguito dei tanti rinvenimenti di materiale archeologico avvenuti durante la costruzione di nuovi edifici residenziali. Tra il materiale recuperato si segnalano frammenti di macine in pietra vulcanica, numerosi laterizi tra cui vari tubuli e un’ingente quantità di ceramica riferibile ad un periodo che va dal I secolo a.C. al V secolo d.C. Si è ipotizzato, in passato, la possibile presenza di un insediamento in villa, monumentale ed esteso, dotato con ogni probabilità di un impianto termale. Tale ipotesi, in parte, è stata confermata dalle indagini archeologiche che, a più riprese, hanno interessato un’area ristretta posta in prossimità del luogo in cui erano stati effettuati gli occasionali recuperi di materiale. L'area indagata costituisce, in effetti, una porzione ridotta riferibile alla pars rustica di un ben più ampio insediamento in villa posto lungo la via litoranea e in maniera equidistante rispetto alla città di Scolacium e alla statio di Caulon-Stilida.
Le indagini hanno evidenziato un popolamento stabile e strutturato a partire dall'età augustea. La prima fase, collocabile con dati numismatici e ceramologici tra la fine del I secolo a.C e gli inizi del successivo, è rappresentata dalla costruzione dell’edificio. Si tratta di una villa rustica della quale, nel saggio effettuato, si distinguono due ambienti (Fig. 1). L’ambiente 1, scavato per intero, era originariamente pavimentato in laterizio, mentre le pareti dovevano essere rivestite da intonaco bianco. La muratura è in opera mista: laterizi frammentari e pietre appena o per nulla lavorate disposti su corsi non perfettamente orizzontali e legati da una malta tenace. L’accesso era assicurato da un ampio ingresso che si affacciava su un’area aperta. Sul lato opposto dello scavo è stata intercettata la cresta di un muro, con lo stesso orientamento dei muri della villa. Di fianco a questa struttura si è messa in evidenza una massicciata orientata est-ovest. Questa, che prosegue oltre gli stretti limiti del saggio, è interpretabile come un battuto stradale posto in fase con strutture di età augustea, come documentato dai materiali ceramici contenuti: terra sigillata italica aretina, ceramica a pareti sottili. Data la vicinanza con la strada e il notevole spessore, la struttura muraria potrebbe essere interpretata come una recinzione. In un momento collocabile alla metà del II secolo, l’edificio subì alcune trasformazioni, legate anche al cambiamento di funzione di alcuni ambienti. Questa seconda fase è ben documentata nell’ambiente 1, dove viene ristretto l’ingresso e rimossa la pavimentazione in laterizio. Il nuovo piano di calpestio s’imposta sulla preparazione della pavimentazione precedente. Alla fine del II secolo la piccola porzione di villa indagata viene abbandonata.
Le strutture crollano e l’area rimane inutilizzata per pochi decenni.
Tra la fine del II e gli inizi del III secolo si registra una ristrutturazione dello spazio edilizio e la destinazione d'uso produttiva di alcuni ambienti. Nell’ambiente 3, due tracce circolari affiancate sono state interpretate come gli incassi di un torcularium in legno. I nuovi ambienti sono ottenuti con una tecnica mista, composta da uno zoccolo in muratura e un alzato in materiale deperibile. All’esterno dell’ambiente 2 viene ricavata una fossa per carbone che è stata indagata solo in parte. Queste evidenze lasciano trasparire il carattere prettamente produttivo di una parte dell’area tra III e IV secolo. Nell’ambiente 2 gli strati relativi a questa fase hanno restituito materiali riconducibili alla sfera domestica e con ogni probabilità ad una dimensione muliebre. Sono stati infatti rinvenuti, insieme a ceramica comune e vasellame fine, un frammento di foculum, alcuni ciottoli tondeggianti utilizzati come pestelli, varie valve di conchiglie tra cui quella di un’ostrica. Dallo stesso contesto proviene, inoltre, una statuetta in bronzo raffigurante Minerva Medica. Una porzione di strada viene obliterata da due nuovi ambienti giustapposti alle strutture augustee. Questa fase è da considerarsi la più ricca dal punto di vista della cultura materiale e attesta una vitalità di rapporti commerciali e nel contempo il sussistere di attività produttive. I dati relativi al terzo secolo permettono, quindi, di documentare la resistenza dell’insediamento nonostante la crisi del medio impero, periodo nel quale, secondo un modello noto, si registra la ristrutturazione dell’habitat rurale con la scomparsa di numerose ville a carattere produttivo e la crescita del latifondo.
A tal proposito, il rinvenimento, in strati riferibili all’età tardo antica, di un anello sigillo con la raffigurazione di una nave (Fig. 2) pone quesiti che interessano la struttura demaniale dell’insediamento, la natura della proprietà, il rapporto con il polo cittadino di riferimento e un’eventuale legame con i sistemi di scambio e distribuzione delle merci, se non con i meccanismi di funzionamento della struttura annonaria. Alla metà del IV secolo si registra il mutamento di funzione di alcuni ambienti, evidenziato dalla presenza di focolari e da piccoli livelli d’uso. Nonostante l’apparente povertà degli ambienti riutilizzati, nei depositi relativi a questa fase si è riscontrata una discreta quantità di ceramica proveniente da varie zone del Mediterraneo e una modesta circolazione monetaria.
3. LA CERAMICA
La prima fase della struttura presenta una cultura materiale molto variegata. Si registra una grande quantità di ceramica fine da mensa tra cui sigillata italica e aretina, sigillata microasiatica e un numero considerevole di frammenti di ceramica a pareti sottili. Sono anche attestate le prime forme della sigillata africana Hayes 8a e Hayes 3.
IANNELLI,-CUTERI,-HYERACI-SALAMIDA
1015
La presenza di ceramica africana nella fase medio imperiale è attestata con un discreto numero di esemplari: casseruole Hayes 23b, Hayes 197, con parete esterna a patina cinerognola; i piatti coperchio Hayes 196, Ostia I, 18 e 261, Atlante CIV, 5, che presentano spesso l’orlo annerito o schiarito (Fig. 4, 1-2). Tra le sigillate si registrano alcuni frammenti riferibili alle forme Hayes 50b e Hayes 61b. E’ presente anche un frammento di forma Hayes 49, solitamente prodotta in sigillata A2 mentre nel nostro caso appare prodotta in C4. Le attestazioni più tarde sono riferibili ad alcuni frammenti, caratterizzati dalla tipica politura a bande, la cui forma non risulta riconoscibile.
Un frammento pertinente ad una coppa riconducibile alla forma Atlante CX, 8 attesta la presenza ad Isca di sigillata pergamena databile tra la metà del secondo e la metà del terzo secolo (Fig. 4, 6). Sempre dall’area orientale sembra provenire un frammento di vaso a listello (Fig. 4, 4) caratterizzato da impasto rosato molto selezionato e ricco di mica finissima, simile a quella che contraddistingue le anfore LR3.
Tra le ceramiche fini si annovera anche un frammento di coppa carenata con orlo indistinto che presenta tracce di vernice rossa e che trova confronto con un esemplare analogo rinvenuto ad Ostia (Ostia III, fig. 58; Fig. 4, 7).
Per quanto riguarda le anfore commerciali, nel III secolo, la ristrutturazione di questa piccola parte dell'insediamento si accompagna, oltre che con l'evidenza di una produzione vinicola locale, con la presenza di alcuni frammenti riferibili alla forma tipica della MR 1 (Fig. 3, 5). Per tale anfora, la cui presenza è documentata in più siti della regione (Cuteri, Salamida 2010), è stata ipotizzata una produzione nell’area dello stretto di Messina (Martin 1999; Tomber 2003), e potrebbe non essere un caso la similitudine morfologica tra questo contenitore e la più tarda Keay LII, che sotto alcuni aspetti sembrerebbe esserne l’evoluzione. Negli stessi strati sono attestate numerose pareti di anfore di produzione africana, ma la mancanza degli orli non permette un riconoscimento delle forme. Si riscontra comunque un frammento del tipo Keay XXVb (Fig. 3, 3). Dal Mediterraneo orientale proviene un’esemplare di anfora cretese 4 caratterizzata dalla tipica ansa apicata e un frammento di parete riferibile ad un contenitore monoansato Agorà F65-66, antenato delle LR3. Da strati più tardi provengono alcuni frammenti di LR5, probabilmente appartenenti allo stesso esemplare, un frammento di LR1 (Fig. 3, 2), un'anfora africana di dubbia attribuzione assimilabile per caratteristiche alla Keay LVIa (Fig. 3, 1) e un frammento riconducibile ad un'anfora di dimensioni ridotte la quale, sia per impasto che per forma dell'orlo, sembra riconducibile alla produzione regionale delle Keay LII (Fig. 3, 4). La presenza di contenitori da trasporto di produzione orientale degli stessi tipi è documentata sia a Scolacium che nell’area di Capo Cocinto (Cuteri et al. 2007; Cuteri, Salamida 2010, 156-157).
Per quanto attiene alla ceramica da cucina, sono attestati, sia negli strati di III secolo, sia in quelli successivi, più
esemplari riferibili a contenitori da cottura biansati, ai quali, solitamente, si attribuisce una provenienza dall’area egea (Fig. 5, 2-6). Una produzione simile è stata riscontrata in Puglia presso il sito di San Giusto (Turchiano 2010), mentre sono già stati riconosciuti esemplari nella vicina loc. San Marco di Monasterace (Cuteri, Salamida 2010, Fig. 3, 2). Per questi contenitori si rileva una duratura diffusione che va dal II al VI secolo senza soluzione di continuità. I contatti con l’area adriatica sembrano trasparire anche attraverso il rinvenimento di pentole assimilabili alla Illyrian Cooking Ware (Fig. 5, 3), prodotta in Albania a partire dal III-IV secolo, la cui circolazione è ampiamente documentata in area pugliese (De Mitri 2010, 682, fig. 5)
In livelli di fine II-III secolo, si riscontra la presenza del tegame ad orlo bifido (Fig. 3, 6), prodotto probabilmente da officine locali, forma alla quale viene solitamente attribuita una datazione più alta. Si attesta anche la forma del tegame ad orlo leggermente introflesso (Fig. 3, 7) già ben documentata a Cosa- Ansedonia (Dyson 1976, LS 39) e in vari siti dell’area campano-laziale (Olcese 2003, Tav. XV, 3).
Il rinvenimento di alcuni frammenti di ceramica da cucina permette di notare che le officine locali si ispiravano a forme tipiche di altre produzioni più diffuse. Sono attestate imitazioni della ceramica africana da cucina, in particolare delle forme Hayes 23b (Fig. 4, 5) e Hayes 197 (Fig. 4, 3), tra le quali richiama l’attenzione una variante attestata anche nell’area di Megara Iblea (Cacciaguerra 2010, Fig. 3-2). Il contenitore da cottura con orlo ingrossato leggermente rientrante e ansa orizzontale applicata (Fig. 3, 9) richiama le note forme della Pantellerian Ware. Manufatti che imitano tale produzione isolana sono attestati a Napoli e in area Campana (Marazzi et al. 2010, 499).
Un frammento di orlo di casseruola a margine superiore schiacciato e inclinato verso l'interno (Fig. 3, 8) richiama una forma attestata a Napoli-Carminiello ai Mannesi nel V secolo (Carsana 1994, 235, n. 28.1) mentre la teglia con orlo ingrossato a sezione triangolare (Fig. 4, 8) risulta già documentata in analogo contesto cronologico nel vicino sito di Loc. San Marco di Monasterace (Cuteri et al. 2007, Fig. 9, 8) così come una pentola con orlo estroflesso (Fig. 5, 1) appare confrontabile con un esemplare rinvenuto a Nicotera (Cuteri et al. 2007, Fig. 7,1). L’olla con orlo estroflesso (Fig. 5, 4), benché ricalchi un modello diffuso a partire dalla media età imperiale, trova confronto con una forma attestata presso la villa del Naniglio a Gioiosa Jonica (RC) (Di Giovanni, Gasperetti 1988, tav. IX, 43). La pentola con orlo a sezione quasi triangolare, estroflesso (Fig. 5, 5), è confrontabile con un esemplare rinvenuto presso il Castrum di Santa Maria del Mare in contesti di V-VI secolo (Raimondo 2006, Fig. 9-5). Meno documentata l’olla con orlo appena estroflesso che presenta una sorta di collarino all’innesto con la parete (Fig. 5, 8). Un esemplare assimilabile, ma non del tutto analogo, è stato rinvenuto nel vicino sito di Loc. San Marco di Monasterace (Cuteri et al. 2007, Fig. 9-2). L’olla con orlo estroflesso appena accennato e corpo globulare (Fig. 5, 7)
LRCW4
1016
è confrontabile con una forma riscontrata nel sito di Paleapoli in contesti leggermente più tardi (Lebole Di Gangi 1991, Fig. 12, 37).
Un'olla, caratterizzata dall’orlo estroflesso e ingrossato sul profilo esterno (Fig. 5, 9), trova invece confronto con esemplari rinvenuti in contesti più tardi e nello specifico in strati di VI secolo nello scavo della Schola Praeconum (Whitehouse et al. 1982, fig. 8, 100).
4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La produzione di ceramica locale, per la quale è possibile distinguere ad un esame autoptico più fabbriche, appare limitata ai contenitori da cottura. La produzione locale sembra essere influenzata soprattutto dai modelli orientali e le analogie morfologiche interessano soprattutto l’olla biansata dal caratteristico orlo estroflesso, tipicamente attribuita all’area egea. In minima parte, invece, si attestano forme che ripropongono le tipologie africane. La diffusione della forma dell’olla, a partire al III secolo, potrebbe essere indice di un mutamento progressivo nelle abitudini alimentari.
Data l’assenza di tabelle quantitative, e considerando la limitatezza dell’area di scavo, non è possibile delineare con precisione la qualità e la direzione dei traffici commerciali.
Dai dati raccolti emerge comunque un’importante fase di III secolo, durante la quale la villa appare inserita, anche con un ruolo produttivo, in un più vasto circuito di scambi commerciali. Attualmente, però, non si hanno i dati necessari per definire l’entità di questa produzione locale. La vitalità dell’insediamento in questo periodo appare indice del diverso ruolo interpretato in rapporto alle trasformazioni che si registrano nella campagna circostante. Tale ruolo sembra riemergere in periodo tardo antico. L’anello sigillo, a questo proposito, potrebbe essere in qualche modo indicatore di uno specifico assetto demaniale e giustificherebbe l'evidenza di circuiti produttivi e commerciali di più ampia portata.
BIBLIOGRAFIA
Aisa, M. G., Corrado, M., De Vingo, P. 2003. Note preliminari sul sepolcreto altomedievale di Cropani (CZ) – Località Basilicata: i materiali rinvenuti nelle sepolture. In R. Fiorillo, P. Peduto (eds.), III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale,741-746. Firenze, All’Insegna del Giglio.
Atlante I = AA. VV. 1981. Atlante delle forme ceramiche, I, Ceramica fine romana nel Bacino mediterraneo (medio e tardo impero), suppl. Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orientale, Roma, Treccani.
Cacciaguerram, G. 2010. La ceramica da fuoco nella Sicilia tardoantica e altomedievale: l’evidenza dell’area iblea orientale. In S. Menchelli, S. Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci (eds.), LRCW3. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae
in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. Comparison between western and eastern Mediterranean. British Achaeological Reports, International Series 2185, 301-310. Oxford. Archaeopress.
Carsana, V. 1994. Ceramica da cucina tardo-antica ed altomedievale. In P. Arthur (ed.), Il complesso archeologico di Carminiello ai Mannesi, Napoli (scavi 1983-1984), 181-220. Galatina, Congedo Ed.
Cuteri, F.A., Corrado, M., Iannelli, M.T., Paoletti, M., Salamida, P., Sangineto, A.B. 2007. La Calabria fra Tarda Antichità ed Alto Medioevo attraverso le indagini nei territori di Vibona Valentia, della Massa Nicoterana, di Stilida-Stilo. Ceramiche, commerci, strutture. In M. Bonifay e J-Ch. Tréglia (eds.), LRCW2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry. British Archaeological Reports, International Series 1662, 461-476. Oxford. Archaeopress.
Cuteri, F.A. e Iannelli, M.T. 2000. Da Stilida a Stilo. Prime annotazioni su forme e sequenze insediative in un’area campione calabrese. In G.P. Brogiolo (ed.), II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, 209-222. Firenze, All’Insegna del Giglio.
Cuteri, F.A. e Rotundo, B. 2001. Il territorio di Kaulonia fra Tradoantico e Medioevo, Insediamenti, risorse, paesaggi. In M. C. Parra (ed.), Kaulonìa, Caulonia, Stilida (e oltre), Contributi storici, archeologici e topografici, I. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Quaderni 11-12, 117-158. Pisa.
Cuteri, F. A. e Salamida, P. 2010. Il litorale jonico calabrese da Crotone a Reggio (Calabria - Italia). Circolazione di manufatti ceramici tra V e VII secolo. In LRCW3, 507-513.
De Mitri, C. 2010. Ceramica da cucina di produzione albanese (Illyrian cooking ware) nel Salento romano (Puglia-Italia): presenza e distribuzione. In LRCW3, 681-686.
Di Giovanni, V. e Gasperetti, G. 1988. La ceramica. In A. de Franciscis (ed.), La villa romana del Naniglio di Gioiosa Ionica, Relazione preliminare della campagna di scavo (1981-86), 65-79. Napoli.
Dyson, S.L. 1976. Cosa, the utilitarian pottery, Memoirs of the American Academy in Rome XXXIII. Roma.
Grelle, F. e Volpe, G. 1999. Aspetti della geografia amministrativa ed economica della Calabria in età tardoantica. In S. Leanza (ed.), Calabria Cristiana. Società, religione, cultura nel territorio della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi. 1. Dalle origini al Medio Evo. Atti del Convegno di Studi, Palmi-Cittanova, 21-25 novembre 1994, 89-143. Soveria Mannelli, Rubbettino Ed.
Iannelli, M.T., Cuteri, F.A. 2007. Il commercio e la lavorazione del pesce nella Calabria antica e medievale con particolare riferimento alla costa
IANNELLI,-CUTERI,-HYERACI-SALAMIDA
1017
tirrenica. In L. Lagóstena, D. Bernal e A. Arévalo (eds.), Cetariae 2005. Salsa y Salazones de Pescado en Occidente durante la Antigüedad. British Archaeological Reports, International Series 1686, 285-300. Oxford, Archaeopress.
Lebole Di Gangi, C.M. 1991. Saggi nell’abitato altomedievale di Paleapoli. In La Calabre de la fin de l’antiquité au Moyen Age, actes de la table ronde (Rome 1989), Mélanges de l’Ecole Française de Rome, Moyen Age 103-2, 575-598.
Marazzi, F., Di Cosmo, L., Salamida, P., Stanco, E.A., Trojsi, G. 2010. Alife (Campania-Italia): produzione e circolazione di ceramiche comuni da mensa, da cucina, ed anfore in una città dell’Italia meridionale fra Antichità e Medioevo. In LRCW3, 497-506.
Martin, A. 1999. Amphorae. In D. Soren e N. Soren (eds.), A Roman Villa and Late Infant Cemetery: excavation at Poggio Gramignano (Lugnano in Teverina), 329-361. Roma.
Martin, J.M., Noyé, G. 2005. Les villages de l'Italie méridionale byzantine. In J. Lefort, C. Morrison, J.-P. Sodini (eds.), Les villages dans l'Empire byzantin. IVe-XVe siècle, 149-164. Paris.
Noyé, G. 2005. Les premiers siècles de la domination byzantine en Calabre. In A. Jacob, J. M. Martin e G. Noyé (eds.), Histoire et Culture dans l’Italie byzantine. Acquis et nouvelles recherches, 445-469. Roma.
Olcese, G. 2003. Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia. Mantova, S.A.P.
Ostia III = Carandini, A., Panella, C. (eds.), 1973. Ostia III, Studi Miscellanei 21. Roma.
Raimondo, C. 2005. Il rapporto tra città e campagna in Calabria tra V e VII secolo: le nuove indagini archeologiche a Scolacium e nel suo territorio. In G.
Volpe e M. Turchiano (eds.), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo, Atti del Primo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia meridionale Foggia 12-14 febbraio 2004, 567-584. Bari, Edipuglia.
Raimondo, C. 2006. Aspetti di economia e società nella Calabria bizantina: le produzioni del medio Ionio calabrese. In A. Jacob, J. M. Martin e G. Noye (eds.), Histoire et Culture dans l’Italie byzantine. Acquis et nouvelles recherches, 406-443. Roma.
Sfameni, C. 2005. Le villae-praetoria: i casi di San Giovanni di Ruoti e di Quote San Francesco. In G. Volpe e M. Turchiano (eds.), Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra tardoantico e altomedioevo, Atti del Primo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia meridionale, Foggia 12-14 febbraio 2004, 609-622. Bari, Edipuglia.
Tomber, R. 2003. Two unusual amphora types from the Museum of London. Journal of Roman Pottery Studies 10, 107-108.
Turchiano, M. 2010. Le ceramiche comuni dell’Apulia tardo antica e altomedievale: luoghi della produzione, del commercio e del consumo. In LRCW3, 657-668.
Vera, D. 1999. Massa Fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio Magno, Mélanges de l’Ecole Française de Rome, Antiquité 111-2, 991-1025.
Vera, D. 2005. I paesaggi rurali del Meridione Tardoantico: bilancio consuntivo e preventivo. In G. Volpe e M. Turchiano (eds.), 23-38.
Whitehouse, D., Barcker, G., Reece, R., Reese, D. 1982. The Schola Praeconum I: the coins, pottery, lamps and fauna. Papers of the British School at Rome 50, 53-101.
LRCW4
1018
Fig. 1. Isca (CZ), Loc. Zagaglie, pianta dell’area di scavo
Fig. 2. Anello sigillo con raffigurazione di nave. Età tardo-antica
IANNELLI,-CUTERI,-HYERACI-SALAMIDA
1019
Fig. 3. Anfore (1. Keay LVIa; 2. LR1; 3. Keay XXVb; 4. Keay LII; 5. MR1) e ceramica da cucina (6-9)