STAZIONE NEOLITICA A VALER (AZZANO DECIMO- PORDENONE): RAPPORTO PRELIMINARE DEGLI SCAVI 1990-1991
Transcript of STAZIONE NEOLITICA A VALER (AZZANO DECIMO- PORDENONE): RAPPORTO PRELIMINARE DEGLI SCAVI 1990-1991
Alli Soc. Preist. Protost. Friuli-V.G .. Tri este. VII I. 1993 ( 1994): 97- 1 n
LEONE FASANI*, PAOLO BIAGI**, C LAUDIO D'AM ICO***. ELISABETTA STARNINI**** e BARBARA A. YOYT EK*****
STAZIONE NEOLITICA A VALER (AZZANO DECIMO- PORDENONE):
RAPPORTO PRELIMINARE DEGLI SCAVI 1990-1991
RIASSUNTO- Sta::ione neolitim a Valer (A ::::ano Decimo - Pordenone): rapporto preliminare degli scavi 1990-1991. Gli autori prendono in esame i materiali provenienti dalle ricerc he nel sito Neolitico antico di Valer da cui sono state portate alla luce due srnllture a pozzetto parzialmente decapi tate. l reperti trovano alcuni confronti nei materiali dell 'attiguo sito di Fagnigola cd in altri del primo Neolitico de lla Pi<mura Friulana. Interesse particolare rivestono le datazioni radiometriche che riconducono la vita nell'abitato intorno alla metà del seuimo millennio BP.
SUMMARY - A preliminary rc>port o.f fil e 1990-199 l e.\Htl'aliolls or file Neolitilic si te ofVall'r ( Porde11n11e- northeastem l wly). The Authors examine the materials from two Ncolithic pits recently excavatcd a t Valer. The pottery and and the lithic assemblages ha ve some parai l cis in the early Neoli t·hic finds from the neighbouring si te of Fagnigola an d in other settlements ofthe centrai Friuli Plain. Of particular intercst are t h ree radiocarbon da t es which attribute t11e si te IO the mid seventh millennium BP.
LE RICERCHE (L.F.)
La stazione neolitica eli Valer è posta a sud-est di Azzano Decimo (Pordenone), ad alcune centinaia di metri a sud del l ' abitato di Cesena ( l ), ne lla vasta pianura alluviona le ad occidente del Tagliamento, in un 'area di risorgive (fig. 1). La sua segnalazione è dovuta a ricercatori locali che, in seguito ad arature profonde, avevano rilevato la presenza, in superfic ie, di zolle nerastre contenenti manufatti sia litici che ceramici. Essi provenivano da alcuni pozzetti posti a 50-80 cm dali ' attuale piano di campagna. Queste strutture, una volta asportato lo strato arativo, si ri conoscono mol to chiaramente per il colore nerastro del loro riempimento che contrasta nettamente con il c ircostante terreno argi lloso. Le ricerche si nora compiute sono rappresentate da due brevi campagne di scavo eseguite nelle estati 1990 e 1991 al fine di rilevare la consistenza de i resti eli tal i pozzetti decapitati dai lavori agricoli in vista eli più ampie, sistematiche, ricerche future.
* Dipanimento di Scienze della Terra dell'Università di Milano ** Dipanimento di Scienze Storico-Archeologiche e Oricntalistiche dell ' Univers ità di Ve nezia *** Dipartimento di Scienze Mineralogiche dell'Università di Bologna **** Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Milano ***** ArcheologicaJ Rcscan:h racility. DeparU11ent o f Anthropology of the University of California at Berkeley ( l ) Il si to oggetto della presente nota è in altr e pubblicazioni denominato Cesena (cfr. FERRARI e PESSINA, 1992).
-97
Fig. l - Ubicazione del si to di Valer nella bassa Pianura Friulana.
Nel le due campagne di ricerche furono esplorati due di tali pozzerti ed è tata loca li zzata l ' ubicazione di altri (2).
Po::ello l Posto a 50 cm dal piano di campagna, era d i pianta subcircolare del diametro di circa 160
cm e della profondità massima di 55 cm (fig. 2). Il riempimento era formato da una zona centrale
(2) S<.:avi eseguiti con fondi CNR e MURST -W%. Alle ricerche hanno partecipato Renato Fasolo. Addone Grillo, Giovanna Marogna, Franco Nicolis, Andrea Pessina, Tu llia Sp<mgaro. Paola Yiscntini. Il restauro elci mate riali è stato eseguito da Giovanna Ma rogna a cui vanno i pitl sentiti ringraziamenti.
98 -
.... 0..
N a..
(,)
.. ... z
o
Fig. 2 - Valer. Planùnetria e sezioni del Pozzeno l e 2.
~ · ..... . • .
o
IU (,) ·e IU ~
Q) (,)
e./ ..c
... I.·':".J
·'; l
!.:·.
· .. ~~· , .· -. · ...
(,)
- 99
con argille nere uliginose, ricche in sostanza organica e da una, più esterna, alquanto più chiara con alcuni li velli ricchi di carboni , soprattutto verso il fondo (3). Lo svuotamento del pozzetto ha consentito il recupero di 95 manufatti in se lce, molti d~i quali alte rati dal f uoco, alcune centinaia di frammenti ceramici, molto minuti, e resti di una mandibola di Sus. Sparsi un po ' ovunque. sono stati rinvenuti , inoltre, frustoli di concotto.
Pozzetto 2 Di forma subci rcolare, era posto a circa 120 cm dal piano di campagna. lJ diametro
mass imo era, come nel caso precedente, di c irca 160 cm. La parte superiore risultava notevolmente compromessa dalle arature che av·evano disperso in un raggio abbastanza vasto resti di argille limose nerastre. Il riempimento , rappresentato da argille limose nerastre, ulig inose, ricche in materia organica, con frequenti carboni soprattutto nella parte più bassa, formava un live llo lenticolare spesso nella parte mediana circa 20 cm e che si abbassava lateralmente in una buca a tronco di cono rovesciato de l diametro di circa 20 cm e profonda altrettanto (fig. 2). A differenza di quello del pozz.etto l , i l riempimento stesso era relativamente indifferenziato. T materiali , resti ceramici e manufatti li tic i. era dispersi uniformemente. Anche qui mo lti e lementi in selce presentavano tracce di fuoco ed erano pure frequenti frustoli di arg illa cotta.
LA CERAMICA (L.F.)
Pozzetto l I frammenti ceramici del Pozzetto l ammontano ad alcune centinaia (fig. 3). Si tratta per
lo più di frammenti minuti di cui solo in pochi casi è poss ibile 1 'attribuzione a forme specifiche. La ceramica è di impasto generalmente fine a superfici per lo più nere o rosse o grig io-nerastre. Sono stati inoltre raccolti frammenti vari di pareti in ceramica figulina a superfici abrase, di impasto giallo o giallo rossiccio non attribuibili a precise forme vascolari .
Tra le fo1me identificabili , vi sono tazze carenate ad alto collo a pareti concave (P l-P5) n·a cui un frammento con decorazione a motivi lineari appaiati a solcature (P3), c iotole a calotta sfe1ica (P9), una ciotol ina carenata (P7) ed una emisferica ornata da una lieve sol.catura sotto il bordo mTotondato (P8). I vasi su piede sono anestati da due frammenti (P l O, P l l ). Le anse sono a nastro e un frammento presenta un tubercolo (P1 4).
(3) Il riempimento del pozzetto è stato oggello di una sotto! esi d i Laurea irì Scienze N murali presso I"Universilà degli Stud i di Milano e de lla quale si trascrivono 4ui le concl usioni: Sulla base dello studio geo-pedologico è possibile condudere che 4UCSIO pOZZCilO è StatO utilizzato come buca di scarico [ ... ]. J. processi che ne hanno portato al riempimento sono l'altermu·si di apporti attificiali d i maleria le ricco in sostanza organica e l'accu mulo gravitativo di materiale derivante dalla degradazione o dal crollo delle pareti de lla buca. Questo è in antitesi con quanto af'fennaro da CALEGARI N al. (1989) che interpretano i pozzetti neolitici come catini di drenaggio posli al di sono della pavimentazione della capanna. successivamente riempi tesi per il crollo de lla capanna stessa andata in disuso. Se così fosse dovremmo 1rovarci d i fronte ad un riempimento del pozzello strutturato in maniera ben d iversa, con un livello profondo completamente ste rile. segui lo da un unico grosso livello di materiale alll ropico chiusoeventuahncnte da una nuova deposizione di materiale sterile. Non si rileva ali" interno del pozzello alcun rivestimento argilloso, infatti il passaggio dal livello A 15 al livello C è graduale: viene quindi scartata anche l'eventuale ipotesi di utilizzo del pozzetto come silos (G EROSA, 1989-90: 36-37).
lOO-
( ' J C) .. · llJ l
P1 P2
i 'l
u ~ ..
' PS l ~
P3 (/
~-l
P6 ' ' l
P7
IV.J ~~(' .
'
P8
P4 pg
-G -~ 1
l l
P11 P12 P13 P10
\ . l (} ' l •
P16
P14 P15
o 5
P17 ~
P18 P19
Fig. 3 - Valer. Lndustria ceramica del Pozz~tto l (P I-Pl4) e del Pozzetto 2 (Pl5-P 19)( l :3)(dis . R. Giacometti P i va).
- 101
Tra i manufatti ceramici vi è da segnalare una rondella a contorno irregolare con foro centrale (fusarola?) ricavata da un frammento di parete di vaso (P l2).
Poz:etto 2 La ceramica è del tutto analoga a quella del pozzetto precedente (fig. 3), compresa la
ceramica figulina, ma di gran lunga meno abbondante. Anche qui è rappresentata da frammenti minuti non riconducibili a forme precise. Gli unici elementi riconoscibili sono un frammento di tazza carenata con tubercolo sulla carena e una linea verticale «a chicchi di grano» impressi (P 15) ed una ciotolina troncoconica a pareti relativamente spesse(P 16). Vi sono inoltre un 'ansa a nastro con tubercolo (Pl 9) ed una decorata con un motivo a solcature appaiate disposte a zigzag (P I8).
THE FLINT ASSEMBLAGE (P.B. and B.A.V.)
The mai n characteri stics of the fl in t asse m blage from the two pits excavated a t Valer (figs. 4 and 5) are displayed in table l below. Ali the artefacts are obtained from nodules of exotic materia!, the source ofwhich is most probably in the Lessini Hills, north ofVerona, some 150 kms west of the si te.
Table l
Flint artefacts 97 lnstruments 11 Unretouched artefacts with traces of wcar 3 Unretouched artcfacts 71 (complete) (16) (brokcn) (55) Cores Microburins Burin spalls Rejuvenations
l
Pitl Burnt Corte x
34 (35.05%) 17 ( 17.52%) (9.09%) 4 (36.36%)
l (33.33%) 3 ( 100.00%) 3 1 (43.66%) IO ( 14.08%)
l (100.00%)
Pit2 Bumt Cortex
65 17 (26. 10%) 17 (26.10%) 13 3 (23.07%) 5 (38.46%)
l 48 13 (27.09%) 12 (25.00%)
(16) (32)
2
l (100.00%)
The industry has bee n described according t o the typological list of G. LAPLACE ( 1964) (table 2).
Cores (N) Only one small , bumt specimen of subconical, bladelet type, struck on one si de, with one
prepared platfonn (F15).
Burins (B) This class is represented by two burins on a side notch, with latera! blows, from Pit l (F l )
and Pit 2 (F I7) respectively. They both have been employed in some kind of wood-working.
102-
-o (.N
Table 2
TYPOLOGY
86 enc prox dext d/-Smi.Smd
T3 rect [Apd] Bc2 [Smd+Smi] Bc2 [Spd+Spi]
Gm8 [T3 eone d+ T3 ree t d]
LO LO LO Ll [Smd sen]
Ll [Smd bil]
Ll [Smi dext] LI [Smi dext]
Ll [Smi dext pan]
D2 [Sma med]
I elass
Bs B6 enc prox dext i.B6enc med sen d-DI [Api] Gl
G 1/.Smi prox sen
G2/-Smd bil T I obl rect [Amd]
T1 obl rect [Amd]/.Smd bil T2 rect [Apd]/.Spd sen
T2 rect [Apd part]
Bc2 [Apd+Apd]
LO L1 [Smi dext prox]
R l la t [Smd bi l]
Rllat [Sma]
R3 bitra [Spd]
Mbdist
Mb dist
TooL FUNCTI0:-1 HAFTIKG REJUVEN. COLOUR (CODE EXPOLAIRE) LENGTH W lOTH THICKJ\ESS COND. CORTEX BURNT FIG. PIT
Burin on a side notch Wood working
Truneation
Y? N N N N N N N N N
Borer
Borer Rhomboid
Unretouched biade Unretouched biade
Unretouehed biade
Retouched biade
Retouched biade
Retouched biade
Retouched biade Retouched biade
Dentieulated scraper
Subeonical core
Burin spali Burin on a side notch
Endscraper
Endscraper
Endscraper
Truncation
T runcation
T runcation
Trunéation
Borer
Unretouched biade
Retouched biade
Side scraper
Side scraper
S id e scraper
Microburin
Microburin
Bore soft wood Wood working
Cut medium soft
Cut wood Cut wood
Scrape soft wood
Cut hard! wood both sides
Serape soft wood both sides N
Serape wood N
Cut med.ium soft N
Work hard Cut wood
Serape soft wood
Serape soft wood
Cut wood
Serape soft wood
Cut wood
Sickle
Boring medium soft
Cut soft
Cut wood
Work hard wood
N N N N
N N y
N y
N y y y
N y y
Bumisher? abrasion-striation N
N ? N
N 890 very light grey 43
N 14
N C81 light grey 13 N E72 brown 19
N C81 light grey 24 N 23
N El4 weak red 18
N B90 very light grey 18
N C81 light grey 39
N B90 very light grey 33 N C72 pale yellow 22
N C81 light grey 9
N D8llight brownish grey 26
N F90 dark grey 40
N 22
N C42 light reddish brown 27
Y 052 light brown 54
N 34
N E6 l dark greyish brown 33
N E72 brown 65
N DIO grey 23
N E90 grey 40
N 35
N E34 reddish brown 25
N 890 very light grey 22
N C81 light grey 17
N 072 yellowish brown 17
N C8J Jight grey 32
N C l O light grey 27
N 41
N C52 pinkish grey 26
N B90 very light grey 19
12 IO 5
IO IO 12
Il 13
12
13
l3 14
9 13
3 1
6 30
14
14
13
9 8
17
28
IO 9 9
16
19
39 12
18
4 F 2 F
2 F 2 F 2 c 2 F 3 F 4 F 3 c 4 F 3 F 4 F 3 F 2 F
17 F
5 c 11 F
3 c 4 c 5 c 5 c 2 c 7 F
5 F 3 F l F 2 F 4 c 6 c
12 c 2 F 4 c
N N N N N y y y y y
N y y
N N N N N y
N N y y y
N N y
N N y
N N
N y N N N y
N N N N N N N N y
N N y
N N N N y
N N N N N N y
N N
Fl Pl
F2 P l F3 Pl
F4 P l FS Pl
F6 Pl
F7 P l FS Pl
F9 Pl
FIO Pl
FII Pt Fl2 P1
Fl3 Pl
Fl4 Pl
Fl5 Pl
Fl6 Pl
F17 P2
Fl 8 P2
Fl9 P2
F20 P2
F21 P2
F22 P2
F23 P2
F24 P2
F25 P2
F26 P2
F27 P2
F28 P2
F29 P2
F30 P2
F31 P2
F32 P2
l
t WW t
l
F10
F14
l
l l
F1
l 1CHW
t
ssw t,
~ F2
I CM S l
- . l , l l
FS
F11
BSW
:'&: f l l
F3
l l
tCW
F7
F15
t-
F4
l
~. l
F12
\
ssw ' l
- l
1CMS
F13
FS
F9
Fig. 4 - Valer. Flìnt instruments from Pit l. Burin (F I ), Truncatìon (F2), Borers (F3 and F4), Rhomboìd (F5), Unretouched blades (F6-F8), Retouched blades (F9- 13), Denticulate (F I4), Core (FI 5), Burìn spali (F I6) ( l : l ) ( drawn by G. Almerigogna).
104 -
F21
H
F17 1
l
F26
ssw 1 l
l
tCS
F22
F30
H
H F27
ssw ---
-\_ F18
s
F23
\
tCW
F31
l
l
F28
l l
WHW ;'
ssw --.... '
H 'c w l
F19
F20 BMS
F25
rt L
:~-· / . .. - -
/ H ~·-
' F29
F32 Fig. 5 - Valer. Flint instnunents from Pit 2. Burin (F l7), End-scrapers (F I8-F20), Truncations (F21-F24), Borer
(F25), Unretouched biade (F26), Retouched biade (F27), Side scrapers (F28-F30), Microburins (F3 l and F32) (1 :1) (drawn by G. Almerigogna).
- 105
Fl is a double instrument with opposite blows, while F17 has a complementary, alternate, simple retouch. One burin spall with traces of wear al so comes from Pit l (Fl6).
End-scrapers (G) Three instruments from Pit 2. Two are bladelets - - long, specimens, used for scraping soft
wood (Fl8 and F I9). The third is on a long, narrow bladelet, with simple, marginai , bilatera) retouch (F20). This latter had been hafted and used for cutting wood.
Truncations (T ) One specimen from Pit l and four from Pit 2. Two are marginai, oblique, on narrow
bladelets (F2 1 and F22); two are norma l on a biade (F23) or a long biade (F24), one is oblique (F2). Two have been used on wood (F22 and F23), while F24 is a hafted sickle.
Borers (Be) The assernblage includes three straight borers on bladelets, two frorn Pit l (F3 an d F4) and
one from Pit 2 (F25), obtained with simple or abrupt, marginai retouch. Two have been used in wood-working (F3 and F4); F25 had been ernployed forpierc ing rnedium-soft materials such as untreated hides.
Geometrics (Gm) Only one rhomboid obtained with two oblique truncations, from Pit l (F5).
Retouched b/ades (L) The rnost comrnon instruments. Five come from Pit l (F9-FI 3) and one from Pit 2 (F27).
As some unretouched bladelets, these tools have mainly been used in wood working.
Denticulates (D) From Pit l comes one denticulate scraper on a bJadelet obtained with simple, marginai,
alternate retouch (F I4).
Side scrapers (R) Three instruments, ali frorn Pit 2. Two, obtained with a simple, marginai retouch, have
been hafted. and used for working wood (F28 and F29). The third has deep, bilatera! retouch, on a corticated flake, poss ibly used as a burnisher (F30).
Microhurins (Mb) Two distai microburins, bot h from Pit 2 (F3 l and F32), one of which (F32) with uncertain
traces of wear.
CoNSIDERATIONS
The flint assemblage frorn Valer is typical for the early Neolithic of the area. I t consists of instruments mainly obtained from blade lets and narrow bladelets struck from subconical
106-
cores of exotic, Lessinian provenance. It is composed of burins on a side notch, Jong end scrapers with abrupt front. straight borers, rhomboids and truncations obtained with the microburin technique. The strongest affin ities are to be sought in the flint industry from the
. ~
=
52
Il
=
51 /
~' /
53 5 4
, 55 (2 =
Il
-~ / '
:
= .~
" /
. :. <tZZJ -..
/
56 57 ' /
58 Fig. 6 - Valer. Industria l i t i~.:a non scheggiata (dis. E. S1amini).
-107
1974 excavations at the nearby site of Fagnigola (BIAGI, 1975; FERRARI and PESSINA, 1992: 25). The rnicrowear analysis suggests that the rnost common usage ofthe chipped stone was t o work wood, both h arder and softer species. Again, this type of usage is typical of the early Neolithic of the area and noted for example in the case of the assernblage frorn Fagnigola (under study by Voytek). The activities represented by the chipped stone assemblage (table 3) do not suggest site specialization. Rather, they fall with in a broad spectrum of tasks and functions, including rnanufacture and maintenance of wooden tools, handles, vessels, and equipment. ln brief, although the chipped stone assemblage is relatively small, its functional range is notably neolithic.
Table 3 cut scrape bore work totals
wood 6 2 9 soft hard l swood 5 6 hwood 2 grain l l msoft 2 1 3 plus l polisher/burnisher
L'INDUSTRIA LITI CA NON SCHEGGIA T A (E.S.)
Si compone di 77 reperti in rocce varie, di cui 69 provenienti dal Pozzetto 2, per un totale di gr 1843, 7 dal Pozzetto l, per un totale di gr 269, ed l frammento di aneJlone in pietra levigata
gr 700
eoo
500
400
300
200
100
50
M2
0 PIT1
fL1 PIT 2
5 4
72
o ~------~L--U~A+L-~~~r---~~4----L~~--~~~-----=~+---~~~
A B c D E F G H
Fig. 7 - Valer. Quantificazione ponderale dei litotipi rinvenuti nei pozzetti: A) quarzo, B) quarz ite, C) arenarie, D) siltite, E) calcari, F) mame, G) rocce silicee, H) diaspri (dis. E. Starnini).
108--
raccolto in superficie (fig. 6). L' insieme è composto principalmente d i frammenti piuttosto informi di ciottoli , le cui
superfici, quando rimaste, sono spesso naturali (tab. 4). Inoltre, la maggior parte dei pezzi ha subito un 'esposizione al fuoco, causa pri ne i pale della loro frammentarietà nonché dell 'alterazione delle superfici, e che spesso rende diffici le il riconoscimento petrografico (4).
Tabella 4
SrRun URA DtscR 17.10NE ROCCIA PESO gr Lxlxs (nun) Fuoco FtGURA
P l ciouolino sferoidale quarzo N
P l c iouolino informe quarzi te l N P l fr. informe arenaria 18 s P l fr. di ciottolo ovaleggiante con depre1-isioni coppelliformi arenaria 115 (57)x40x32 S Sl
P l fr. di utensile con 2 incisioni lineari con sezione a V arenaria 42 (53)x30x2 1 N S2
P l fr. di ciottolo quarzi te 58 N
P l fr. di ciottolo arenaria 34 s P2 6 fr. di c iottoli arenar ia 70 s P2 fr. informe rnarnct 5 s P2 l'r. di ciottolo quarzite 43 s P2 fr. el i cionolo calcare n s P2 3 fr. dì lista. 2 con cortice diaspro 35 s P2 fr. eli CÌOIIOIO quarzi te 5~ s P2 2 fr. di c iottolo calcare 44 s P2 fr. infonne a superfici erose si ltìte 8 N
P2 fr. di c iot'lolo arenaria 54 N
P2 8 fr. di ciouol i . 2 con superficie piatta calcare 125 s S3 P2 7 l'r. di ciottol i sil tite 108 s P2 fr. d i ciottolo calcare 59 s P2 fr. inJorrn c quarzi te 83 s P2 fr. di c iottolo con un tratto d i super fic ie piatta calcare rnarnoso 4 1 (54)x(46)x( l7) S S4
P2 fr. di ciottolo arenaria 15 s P2 fr. d i ciottolo con l faccia pialla m·enaria 62 (63)x(28)x34 S S5
P2 4 fr. di ciottoli calcare 83 s P2 2 fr. di ciottolo qmu·zite 73 s P2 fr. di ciottolo con l faccia pialla calcare marnoso Il s P2 2 f r. d i ciottolo arenaria a cemento argilloso 190 s P2 fr. eli ciottolo con l faccia piatta arenaria 23 (42)x(33)x(26) S S6
P2 2 fr. di ciottolo quarzite IlO s P2 ciottolo c ilindrico a superfic i erose sil tite 43 N S7
P2 5 fr. di ciottoli arenaria 43 s P2 fr. di lista con cortice diaspro 37 s P2 7 fr. di ciottolo arenaria 94 s P2 2 fr. eli ciottolo calcare 19 s P2 fr. di ciottolo arenaria quarzosa 37 s P2 ciouolo ovaleggiante arenaria 94 60x26x26.5 S
P2 ciottolino scheggiato con superfic i eolizzate selce grigia 4 N
P2 fr. di ciotto lo quarzite microcristall ina 104 s Su p fr. di anellone in pietra levigata n sezione triangolare scrpentìnite 23 (62,5)x24x I l s S8
(4) Sj ringrazia il prof. T. Mannoni deU ' Universi L~ di Genova per aver gentilmente eseguito la clctem1 inazione dei
litotipi .
- 109
Il itotipi più rappresentati a livello ponderate , sono l'are naria, generalme nte a grana fine, il ca lcare e la quarzi te microcris tallina (fig. 7). Sono presenti anche alcuni frammenti di rocce si licee (selci-diaspri), spesso fratturati dal fuoco, c he pur non ave ndo tracce di scheggiature intenzionali . sono probabilmente connessi con l'approvv ig ionamento di litotipi per la lavorazione de ll'industria scheggiata. Gli unici re perti ri conducibili con una certa sicurezza a manufatti sono un frammento di probabi le affilato io. in are naria f ine e dura, che presenta due incis ioni lineari con sezione a « V» su due delle facce (S2), prove niente dal Pozzetto l. Sempre ne lla medes ima s truttura è stato rinvenuto un ciotto lo frammentario, anch'esso in arenaria fine e dura, con quattro depressioni coppelliformi piuttosto ravvic inate su di una delle facce (S l). Purtroppo le superf ic i sono molto alterate dall'esposizione al fuoco, per cui eventuali tracce
d ' uso risult ano illeggibi li . De i nume rosi ciottoli frammentari prove nienti dal Pozzetto 2, 5 presentano una superficie
di lavoro piana. 2 sono in arenaria fine e 3 in calcare (S3-S6). Il tipo d i roccia utilizzato esclude
il loro impiego per lo sfariname ntode i cereali , per i quali sono necessari macineecontromacine ricavate in are narie a g rana più grossa. Sempre ne l Pozzelto 2, è s tato raccolto un ciotto lo ci lindrico (S7). il c ui stato d i alterazione cleJJe supe rf.ic i impedisce di valutare se abbia o meno
subito una lavorazione intenzionale . Infine. dalla supe rfic ie del s ito, proviene un frammento eli ane llone in serpentinite levigata, a sezione triangolare (SR) (FERRARI e P ESSINA, 1992: 40) de l
tipo A l della T ANDA ( 1977). Questo manufatto, sottoposto acl anal isi in sezione sottile (Appendi x l ), rappresenta un ' ulteriore testimonianza de lla c ircolazione a largo raggio delle rocce verdi durante il Neolitico (D ' AMICO et al., 199 1 ). La diffusione degli anellon i in pietra
levigata che è documentata dal Mieli della Francia (COURTI c G uniERZ, 1976) alla Pianura Padana (TA DA, 1977), raggi unge ad oriente il Friuli, com 'è docume ntato anche dai ritrovamenti di Sammardenchia (UD) (FERRARI e PESSINA, 1992; D ' AMICO e FELICE, 1994).
Nuovi dati a disposizione documentano la lavorazione in s i tu di questi manufatti in alcuni insecl iamenti de lla Cultura del Vhò, come Brignano Frascata (AL ) (STARNINI, 1993), Travo, Casa Gazza (PC) (BERNABò BREA, 1992) e Vhò, Campo Ce resole (CR) (BIAGI, com. pers. 1992).
Non s i può quindi escludere che gli anelloni venmssero prodotti localmente con materia prima
di imporl'az ione.
CONSIDERAZIONI GENERALI (P.B. e L.F.)
Il complesso portato alla luce ne i due pozzetti d i Valer è c hiarame nte da att ribuire ad un momento del primo Neolitico de lla Pianura Friulana. Interessanti ratfronti presentano sia l'i ndustria litica che quella ceramica. L ' industria su sclce scheggiata d i Valer, o ttenuta inte rame nte su c iottoletti s ilicei di provenie nza esotica , con ogni probabilità Veronese, trova de i confronti s tringenti nei reperti degli scavi cle l1 974 nel vicinissimo sito di Fagnigola (BIAGI, 1975). I confronti sono comunque leggennente m eno precisi, ma pur sempre molti attinenti, con le industrie in se Ice degli altri s iti de l Neolitico antico de l Friuli, pe r quanto s ia da notare come complessi litici interamente alloctoni s iano pe r ora conosciuti solo nel Pordenonese (Vale r e Fagnigo la appunto) oltre che lungo i margini della Laguna di Marano (FERRAI{! e
PESSIN A, 1992: 47). L ' insieme de i repert i fittili messo in luce nei due pozzctti comprende forme vasco lari che,
IlO -
pur non essendo precisamente identiche, indubbiamente ri chiamano quelle dei complessi caratteristici della Cultura di Fiorano (M ALA VOLTI, 1951-52). In particolare, tazze carenate con decorazioni incise, lineari, appaiate e «a chicchi di grano» e bugnette sull'ansa a nastrÒ, sono tipologicamente molto vicine a quelle della C ultura citata. Reperti fittili di questo tipo, in Friuli, sono stati recentemente raccolti anche nel sito di Sammardenchia di Pozzuolo (PESSINA, com. pers. 1994) oltre che nei pozzetti scavati a Fagnigola di Azzano Decimo nel 199 l (BAGOLINI et al.; 1993: 50); recipienti carenati relativamente simili , o con decorazioni affini, sono note anche a Nogaredo al Torre (UD) (PESSINA, 1993: 51). Da due dei siti citati, FagnigolaeSaminardenchia (FERRARI e PESSINA, 1992: 35; 42), provengono anche frammenti di recipiente su piede cavo simili a queUi raccolti nella stazione in esame.
Interesse particolare rivestono le datazioni radiometricheeseguite su campioni di carbone vegetale dei due pozzetti di Valer. Il Pozzetto l è infatti stato datato a 6504±59 BP (B ln-4431) e6400±200 BP (Bin-4432); mentre il campione del Pozzetto 2 ha restituito una data di 6557±71 BP (Bin-4436). Nel quadro generale, non ancora molto chiaro, del primo Neolitico del Friuli si tratta del.le due datazioni più antiche, dato che gli altri due siti datati, Fagnigola e Sammardenchiahannofomitorisultati inquadrabili verso la fine del settimo millennio BP, inizi di quello successivo (BAGOLINI e BIAGI, 1990: 12), sempre che la data R-.1545A (5760±160 BP) sia accettabile, cosa di cui al momento pare lecito dubitare. Se le date di Valer sono attendibili , cosa che si potrà verificare moltiplicando le analisi con campioni da altri pozzetti , si verrebbe a colmare una lacuna nell'assetto della cronologia dei più antichi insediamenti neolitici del Friuli. Sappiamo oggi che il Gruppo di Vlaska (o dei Vasi a Coppa) del Carso Triestino, iniziò a manifestarsi intorno alla metà , o poco prima, del settimo millennio BP. Le datazioni di tre focolari sovrapposti recentemente scavati nella Grotta dell'Edera di Aurisina (TS) (BIAG! et al., 1994), sono probanti in questo senso. L 'affermarsi del Gruppo di Vlaska sarebbe quindi contemporaneo ai primi momenti della Cultura di Danilo (MOLLER, 1991; BI AGI, 1994: fig. l ) lungo la costa Dalmata, di cui, in effetti, non rappresenta altro che la punta espansiva più settentrionale si nora conosciuta.
La situazione del primo Neolitico del Friuli, non astante gli scavi degli ultimi anni, è tuttora non molto chiara, o almeno molto fluida, per una serie di fattori, quali: l) le caratteristiche dei siti stessi, in cui sono state riconosciute, almeno sinora, solamente strutture a pozzetto di dimensioni modeste; 2) le difficoltà causate dalla natura dei suoli che non permettono la conservazione di resti faunistici e rendono spesso difficile la ricostruzione dei reperti fittili; 3) la scarsità di scavi in siti posti in immediata vicinanza del mare; 4) la mancanza eli scavi in accampamanti mesolitici Castelnoviani all'aperto; 5) la mancanza di s iti attribuibili cronologicamente alla prima metà del sesto millennio BP e conseguentemente l 'impossibilità della loro attribuzione culturale.
Il più antico Neolitico della regione, almeno così com 'è noto dai materiali degli scavi sopracitati, si differenzia nettamente da quello Cars ico. Le affinità più chiaramente definibili, almeno per quanto riguarda le industrie litiche ed alcuni prodotti vascolari, sono con la Valle Padana. Fra questi ultimi vanno ricordati alcuni recipienti specifici, le tazze carenate con bugnetta sull 'ansa a nastro, che si avvicinano molto a quelli di Fiorano ma che, nel caso di Valer, rendono più complesso il quadro generale in quanto sono cronologicamente più antichi dei prodotti classici della Cultura, così come si presenta in Emilia e nel Veneto. È chiaro, d'altra parte, come molte altre delle caratteristiche vascolari e, in particolare gli stili ornamentali molto variati , fra cui figurano anche colorazioni in rosso e in nero a Sammardenchia (FERRARI e
- 111
P ESSINA, 1987-9 1: 34). siano del tuuo estranee al primo Neolitico della Valle Padana. Particolare interesse riveste anche la presenza, a Valer, d i carioss idi di due varietà di
frumento c di una di orzo domestico (CARUGATI, 1.994). Un 'ulteriore dato che, unitamente a quelli forniti dai reperti della cultura materiale, ci informa delle caratteristiche g ià del tutto pienamente neolitiche cie li ' insediamento.
APPENDIX l
RISULTATI DELL'ANA LISI DEL FRAMMENTO DI ANELLONE IN PIETRA LEVIGATA (C.O.)
I l manufatto (S8) è stato ricavato da una pietra di colore verde chiaro a venature nerastrc. scistosa, con forte patina g iallastra. Pre!)cnta una struttura fortemc.:nle deformala c p lissettata, con predominanza di g ranu lazione su S2. Le componenti. determinate microscopicamente e in XDR. sono risultate essere le seguent i: antigorite (ca. 70°/n). c lorite poco ferrifera tipo pennina-clinocloro (ca. 20%) e magneti te (m. l Oo/c). La c lorite è lepido-diablastica. a s ua volta defonnata. La magnetite è sgranulara ne lla scisrosità. L ·antigorite fom1a la matrice c associazioni di lamine pseudomorfiche su fantasmi d i minerali protolitici (pirosseni?). La pietra è definibile <.:ome Serpcntinoscisto antigorit ieo-cloritico. Le provenienze possibili sono molteplici. dalle Uni1:1 pcnnidichedellc.: Alpi occidentali . centrali , orientali. Solo uno studio comparalo da impostare può dare conclusioni più precise. Tuttav ia il serpcntinoscisto è decisamente diverso da altre scrpcntùùt i già csmninate tra i manufaui trcntini (probabile provenienza: Alpi orientali, Alpi T auri) c tra 4uclli di Sammardenchia (UD) (provenie nza supposta: area Canavese-Aostana).
112-
B I B L IOGRAFIA
BAGOI.INI, B. e BIAGI, P. 1990 - The Radiocarbon Chronology ofllw Neolitlricand Copper Age ofNorthem ltaly. O x ford Journal of Archaeology. 9 (l): 1-24.
BMìOUNI. B .. CARUGATI, M.G .. FERRAI< l, A. e PESSINA. A. l 993 - Fagnigula Bosco Mawova (A::ano DecillloPordenone). Noti:ie preliminari sull'intervento dell991 . Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, VII: 47-64.
BERNAUÒ BREA, M. 1992 - l primi agricoltori. Tipolito Farnese, Piacenza. BIAGI, P. 1975 - Stmione neolitica a Fagnigola ( A::ano Decimo-Pordenone). Rela::ione preliminare dello scm•o /()74.
Annali dell'Università di Ferrara. Nuova Serie, Sezione XV, Il (6): 247-269. BI AGI. P. 1994- Alnmi aspe/li del Mesolitù·o nel Friuli e nel Carso Triestino. Ani della XX l X Riunione Scìentifica
deii'I IPP (in stampa). BIAGI. P., STARNINI, E. e VoYTEK, B.A. 1994-The late Mesolithic an d early Neolithic selflement ofnorthem lwly: recent
comiderations. Porocilo o raziskovanju palcolita, neoliw in eneolita v Sloveniji, XXl (in stampa). CAILLEUX. A. e TAYLOR. G. nel- Code E.rpolaire. N. Boubée, P<u·is. CALEGARI. G., SIMONio, L. e TINÉ, S. 1989 - Ricostm::ione sperimentale di 11110 capanna del neolitico antico. ln
lnterprera:ione ji111zionale dei <<fondi di capanna>> di età 'preistOrica: 9-14. Casamara, Genova. CARVGATl, M.G. 1994- Nota sui resti vegetali carhnni:zati del sito neolitico di Valer (A z::ano Decimo-Pordenone J.
Alti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, VIli : 11 5-1 20 CouRTIN, .1 . e GuTHER7 .. X. 1976 - Le.\' hracelets de pierre du Néoli11iique méridional. Bulletin de la SocJctc
Préhistorique Française. 73: 352-369. D'AMICO. C., BAR<.ìOSsl, G.M., FELICE. G. e MAZZEO. M. 1991 - Giade ed eclogiti in pielra lel'tgalLt. Studio
Petroarclteomctrico. Mineralia Petrografica Acta, XXXIV: 257-283. D' AYIICO. C. e FELICE, L. 1994 - Petroarclu!ometria di reperti neolitici di Sammardenchia (Udine). Atti della XXIX
Riunione Scientifica deii'IIPP (in stampa). FERRARI. A. e PESSINA, A. 1992 -Considera:ioni sul primo popolamento neolitico del t areafi-iulano. Atti della So~ lei<\
per la Preis1oria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia. VI: 23-60. GEROSt\, A. 19'?39-90-Analisi sedimemologiclte e pedologiche di un po::ello neolitico di Az::ano Decuno ( Fmtli ). Te~i
di Laurea discussa all'Università di Milano. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Nawrali. Corso di Laurea in St:ienze Naturali (inedita).
LAPLACE. G. 1964 - Essai de typologie systématique. Anmùi dell'Università di Ferrara. Nuova Serie, Sezione XV, Supplemento U <ù Volume l: 1-82.
MA LA VOLTI, F. 1951-52 - Appnllti per ww cronologia relativa del Neo-eneolitico Emiliano. Emilia Preromana, l Il : 3-
28. Miri.LER, J. 199 1 -Di e Ostadriatische lmpresso-Kultur: Zeitlicfte Gliedemng nn d kulturel/e f:inhillllitn~. Gem1ania,
69 (2): 311-358. PESSINA. A. 1993-Si ti preistorici a Nogaredo al Torre. Quaderni Friuhmi di Archeologia. Ili : 39-53. STARNINI, E. 1993 - L'industria litica. In PANTÒ. G. (ed.) Archeologia della Valle del Curone. Quaderni della
Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Monografie. 3: 31-42. TANDA. G. 1977 - Gli anelloni li t ici italiani. Preistoria Alpina, 13: l L 1- 155.
Indirizzo degli Autori: LEONE FASAN I, Dipartimento di Scienze della TeJTa dell'Università di Mi lano, Via Mangiagalli 34 - I-20133 MILANO PAOLO 8.1 AG l. Dipartimento di Scienze Storico-Archeologiche e Orientalistiche dell 'Università di Venezia, Palazzo Bernardo, S. Polo 1977A - 1-30 125 VENEZIA CLAUDIO D'AMICO. Dipartimento di Scienze Mineralogiche dell'Universitàdi Bologna. Piazza Porta S. Donato 1-l-40126 BOLOGNA ELISABETTA ST ARNTN1, Soprintendenza Archeologica della Lombardia. Via E. De Amicis l l - l-20 123 MILANO BARBARA A. VOYTEK, Archeologica! Research Facility, Department of Anthropology of the University of Californ ia at Berkeley - USA - CA94720 BERKELEY
- 113























![Odorikův cestopis a cyklus fresek o umučení čtyř františkánů v indické Tháně [Odoric of Pordenone and the frescos on the martyrdom of four Franciscans in Thāna (India)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633336fcb94d6238420216a8/odorikuv-cestopis-a-cyklus-fresek-o-umuceni-ctyr-frantiskanu-v-indicke.jpg)



![Bl. Odorik z Pordenone - 680 let od smrti († 14. ledna 1331) - prezentace [Bl. Odoric of Pordenone - 680 years since his death († 14 January 1331) - A presentation]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323300061d7e169b00cf6f6/bl-odorik-z-pordenone-680-let-od-smrti-14-ledna-1331-prezentace-bl.jpg)

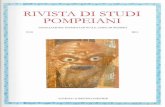



![Esame autoptico preliminare ascia-martello [Ginosa - TA]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6323eff6078ed8e56c0b191f/esame-autoptico-preliminare-ascia-martello-ginosa-ta.jpg)




