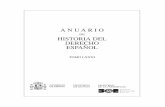Ordini religiosi, spazi urbani ed economici nella Calabria Spagnola
Transcript of Ordini religiosi, spazi urbani ed economici nella Calabria Spagnola
La Calabriadel viceregno
spagnolostoria arte architettura
e urbanistica
LaCalabria
delviceregnospagnolo
storiaarte
architetturaeurbanistica
t ,www.gangemieditore.it
a cura di
Alessandra Anselmi
Il volume è l’esito di un progetto di ricerca sulla Calabriadel viceregno spagnolo – considerata come parte di unsistema più vasto quale la Monarchia Cattolica – che hacoinvolto, a livello internazionale, studiosi di diversaformazione e appartenenza. I contributi spaziano dallastoria alle identità sociali, dai patriziati urbani allecomunità religiose, comprendendo l’attività produttiva,l’architettura, la scultura, la pittura e la miniatura (lettealla luce del contesto culturale che le ha prodotte, ma congrande attenzione anche all’analisi stilistica e filologica),l’urbanistica e il restauro. La Calabria vicereale, luogocruciale di transito e di scambi, spesso anche diincursioni, emerge come un crocevia da cui si diramanopercorsi e vicende che la collegano al resto d‘Italia, alMediterraneo e all’Europa. Il confronto interdisciplinareha messo in luce gli aspetti vitali e creativi di un periodostorico, tra Rinascimento e Barocco, travagliato, mamolto vivace culturalmente, politicamente e ancheeconomicamente, che ha prodotto importantissimimonumenti, opere d’arte e testi letterari, che non sempre,anche a causa della mancanza di studi, sono valorizzati etutelati come meritano. In questa nostra epoca di conflittie di tensioni, di relativismi esasperati, di identità aperte eincerte, i saggi qui presentati, oltre a gettare luce sulpassato, contribuiscono a far riflettere, sotto molti puntidi vista, anche sul presente: su quanto gli scambi e gliincontri tra culture diverse possano risultare arricchenti.
ALESSANDRA ANSELMI insegna Storia dell’Arte Moderna pressol’Università della Calabria ed è specializzata nello studio deirapporti tra l’Italia e la Spagna in epoca moderna. Oltre anumerosi saggi su riviste italiane e straniere, tra le sue principalipubblicazioni Il Palazzo dell’Ambasciata di Spagna presso laSanta Sede, Roma, De Luca Editore, 2001; Il diario del viaggioin Spagna del cardinale Francesco Barberini scritto da Cassianodal Pozzo, Madrid, Doce Calles, 2004 e la cura del volumeL’Immacolata nei rapporti tra l’Italia e la Spagna, Roma, DeLuca Editori d’Arte, 2008.
copertina calabria:Layout 1 30-11-2009 14:55 Pagina 1
Indice
PRESENTAZIONI
HANS GERT PÖTTERINGPresidente del Parlamento Europeo 11
SANDRO BONDIMinistro per i Beni e le Attività Culturali 12
LUIS CALVO MERINO
Ambasciatore di Spagna presso la Repubblica Italiana 13
GIOVANNI LATORRERettore dell’Università della Calabria 14
MICHELANGELO TRIPODIAssessore all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria 15
WANDA FERROPresidente dell’Unione Province Calabria 16
FABIO DE CHIRICOSoprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria 17
GREGORIO CARRATELLIPresidente del FAI Calabria 18
MARIO BOZZOPresidente della Fondazione Carical 19
INTRODUZIONE
Alessandra Anselmi 21
STORIOGRAFIA E STORIA
LUIS RIBOT Italianismo spagnolo e spagnolismo italiano 37
GIUSEPPE GALASSO La Calabria spagnola 47
GIUSEPPE CARIDI La Calabria nei secoli XVI e XVII: politica, territorio, società 55
FAUSTO COZZETTO Cosenza e i suoi Casali nella prima età spagnola 69
FRANCESCO CAMPENNÌ Giuristi per la patria dottori in utroque nelle élites urbanedella Calabria spagnola 83
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:27 Pagina 7
IDENTITÀ REGIONALE
GIOVANNI MUTO Identità regionale e memorie cittadine nella Calabria spagnola 115
ANTONIO BATTISTA SANGINETO L’origine della costruzione dell’identità calabrese:XVI-XVII secolo 127
VITO TETI Gian Giacomo Martini e Uluccialì alias Kiliç Alì Pasha: aspetti dellacostruzione dell’identità calabrese tra XVI e XVII secolo 139
LA CALABRIA E NAPOLI NELLE ARTI VISIVE
JOAN LLUÍS PALOS La Calabria e l’immaginario dei viceré: i dipinti di BattistelloCaracciolo nel Palazzo Reale di Napoli 173
DIANA CARRIÓ-INVERNIZZI La Calabria del secolo XVII agli occhi dei viceré di Napoli 187
IDA MAURO La presenza della Calabria negli apparati per le feste napoletane 199
LE FAMIGLIE NOBILI: CERIMONIALE, POLITICA E COMMITTENZA
ANTONELLO SAVAGLIO Ordine gerarchico e conflittualità tra le famiglie del patriziatodi Cosenza tra Cinquecento e Seicento 217
FRANCESCA MARTORANO Territorio e città nella politica dei Carafa di Roccellae degli Spinelli di Seminara e Ricca, tra Cinque e Seicento 227
ROSSANA SICILIA Giovan Battista Spinelli conte di Cariati 249
CHIARA MICELI I Firrao di Luzzi tra la Calabria e Napoli 261
FABIO DE CHIRICO La committenza artistica di Gregorio Carafa (1615-1690)tra la Calabria e Malta 281
ARCHITETTURA, SCULTURA, PITTURA EMINIATURA
SIMONETTA VALTIERI La Calabria nel Rinascimento e il Rinascimento in Calabria 303
FRANCESCO NEGRI ARNOLDI Antonello Gagini per le chiese di Calabria 321
FRANCESCO CAGLIOTI-LUIGI HYERACE Antonello Gagini e le tombe Carafa di Castelvetere 337
ANDREA SPIRITI Cosimo Fanzago da Bergamo a Serra San Bruno: influenze e problemi 387
FRANCESCO ABBATE Aspetti della pittura della Controriforma in Calabria 405
MARIO PANARELLO La pittura del Seicento in Calabria tra manierismo, naturalismoe classicismo 421
FRANCESCO GATTA Un inedito dipinto di Gregorio Preti: il Cristo mostrato ai giudeida Ponzio Pilato 473
ALESSANDRA ANSELMI L’iconografia della Madonna del Rosario nella Calabria spagnola 487
CARMELA PORCO Pergamene miniate nella Calabria del Cinquecento 519
ORDINI RELIGIOSI: STORIA, ARTE E ARCHITETTURA
ELISA NOVI CHAVARRIA Ordini religiosi, spazi urbani ed economici nella Calabria spagnola 537
MAGGIORINO IUSI La breve parabola di un convento agostiniano: Santa Maria delle Graziea Pianette di Rovito 547
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 1-12-2009 20:03 Pagina 8
ROBERTO BANCHINI Francescani e Minimi: architetture in Calabria tra XVI e XVII secolo 559
DARIO PUNTIERI La chiesa cinquecentesca della certosa di Serra San Bruno 593
ORNELLA MILELLA I Gesuiti e la Calabria: tipologie religiose nell’architettura calabresetra XVI e XVII secolo 611
FRANCESCA PASSALACQUA Città e architettura dei Domenicani nella Calabria del viceregno 631
ATTILIO SPANÒ Aspetti dell’architettura e dell’arte cappuccina nella Calabria del Seicento 647
LA CALABRIA E GENOVA: LA COMMITTENZA ARTISTICA
LAURO MAGNANI Nobili, artisti, santi: percorsi tra Genova e la Calabria 663
ANDREA LEONARDI Affari e preghiere di seta: i Sauli devoti hombres de negociostra Genova e la Calabria del viceregno 681
MARGHERITA PRIARONE I Ruffo di Calabria, medici e collezionisti nella Genova del Seicento 703
LAURA STAGNO La fortuna a Genova e in Liguria delle iconografie legate all’immagineacheropita di San Domenico di Soriano 719
IL SISTEMA DIFENSIVO E PRODUTTIVO
MIRELLA MAFRICI L’architetto e il territorio: la politica difensiva spagnola in Calabria 741
BRUNO MUSSARI Il cantiere della fortificazione di Crotone: fonti, architettura,protagonisti, eventi 759
GREGORIO E. RUBINO Le “Regie Ferriere di Stilo”: genesi e struttura di un villaggioprotoindustriale in età vicereale 781
URBANISTICA E RESTAURO ARCHITETTONICO
BRUNELLA CANONACO La composizione urbana della città di Cosenza tra il XVIe il XVII secolo 795
FABRIZIO AGGARBATI La riqualificazione urbana dei centri storici: l’esempio di Cosenza 805
STEFANO GIZZI Interventi di restauro sulle architetture del periodo vicerealetra Campania e Calabria 819
GINO MIROCLE CRISCI-CATERINA GATTUSO-ANNA MARIA DE FRANCESCO-DOMENICO MIRIELLO Le calcareniti del centro storico di Cosenza: uso e provenienza 841
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:27 Pagina 9
Scopo di questo contributo è quello di mettere in lu-ce il ruolo che nella Calabria di età spagnola ebberogli Ordini religiosi, maschili e femminili, nel ridise-
gnare gli spazi urbani e nel sollecitare, a livello territoriale, si-gnificative forme di indotto economico nel settore edile, del-le professioni e dei servizi.A questo scopo siamo partiti da due considerazioni preli-
minari, che possiamo ritenere entrambe ormai acquisite ne-gli studi di settore. La prima riguarda il rapporto tra istitu-zioni ecclesiastiche e comunità cittadine, nel loro intrecciocon i poteri e i ceti dirigenti locali e la configurazione delleidentità municipali in un interscambio che va molto oltre ildato del radicamento religioso e della peculiare offerta di ser-vizi sacerdotali1. Essa deriva dall’istanza, da tempo determi-natasi negli studi di storia socio-religiosa, di condurre la sto-ria della religiosità popolare ai suoi nessi con la storia della so-cietà civile, individuando lo specifico della dimensione reli-giosa in relazione a tutto il concreto inserimento sociale di cuie in cui vive2. La seconda analizza il rapporto tra istituzioniecclesiastiche e territorio in un’ottica diversa da quella tradi-zionale, che aveva prodotto una immagine assolutamente ne-gativa di conventi e monasteri quali istituti dediti esclusiva-mente a consumi parassitari e passivi percettori di rendite.Quella immagine, fortemente condizionata da tutta la pole-mica gravante sulla “questione meridionale” e il mancato svi-luppo del Mezzogiorno d’Italia, oltre che dalla ulteriore pole-mica anticlericale3, ha di fatto ostacolato a lungo l’individua-zione della rete di relazioni precipue che definivano ruolo eattività di conventi e monasteri all’interno della loro specifi-ca organizzazione complessiva. Senza voler comunque esclu-dere dal nostro orizzonte cognitivo la consapevolezza di quan-to abbia pesato sulla vita economica e sociale delle popola-
zioni calabresi in età moderna il condizionamento dei privi-legi e delle esenzioni dei Regolari, il drenaggio di risorse eco-nomiche verso scopi improduttivi attraverso il fenomeno del-le donazioni e dei legati pii, vorremmo ora tentare di analiz-zare oltre gli aspetti ‘negativi, anche quelli ‘positivi’ della loropresenza, non nel senso etico della parola, come è ovvio, maper le relazioni economiche più “moderne” che essi pure han-no potuto sollecitare4.Partiamo allora da un dato che ci sembra assolutamente
incontrovertibile, ovverosia la rilevanza acquisita, in età spa-gnola, da molti complessi conventuali nella conformazioneurbanistica della maggior parte dei centri urbani della pro-vincia e del Regno, grazie alla ricchezza architettonica e arti-stica conseguita con il denaro proveniente dalle donazioni edai lasciti dei fedeli. Si trattò di un processo che avvenne qua-si sempre per l’iniziativa di famiglie delle élites e di gruppi di-rigenti locali, intenti ad estendere o a rafforzare i propri am-biti di controllo su spazi urbani e spazi religiosi. Ma in gene-rale esso avvenne per il concomitante processo di promozio-ne dei culti e di rafforzamento del reticolo istituzionale, por-tato avanti dalla Chiesa nella lunga età della Controriforma.Al pari delle dimore signorili o delle “case palaziate”, conven-ti e monasteri rappresentarono uno dei fattori maggiormen-te in grado di determinare la trasformazione della forma urbise degli spazi politici ad essa connessi. I nuovi insediamenti, el’adeguamento dei più antichi ai nuovi canoni dell’architet-tura barocca, promossero quasi sempre un processo di valo-rizzazione urbanistica complessiva dell’area in cui erano ubi-cati, modellarono le città, delineando nuovi percorsi e nuovegerarchie all’interno degli spazi urbani5.Per la Calabria il caso più noto è rappresentato dall’archi-
tettura di chiese e collegi dei Gesuiti. Ne siamo edotti grazie
537
ELISA NOVI CHAVARRIA
Ordini religiosi, spazi urbani ed economici nella Calabria spagnola
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 537
soprattutto agli studi di Ornella Milella, che ha ricostruito inmaniera puntuale non solo le fondazioni, i progetti, le tipo-logie costruttive, le strategie insediative, spesso controverse edai difficili esordi, della Compagnia nella regione, ma ha ri-levato anche come in molti casi la costruzione del Collegio ge-suitico abbia contribuito a conferire prestigio urbanistico atutta la città calabrese cinque-seicentesca, o a un intero quar-tiere, ponendosi al centro di essa e della rete insediativa deiRegolari. Sin dalla fase progettuale, infatti, grande importan-za veniva attribuita dai vertici romani della Compagnia allaindividuazione di un sito quanto più vicino alla cattedrale.Così fu, ad esempio, per il primo insediamento dei Gesuiti aReggio, situato in un’area centrale della città, nei pressi dellachiesa madre e a una adeguata distanza dall’area di influenzadegli Ordini Mendicanti, davanti la cui fabbrica fu creato unoslargo che mutò la viabilità della intera zona. Così fu ancheper il collegio di Cosenza, per il quale la scelta cadde nell’areadella Giostra, nel cuore del quartiere principale della città; peril collegio di Catanzaro che, dopo una destinazione provviso-ria, trovò la sua ubicazione definitiva a sud del colle di SanGiovanni, dove con la sua presenza finì con il valorizzare l’in-tera area circostante6; a Monteleone, dove la costruzione delcomplesso gesuitico contribuì non poco allo sviluppo econo-mico e sociale in generale, e delle arti e delle maestranze loca-li in particolare7.Rilevante era anche la presenza dei Domenicani, che negli
anni Trenta del Seicento avevano in Calabria 39 priorati e 48vicariati con 626 frati e 28.795 ducati di rendita, parte dellaquale era stata e sarà investita ancora negli anni a venire in la-vori di costruzione e ristrutturazione degli edifici conventua-li8. Rispetto alla ben più modesta edilizia parrocchiale locale,le loro chiese e conventi si imponevano per l’architettura fon-data quasi sempre su un disegno e un progetto specifici, ope-ra per lo più di valenti architetti. Il convento dei Domenicanidi Grotteria, per esempio, era – si legge nella relazione del-l’ingegnere Gallarano del 1707 – «di buona forma con chio-stro compartito a pilastri di taglio del paese»9.Considerata, comunque, la ramificata presenza degli
Ordini regolari in tutta la regione, gli esempi al riguardo pos-sono essere assai più numerosi. Contiamola, dunque, questapresenza. Particolarmente affini alle inclinazioni e alla men-talità delle popolazioni rurali del Mezzogiorno, i Francescaniavevano da tempo costruito nelle due province di CalabriaCitra e Calabria Ultra una rete insediativa senz’altro fitta. NelCinquecento la loro presenza ebbe un nuovo impulso con la
istituzione del movimento della Osservanza e la fondazionedi oltre settanta conventi già alla fine di quel secolo: deiTerziari Regolari Francescani (39 conventi); dei fratiCappuccini (85 conventi)10; dei Minimi (53 fondazioni alladata del 1649)11. Alla fine del Settecento la loro presenza, inparticolar modo quella dei Cappuccini, continuava a esserediffusissima per ogni dove12. Per i Carmelitani il maggiore svi-luppo in Calabria si verificò negli anni a cavallo tra Cinque eSeicento, allorché in poco più di quaranta anni furono aper-ti 28 conventi13. Si consideri poi la nascita dei nuovi Ordini,come i Teatini, con sedi a Cosenza (1624) e a Catanzaro(1632), e gli Agostiniani Scalzi, che alla metà del Seicento ave-vano in Calabria conventi a Tropea (1619), Monteleone(1620) e a Lago (1632).A prescindere dall’importanza dei luoghi, e stando alla opi-
nione espressa dagli stessi periti dell’epoca, si trattava moltospesso, a volte anche nei minori centri urbani, di una edilizia“di eccellenza”. A detta dell’ingegnere Ascanio Raitano, peresempio, che redige la sua perizia nel 1659, gli Agostiniani diMorano Calabro avevano una chiesa «piccola assai bella», conun altare maggiore «di buonissima architettura»; molto benfatta veniva accreditata anche la chiesa dei Celestini diTerranova e «di tutta politia», ovverosia armonica e ben ordi-nata14. Alla metà del Seicento la chiesa dei Teatini diCatanzaro era considerata «una delle più belle fabbriche chesiano non solo nella Città, ma nella Provincia tutta»15.La maggior parte di questi insediamenti sorgeva nei centri
abitati o nella loro immediata periferia, nelle vicinanze delleporte della città. A Filogaso, per esempio, i Domenicani vi-vevano «nel principio dell’abitato»16. A Cropani il conventodei Cappuccini sorgeva poco distante dal paese, «in luogomolto delizioso, con bellissime fabbriche e con una famosa li-braria»17. Ai confini della terra di Gioiosa si ergevano i con-venti dei Francescani dell’Osservanza e dei Domenicani18. Nel1643, Nicotera contava 2.000 abitanti e sei insediamenti diRegolari: nel centro della città si trovava il convento di SantaChiara dei padri Zoccolanti; ai piedi del castello vi era quellodi Santa Caterina dei Celestini; sotto la pedementina un con-vento di Francescani; e, fuori l’abitato, vi erano i conventi deiDomenicani della SS. Annunziata e quello di S. Maria delleGrazie dei Minimi, dove erano in corso lavori per la costru-zione di «un bellissimo claustro a quattro ale»19.I conventi dislocati fuori i centri abitati erano spesso sede
di ospedali o fungevano anche da ospizi per i viaggiatori. Cosìera per quello degli Agostiniani Scalzi di Lago, diocesi di
538
ELISA NOVI CHAVARRIA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 538
Cosenza, dislocato lungo la strada pubblica; per il conventodi San Carlo, a Castiglione, sorto essenzialmente come sededi transito per i religiosi diretti in Sicilia; per quello diMonteleone, che appariva “grande e isolato”, situato lungouna strada percorsa da mercanti, che divenne per la sua stes-sa collocazione topografica una sede strategica per tutta l’e-conomia del territorio20.La saldatura tra istituzioni conventuali e società civile si
realizzava così non solo sul piano della devozione o della par-tecipazione alla vita religiosa, che – come è noto – tra le po-polazioni della Calabria, e in genere di tutto il Mezzogiorno,fu vissuta con particolare intensità, ma anche nella configu-razione complessiva delle identità locali. Nella percezione deiluoghi, l’imponenza e la bellezza di chiese e conventi e dei lo-ro elementi di arredo architettonico, le loro molteplici fina-lità e funzioni costituivano un elemento distintivo della im-magine di una città, intorno al quale si coagulava anche il sen-so di appartenenza delle comunità21. Ciò appare particolar-mente evidente nel caso dei monasteri femminili, entro le cuimura si raccoglievano i rami femminili delle famiglie del pa-triziato locale, cui le famiglie di origine versavano cospicuerendite e per ciò stesso divenuti simbolo dell’onore e dellevirtù di quelle stesse élites cittadine22. L’introduzione dellenorme sulla clausura, stabilita dal Concilio di Trento, gerar-chizzò ulteriormente le forme del reclutamento delle religio-se, ma ebbe anche un forte impatto sulla riorganizzazione de-gli assetti urbanistici in seguito alla nascita dei nuovi istitutivicini allo spirito della Controriforma. Alla metà del Seicento,monasteri femminili sorgevano un po’ ovunque nella regio-ne, anche in molti centri urbani minori, come a Grotteria, aCastelvetere, a Maida e a Chiaravalle23. A Nicotera, il mona-stero delle monache di Santa Chiara si ergeva nella piazzaprincipale della città, accanto alla cattedrale. In esso erano ac-colte donne cittadine e “forastere”, previo il versamento diuna dote di 200 ducati24. Nel monastero di Santa Maria laSanità di Terranova, dove nel 1647 risiedevano 24 monache,la dote prevista era di 400 ducati25. A Gerace, i monasterifemminili erano tre: quello intitolato a Sant’Anna, che nel1647 ospitava 20 religiose e 25 educande; il monastero di SanPantaleo con 20 religiose e il monastero della SS.maAnnunziata che accoglieva altre 15 religiose26. A Catanzaro,alla metà del Cinquecento, all’antico monastero delle Clarissedi Santa Chiara si aggiunsero due nuove istituzioni di mona-che Clarisse, il monastero di Santa Maria Maddalena e quel-lo di SantaMaria della Stella, e la comunità delle Domenicane
di Santa Caterina27. Nelle città calabresi maggiori, certamen-te a Cosenza e aTropea, dove queste realtà sono state più stu-diate, la selezione delle domande di accesso al chiostro era ba-sata su regole rigide, basate sull’appartenenza a determinaticlan familiari e la possibilità del pagamento di una dote piut-tosto alta28.Un tale “affollamento” istituzionale femminile degli spazi
cittadini era dovuto essenzialmente a due motivi. Il primo ri-guarda la soppressione dei conventi femminili extra-moenia,disposta dalle norme del Concilio, che concluse un secolareprocesso di inurbamento delle istituzioni ecclesiastiche fem-minili accentuandone il carattere cittadino. Il secondo ri-guarda la necessità per tutte le comunità monastiche di ade-guarsi alla regola che li voleva all’interno delle mura cittadi-ne, ma al contempo isolate dal contesto urbano. Vi si portòriparo un po’ ovunque mediante l’acquisizione dei fabbricaticircostanti il monastero, la costruzione di recinti murari, l’ap-posizione di scuri e battenti alla finestre, dispositivi che tra-sformarono i conventi in una sorta di cantiere edile perma-nente. Nel 1579 le clarisse di Cosenza abbandonarono l’anti-ca sede extra muros, aprendo un nuovo monastero nelle im-mediate vicinanze della Giostra Nuova, del palazzo arcive-scovile e della cattedrale, nella stessa area dove, negli anni suc-cessivi, a pochi metri di distanza da Santa Chiara e dall’altromonastero femminile delle Vergini, si insediarono anche ilcollegio e il convento dei padri Gesuiti. L’intera zona diven-ne allora – ha scritto Fausto Cozzetto – un triangolo ecclesia-stico urbano di forte rilievo e un importante strumento dellapolitica locale29, oltre che un laboratorio per il mercato del la-voro cittadino.Per tutta l’età spagnola una intensa attività edilizia, pro-
mossa dagli enti ecclesiastici sia maschili che femminili inte-ressò i centri urbani anche di medie e piccole dimensioni del-la Calabria. Decisivo fu, in molti casi, l’apporto economico eil patrocinio dei feudatari locali, esercitato spesso anche ver-so più di una istituzione, allo scopo di proiettare sull’interospazio cittadino la sfera d’influenza del proprio casato. Nel1667, per esempio, la duchessa di Monteleone, GeronimaPignatelli, lasciò ai padri Domenicani della città 500 ducatiper la fabbrica del convento; altri 250 ducati intestò ai padririformati di Sant’Angelo per la fabbrica della sacrestia della lo-ro chiesa e altrettanti 250 ducati donò ai frati Cappuccini peril riattamento dei locali della infermeria del convento30.Nel 1649, anno in cui data il testo dell’inchiesta sullo sta-
to dei Regolari in Italia promossa dal papa Innocenzo X, era-
539
ORDINI RELIGIOSI, SPAZI URBANI ED ECONOMICI NELLA CALABRIA SPAGNOLA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 539
no in corso lavori di ristrutturazione in tutti i conventi degliAgostiniani Scalzi della Calabria. A Monteleone i Padri ave-vano comperato case, palazzi, giardini circostanti e chiuso duestrade per adattare il tutto a forma di monastero. Dopo annidi lavori, erano ancora impegnati nella “sfabricazione” degliimmobili acquisiti e avevano ultimato solo una parte del dor-mitorio. Anche a Lago la realizzazione del convento era an-cora incompleta, e a Tropea i Padri erano impegnati a cam-biare la destinazione d’uso di alcune vecchie case in refettorioe alloggio per i forestieri in transito31. Alla stessa data, iCappuccini del convento dell’Immacolata Concezione diCosenza prevedevano lavori di ampliamento per la costruzio-ne di nuovi locali per l’infermeria; a Rossano e a Castrovillariavevano abbandonato i vecchi insediamenti, per trasferirsi nelcentro abitato dove stavano costruendo dei nuovi ospedali32.In quegli stessi anni altri cantieri erano aperti presso i conventidei Minimi a San Marco, Stilo, Altomonte, Rossano,Castrovillari, Anoia e Monteleone33; presso quelli deiCarmelitani a Monteleone, Sambiase, Corigliano, Tropea,Satriano, Motta San Demetrio, Lungo, Catanzaro, Sieri,Palmi e Amantea34 e nei conventi degli Agostiniani diCastelmonardo e Maierato35.Il catastrofico terremoto che la sera del 27 marzo 1638 ave-
va colpito la Calabria, radendo al suolo 23 centri abitati e ar-recando innumerevoli danni in moltissimi altri, vi aveva cer-to messo del suo, rendendo praticamente inagibili molti diquei complessi e inevitabili, quindi, i lavori di consolidamen-to e adeguamento delle fabbriche. Ma in certi casi fu propriol’opera di ricostruzione avviata dai religiosi a riqualificare queiluoghi e a renderne possibile il ripopolamento. Sant’Eufemia,che era stata praticamente cancellata dal terremoto – ove sor-geva prima l’abitato si era formato un bacino lacustre36 – furicostruita di lì a poco dai Cavalieri dell’Ordine di Malta, chel’avevano in feudo, in un luogo più elevato, a circa mezzo mi-glio dal mare e dall’antico insediamento, intorno al fortilizioche costituì la loro nuova sede e intorno al quale essi fecerocostruire le abitazioni per i vassalli sopravvissuti al terribile si-sma. La Torre di Malta svolse ancora per molti anni funzionimilitari difensive del territorio, specie per l’avvistamento deiTurchi lungo la costa, facendo sì ché il territorio non andassedesertificato37.In Calabria finalità analoghe, di difesa e valorizzazione del
territorio, ebbero anche molte altre istituzioni religiose. ACrotone, per esempio, i Minimi avevano costruito il loro con-vento a forma di torre per rifugiarvisi insieme alla popolazio-
ne del luogo in caso di un attacco dei pirati barbareschi sullacosta. Lo stesso dicasi per i frati Minimi di Roccella, la cui se-de era stata concepita «in modo di una torre serrata», con ot-to celle disposte su due piani e le officine al piano terra38.Un’opera di valorizzazione del territorio fu anche quella
che portò gli Agostiniani Scalzi di Tropea a sistemare, accan-to al loro convento intitolato alla Madonna della Libertà, unbel giardino con pergolati e alberi da frutta con «una pischie-ra d’acqua viva per adacquare le verdume»39. Alla metà delSeicento fuori la città di Terranova si ergevano il monasterodi Sant’Agostino «ornato di famosi boschetti, giardini dilet-tevoli e vigne amene» e quello dei padri Zoccolanti «partico-larmente bello, con boschetti e formaletti d’acqua correnti ebone», che venivano raccolte in una grande vasca di pietra peressere utilizzate sia nel lavoro dei campi che per gli usi perso-nali dei padri40. Se da un lato le opere di canalizzazione delleacque servivano a valorizzare le proprietà degli Ordini, dal-l’altro – non bisogna dimenticarlo – la sistemazione del terri-torio a scopi produttivi costituiva anche una risorsa e una op-portunità di lavoro per la gente del luogo.Conventi e monasteri costituivano, infatti, delle unità eco-
nomiche, centri di produzione, oltre che di consumo, e di ri-distribuzione delle risorse finanziarie e materiali prodotte a li-vello locale. Intorno a essi ruotavano interi comparti del la-voro contadino (braccianti, viticoltori, giardinieri) e operaio(lavoratori edili, fornitori, magazzinieri), ma anche il vastomondo delle professioni e del terziario: avvocati, notai, me-dici, artigiani, falegnami, piastrellisti, intagliatori, cucitori,sarti, calzolai, tutti debitamente presenti nelle liste di paga-mento dei monasteri. Si tratta di quei settori e di attività chedi norma qualifichiamo come funzioni urbane, molti dei qua-li, specie nei minori centri urbani della Calabria, e delMezzogiorno in generale, erano alimentati proprio dalla pre-senza di un complesso conventuale. I Chierici RegolariTeatini di Catanzaro, per esempio, nel 1649 denunciavanouna spesa annua di 50 ducati per medici e medicine e di altri60 ducati per l’acquisto di biancheria e mobilia41. Persino nel-la più piccola comunità di Lago, in Calabria Citra, gliAgostiniani Scalzi del convento di S. Maria degli Angeli fo-raggiavano la micro-economia locale spendendovi circa 100ducati l’anno per abiti, mantelli, sandali e biancheria e altridieci ducati in medicine e “cose di spetiarie”42.Si pensi, inoltre, alle varie forme di indotto economico da
quello che oggi definiremmo il settore del “turismo religio-so”43. Il Calabria il caso più eclatante è quello del convento di
540
ELISA NOVI CHAVARRIA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 540
San Domenico Soriano. Sorto nel 1510, in una zona strate-gica per i traffici commerciali, esso divenne uno dei santuaripiù visitati e più ricchi d’Europa da quando, nel 1530, vi erastata rinvenuta una immagine miracolosa del Santo, verso laquale cominciò ad indirizzarsi il flusso dei fedeli e delle lorocospicue donazioni. Al fervore religioso che vi si raccoglievasi affiancò quello almeno altrettanto vivace indotto da fatto-ri economici. I pellegrinaggi dei fedeli non si esaurivano, in-fatti, nell’atto devozionale, ma diventavano una grande occa-sione di scambio commerciale e una formidabile opportunitàper gli addetti al mercato locale. Fuori la chiesa venivano ven-duti riproduzioni del quadro di San Domenico e libri sullasua vita e, in occasione della fiera che vi si svolgeva per duesettimane, tra il 25 luglio e il 5 agosto, si commerciavano an-che animali e seta di produzione locale. Stando a quanto ri-ferì un cronista del tempo, il Padre Silvestro Frangipane, nel1620 i pellegrini convenuti a Soriano in occasione della fierafurono tra i cento e i centotrentamila44.Altro polo di attrazione cultuale era il convento di San
Francesco di Paola e un gran numero di santuari mariani,disseminati un po’ in tutta la regione, tra città, aree rurali ezone di montagna. Ne ricordiamo alcuni: il santuario diSanta Maria delle Armi a Cerchiara, quello di Santa MariaOdigitria a San Basile, della Madonna del Pettoruto a SanSosti, di Santa Maria della Pietà a Monteleone45, dellaVergine di Romania a Tropea e della Madonna dellaConsolazione di Reggio, poli cultuali la cui fama andava benoltre i confini della regione, attraendo ogni anno un gran nu-mero di pellegrini la cui presenza contribuiva a dar vita a unavivace economia locale. I fedeli provenienti da lontano sog-giornavano, infatti, qualche giorno nel luogo dove si ergevail santuario, vi acquistavano di che nutrirsi e le provviste peril viaggio di ritorno, qualche manufatto locale, immaginettesacre, ceri ed ex-voto.Molti di questi pellegrinaggi assumevano una chiara di-
mensione taumaturgico-terapeutica. Nel territorio diMelicuccà si ergeva l’antica abbazia di S. Basilio, nelle cui per-tinenze si diceva fosse stato sepolto il corpo del Santo e allacui chiesa la gente del luogo, ma anche tanti pellegrini in viag-gio, portavano molta devozione e «se ne ricevono molte gra-tie – si legge in una relazione del 1629 – e per intercessione didetto Santo e suoi meriti non si sa mai che in questa terra vi
siano stati spiritati»46. A Nicastro, nella chiesa di Santa Mariadegli Angeli dei frati Cappuccini, vi era una effigie diSant’Antonio di Padova che dava lustro all’intera città «per lecontinue grazie e miracoli che da pochi anni in qua compar-tisce a suoi devoti» non solo del luogo, ma anche a quanti viaffluivano in pellegrinaggio il giorno della sua festa, «a’ segnoche non più Sant’Antonio di Padoa, ma di Nicastro l’invoca-no per le grazie che bramano e ne vengono tutti consolati»47.Ai confini della terra di Gioiosa, nella chiesa del convento deiDomenicani, si venerava una immagine miracolosa di SantaMaria delle Grazie, «quali anni addietro ha dispensato assais-sime a’ suoi devoti». Il 2 luglio, giorno della sua festa, vi si te-neva una fiera «con gran concorso di genti specialmente perla devozione grande a’ questa santissima immagine»48. Nel1535 la chiesa della Madonna del Castello, a Castrovillari, eb-be un ospite d’eccezione, l‘imperatore Carlo V reduce dal-l’impresa di Tunisi, che vi si recò in preghiera per renderleomaggio. Da allora il flusso di fedeli verso quel santuario eb-be nuovo impulso e nuovo slancio fu dato di riflesso dato atutto il territorio49.Certo tutto questo di per sé solo non poteva bastare a fare
di molti piccoli, a volte anche sparuti insediamenti conven-tuali dei fattori trainanti della vita economica della regione,né tanto meno invertire il rapporto di forze tra centro e peri-feria del regno o il peso del feudalesimo su territori e popola-zione. Molti degli elementi che abbiamo, seppur sintetica-mente, tentato di delineare costituirono, però, parte inte-grante nella organizzazione dello spazio economico, sociale epolitico della regione. Grandi o piccoli che fossero, i com-plessi conventuali di cui abbiamo parlato costituivano una“presenza economica” rilevante, pienamente funzionale allatenuta degli assetti territoriali in cui erano ubicati. Essi con-tribuivano a fornire svariati servizi, ma anche a sostenere ladomanda di prodotti e uffici, offrendo occupazione per laconduzione delle terre in loro possesso, come committenti dimaestranze locali e acquirenti di beni. In questo modo gliOrdini regolari assolvevano, oltre che alle più ovvie finalità re-ligiose, anche a funzioni assistenziali, imprenditoriali e di ri-distribuzione delle risorse, in una parola a funzioni economi-che ‘moderne’– come abbiamo cercato di dire50 – e, in defi-nitiva, quindi, a un processo di stabilizzazione complessiva delquadro politico generale.
541
ORDINI RELIGIOSI, SPAZI URBANI ED ECONOMICI NELLA CALABRIA SPAGNOLA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 541
ABBREVIAZIONI
ASNa = Archivio di Stato di Napoli.BNNa = Biblioteca Nazionale di Napoli.
NOTE
Immagine di apertura: sportello della Madonnadi Romania, 1704, argento lavorato, Tropea,Cattedrale, particolare.
1 Della vasta letteratura sull’argomento mi li-mito a segnalare per i monasteri femminili G.ZARRI,Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII), in Storia d’Italia, Annali 9, La Chiesae il potere politico dal Medioevo all’età contem-poranea, a cura di G. CHITTOLINI-G.MICCOLI, Torino, Einaudi, 1986, pp. 359-429, ora in G. ZARRI, Recinti. Donne, clausu-ra e matrimonio nella prima età moderna,Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 43-143 e, rela-tivamente al Regno di Napoli in età moderna,gli studi raccolti in La città e il monastero.Comunità femminili cittadine nel Mezzogiornomoderno, a cura di E. NOVI CHAVARRIA, Attidel Convegno di Studi, Campobasso,Università degli Studi del Molise 11-12 no-vembre 2003, Napoli, Esi, 2005. Sulle nuoveprospettive degli studi sugli Ordini regolarimaschili si rinvia al contributo di sintesi di F.RURALE,Monaci, frati, chierici. Gli Ordini re-ligiosi in età moderna, Roma, Carocci, 2008,anche per l’ottima bibliografia che vi viene ci-tata.2 Problemi storiografici e di metodo furonodelineati già da G. GALASSO, La storia socio-religiosa e i suoi problemi, in Per la storia socia-le e religiosa del Mezzogiorno d’Italia, a cura diG. GALASSO-C. RUSSO, Napoli, Guida, 1980,pp. IX-XXXI, ma se ne vedano ora ulterioriaggiornamenti in IDEM, L’altra Europa. Perun’antropologia storica del Mezzogiorno d’Italia,Napoli, Guida, 20093, pp. 385-401.3 Si tratta di un pregiudizio molto risalente neltempo e su cui si vedano gli studi raccolti daA. MUSI, Alle origini di una nazione.Antispagnolismo e identità italiana, Milano,Guerini e Associati, 2003.4 In tal senso si vedano soprattutto le indica-zioni che vengono dagli studi di F. LANDI,Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX, Roma, Carocci, 2005; IDEM, La globa-lizzazione dei regolari. Le dimensioni europee
della rete dei monasteri e dei conventi, in Clero,economia e contabilità in Europa.TraMedioevoed età contemporanea, a cura di R. DI PIETRA-F. LANDI, Roma, Carocci, 2007, pp. 147-155;G. POLI, L’anima e la terra nel Mezzogiornomoderno, Bari, Progedit, 2008. Per la storiadella Calabria in età spagnola il richiamo piùesaustivo è a A. PLACANICA, La Calabria in etàmoderna, 2 voll., Napoli, Esi, 1985-1988 e aG. GALASSO, Economia e società nella Calabriadel Cinquecento, Napoli, Guida, 19903. Ora siveda anche il contributo del medesimo Autorein questo volume.5 Cfr. E. NOVI CHAVARRIA, Sacro, pubblico eprivato. Donne nei secoli XV-XVIII, Napoli,Guida, 2009, pp. 77-88.6 Si vedano soprattutto O. MILELLA, LaCompagnia di Gesù e la Calabria. Architetturae storia delle strategie insediative, Roma,Gangemi, 1992; E. ZINZI, Insediamento gesui-tico in Calabria: aspetti architettonici, urbani-stici, territoriali, in I Gesuiti e la Calabria, Attidel Convegno, Reggio Calabria, Deputazionedi Storia Patria 27-28 febbraio 1991, a cura diV. SIBILIO, Reggio Calabria, Laruffa, 1992,pp. 177-310 ed il saggio di O. MILELLA pub-blicato in questa sede.7 Cfr. EADEM, La Compagnia di Gesù e laCalabria. Architettura e storia delle strategie in-sediative. I centri minori, Roma, Gangemi,2000, pp. 73 e sgg. Sulle strategie insediativedei Gesuiti, nelle città del Mezzogiornod’Italia, e i rapporti con gruppi di potere lo-cale si rimanda a B. PELLEGRINO, I collegi ge-suitici e la strategia della Compagnia nel Regnodi Napoli tra ‘500 e ‘600, in Alle originidell’Università dell’Aquila. Cultura, università,collegi gesuitici all’inizio dell’età moderna inItalia meridionale, Atti del Convegno interna-zionale di studi promosso dalla Compagnia diGesù e dall’Università dell’Aquila nel IV cen-tenario dell’istituzione dell’AquilanumCollegium (1596), L’Aquila 8-11 novembre1995, a cura di F. JAPPELLI-U. PARENTE,Roma, Institum Historicum S. J., 2000, pp.107-126. In particolare per Napoli cfr. C.BELLI, La fondazione del Collegio dei Nobili diNapoli, in Chiesa, assistenza e società nelMezzogiorno moderno, a cura di C. RUSSO,prefazione e introduzione di G. GALASSO,Galatina, Congedo, 1994, pp. 183-280.8 Per questi dati si rinvia a G. GALASSO,Economia e società nella Calabria delCinquecento cit., pp. 336 e sgg.
9 La testimonianza è riportata da G. LABROT,Quand l’historie murmure. Villages et campa-gnes du royaume de Naples (XVIe-XVIIIe siècle),Roma, École Française de Rome, 1995, p.161. Sull’architettura dei Domenicani inCalabria si vedano I Domenicani in Calabria:storia e architettura dal XV al XVIII secolo, acura di O.MILELLA, Roma, Gangemi, 2004 e,in questo volume, il saggio di F. PASSALACQUA.10 Cfr. F. RUSSO, Presenza francescana inCalabria in età moderna (sec. XVI-XVIII), inOrdini religiosi e società nel Mezzogiorno mo-derno, 2 voll., Atti del seminario di Studio,Università degli Sudi di Lecce 29-31 gennaio1986, a cura di B. PELLEGRINO-F. GAUDIOSO,Galatina, Congedo, 1987, I, pp. 257-267; F.F. MASTROIANNI, L’inchiesta di Innocenzo X suiconventi cappuccini italiani (1650). Analisi deidati, Roma, Pontificia Università Lateranense,1985; M. D’ALATRI, I conventi cappuccini nel-l’inchiesta del 1650, 3 voll., Roma, Istituto sto-rico dei Cappuccini, 1984-86.11 Per i Minimi si rimanda a M. CAMPANELLI,Gli insediamenti dei Minimi nel regno diNapoli fra XV e XVII secolo, in S. Francesco diPaola e l’Ordine dei minimi nel Regno di Napoli(secoli XV-XVII), Atti del primo Convegno perla celebrazione del quinto centenario dellamorte di S. Francesco di Paola (1507-2007),Napoli, Istituto Italiano per gli StudiFilosofici, 2007, pp. 143-184.12 Cfr. A. PLACANICA, La Calabria nell’età mo-derna cit., II, pp. 71 e sgg. Sulla particolarecorrispondenza tra il vissuto francescano e leinclinazioni e lo spirito delle popolazioni me-ridionali si veda G. GALASSO, L’altra Europacit., pp. 110 e sgg. Sulle ragioni della diffusio-ne dei Cappuccini nella società meridionale ingenere si veda pure A. PLACANICA, Il cappucci-no nel mezzogiorno in età moderna, in I fratiminori cappuccini in Basilicata e nel salernita-no fra ‘500 e ‘600, a cura di V. CRISCUOLO,Roma, Istituto storico dei Cappuccini, 1999,pp. 7-16.13 Cfr. E. NOVI CHAVARRIA, Insediamento econsistenza patrimoniale dei Carmelitani inCalabria e in Puglia attraverso l’inchiesta inno-cenziana, in Ordini religiosi e società nelMezzogiorno moderno cit., I, pp. 203-230.14 G. LABROT, Quand l’historie murmure cit.,p. 161.15 Cfr. I Teatini, a cura di M. CAMPANELLI,Introduzione di G. GALASSO, Roma, Edizionidi Storia e Letteratura, 1987, p. 59.
542
ELISA NOVI CHAVARRIA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 542
16 G. LABROT, Quand l’historie murmure cit.,p. 139.17 Cfr. G. FIORE, Della Calabria illustrata.Opera varia istorica, Napoli, Parrino eMicheleLuigi Mutij, 1691, p. 215.18 Ivi, p. 175.19 BNNa, Apprezzo di Nicotera,Ms. XV D 4,ff. 22 r-23 r.20 Cfr.Gli Agostiniani Scalzi, a cura e con sag-gio introduttivo di M. CAMPANELLI, Napoli,La città del sole, 2001, rispettivamente allepp. 347, 61, 70.21 Per le storie municipali calabresi si rimandaa F. CAMPENNÌ, Le storie di città: lignaggio e ter-ritorio, in Il libro e la piazza. Le storie locali deiRegni di Napoli e di Sicilia in età moderna, acura di A. LERRA, Manduria-Bari-Roma,Laicata, 2004, pp.69-107.22 Ho sviluppato tali considerazioni in E.NOVI CHAVARRIA, Identità cittadine, identitàdi ceto e monasteri femminili, in La città e ilmonastero cit., pp. 7-28.23 Notizie al riguardo si trovano in G. FIORE,Della Calabria illustrata cit., rispettivamentealle pp. 174, 176 e sgg. e 186.24 BNNa, Apprezzo di Nicotera, Ms. XV D 4,ff. 22 r – 23 r.25 ASNa, Archivi privati, Serra di Gerace,Appendice, 19/I, f. 3 v.26 Ivi, 19/II, ff. 215 e sgg.27 Cfr. A. PLACANICA, La Calabria nell’età mo-derna cit., II, p. 187.28 Cfr. F. COZZETTO, Il monastero di S.Chiara a Cosenza. Sodalizio urbano e proie-zioni nell’hinterland, in La città e il monaste-
ro cit., pp. 105-122. Sulla struttura esclusi-va dei monasteri femminili di Tropea si ve-da F. CAMPENNÌ, La patria e il sangue. Città,patriziati e potere nella Calabria moderna,Manduria-Bari-Roma, Laicata, 2004, pp.328 e sgg.29Cfr. F. COZZETTO, Il monastero di S. Chiaraa Cosenza cit., pp. 115 e sgg.30 L’episodio è citato da G. LABROT, Quandl’historie murmure cit., p. 160.31 Cfr. Gli Agostiniani Scalzi cit., p. 70.32 Cfr. F. F. MASTROIANNI, L’inchiesta diInnocenzo X cit., pp. 65 e sgg.33 M. CAMPANELLI, Gli insediamenti deiMinimi cit., pp. 154 e sgg.34 Cfr. E. NOVI CHAVARRIA, Insediamento econsistenza patrimoniale dei Carmelitani cit.,pp. 212 e sgg.35 Cfr. F. ACCETTA, L’Ordine agostiniano e lecongregazioni di osservanza in Calabria (secoliXV-XIX), in «Analecta Augustiniana», 67,2004, pp. 183-254.36 Cit. E. NOVI CHAVARRIA, I “tremuoti” dellaCalabria del 1638, in «Prospettive settanta»,3-4, 1985, pp. 362-377.37 Cfr. P. SPOSATO, Per la Storia delBrigantaggio nella Calabria del Settecento.Episodi di malvivenza a Nocera feudo ecclesia-stico del baliaggio gerosolimitano diSant’Eufemia, Roma, Collezione meridionaleEditrice, 1968.38 Si vedano le testimonianze riportate da M.CAMPANELLI,Gli insediamenti dei Minimi cit.,pp. 153 e sgg.39 Cfr. Gli Agostiniani Scalzi cit., p. 362.
40 ASNa, Archivi privati, Serra di Gerace,Appendice, 19/I, f. 3 v.41 I Teatini cit., p. 364.42 Gli Agostiniani Scalzi cit., p. 353.43 Cfr. Per una storia del turismo nelMezzogiorno d’Italia. XIX-XX secolo, a cura diA. BERRINO, Napoli, Istituto per la Storia delRisorgimento Italiano, 2001.44 Cfr. A. PLACANICA, La Calabria nell’età mo-derna cit., II, pp. 307-335. Sul culto di SanDomenico a Soriano si veda inoltre qui stessoil saggio di L. STAGNO.45 In quest’ultima località il potere taumatur-gico era riconosciuto all’olio della lampadache ardeva davanti all’immagine dellaMadonna posta nella chiesa degli AgostinianiScalzi. Cfr. Gli Agostiniani Scalzi cit., p. 74.46 ASNa, Real Sovrano Ordine di Malta,Cabrei, 49, f. 17 v.47 Cfr. G. FIORE,Della Calabria illustrata cit.,p. 125.48 Ivi, p. 175. Sulla dimensione taumaturgico-terapeutica della festa e dei pellegrinaggi nel-la religiosità popolare meridionale si rinvia aG. GALASSO, L’altra Europa cit., pp. 129-150.49 Cfr. M. CAMPANELLI, Feste e pellegrinaggi nelXVI e XVII secolo, in Storia del Mezzogiorno,Aspetti e problemi del medioevo e dell’età mo-derna, 12 voll., a cura di G. GALASSO-R.ROMEO, Napoli, 1991, IX/2, pp. 483-507.50 Sul concetto di “presenza economica” si ve-dano le considerazioni di G. POLI, La presen-za economica della Chiesa nell’Italia meridio-nale durante l’età moderna, in Clero, economiae contabilità in Europa cit., pp. 185-225.
543
ORDINI RELIGIOSI, SPAZI URBANI ED ECONOMICI NELLA CALABRIA SPAGNOLA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 543
FONTI ARCHIVISTICHE
ASNa, Archivi privati, Serra di Gerace, Appendice.ASNa, Real Sovrano Ordine di Malta, Cabrei, 49.BNNa, Apprezzo di Nicotera,Ms. XV D 4.
BIBLIOGRAFIA
ACCETTA, F., L’Ordine agostiniano e le congregazioni di osservanza inCalabria (secoli XV-XIX), in «Analecta Augustiniana», 67, 2004,pp. 183-254.
BELLI, C., La fondazione del Collegio dei Nobili di Napoli, in Chiesa, as-sistenza e società nel Mezzogiorno moderno, a cura di C. RUSSO, pre-fazione e introduzione di G. GALASSO, Galatina, Congedo, 1994,pp. 183-280.
CAMPANELLI, M., Feste e pellegrinaggi nel XVI e XVII secolo, in Storiadel Mezzogiorno, Aspetti e problemi del medioevo e dell’età moderna,12 voll., a cura di G. GALASSO-R. ROMEO, Napoli, 1991, IX/2, pp.483-507.
CAMPANELLI, M., Gli insediamenti dei Minimi nel regno di Napoli fraXV e XVII secolo, in S. Francesco di Paola e l’Ordine dei minimi nelRegno di Napoli (secoli XV-XVII), Atti del primo Convegno per lacelebrazione del quinto centenario della morte di S. Francesco diPaola (1507-2007), Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici,2007, pp. 143-184.
CAMPENNÌ, F., La patria e il sangue. Città, patriziati e potere nellaCalabria moderna,Manduria-Bari-Roma, Laicata, 2004.
CAMPENNÌ, F., Le storie di città: lignaggio e territorio, in Il libro e la piaz-za. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna, acura di A. LERRA,Manduria-Bari-Roma, Laicata, 2004, pp.69-107.
COZZETTO, F., Il monastero di S. Chiara a Cosenza. Sodalizio urbano eproiezioni nell’hinterland, in La città e il monastero. Comunità fem-minili cittadine nel Mezzogiorno moderno, a cura di E. NOVICHAVARRIA, Atti del Convegno di Studi, Campobasso, Universitàdegli Studi del Molise 11-12 novembre 2003, Napoli, Esi, 2005,pp. 105-122.
D’ALATRI, M., I conventi cappuccini nell’inchiesta del 1650, 3 voll.,Roma, Istituto storico dei Cappuccini, 1984-86.
FIORE, G., Della Calabria illustrata. Opera varia istorica, Napoli,Parrino e Michele Luigi Mutij, 1691.
GALASSO, G., Economia e società nella Calabria del Cinquecento,Napoli, Guida, 19903.
GALASSO, G., La storia socio-religiosa e i suoi problemi, in Per la storiasociale e religiosa del Mezzogiorno d’Italia, a cura di G. GALASSO-C.RUSSO, Napoli, Guida, 1980, pp. IX-XXXI.
GALASSO,G., L’altra Europa. Per un’antropologia storica del Mezzogiornod’Italia,Napoli, Guida, 20093.
Gli Agostiniani Scalzi, a cura di M. CAMPANELLI, Napoli, La città delsole, 2001.
I Domenicani in Calabria: storia e architettura dal XV al XVIII secolo, acura di O. MILELLA, Roma, Gangemi, 2004.
I Teatini, a cura di M. CAMPANELLI, Introduzione di G. GALASSO,Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1987.
LABROT,G.,Quand l’historie murmure. Villages et campagnes du royau-me de Naples (XVIe-XVIIIe siècle), Roma, École Française de Rome,1995.
La città e il monastero. Comunità femminili cittadine nel Mezzogiornomoderno, a cura di E. NOVI CHAVARRIA, Atti del Convegno diStudi, Campobasso, Università degli Studi del Molise 11-12 no-vembre 2003, Napoli, Esi, 2005.
LANDI, F., La globalizzazione dei regolari. Le dimensioni europee dellarete dei monasteri e dei conventi, in Clero, economia e contabilità inEuropa.TraMedioevo ed età contemporanea, a cura di R. DI PIETRA-F. LANDI, Roma, Carocci, 2007, pp. 147-155.
LANDI, F., Storia economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX, Roma,Carocci, 2005.
MASTROIANNI, F. F., L’inchiesta di Innocenzo X sui conventi cappucciniitaliani (1650). Analisi dei dati, Roma, Pontificia UniversitàLateranense, 1985.
MILELLA, O., La Compagnia di Gesù e la Calabria. Architettura e storiadelle strategie insediative, Roma, Gangemi, 1992.
MILELLA, O., La Compagnia di Gesù e la Calabria. Architettura e storiadelle strategie insediative. I centri minori, Roma, Gangemi,2000,MUSI, A., Alle origini di una nazione. Antispagnolismo e iden-tità italiana, Milano, Guerini e Associati, 2003.
NOVI CHAVARRIA, E., I “tremuoti” della Calabria del 1638, in«Prospettive settanta», 3-4, 1985, pp. 362-377.
NOVI CHAVARRIA, E., Insediamento e consistenza patrimoniale deiCarmelitani in Calabria e in Puglia attraverso l’inchiesta innocen-ziana, inOrdini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, 2 voll.,Atti del seminario di Studio, Università degli Sudi di Lecce 29-31gennaio 1986, a cura di B. PELLEGRINO-F. GAUDIOSO, Galatina,Congedo, 1987, I, pp. 203-230.
NOVI CHAVARRIA E., Identità cittadine, identità di ceto e monasteri fem-minili, in La città e il monastero. Comunità femminili cittadine nelMezzogiorno moderno, Atti del Convegno di Studi, Campobasso,11-12 novembre 2003, a cura di E. NOVI CHAVARRIA, Napoli, Esi,2005, pp. 7-28.
NOVI CHAVARRIA, E., Sacro, pubblico e privato. Donne nei secoli XV-XVIII,Napoli, Guida, 2009.
PELLEGRINO, B., I collegi gesuitici e la strategia della Compagnia nel Regnodi Napoli tra ‘500 e ‘600, in Alle origini dell’Università dell’Aquila.Cultura, università, collegi gesuitici all’inizio dell’età moderna in Italiameridionale, Atti del Convegno internazionale di studi promossodalla Compagnia di Gesù e dall’Università dell’Aquila nel IV cen-tenario dell’istituzione dell’Aquilanum Collegium (1596), L’Aquila,8-11 novembre 1995, a cura di F. JAPPELLI-U. PARENTE, Roma,Institum Historicum S. J., 2000, pp. 107-126.
Per una storia del turismo nel Mezzogiorno d’Italia. XIX-XX secolo, a cu-ra di A. BERRINO, Napoli, Istituto per la Storia del RisorgimentoItaliano, 2001.
PLACANICA, A., La Calabria in età moderna, 2 voll., Napoli, Esi, 1985-1988.
PLACANICA, A., Il cappuccino nel mezzogiorno in età moderna, in I fra-ti minori cappuccini in Basilicata e nel salernitano fra ‘500 e ‘600, acura di V. CRISCUOLO, Roma, Istituto storico dei Cappuccini,1999, pp. 7-16.
544
ELISA NOVI CHAVARRIA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 544
PLACANICA, A., La Calabria in età moderna, 2 voll., Napoli, Esi, 1985-1988, II, pp. 307-335.
POLI, G., L’anima e la terra nel Mezzogiorno moderno, Bari, Progedit,2008.
POLI, G., La presenza economica della Chiesa nell’Italia meridionale du-rante l’età moderna, in Clero, economia e contabilità in Europa. TraMedioevo ed età contemporanea, a cura di R. DI PIETRA-F. LANDI,Roma, Carocci, 2007, pp. 185-225.
RURALE, F.,Monaci, frati, chierici. Gli Ordini religiosi in età moderna,Roma, Carocci, 2008.
RUSSO, F., Presenza francescana in Calabria in età moderna (sec. XVI-XVIII), inOrdini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, 2 voll.,Atti del seminario di Studio, Università degli Sudi di Lecce 29-31gennaio 1986, a cura di B. PELLEGRINO-F. GAUDIOSO, Galatina,Congedo, 1987, I, pp. 257-267.
SPOSATO, P., Per la Storia del Brigantaggio nella Calabria del Settecento.Episodi di malvivenza a Nocera feudo ecclesiastico del baliaggio gero-solimitano di Sant’Eufemia,Roma, Collezione meridionale Editrice,1968.
ZARRI, G., Monasteri femminili e città (secoli XV-XVIII), in Storiad’Italia, Annali 9, La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’etàcontemporanea, a cura di G. CHITTOLINI-G. MICCOLI, Torino,Einaudi,1986, pp. 359-429.
ZARRI, G., Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età mo-derna, Bologna, Il Mulino, 2000.
ZINZI, E., Insediamento gesuitico in Calabria: aspetti architettonici, ur-banistici, territoriali, in I Gesuiti e la Calabria, Atti del Convegno,Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria 27-28 febbraio1991, a cura di V. SIBILIO, Reggio Calabria, Laruffa, 1992, pp.177-310.
545
ORDINI RELIGIOSI, SPAZI URBANI ED ECONOMICI NELLA CALABRIA SPAGNOLA
calabria sequenza corretta fg DEFINITIVO:anselmi 28-11-2009 11:32 Pagina 545