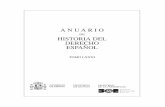Una viceregina napoletana nella Napoli spagnola: Anna Carafa, in Donne di potere nel Rinascimento, a...
Transcript of Una viceregina napoletana nella Napoli spagnola: Anna Carafa, in Donne di potere nel Rinascimento, a...
Copyright © 2008 - Viella s.r.l.Tutti i diritti riservatiPrima edizione: ottobre 2008ISBN 978-88-8334-365-0
Questo volume è pubblicato con il contributo dell’Università degli studi di Milano e del Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica, nell’am-bito del programma di ricerca di interesse nazionale cofinanziato dal MIUR.
viellalibreria editricevia delle Alpi, 32I-00198 ROMAtel. 06 84 17 758fax 06 85 35 39 60www.viella.it
Indice
Letizia arcangeLi e SuSanna PeyroneL Premessa 9
I. Tra famiglie e patrimoni: ricchezze materiali e immateriali
StanLey chojnacki
At Home and Beyond: Women’s Power in Renaissance Venice 25
eveLyn WeLch
Women in Debt: Financing Female Authority in Renaissance Italy 45
chriStina antenhofer
Il potere delle gentildonne: l’esempio di Barbara di Brandenburgo e Paula Gonzaga 67
Laura caSeLLa
Donne aristocratiche nel Friuli del Cinquecento tra strategie familiari e conflitti di fazione 89
Diane ghirarDo
Lucrezia Borgia, imprenditrice nella Ferrara rinascimentale 129
francine DaenenS
Debiti e crediti di una gentildonna: Isabella Sforza 145
feDerica ambroSini
Una vedova genovese nella Padova del Cinquecento:Caterina Sauli da Passano 169
6 Donne di potere nel Rinascimento
II. Reti di poteri e spazi di corte femminili
Simona feci
Signore di curia. Rapporti di potere ed esperienze di governo nella Roma papale (metà XV-metà XVI secolo) 195
beneDetta boreLLo
Protezioni di donne. Mogli aristocratiche e patriziato cittadino (Gubbio, Roma, Siena XV-XVI secolo) 223
naDia covini
Tra patronage e ruolo politico: Bianca Maria Visconti (1450-1468) 247franca Leverotti
Lucia Marliani e la sua famiglia: il potere di una donna amata 281angeLantonio SPagnoLetti
Donne di governo tra sventura, fermezza e rassegnazione nell’Italia della prima metà del ’500 313
aLeSSanDro barbero e thaLia brero
Genre et nationalité à la cour de Béatrice de Portugal, duchesse de Savoie (1521-1538) 333
eLiSa novi chavarria
Reti di potere e spazi di corte femminili nella Napoli del ’500 361Dorit raineS
La dogaressa erudita. Loredana Marcello Mocenigo tra sapere e potere 375
aLiSon a. Smith
Women and Political Sociability in Late Renaissance Verona: Ersilia Spolverini’s Elogio of Chiara Cornaro 405
Sara cabibbo
Percorsi del potere femminile fra Italia e Spagna: il caso di Vittoria Colonna Enriquez (1558-1633) 417
vittoria fioreLLi
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 445
Indice 7
III. Donne e potere politico
chriStine ShaW
Bartolomea Campofregoso: A Woman’s Claim to Power in Fifteenth-Century Genoa 465
marco foLin
La corte della duchessa: Eleonora d’Aragona a Ferrara 481ceSarina caSanova
Mogli e vedove di condottieri in area padana fra Quattro e Cinquecento 513
eLena PaPagna
Tra vita reale e modello teorico: le due Costanze d’Avalos nella Napoli aragonese e spagnola 535
gabrieLLa zarri
Caterina Cibo duchessa di Camerino 575Letizia arcangeLi
Un’aristocrazia territoriale al femminile. Due o tre cose su Laura Pallavicini Sanvitale e le contesse vedove del parmense 595
roSSana Sacchi
Caterina Bianca Stampa Petra e poi Lodrone 655micheLe caSSeSe
Giovanna e Maria d’Aragona: due sorelle napoletane «doppio pregio ad una etade» e il rapporto con il potere nel ’500 669
SuSanna PeyroneL
I carteggi di Giulia Gonzaga 709bruce L. eDeLStein
Eleonora di Toledo e la gestione dei beni familiari: una strategia economica? 743
monica miretti
Mediazioni, carteggi, clientele di Vittoria Farnese, duchessa di Urbino 765
Indice dei nomi 785
Abbreviazioni
AC Subiaco, Biblioteca del Monastero di S. Scolastica, Archivio ColonnaADP Roma, Archivio Dora PamphiljALPMi Milano, Archivio Luoghi Pii ElemosinieriAOM Milano, Archivio Ospedale MaggioreASBo Bologna, Archivio di StatoASBPd Padova, Archivio privato Savorgnan BonatiASCLo Lodi, Archivio storico del comune ASCMi Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana ASCPs Pesaro, Biblioteca Oliveriana, Archivio Storico del ComuneASCr Cremona, Archivio di StatoASFe Ferrara, Archivio di StatoASFe, ANA Ferrara, Archivio di Stato, Archivio Notarile AnticoASFi Firenze, Archivio di StatoASGe Genova, Archivio di StatoASGe, Segreto Genova, Archivio di Stato, Archivio Segreto ASGo Gorizia, Archivio di StatoASMi Milano, Archivio di StatoASMn Mantova, Archivio di StatoASMo Modena, Archivio di StatoASNa Napoli. Archivio di Stato ASPc Piacenza, Archivio di StatoASPd Padova, Archivio di StatoASPN «Archivio storico per le province napoletane»ASPP «Archivio storico per le province parmensi»ASPr Parma, Archivio di StatoASPs Pesaro, Archivio di StatoASPVe Venezia, Archivio Storico del PatriarcatoASRa Ravenna, Archivio di StatoASRoma Roma, Archivio di StatoASSi Siena, Archivio di StatoASTo Torino, Archivio di Stato
Donne di potere nel Rinascimento22
ASUd Udine, Archivio di StatoASVat Archivio Segreto VaticanoASVe Venezia, Archivio di StatoASVr Verona, Archivio di StatoAutografoteca Campori Biblioteca Estense, Autografoteca Campori, Giulia GonzagaBAM Milano, Biblioteca AmbrosianaBAV Biblioteca Apostolica Vaticana BEMo Modena, Biblioteca Estense, BNM Venezia, Biblioteca Nazionale MarcianaBNNa Napoli, Biblioteca Nazionale BSNSP Biblioteca della Società Napoletana di Storia PatriaBUB Biblioteca dell’Università di BolognaDBI Dizionario Biografico degli ItalianiMCC Venezia, Biblioteca del Museo Civico Correr Mss. Oliv. Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ManoscrittiTLA Tiroler Landesarchiv
vittoria fioreLLi
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa
Fino a qualche decennio fa, nel quadro di una tradizione storiografica consolidata, mettere insieme le donne e il potere in una unica prospettiva di ricerca poteva apparire operazione velleitaria e di scarsa intelligenza pro-spettica. Nel quadro attuale degli studi, invece, la proposta di fare emerge-re, all’interno del tessuto aristocratico degli Stati italiani del Rinascimento, la figura di una donna alla quale sia lecito riconoscere spazi di autonomia politica e di incidenza sulla vita pubblica apre ambiti di riflessione ina-spettati. Il taglio tematico proposto dal convegno raccoglie l’orientamento ripetutamente emerso nelle pagine di chi si è occupato della storia sociale della nobiltà a partire dagli anni Ottanta. All’intenzione di ridefinire il rap-porto complesso che ha legato i comportamenti familiari e cetuali alla sto-ria della politica moderna, però, il percorso di ricerca suggerito in questa occasione ha affiancato una prospettiva metodologica di più ampia portata, orientata ad analizzare la struttura del contesto e la fisionomia dei gruppi nei quali le strategie femminili potevano essere identificate e studiate.
In questo quadro la situazione degli studi dedicati al Mezzogiorno d’Italia gode da tempo del privilegio di essere percorsa da una serie di tentativi di individuarne la cifra di specificità e di identità storica.1 Al suo interno, però, non appare rintracciabile un filone di ricerca specificamente dedicato alla titolarità del potere politico, di fatto o di diritto, esercitato dalle donne nel complesso panorama delle élites feudali e cittadine. Galas-
1. Non si vuole in questa sede dare conto di una bibliografia ampia e complessa. Ci limitiamo segnalare che è oramai alle fasi conclusive la pubblicazione di G. Galasso, Il Regno di Napoli, Torino 2005 (Storia d’Italia, XIV-XVIII). Tra gli studi monografici: M.A.Visceglia, Identità sociali. La nobiltà napoletana nella prima età moderna, Milano 1998, ma si veda, a cura della stessa, la raccolta Signori, patrizi, cavalieri nell’età moderna, Bari 1992 che costituisce ancora un punto di riferimento importante. Per le storie familiari: E. Papagna, Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica. I Caracciolo di Martina in età moderna, Milano 2002; F. Luise, I d’Avalos, Napoli 2006.
Vittoria Fiorelli446
so ha sottolineato di recente l’assenza, nella storia del Regno di Napoli, di donne il cui ruolo istituzionale potesse offrire lo spazio per la ricognizione di una loro specifica personalità di governo. Un vuoto di ruolo che, nelle riflessioni metodologiche espresse in quelle stesse pagine, non rinnegava di certo le rilevanti funzioni informali legate al posizionamento sociale e familiare, ma ne coglieva l’incapacità a tramutarsi in iniziativa politica individuale.2
La chiave prosopografica suggerita dal convegno appare dunque quel-la più adatta ad affrontare un tema nel quale la valenza pubblica del privato ha già da tempo dimostrato la sua centralità. L’intreccio dei casati, sospesi tra vita familiare e reti politiche, consente infatti un approccio comple-to all’analisi degli elementi portanti della struttura storico-sociale dell’età moderna.3
In questo quadro teorico è maturata la scelta di Anna Carafa come argomento della mia ricerca. Figlia di Antonio, duca di Mondragone, e di Elena Aldobrandini, donn’Anna aveva sposato nel 1636 il duca di Medina de las Torres, futuro viceré di Napoli. Sebbene vissuta in un clima che an-drebbe oramai definito barocco, la sua vicenda consentiva di operare una saldatura di fatto tra nobiltà feudale e patriziato cittadino, capace di offrire una prospettiva privilegiata per l’analisi delle dinamiche relazionali e pa-trimoniali integrate nella dimensione pubblica dei casati aristocratici. Il suo posizionamento familiare la proiettava nel contesto italiano attraverso i Gonzaga e gli Aldobrandini, mentre il matrimonio con Ramiro Guzmán, duca di Medina de las Torres le consentiva di accedere al sistema di inte-grazione dinastica delle famiglie aristocratiche napoletane nella corte di Madrid.4
2. Il riferimento è a Donne e potere nella tradizione napoletana, presentazione del volume di saggi sulle regine napoletane, in corso di stampa, la cui lettura devo alla cortesia dell’Autore. Sulla difficile percorribilità dell’ipotesi di rintracciare una identità di genere nella storia meridionale Galasso si era già soffermato in L’esperienza religiosa delle donne, in Donne e religione a Napoli in età moderna. Secoli XVI-XVIII, a cura di G. Galasso, A. Valerio, Milano 2001, pp. 13-46.
3. è di recente pubblicazione una rassegna dedicata agli studi di storia della famiglia: R. Sicilia, Temi e problemi di storia della famiglia in età moderna, in «L’Acropoli», VII/ 4 (luglio 2007), pp. 484-491.
4. Sulla famiglia Carafa si vedano: B. Aldimari, Historia genealogica della famiglia Carafa, a cura di Bulifon, Napoli 1691; S. Ammirato, Delle famiglie nobili napoletane parte seconda, Firenze 1651, p. 139; B. Minichini, Del cognome e dello scudo dei Carafa
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 447
Quello che Elliott aveva indicato come “regime Olivares”, che uti-lizzava la sovrapposizione di poteri giurisdizionali a riconoscimenti di distinzione cetuale quali la concessione di titoli nobiliari, cavallereschi o militari, ma anche la stipula di alleanze matrimoniali, ha trovato una sua realizzazione paradigmatica nella vicenda della saldatura dei ceppi Carafa e Medina de las Torres, progettata dal potente valido di Filippo IV.5 Analiz-zata in questa ottica, la vicenda personale della Carafa offriva la possibilità di comprendere ruoli e posizioni consentiti alle donne appartenenti alle sfere più alte del tessuto sociale e politico dell’Europa moderna. Ereditiera di un immenso patrimonio di terre e di palazzi, depositaria di privilegi e prerogative sovrane, grazie al matrimonio con uno straniero ella sarebbe diventata la prima viceregina napoletana nella Napoli spagnola. Un ruolo che le avrebbe dato, nella città nella quale aveva comunque occupato una posizione sociale e patrimoniale predominante, la preminenza assoluta ac-quisita attraverso la più alta carica istituzionale del Regno. Parallelamente, questo matrimonio consentiva al casato napoletano di mantenere l’alto li-vello di relazioni internazionali che l’attenta politica familiare aveva svi-luppato negli ultimi decenni.
L’ipotesi di ricerca era quella di verificare se una donna di quei natali, una volta conquistato un ruolo ufficiale nella compagine di governo in qualità di consorte del viceré in carica, fosse poi in grado di esercitare in proprio qualche forma di potere che si potesse definire femminile. Da un lato esso poteva tradursi nella capacità di operare una azione di controllo e di indirizzo dell’attività del marito nel corso del suo mandato. Distinguen-do tra donna di potere e donna vicina al potere, dall’altro restava aperta l’ipotesi di delineare un ruolo simbolico altrettanto importante, che si sa-
nobili napoletani, Napoli 1860; M.A. Visceglia, Strategie successorie e regimi dotali, in M.A. Visceglia, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età mo-derna, Napoli 1988, pp. 34 e 65. Tra le fonti manoscritte: BNNa, Discorso della famiglia Carrafa, ms. X.A.26; F. Campanile, Discorso intorno alla famiglia Carrafa, Ivi, ms. San Martino 354. Su Anna: L. Lucci, Donn’Anna Carafa principessa di Stigliano e viceregina, Napoli 1905.
5. Si vedano a questo proposito: A. Spagnoletti, Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milano 1996; A. Musi, L’Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel siste-ma imperiale spagnolo, Cava de’ Tirreni 2000. Per un periodo antecedente C. Cremonini, Considerazioni sulla feudalità imperiale italiana nell’età di Carlo V, in L’Italia di Carlo V. Guerra religione e politica nel primo Cinquecento, a cura di F. Cantù, M.A. Visceglia, Roma 2003, specialmente le pp. 256-275.
Vittoria Fiorelli448
rebbe forse potuto definire tipico delle donne, al quale riconoscere però un ambito di esercizio attivo. Sullo sfondo restava la necessità di rivedere spazi e forme del concetto stesso di potere, declinandolo nelle sue appli-cazioni più ampie e complesse.6 In quest’ottica è lecito chiedersi quanto della rilevanza sociale e dei privilegi di Anna le venissero dal suo ruolo di viceregina o se non sia stato piuttosto il suo posizionamento familiare a garantire il viceré nella difficile congiuntura della storia napoletana che sarebbe esplosa di lì a qualche anno.
Prima di delineare il sistema di parentele nel quale la duchessa era nata, però, qualche parola andrebbe spesa a proposito della tipologia delle fonti che sono state utilizzate per ricostruire l’intera vicenda. L’uso quasi esclusivo di una documentazione indiretta è dovuto al fatto che l’archivio privato della famiglia è in gran parte rientrato a Madrid con il viceré alla fine del suo mandato. Il restante asse ereditario dei Medina avrebbe preso la via della Spagna con l’estinzione del ramo della casata dopo la morte di Anna e dei suoi figli.7 Accanto agli scritti encomiastici che riguardano la famiglia, però, sono state utilizzate soprattutto cronache risalenti alla fine del secolo XVII che hanno dato un forte contributo alla contestualizzazio-ne in chiave politica e sociale del rapporto, mediato da Anna, tra la città e il rappresentante di Madrid.
Unica eccezione a questo vuoto di testimonianze dirette è costituito da un gruppo di lettere che diversi componenti della famiglia avevano scam-biato con i direttori spirituali teatini. Nelle pieghe degli argomenti devo-zionali, tipici di questo genere di corrispondenza, emergono a più riprese i tratti personali dei protagonisti e particolari inattesi della vita di famiglia.8
6. Trattazioni più distese dell’argomento sono incluse in questo volume e non si intende in alcun modo dare conto del dibattito nato attorno a questi temi. Si segnalano però: Culture et pouvoir des femmes: essai d’historiographie, in «Annales», 41/2 (1986), pp. 271-293 e il recente volume Innesti. Donne e genere nella storia sociale, a cura di G. Calvi, Roma 2004.
7. Nell’archivio tutt’ora conservato dagli eredi si dovrebbero trovare le copie dei contratti matrimoniali e le tracce della laboriosa contrattazione che li aveva preceduti, ma anche i minuziosi elenchi di ricchezze dei quali favoleggiavano i contemporanei. Sembra infatti che gli accordi dotali prevedessero un milione e mezzo di scudi oltre ad arredi, beni e gioie per circa 600.000 ducati: «come da un meraviglioso inventario si fa palese, basta dire soltanto che vi erano cento venti mila scudi di argento antico inservibile, che buona parte poi andò a male», BSNSP, Sollevazione dell’Anno 1647, ms. XXII C 6, p. 241.
8. Le lettere autografe sono in: BNNa, ms. San Martino 213 e 389, per le risposte di Andrea Avellino: Lettere scritte dal glorioso S. Andrea Avellino a diversi suoi divoti,
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 449
Luigi Carafa, principe di Stigliano e duca di Mondragone, aveva a suo tempo enormemente rafforzato la posizione della famiglia grazie al ma-trimonio con Isabella Gonzaga. Erede universale del padre Vespasiano, la sposa, oltre al lustro di una parentela di grande prestigio, aveva portato al marito una ricca dote della quale facevano parte possedimenti provenienti da casa Colonna e il ducato di Sabbioneta, un titolo imperiale che dava ai suoi possessori diritti e privilegi sovrani.9
Vespasiano era stato educato a Napoli dove aveva trascorso un periodo al seguito della zia, Giulia Gonzaga, e dove aveva lasciato una solida rete di relazioni. In quegli ambienti egli aveva scelto per la figlia uno sposo di alto lignaggio, ma anche un «ricchissimo Signore, e bellissimo giovane» che venne a celebrare il matrimonio a Bozzolo il 29 novembre 158410. Tra i due uomini si dovette costruire un solido legame tanto che, nominatolo esecutore testamentario, il vecchio duca lasciò al genero la sua libreria personale, segno di intimità e di interessi condivisi.11
Alla figlia egli assegnava invece il compito di scegliere forme e ceri-moniali per la sepoltura. Vespasiano effettuava in questo modo una vera e propria investitura della sua erede attribuendole la responsabilità di gestire le implicazioni connesse alla sfera pubblica dell’appartenenza nobiliare e
Ristampa in facsimile dell’edizione napoletana del 1731-32, a cura di D.A. D’Alessandro, C. Mazza, Napoli 2007.
9. Luigi (1570 ca.-1630) era figlio di Antonio Carafa, conte e poi duca di Mondragone e principe di Stigliano. Vespasiano, figlio di Luigi Gonzaga e di Isabella Colonna, era nato a Fondi, contea di Terra di Lavoro, il 6 dicembre 1531. Sua figlia avrebbe portato al marito i possedimenti nel Regno di Napoli provenienti dall’eredità della nonna paterna: il ducato di Fondi e Traetto con i centri di Itri, Castelforte, Sperlonga e Pastena, un feudo in Terra di Lavoro e la Rocca di Caramanico in Abruzzo Citra.
10. Anche Luigi era stato educato da una zia illustre: Roberta Carafa duchessa di Maddaloni (nello stesso volume si veda il saggio di E. Novi Chavarria). Egli fu un fine letterato legato a personaggi dello spessore di Camillo Pellegrino e Giambattista Marino. Cfr.: B. Croce, Il Palazzo Cellamare a Chiaia, in «Napoli Nobilissima», X/4 (1901), p. 51 e i numerosi riferimenti alla sua passione culturale nelle lettere del padre spirituale, Andrea Avellino. Cfr. Lettere, p. 384 e passim.
11. Luigi figurava, con il nome “il solitario”, tra i fondatori dell’Accademia degli Oziosi. Su questo: G. de Miranda, La quiete operosa. Forma e pratica dell’Accademia napoletana degli Oziosi 1611-1645, Napoli 2000. Sul nesso tra nome e impresa nelle acca-demie e sull’uso metaforico dei nomi al loro interno si veda: A. Quondam, L’accademia, in Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, Torino 1982, vol. I, pp. 845 ssg.; G. Pozzi, Poesia e gioco. Prontuario di figure artificiose, Bologna 1984.
Vittoria Fiorelli450
quindi la quota visibile e attiva del privilegio e del potere sociale ad essa collegati.12
Isabella avrebbe portato nella sua nuova vita tutta la consapevolezza di ruolo che le veniva dalle sue origini e la capacità di organizzare strategie di tutela dell’onore e del patrimonio familiare.13 I capitoli matrimoniali stipulati per il figlio Antonio con Elena Aldobrandini, firmati a Roma il 22 giugno del 1602, portavano il segno della sua abilità di negoziazione e forse anche una percezione tutta femminile della funzione della dote nella prospettiva di una tutela del patrimonio nella quale la solidità della rete familiare doveva superare la preminenza dei rapporti agnatizi.14
La morte prematura del giovane erede faceva emergere tutta la com-plessità della struttura familiare della casata napoletana. Il duca di Mon-dragone, incline al gioco e ai comportamenti smodati, aveva enormemente impensierito i genitori che, per tutelarlo dal richiamo della vita mondana, si erano trasferiti ad abitare prima nella residenza di Torre del Greco e poi a Teano.15 In una delle rare lettere di Luigi ancora in nostro possesso,
12. Il testamento che lascia al «genero mio dilettissimo la mia libreria piccola, la quale ho in Palazzo appresso la camera mia» è trascritto in I. Affò, Vita di Vespasiano Gonzaga duca di Sabbioneta, e Trajetto, marchese di Ostiano, conte di Rodigo, Fondi ecc. scritta dal p. Ireneo Affò…, Parma 1780, pp. 113-124. La biografia è dedicata al cardinale Francesco Carafa di Traetto, prefetto della Congregazione dei Vescovi e Regolari, a dimostrazione della solida persistenza dei legami familiari e cetuali. Fonti a stampa per la vita di Vespa-siano sono anche le biografie scritte da Alessandro Lisca, pubblicata a Verona nel 1592, e quella di Giulio Faroldi. Sull’importanza delle sepolture si veda: M.A. Visceglia, Scegliere la sepoltura: il bisogno di eternità, in Visceglia, Il bisogno di eternità, pp. 107-139.
13. Un esperto conoscitore degli ambienti nobiliari di quegli anni la descriveva come «donna vivacissima d’ingegno, [a cui] si attribuisce avarizia e tirannide verso i vassalli, et una indifferente murmuratione contro amici e nemici.» F. della Marra, Ruina di case na-poletane del suo tempo scritta da d. Ferrante della Marra duca della Guardia, trascritta in ASPN, XV/3 (1900), p. 371.
14. La sposa era nipote di Clemente VIII, sorella della duchessa di Parma e Piacen-za Margherita, moglie di Ranuccio Farnese, e di Lucrezia, moglie di Marino Caracciolo principe di Avellino. Nella genealogia dei Carafa si accenna alla stipula dell’istrumento dotale della consistenza di trecentomila ducati: «interviene Isabella Gonzaga d’Aragona Principessa di Stigliano, e Duchessa di Sabbioneta, in presenza del Principe suo marito con l’intervento del Duca di Sessa affine di essa Principessa». L’assenso regio giunse il 13 gennaio dell’anno successivo. Aldimari, Historia genealogica, p. 397.
15. Nelle cronache coeve il ruolo di controllo è assegnato a Isabella. Gravato dai debiti di gioco, egli percorreva i feudi prelevando denari dai vassalli «perché la madre che lo dominava stava renitente in pagarli, lui scornato di ciò, si risolse andare per lo stato bu-
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 451
indirizzata ad Andrea Avellino, egli si doleva della morte del nipotino ap-pena nato e cercava di esorcizzare il senso di colpa per avere fatto nascere il proprio erede lontano dagli agi della capitale. Sono parole di un padre affettuoso, preoccupato per il figlio Antonio, consapevole del dovere di adottare una strategia di protezione del casato anche a costo di rinunciare per un periodo alla fastosa residenza della capitale:
Le lettere di Vostra Paternità mi sono state di molta consolatione in questa tri-ste cosa che il Signore mi ha dato dela morte del figliuolo [...] per rispondere a quelli che dicono di Tiano in ogni parte se muore e se vive ne Tiano è più cattiva aria di Sabioneta e pure a Sabioneta il duca se nacque e se stete sempre bene [...] sia come si voglia mi stavo à Tiano adesso per necessità [...] perché il Duca essendo così giovanne spesso anderia à Napoli e bisognaria che se prendesse e poserai anchora giocare e perdere in grosso...16
Le donne della casa mantenevano, probabilmente in virtù del lignag-gio, una impronta rinascimentale che lasciava loro spazi di gestione ina-spettati e forme di rappresentanza nelle quali la connotazione più maschia era stemperata nella condivisione di politiche familiari e cetuali.
I rapporti tra suocera e nuora, però, non furono sempre tranquilli. La Aldobrandini aveva consentito ai Carafa di proseguire la politica di poten-ziamento esterno del casato attraverso l’alleanza con una delle più potenti famiglie romane.17 La scelta aveva pienamente soddisfatto i principi di Sti-gliano fin quando, tristemente provata dalla perdita di due figli appena nati, alla morte del marito la duchessa era tornata a Roma.18
scandoli». Della Marra attribuì la sua morte ai miasmi respirati in Calabria, Ferrante Bucca parlava invece di un avvelenamento per iniziativa dei vassalli.
16. La lettera è datata 17 agosto 1605 e il bimbo era morto all’inizio del mese. La coppia aveva già perduto il primogenito di sette mesi nel luglio del 1604. BNNa, ms. San Martino 389, Lettere ad Andrea Avellino. Cfr: Andrea Avellino, Lettere, pp. 522 e 559.
17. Ne è una dimostrazione la retorica classicheggiante tipica della tradizione umani-stica napoletana che ritroviamo nel componimento encomiastico che Marino compose per l’evento: Himeneo epitalamio delle nozze dell’illustriss. & eccell. Sig. don Vincenzo (sic) Caraffa duca di Mondragone et d. Helena Aldobrandina, in G.B. Marino, Epitalami del Cav. Marino, Venezia 1628.
18. Anche la Aldobrandini venne affidata alle cure spirituali di Andrea Avellino il quale, subito dopo le nozze, nel 1602, scriveva: «son costretto amarla, essendomi scritto, & a bocca riferito, che V.E. dona grandissima sodisfattione all’Eccellentissima Signora Prin-cipessa, al Signor Principe, al Signor Duca, & à tutta la casa», Andrea Avellino, Lettere, p. 470. I nomi di Antonio e della moglie erano anche negli elenchi dei devoti di suor Giulia
Vittoria Fiorelli452
La Gonzaga si adoperò per riportare la nuora ai suoi doveri di madre e di componente di prestigio della nobiltà della capitale. A questo scopo si servì di diverse mediazioni, ma la sua sponda principale fu Andrea Pe-scara Castaldo. Dalle lettere inviate da Isabella al teatino emerge la sua sostanziale solitudine nel fronteggiare le emergenze familiari e l’abitudine ad amministrare negozi importanti. Un ruolo di gestione delle dinamiche nobiliari e di conduzione delle iniziative imprenditoriali che non di rado le donne dell’aristocrazia svolgevano dopo la vedovanza o in assenza del marito. L’eccezionalità della situazione della Gonzaga stava nel controllo di queste attività ben prima che Luigi si rifugiasse presso i gesuiti dove trascorse i suoi ultimi anni. Una decisione che non gli fece comunque per-dere il ruolo di capo della casata come dimostra il suo solenne funerale.19 è come se ad una rappresentazione patrilineare e agnatizia rintracciabile nei cerimoniali, ma anche nei documenti e negli atti ufficiali, fosse sotteso un silente spazio di azione femminile.
Una differenza si coglie anche nei comportamenti tra le donne di fa-miglia. Alla neutra cortesia di Elena che, tornata a Roma dopo la morte del marito, indirizzava alla suocera parole di circostanza, la principessa rispon-deva richiamando con chiarezza il senso di abbandono e di inopportunità che aveva suscitato in lei la decisione della nuora di ritornare dalla famiglia di origine, dimentica dei nuovi doveri e del suo ruolo accanto ai figli:
mi haveria parso fare torto a me istessa convitare V.E. alla sua propria casa poiché essendo delli suoi figlioli nessuna casa è sua, se non questa et cossì ho resposto al patre già generale de Theatini, alla signora Ciomma di Capua [...] che hanno fatto offizio meco che mandasse a convitare V.E. perché deside-rava venirsene soggiungendoli che io non credeva questo perché mi haveria scritto questa sua volontà sapendo il dolor grande che sentivi della sua partita
de Marco, una carismatica protetta dai gesuiti che i teatini denunciarono al Sant’Uffizio che la condannò come eretica. Su questo: E. Novi Chavarria, Monache e gentildonne. Un labile confine. Poteri politici e identità religiose nei monasteri napoletani secoli XVI-XVII, Milano 2001, pp. 161-189 e di chi scrive Una santa della città. Suor Orsola Benincasa e la devozione napoletana tra Cinquecento e Seicento, Napoli 2001, pp. 29-32 e passim.
19. Il principe morì il 13 gennaio 1630 e il suo funerale è descritto da Bucca, Aggion-ta, p. 171. Fu trasportato sopra una coltre di broccato, in abito ducale «di raso cremisino, berrettone, mozzetta e scettro e lo stocco, sproni e tutte le altre insegne ducali, scoperto che era da tutti veduto»; l’autorizzazione era stata concessa dal viceré che ne aveva discusso nel Consiglio Collaterale. Alla morte di Anna, anche lei duchessa di Sabbioneta, l’autoriz-zazione venne negata.
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 453
e quanto la pregai che non mi lassasse in quella acerbità de dolore de mio figlio et che almeno se trattenesse finchè li suoi figli fossero slattati però Si-gnora mia se è vero che ha voglia di stare con li figli suoi in questa casa sua venga in bon’hora che in questo non ci vogliono cerimonie, poiché io che li sono ava ho faticato tanto per aiutarli e ci ho messo quarantamila docati l’an-no, de entrata mia [...] hora quanto più V.E. che è matre giovene deve stare con li figli suoi giachè io hormai sono uno cadavero…20
Lo spazio cittadino frequentato dalle dame di casa Carafa era quello che la rigida etichetta spagnola aveva riservato alla rappresentanza fem-minile. L’impegno nelle opere pie era diventato un tratto necessario del lignaggio e in quel contesto la loro presenza segnava una posizione di pre-stigio nella quale privilegio e maternage si fondevano in un unico segno di distinzione familiare.21
Isabella figurava tra le fondatrici del Conservatorio di S. Maria soccurre miseris destinato alle donne che volevano abbandonare la vita di strada.22
20. BNNa, ms. San Martino 213, Lettere Originali della Sig.ra Principessa di Sti-gliano Al P. D. Andrea Castaldo Generale dei Chierici Reg. Nel fascio sono conservate diciannove lettere autografe non numerate tra le quali è la copia di due lettere direttamente scambiate con la nuora. Quella qui riportata è scritta a Torre del Greco il 2 agosto 1621 e dunque smentisce l’ipotesi fatta da S. Volpicella che ha collocato la data di morte del duca di Mondragone tra il 1627 e il 1628. S. Volpicella, Descrizione storica di alcuni principali edificii della città di Napoli, Napoli 1850, p. 121.
21. Le Carafa furono assidue frequentatrici dell’Ospedale degli Incurabili, dove le ari-stocratiche napoletane erano solite recarsi il martedì a dare da mangiare alle inferme, dopo che Giovanna d’Austria principessa di Butera aveva lasciato all’ospedale legati sostanziosi, seguendo la traccia segnata dalla viceregina contessa de Miranda che si era a sua volta avvi-cinata alla struttura grazie alle sollecitazioni dell’oratoriano Giovenale Ancina. Donn’Anna «era solita, ad imitazione della Contessa di Monterey, unitamente con la Duchessa di Mon-dragone sua madre di spesso portarsi a visitare le povere donne inferme dell’Ospedale degli Incurabili». La notizia è riportata dall’anonimo estensore della settecentesca Sollevazione dell’anno 1647 che ha arricchito la copia manoscritta delle Cose degne di memoria della cit-tà di Napoli del Campanile di alcuni medaglioni dedicati a personaggi in vista del Regno, tra i quali è una Digressione intorno alla Principessa D. Anna Carafa di Stigliano viceregina di Napoli, BSNSP, Sollevazione, pp. 227-249. Una speciale dispensa del papa consentiva loro di visitare il monastero di clausura di Donna Regina, per esempio il 3 gennaio 1630: F. Bucca d’Aragona, Aggiunta alli diurnali di Scipione Guerra, in ASPN, XXXVI (1911), p. 169.
22. L’istrumento di fondazione redatto il 6 febbraio 1613 nominava anche Maria Ca-racciolo marchesa di Bracigliano e Dorotea del Tufo, figlie spirituali dei padri teatini di S. Paolo che ospitarono la piccola comunità fino all’apertura della sede di S. Antoniello ai Vergini. Regole e capitoli del conservatorio sono in BNN, ms. San Martino 134-136.
Vittoria Fiorelli454
Molti anni dopo Elena Aldobrandini istituiva, ai confini della residenza di Chiaia dei principi di Stigliano, un «Ritiro per Matrone e Vergini nobili ed altre introducenda a suo libito le quali senza legame alcuno di voto volonta-riamente servano a Dio benedicendo».23
La loro presenza nelle occasioni mondane era invece più rara. La lun-ga lontananza dalla vita della capitale e qualche ristrettezza economica che non consentiva di mantenere il livello a cui le obbligava il lignaggio aveva ispirato un rigore familiare in seguito abbandonato dalla duchessa di Medina de las Torres che, da viceregina, avrebbe partecipato alla vita di corte costellata di eventi mondani. La sua attività caritativa sarebbe stata relegata ad un ruolo marginale, segno di un disinteresse che traspariva dal testamento dettato quando donn’Anna era già divorata dalla malattia che la avrebbe condotta alla morte. Si tratta di un documento scarno e sinteti-co che indicava laconicamente la successione prevista dalle consuetudini per il marito e per i figli. Mancava del tutto la ragnatela di lasciti e legati caritativi e devozionali che si ritrovava solitamente nelle successioni dei grandi patrimoni che in questo caso venivano frettolosamente affidati alla madre Elena il cui impegno nella sfera della pietà era ampiamente ricono-sciuto.24
Un episodio della vita napoletana di quegli anni nel quale lo spazio dedicato alle donne ebbe la fugace occasione di dilatarsi fu il soggiorno dell’infanta di Spagna nel 1630. Il suo arrivo pose in subbuglio la città e un commentatore acuto come il Caputo avrebbe sottolineato gli aspetti nega-tivi di una lunga permanenza che costò cifre enormi alle casse del Regno e scatenò aspre contese legate al cerimoniale, come quella che oppose il
23. Nato nel 1654 presso la sua dimora, il libero ritiro ricevette dal testamento della Al-dobrandini, stilato l’8 dicembre dell’anno successivo, la casa acquistata «vicino la chiesa di S. Carlo nel luogo detto le Mortelle» e una congrua rendita proveniente dal suo patrimonio. Il riconoscimento per un oratorio privato giunse con il breve del 23 ottobre 1656. Morta nel 1663 la fondatrice, il conservatorio ebbe l’approvazione della Congregazione dei Vescovi e Regolari nel 1684. Una copia del testamento è in Archivio Mondragone, I A 1, fasc. 1, ff. 3r-5v. Diverse versioni della Regola mai data alle stampe sono in Archivio Storico Diocesano di Napoli, Vicario delle monache, 447 D, Vergine delle Grazie a Mondragone. Una descrizione tarda del complesso è nella Santa Visita del cardinale Riario Sforza citata da A. Illibato, La visita pastorale nella diocesi di Napoli , in «Campania Sacra», 1998, pp. 165-234.
24. Nel testamento sono indicati un lascito di mille ducati per la cappella di Andrea Avellino in S. Paolo Maggiore e quattromila ducati affidati alla madre per opere pie. Una copia del documento è in BSNSP, ms. XXIX A 3, ff. 64r-65v.
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 455
viceré in carica al suo predecessore che guidava il seguito della sorella del sovrano.25
Le descrizioni degli impegni della regina e del suo seguito erano ac-compagnate dal ricordo fugace di chi vi aveva preso parte. Solo in rare occasioni veniva menzionato qualche nome come successe per le Carafa in omaggio al rilievo dei loro titoli imperiali. Nel racconto di Bucca, sem-pre sensibile agli aspetti connessi alla vita dell’aristocrazia, si metteva in evidenza il disgusto delle dame napoletane provocato dalla spocchia di Maria: «fa pochissima cortesia perché per Napoli non cala la testa di niuna maniera, si pare una vera statua di marmo, et in casa solo alla duchessa di Sabioneta Gonsaga, duchessa di Mondragone Aldobrandina, e Principessa di Stigliano [...] ha trattato da grandi di Spagna e datoli per sedere un cu-scino in terra».26
La rilevanza patrimoniale e la rete di relazioni familiari di donn’Anna avevano proiettato la progettazione del suo matrimonio in dinamiche che trascendevano di gran lunga gli orizzonti della nobiltà napoletana. Nella rete complessa di contatti che ne accompagnò l’organizzazione, accanto alla chiara ingerenza di Madrid, emerse con nettezza il peso dell’iniziativa femminile in uno degli aspetti più delicati della vita aristocratica. Strate-gie diverse si incrociarono all’interno della famiglia, provocando tensioni acuite dalla commistione tra pubblico e privato propria delle scelte matri-moniali. Isabella sperava di «maritar sua nipote o con un principe straniero, il maggiore che avesse potuto, o con uno del lignaggio dei Gonzaghi suoi parenti».27 Il suo sguardo aveva vagato oltre i confini del Regno, valutando
25. In quella occasione il duca di Alcalà, innervosito per aver dovuto lasciare la sua residenza all’augusta ospite, non le era andato incontro al suo arrivo. La viceregina cercò di stemperare le asprezze del marito recandosi ad accogliere Sua Altezza con tutti gli ono-ri. Un tentativo di evitare problemi con la corona che avrebbe avuto successo se il duca d’Alba, solerte custode dell’etichetta, una volta tornato a Madrid non avesse alacremente lavorato contro il suo successore. N. Caputo, Frammenti delli Annali Della Città di Napoli Dal 1611 al 1679 scritti da Nicolò Caputo Gentiluomo Napolitano, BSNSP, ms. XXI D 15, pp. 23-34; Bucca, Aggionta, pp. 339-343.
26. Bucca, Aggionta, p. 343. Si veda anche in un libricino scritto da un letterato del seguito del duca d’Alba, una lusinghiera descrizione di donn’Anna come uno dei più ap-petibili partiti del Regno. A. Fellecchia, Viaggio della maestà della regina di Boemia e d’Ungheria da Madrid fino a Napoli con la descrittione di Pausillipo e di molte Dame Napoletane, Napoli 1630, pp. 20-21.
27. F. Capecelatro, Degli annali della città di Napoli di don Francesco Capecelatro, Parti due, 1631-1640, a cura di S. Volpicella, Napoli 1849.
Vittoria Fiorelli456
l’ipotesi di Francesco d’Este, di Taddeo Barberini, del principe polacco Carlo Wasa, del fratello del granduca di Toscana.28 Questo orientamento non poteva che essere inviso alla corona spagnola, interessata a non perde-re il controllo sulle oltre quattrocento terre che costituivano il patrimonio dell’erede dei Carafa. Perciò la questione venne trattata direttamente da Olivares il quale, usando le parole di Giannone, «con assoluto arbitrio reg-geva in Spagna non meno il Re, che i suoi Stati, con superbissimo genio, e con massime severe».29 Egli accarezzava l’ipotesi di mettere insieme una dama napoletana e un esponente della nobiltà castigliana a lui vicino, che potesse col tempo sostituire il viceré in carica. Il duca di Medina, vedovo della figlia del Conte Duca dal quale era stato enormemente favorito, co-stituiva uno sposo ideale per il progetto di integrazione spagnola di uno dei più ingenti patrimoni napoletani e un ottimo candidato per rappresentare il re dopo essersi inserito nel tessuto nobiliare del Regno.30
Nel dibattito storiografico sull’evoluzione degli apparati nobiliari mo-derni si è più volte evidenziato, nell’ambito del sistema imperiale spagnolo, il ruolo ricoperto dalle esperienze accumulate nei reiños nel processo di for-malizzazione delle carriere che avrebbero contribuito alla trasformazione dell’aristocrazia in ceto di governo. Un percorso nel quale l’emersione dello “spirito di servizio” ha progressivamente affiancato la ricerca del vantaggio individuale propria della consuetudine alla contrattazione della deroga insi-ta nella normativa feudale.31 Nel nuovo clima istituzionale la compresenza
28. Il primogenito del duca di Modena Alfonso III d’Este sposò poi Maria Farnese mentre l’impegno con Gian Carlo de’ Medici, fratello di Ferdinando II, giunse alla scrittura di un trattato datato 19 gennaio 1630. Taddeo Barberini fu indicato come suggello di un ac-cordo sulla Valtellina tra la corona e il papa da G.B. Nani, Historia della repubblica veneta di Battista Nani cavaliere e procuratore di San Marco, Venezia 1673. Secondo Caputo il nipote del papa, dal 1627 marito di Maria Colonna, promise un appannaggio di trecentomila talleri e la concessione di tre cappelle cardinalizie.
29. P. Giannone, Istoria civile del Regno di Napoli, Venezia 1766, t. IV, p. 274. Dell’ipotesi è convinto Galasso che ne parla in Storia del Regno di Napoli, vol. III, pp. 134-136. Aldimari, Historia genealogica, p. 400.
30. Il conte di Monterey aveva svolto con successo una politica di rastrellamento fiscale che, condiscendendo alle continue richieste di Madrid, aveva ridotto allo stremo le riserve economiche e il consenso dei napoletani Anch’egli godeva di un legame familiare con Olivares avendo ciascuno sposato la sorella dell’altro.
31. Pur in presenza di una chiara regolamentazione feudale e consuetudinaria, era radicato nel Regno il costume di utilizzare le donne, sia nei regimi dotali che nella pratica testamentaria, per aggirare il rischio della devoluzione legato alla ristrettezza del campo
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 457
di pubblico e privato nello svolgimento dei compiti delle alte magistrature del Regno aveva incluso la progettazione delle alleanze familiari nell’oriz-zonte dell’attività di governo.32 Il matrimonio dei duchi di Medina de las Torres costituisce dunque un esempio paradigmatico dei rapporti delle élites italiane con la corona spagnola. Sostenuto dalla Aldobrandini, portavoce di interessi romani orientati a rafforzare il legame con Madrid in vista della sostituzione di Monterey,33 il progetto era osteggiato dalla Gonzaga che, in aggiunta al suo acceso antispagnolismo, era fermamente intenzionata a difendere Sabbioneta dalle mire della corona che cercava di recuperarne la gestione diretta. Dopo aver minacciato di diseredare Anna se avesse con-fermato l’intenzione di sposare il nobile protetto di Olivares, una volta ce-lebrate le nozze, la Gonzaga chiese al duca di Parma di occupare il ducato, del quale ella continuava a reggere le sorti. Odoardo, figlio di Margherita Aldobrandini, si prestò a questa prova di forza nei confronti di Madrid e avrebbe richiamato le truppe solo dopo il 1637 quando, morta la duchessa, avrebbe lasciato il territorio al controllo di Tiberio Brancaccio e dei suoi soldati inviati da Anna e dal marito, eredi di Isabella.34
Mentre grandi alleanze si tessevano nelle stanze delle donne di casa Carafa, quasi nessuno spazio veniva lasciato alla progettazione degli uo-
successorio. Una tendenza che si era mantenuta nel corso del Cinquecento quando le famiglie si erano strutturate per rami di lignaggio con patrimoni feudali autonomi. Gli Asburgo, pur ampliando le possibilità di trasmissione dei beni feudali, avevano riaffer-mato la centralità del ruolo del re nella determinare la loro circolazione attraverso una precisa revisione normativa che contemplava la concessione del regio assenso per le scel-te maturate all’interno del sistema di relazionali della famiglia. Cfr. Visceglia, Il bisogno di eternità ma anche A. Cernigliaro, Sovranità e feudo nel Regno di Napoli. 1505-1557, Napoli 1983.
32. A. Musi, Il feudalesimo nell’Europa moderna, Bologna 2007, pp. 97-122.33. Settembre 1632: «si dice ancora che S. Santità ne habbia scritto al Re molto risen-
titamente accumulando con questa molte altre male soddisfazioni avute dal Monterey vice-ré, dal che si giudica, che vi sarà presto mutatione di governo», Bucca, Aggionte, p. 309.
34. L’importanza di Sabbioneta nelle scelte di Isabella era ben chiara ai contempora-nei: «Volendo nel suo morire lasciare a chi più le aggradiva, sdegnata con Anna sua nipote per essersi maritata contro il suo volere, ed avendo già in cotal guisa fatto il suo testamento, svolta dalle preghiere del duca suo genero, il quale meravigliosamente s’avea acquistato il suo buon volere, da quelle del duca di Sermoneta e dall’autorità del padre Olimpo, rivocò quel che fatto avea, lasciando erede sua nipote», Caputo, Annali, p. 78. Il ducato sarebbe poi passato da Anna al figlio Nicola Guzmán Carafa e alla sua morte nel 1698 sarebbe tornato all’imperatore. Vedi poi anche la nota 43.
Vittoria Fiorelli458
mini. Luigi, rimasto a capo del casato dopo la morte del figlio, accarezzava l’ipotesi di un “matrimonio parallelo” che mantenesse titoli e beni all’in-terno della famiglia.35 La sua avversione allo sposo spagnolo era dovuta a un atteggiamento diffuso nel tessuto aristocratico napoletano, che per-cepiva la cessione dotale come ulteriore prelievo di risorse ai danni della nobiltà del Regno. Le sue aspettative rimasero schiacciate dalle tensioni che attraversavano i suoi rapporti con la moglie e che lo spinsero di lì a poco a ritirarsi dai Gesuiti dove morì nel 1630.36 Il matrimonio con Medina fu dunque una scelta di Anna e della madre. Parte integrante degli accordi erano la nomina a viceré per il duca, insieme all’abituale corredo di titoli e benefici che accompagnava questi percorsi di integrazione tra aristocrazie diverse.37 L’avvicendamento ai vertici del governo napoletano venne però
35. Secondo la consuetudine di incrociare rami diversi dello stesso casato uno dei pretendenti era Antonio Carafa duca di Nocera che, secondo Bucca, abbandonò la capita-le nel 1629 «per vedere andare poco bene le sue pretendenze al matrimonio di Anna». Il possibile matrimonio accese la rivalità tra altri esponenti del casato: il duca di Maddaloni e il marchese di Castelvetere, primogenito del principe della Roccella, gareggiavano in abiti, serenate e magnificenze di ogni tipo. Di uno scontro durante un ricevimento tenuto-si il 5 giugno 1633 nel palazzo del viceré parla Bucca, Aggiunta, pp. 123 ssg. Volpicella riporta la voce che il principe di Stigliano avrebbe stretto nel 1627 una trattativa segreta con il duca d’Alba promettendo la mano della nipote al figlio Ferdinando, contestabile di Navarra.
36. Dopo una lunga consuetudine con i chierici regolari Luigi scelse i gesuiti proprio per aggirare il legame della moglie con la casa di S. Paolo. Nelle lettere scritte da Isabella al teatino Pescara Castaldo durante il soggiorno romano della nuora risulta evidente l’insoffe-renza nei confronti del marito, ma anche la consapevolezza del coinvolgimento dei religiosi nelle tensioni private: «che il Principe non si ferma mai di fare delle sue pazzie, e che vuole comprare l’officio di Giustiziero, e però ne vorrìa scriverne alla duchessa, e vorrìa un Padre teatino confidente di Vostra Paternità a Roma, al quale vorrìa mandare in mano la lettera della duchessa e che il detto Padre ce la leggesse e facesse vedere» e ancora « se non può venire, Vostra Paternità avvisame se v’è risposta per la staffetta; io gli manderìa la carrozza, ma pigliala che si pagherà qua, acciò non para che io lo mando a pigliare, che i Gesuiti ci vegliano», BNNa, ms. San Martino 213.
37. Il nesso tra le nomine e il matrimonio è chiaro: «cum nomine Illustrium consan-guinearum nostrarum Ducissae de Mondragon et Donnae Annae Carrafae Principessae Ho-stiliani eius filiae nobis humiliter supplicatum fuerit ut ad effectum matrimonis inter te pra-edicte dux condere dignaremur futuram successionem officij Magisteri Iustitiarij Citerioris [...] Siciliae Regni» Archivio General de Simancas, Secreterias Provinciales, libro 195, ff. 216r-221r.; «[...] ad effectum matrimonij [...] concedere dignaremur futuram successionem Praefecturae Castri seu arcis Castrinovi fedelissimae civitatis nostrae Neapolis», Ivi, libro 196, ff. 120v-125v.
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 459
più volte ritardato provocando stizzite reazioni da parte di tutti i compo-nenti della famiglia.38
Durante il mandato vicereale la presenza di Anna accanto al marito sembra parte dell’apparato di potere: le occasioni ufficiali si sovrappo-nevano agli impegni mondani in un contrasto stridente con le ristrettezze economiche patite dal Mezzogiorno in quegli anni.39 è il caso del ballo in maschera tenuto a Palazzo nel 1639 ricordato come un evento memorabile anche oltre i confini del Regno. Ventiquattro dame, guidate dalla viceregina, si vestirono da amazzoni «passando il segno della modestia femminile».40
Galasso ha recentemente sottolineato quanto lucida fosse la visione del panorama socio-politico della capitale che guidava le scelte di Medina e non vi è dubbio che le assidue frequentazioni di ceto alle quali attendevano il duca e la moglie fossero parte dell’azione di controllo dell’antispagnoli-smo latente, ma anche spia della capacità di tessere le relazioni necessarie ad ottenere il sostegno del baronaggio per le richieste della corona.41 Per
38. Giunto a Napoli nell’aprile del 1636 il duca venne ricevuto con gli onori del futuro incarico. Le nozze furono celebrate nel palazzo di Chiaia mentre Monterey simulava la par-tenza. L’avvicendamento sarebbe però avvenuto solo nel novembre 1637. Su questo Bucca, Aggionta, p. 144; D.A. Parrino, Teatro eroico e politico de’ governi de’ vicere del regno di Napoli dal tempo del re Ferdinando il Cattolico fino al presente ..., Napoli 1692-1694, vol. II, p. 252. Capecelatro, più incline alla lettura politica, ha attribuito il ritardo ad un accordo tra Olivares e il viceré. Nel dicembre del 1634, dopo che a settembre il matrimonio e la nomina vicereale erano stati confermati, nelle corrispondenze dei diplomatici si ipotizzava ancora che il governo del Regno tornasse nelle mani del duca di Alcalà e che al duca di Medina spettasse solo l’interim. Vedi i dispacci raccolti nelle Corrispondenze diplomatiche veneziane citati da Galasso, Storia del Regno di Napoli, vol. III, pp. 135-136.
39. La viceregina era presente alla partenza delle truppe inviate a Milano nella primave-ra del 1638 quando un colpo di cannone partito accidentalmente colpì la facciata del palazzo da cui si era affacciata col marito. Capecelatro, Annali, p. 124. Il 24 giugno 1640 partecipava alla cavalcata per la festa di s. Giovanni allestita dall’eletto Naclerio interrotta da un acquaz-zone «lui costrinse a tornarsene postosi subito in un cocchio frettolosamente con la viceregina sua moglie che giva in sedia, tutto molle al suo ostello» Ibidem, p. 198. Il 15 gennaio 1639 durante una visita alla Vicaria otteneva la grazia per alcuni condannati: BNNa, T. Mozzi, Avvisi pubblici dell’anno 1639 scritti da Roma da Timoleone Mozzi, ms. XII B, f. 18v.
40. Ivi, dispaccio del 26 febbraio. Vedi anche G.C. Sorrentino, La fama. Panegirico per lo ballo dell’Eccellentiss. Sig. D. Anna Carafa, s.l. 1639. Era lo stesso anno in cui un difficile parlamento aveva fatto emergere tutte le divisioni e le fratture interne alla nobiltà e ai seggi causate dalla difesa corporativa dei patrimoni e delle nicchie di privilegio.
41. Si vedano a questo proposito le lettere di Medina a Olivares citate da Galasso, ma anche quelle conservate in BSNSP, ms. XXVII B 11.
Vittoria Fiorelli460
questo il duca era costretto a coltivare quel gruppo di mercanti e finanzieri che in quegli anni costituivano il supporto irrinunciabile al finanziamento dei donativi napoletani; un impegno nel quale la presenza della viceregina era tutt’altro che secondaria, perché rafforzava l’immagine di familiarità con ambienti che non sarebbero altrimenti rientrati tra quelli elettivamente scelti da una coppia così attenta ad ostentare la propria posizione.42 Un atteggiamento nel quale il lignaggio e il patrimonio dei Carafa erano utiliz-zati dal viceré a sostegno del suo ruolo di governo, confondendo pubblico e privato in un unico apparato.43
In questo quadro, nel 1642, iniziarono i lavori, progettati da Cosimo Fanzago, per ristrutturare il casino della Sirena a Posillipo e trasformarlo in una vera e propria reggia delle meraviglie da affiancare alla splendida residenza di Chiaia. La ristrutturazione rimase incompiuta a causa della partenza precipitosa di Medina alla fine del suo mandato. Rientrato in Spa-gna il duca perse ogni interesse alle vicende della famiglia e ai progetti che aveva abbandonato a Napoli.44
Non sembra comunque di poter attribuire alla Carafa un potere com-misurato al suo ruolo pubblico. Lo denuncia per esempio la sua incapacità di favorire le mire del suo confessore al titolo di vescovo di Reggio. L’in-fluente teatino Benedetto Mandina preferì ingraziarsi il viceré attraverso la spregiudicata gestione di una trattativa con gli eletti, piuttosto che affidarsi all’intercessione della sua figlia spirituale.45
Allo scadere del suo mandato, dopo avere cercato di prolungare in ogni modo il suo soggiorno napoletano, il Medina partì per la Spagna la-
42. Sulla consuetudine col mercante Bartolomeo d’Aquino, personaggio chiave dell’alleanza del ceto mercantile con gli spagnoli, Capecelatro, Annali, pp. 201-207.
43. Il titolo imperiale di Sabbioneta era certamente quello più prestigioso. Scipione Gonzaga aveva cercato di recuperarlo portando la questione davanti alla Camera Imperiale che il 2 maggio 1640 emetteva una sentenza favorevole ad Anna. F. Censalio, Observatio-nes singulares cum additionibus ad tractatum de fideicommissis Marci Antonimi Peregrini, Lugduni 1672, pp. 114-141. Va comunque considerato che il ducato di Sabbioneta, esposto alle tensioni europee, poneva problemi di gestione politica di non poco conto mentre i feudi napoletani, inseriti nel sistema di una corona stabile, costituivano una risorsa per l’incre-mento delle rendite necessarie a sostenere lo sfarzo della vita del viceré.
44. M. Schipa, Il Palazzo di Donn’Anna a Posilipo, in «Napoli Nobilissima», XII/3 (1903), pp. 177-185. Sul ruolo mondano delle residenze di Posillipo: R. Pane, L’ambiente tra cronaca e storia, in Seicento napoletano. Arte, costume e ambiente, Milano 1984, pp. 2-11.
45. L’episodio è in Capecelatro, Annali, pp. 123-124.
Una viceregina napoletana della Napoli spagnola: Anna Carafa 461
sciando la moglie incinta e malata nella casa di Portici. Le fonti non chia-riscono se sia stata Anna a rifiutare di seguire il marito o se la separazione non sia piuttosto da attribuire all’esaurimento del ruolo politico del loro matrimonio. La duchessa «addolorata per la perdita del governo [...] poscia sconciatasi, morì d’una infermità, che l’innondò di pidocchi: servendo di solennissimo essempio all’umana superbia, giache tutte le grandezze, che per ricchezza, per nascimento, per bellezza, e per dignità s’addrappellarono nella persona di questa Dama, si videro ridotte in un punto in un mucchio di così vili immondizie».46 Sepolta nella vicina chiesa degli Agostiniani non le fu concesso il rito ducale connesso al titolo di Sabbioneta che aveva accompagnato Luigi né la successiva traslazione in una chiesa della capi-tale, nella cappella di famiglia dentro San Domenico Maggiore.
La vicenda personale della Carafa, nella quale era sembrato di poter ritrovare la traccia della parabola ascendente di uno dei maggiori lignag-gi napoletani, avrebbe invece segnato la fine di un ramo del casato e lo smembramento del suo patrimonio.47 Se è indubbia l’incidenza della diffi-cile congiuntura economica degli anni Trenta e Quaranta del secolo XVII nell’indebitamento che provocò la vendita da parte del fisco delle presti-giose residenze cittadine dei principi di Stigliano, altrettanto chiara è la sua connessione con il fallimento, aggravato dalle difficoltà demografiche, della loro strategia matrimoniale.
A differenza di politiche familiari come quelle dei Caracciolo di Brien-za che avevano fatto del radicamento dei feudi un punto di forza, l’orien-tamento cittadino e internazionale della politica matrimoniale dei Carafa aveva rivelato una debolezza strutturale. Il prestigio del viceregno non era bastato a garantire continuità al casato, mentre era stata piuttosto la rile-vanza del suo lignaggio a dare lustro al duca di Medina. Questi, alla fine del suo mandato, avrebbe abbandonato Napoli e la moglie per proseguire la propria carriera all’ombra della corte.
Tra la vita mondana al tempo del viceré Pedro de Toledo e quella che ha caratterizzato il governo dei suoi successori sembra dunque si sia con-sumata una evoluzione culturale, oltre che politica e sociale. L’affermazio-ne del costume spagnolo negli stili di vita e nella progettazione delle reti
46. Parrino, Teatro eroico, vol. II, p. 298.47. Le difficoltà di Anna con i creditori sono trattate dalle fonti con dovizia di partico-
lari. Portata davanti al Consiglio Collaterale il 4 giugno 1636 la questione venne ripianata solo alla morte dei figli della Carafa. Sollevazione, pp. 234 e 242.
Vittoria Fiorelli462
di relazione della capitale avrebbe fatto emergere un rigido formalismo dai chiari risvolti morali, che aveva progressivamente sfumato la presenza femminile negli apparati di potere, riducendo al minimo anche la valenza di rappresentanza che le donne avevano ricoperto fino a quel momento.48
L’estinzione del ramo dei Carafa dopo la morte dei figli di Anna e la dissoluzione del loro patrimonio gravato da debiti hanno fatto dimenticare la presenza di questa gentildonna napoletana al fianco del viceré. La sua scarsa autonomia rispetto al ruolo del marito rispondeva alle esigenze della nuova etichetta, ma l’assenza totale della sua iniziativa ha probabilmente scontato una formazione schiacciata dal peso delle altre donne di famiglia, il cui spessore pubblico godeva di un rilievo e di un posizionamento ora-mai tramontato nella Napoli barocca.
Le due viceregine giunte nel Regno prima e dopo di lei sono ricordate dai contemporanei per la loro capacità di fare da sponda al governo dei ma-riti. L’immagine di donn’Anna invece si è sbiadita al punto che, all’inizio del ’900, lo splendido palazzo che ancora porta il suo nome nelle abitudini dei napoletani veniva legato alla regina Giovanna e Matilde Serao, nelle pagine da lei dedicate a quei luoghi, attribuiva alla Carafa il titolo di du-chessa di Medina Coeli.49
48. Non si intende in questa sede cercare di semplificare una bibliografia molto vasta sul ruolo dei linguaggi nella storia della cultura. Ci limitiamo a segnalare: S. Bertelli, Vivere a palazzo, in Vivere a Pitti. Una reggia dai Medici ai Savoia, Firenze 2002, pp. VII-XXIV; S. Mantini, «Alli altri del vulgo lasciaremo fantasticare col cervello»: letture e linguaggi dei cerimoniali rinascimentali, in Le trame del tempo. Reti di saperi, autonomie culturali, tradizioni, a cura di R. Mancini, Roma 2005, pp. 181-204.
49. M. Serao, Il palazzo dogn’Anna, in M. Serao, Leggende napoletane, Napoli 1993, p. 77-89.