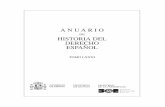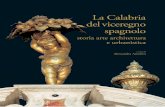Lavoro di squadra. Alleanza profit e non profit per un volontariato di competenze
Guerra civile spagnola e volontariato internazionale: il caso italiano in prospettiva comparata
Transcript of Guerra civile spagnola e volontariato internazionale: il caso italiano in prospettiva comparata
1
Guerra civile spagnola e volontariato internazionale
Il caso italiano in prospettiva comparata
Enrico Acciai Università degli Studi della Tuscia
1. Premessa
Quello del volontariato internazionale durante la guerra civile spagnola è un tema ancora oggi
in grado di suscitare dei vivaci dibattiti: sono passati pochi anni da quando, nell'autunno del
2007, il governo polacco propose di cancellare le pensioni dei volontari suscitando una
reazione sdegnata del primo ministro spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero. Ma perché
quest’ostinazione? La guerra civile spagnola, e con essa il fenomeno del volontariato, deve
essere accosta alle vicende della seconda guerra mondiale: se i traumi ad essa legati sono
ancora ben presenti nella memoria collettiva europea, si può dire altrettanto riguardo a quelli
derivati dal conflitto iberico. «Gli ultimi rigurgiti di memorie laceranti», ha recentemente
scritto Tony Judt, «non devono essere intesi come sinistra prova del “peccato originale”
dell'Europa. […] L'Europa non sa rientrando nel suo inquietante passato di guerra: al contrario,
ne sta uscendo».1 Si tratta però di un processo lungo e complicato. Il 2006, l'anno delle
celebrazioni per il settantesimo anniversario dallo scoppio della guerra civile, ci ha dimostrato
in maniera lampante quanto nella Spagna di oggi la guerra civile sia ancora in grado di toccare
nel profondo la società civile.2 Anche in quell'occasione, così com'era successo dieci anni
prima, gli ex-combattenti stranieri hanno occupato un ruolo importante nelle celebrazioni;
crediamo quindi che sia tanto attuale quanto tutt’altro che scontato tornare a parlare di quel
volontariato. Il caso italiano merita poi un'attenzione particolare: oltre a mancare un lavoro di
sintesi sull'intervento dell'antifascismo italiano, non ci sono ancora neanche certezze riguardo il
numero totale di volontari.3
1 Tony Judt, Dopoguerra – Com'è cambiata l'Europa dal 1945 ad oggi, Milano, Mondadori, 2007, pp. 14-15.
2 Si veda, a questo proposito, il bel saggio di François Godicheau, “Après le soixante.dixième anniversaire de 1936: vers une histoire en débat?”, in: Mélanges de la Casa de Velazquez, 38 (2008), pp. 271-290. Un altro testo di riferimento riguardo il tema della memoria è: Julio Arostegui, François Godicheau (a cura di), Guerra Civil – Mito y memoria, Madrid, Marcial Pons, 2006.
3 Negli elenchi pubblicati dall'Aicvas [Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna] si è sempre parlato di poco più di 4.000 uomini (AA. VV., La Spagna nel nostro cuore, 1936-1939 – Tre anni di storia da non dimenticare, Roma, AICVAS, 1996). In realtà, come vedremo in questo nostro intervento, crediamo
2
Le decine di migliaia di volontari che accorsero in Spagna, tra il 1936 ed il 1939, da ogni parte
del mondo lo fecero principalmente perché vedevano nei fascismi, e nelle loro politiche
aggressive, delle minacce ai loro “mondi privati”. Nelle prossime pagine ci concentreremo sul
caso italiano, ed in particolare su le due principali formazioni che “accolsero” i volontari
italiani: la Sezione Italiana della Colonna Ascaso (una colonna composta principalmente da
anarchici che combatté sul fronte aragonese) ed il Battaglione Garibaldi delle Brigata
Internazionali (la principale esperienza dell’antifascismo italiano in Spagna). Si cercheranno di
individuare le peculiarità di queste due esperienze rispetto al complesso del volontariato
internazionale. Cercheremo di dimostrare come chi scelse di partire non fu né un eroe
romantico né, tanto meno, un mercenario al servizio di Stalin ma, più semplicemente, si trattò
di uomini pienamente inseriti nelle contraddizioni e nei conflitti del proprio tempo. Le ricerche
degli ultimi anni sui diversi casi nazionali sono state caratterizzate da una rinnovata, o a volte
trovata, centralità dei volontari e delle loro vicende personali; una strada che si è rivelata quella
giusta per riuscire, finalmente, ad analizzare la complessità e le contraddizioni di un fenomeno
centrale nella storia europea del XX secolo: poter osservare «da una prospettiva individuale un
fenomeno che finora è stato studiato unicamente in modo collettivo», ha recentemente
osservato Lourdes Prades, si può rivelare la giusta via per andare ancora più a fondo nella sua
stessa comprensione.4
2. Guerra civile spagnola e volontariato internazionale: l’origine del contributo
italiano
Nell’estate del 1936 una parte dell’esercito cercò di rovesciare il legittimo governo, il tentativo
non solo fallì ma diede il via ad una guerra civile che sarebbe durata quasi tre anni.5 A metà
luglio la Spagna era praticamente divisa in due e nel giro di poche settimane quello spagnolo
divenne un conflitto dalle spiccate caratteristiche internazionali: il sostegno italo-tedesco agli
insorti non si fece attendere, mentre le democrazie europee abbandonarono ben presto al suo
destino quella spagnola.6 Sin dai primi momenti, in molti cominciarono ad accorrere in Spagna
che questa cifra dovrà essere necessariamente rivista al rialzo.
4 Maria Lourdes Prades i Artigas, “I miliziani delle Brigate Internazionali della guerra civile spagnola e la memoria storica, un sistema di informazione digitale”, in Spagna Contemporanea, 36 (2009) p. 194.
5 Riguardo alle prime fasi del conflitto spagnolo si veda: Angel Viñas, La soledad de la República – El abandono de las democracias y el viraje hacia la Unión Soviética, Barcellona, Critica, 2006.
6 Ivi, pp. 45-52.
3
per offrire il proprio sostegno alla causa repubblicana: «vidi negli invasori della Spagna»,
avrebbe poi ricordato un ex-volontario inglese, «quelle stesse persone che avevo combattuto
per tutta la vita».7 Quel fenomeno volontaristico che avrebbe avuto nelle Brigate internazionali
la sua declinazione più celebre si andò delineando sin dai primi momenti. Durante le settimane
a cavallo tra il luglio e l’agosto, Barcellona fu letteralmente invasa da una moltitudine umana:
rapidamente si diffuse la consapevolezza che quello spagnolo sarebbe stato un conflitto
destinato a travalicare, almeno a livello simbolico, il limite geografico dei Pirenei.8
L’Europa del 1936 era un continente con un alto numero di esiliati e di rifugiati politici, uomini
e donne che avrebbero costituto la base di quel volontariato. C’erano gli ungheresi che avevano
sostenuto al rivoluzione di Béla Kun e che poi erano stati vittime del regime dell’ammiraglio
Horthy, i polacchi oppositori del generale Pilsudski, i greci che scappavano a Metaxas e poi i
rumeni e gli jugoslavi, per non citare i casi più noti dei tedeschi e degli austriaci antinazisti (a
cui andrebbero sommati gli esuli ebrei) e degli italiani antifascisti. Nella sola Francia erano
presenti circa due milioni e mezzo di esiliati provenienti da mezza Europa e costituivano più
del 5% della popolazione.9 Fu questo il variegato universo umano che per primo si rese conto
della natura ideologica che andava assumendo la guerra civile spagnola e fu da allora che
impedire la vittoria dei militari insorti divenne, per molti, un imperativo: «avevano ben chiaro
che il fascismo costituiva una minaccia internazionale e che la Spagna era il luogo appropriato
dove combatterlo».10
I passaggi della frontiera franco catalana di Port-Bou si fecero progressivamente più intensi. Il
30 luglio l’ambasciatore repubblicano a Parigi, Alvaro de Albornoz, riferì come nei suoi uffici
si presentassero, giornalmente, antifascisti italiani e tedeschi che si offrivano per partire per la
Spagna.11 A fine agosto, un informatore fascista presente a Barcellona avrebbe riportato, forse
esagerando le cifre, che da quando era cominciato il conflitto arrivavano regolarmente, via
Port-Bou, due treni al giorno «carichi di volontari rossi e fra questi una media di 60-70 italiani
7 Richard Baxell, British Volunteers in the Spanish Civil War, Londra, Warren&Pell, 2007, p. 50
8 Cfr. Remi Skoutelsky, “L’engagement des volontaires françias en Espagne républicaine”, in Le Mouvement social, 181 (1997).
9 Michael Jackson, Fallen Sparrows. The International Brigades in the Spanish Civil War, Philadelphia, American Philosophical Society, 1994, p. 42.
10 Julián Casanova, República y guerra civil, Madrid, Critica/Marcial Pons, 2007, p. 276-277.
11 “Telegramma dell'ambasciatore spagnolo a Parigi”. 30/07/1936. Caja RE-154, Carpeta 33, Archivo Ministerio Asuntos Exteriores, Madrid (AMAE).
4
al giorno».12 Secondo i dati raccolti da Rémi Skoutelsky, alla fine di agosto sarebbero stati già
presenti in Catalogna almeno 280 volontari francesi; per una fase nella quale ancora non era
organizzato un sistema di reclutamento su vasta scala si tratta di un dato significativo.13
Nel giro di pochi giorni, visto il grande afflusso di stranieri verso la Catalogna, a Barcellona
cominciarono ad organizzarsi dei gruppi “internazionali” che si affiancarono alle colonne di
miliziani in formazione.14 Tra questi ci fu anche la Sezione Italiana della Colonna Ascaso. Una
colonna che si formò per l’iniziativa dell’anarchico Camillo Berneri e del fondatore di GL,
Carlo Rosselli, e che avrebbe visto passare tra le sue fila quasi 650 antifascisti italiani, in larga
parte anarchici.15 Questo primo gruppo italiano, inquadrato nella colonna libertaria intitolata a
Francisco Ascaso, partì da Barcellona per il fronte aragonese la sera del 19 agosto ed
inizialmente contò su circa 130 volontari (non pochi se si considera che la guerra civile era
scoppiata da appena un mese). Nel giro delle settimane successive, cominciò poi a prendere
forma anche il progetto delle BI [Brigate Internazionali]: nonostante le notizie diffuse dalla
stampa nazista e da quella dell’estrema destra francese che parlavano di una legione straniera
gestita dai sovietici già da fine luglio, questo corpo sarebbe apparso sui campi di battaglia
solamente durante i primi giorni di novembre.16 Non essendo questa la sede per entrare nel
complesso dibattito sulla loro formazione, basterà ricordare che le BI con ogni probabilità non
sarebbero potute nascere senza l’iniziativa che venne da Mosca ma, nonostante questo, è
inopportuno definirle, come hanno fatto Dan Richardson e altri, l’armata del Comintern o un
«esercito sovietico in terra spagnola».17
La brigata a maggioranza italiana, passata alla storia con il nome prima di battaglione e poi di
brigata Garibaldi, fu la XII. Come vedremo meglio in seguito, quello italiano fu un contributo
12 “Relazione informatore C20/67”. 26/08/1936. Divisione Polizia Politica (DPP), Fondo per Materia (FM) Pacco 50, Fascicolo 1, Archivio Centrale dello Stato, Roma (ACS).
13 Skoutelsky, L'engagement des volontaires... cit., pp. 8-9.
14 Sulla questione delle milizie durante le prime fasi della guerra civile spagnola si veda il saggio: Michael Alpert, El ejército popular de la República (1936-1939), Barcellona, Crítica, 2007, pp. 35-92.
15 Per quanto riguarda la Sezione Italiana della Colonna Ascaso mi permetto di rimandare alla mia tesi di dottorato: Enrico Acciai, Viaggio attraverso l’antifascismo. Volontariato internazionale e guerra civile spagnola: il caso della Sezione Italiana della Colonna Ascaso, XXII Ciclo di Dottorato, Università degli Studi della Tuscia. I comunisti ed i socialisti che presero parte a questa esperienza lo fecero a titolo personale e, a volte, andando contro le direttive dei propri partiti.
16 Rémi Skoutelsky, Novedad en el frente – Las Brigadas internacionales en la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, pp. 71-98.
17 Ronald Radosh, Mary Habeck, Grigory Sevostianov, España traicionada - Stalin y la guerra civil, Barcellona Planeta, 2002, [ed. orig. Spain betrayed, 2001] p. 146.
5
peculiare al fenomeno inter-brigatista: tra i garibaldini ci fu, infatti, una varietà politica che non
conobbe nessun altro gruppo nazionale. «Fate sapere che anche i comunisti italiani», recitava
una nota del comitato centrale del PCd’I redatta pochi giorni dopo la vittoria di Guadalajara e
indirizzata ai propri militanti, «lottano oggi per la conquista della democrazia, della libertà, non
si pongono come obbiettivo politico attuale un’Italia sovietica, pur senza rinunciare al loro
obbiettivo finale. In questo momento, il problema essenziale è di unire tutti gli antifascisti e
tutti coloro che soffrono della situazione creata dalla catastrofe politica di Mussolini, senza
eccezioni».18 La scelta di intitolare il gruppo a Giuseppe Garibaldi, l’eroe per antonomasia del
risorgimento, è rappresentativa della ricerca di un consenso che fosse il più ampio e condiviso
all'interno del mondo dell’antifascismo italiano, questa fu approvata durante una riunione dei
primi commissari politici italiani che si tenne la mattina del 4 novembre. In quell’occasione
furono scelti anche i nomi delle quattro compagnie italiane che avrebbero fatto parte della XII
brigata (Sozzi, De Rosa, Angeloni e Gramsci) e fu presentato Randolfo Pacciardi,
repubblicano, come comandante della formazione.19
Le due esperienze dell'antifascismo italiano in Spagna ebbero storie tra di loro molto diverse.
La Sezione Italiana, come avrebbe ricordato anche uno dei suoi componenti, a partire dalla fine
del dicembre 1936 dovette fare i conti con l'abbandono del fronte da parte di Carlo Rosselli e
dei militanti di GL.20 Rosselli aveva tentato, fallendo e creando delle tensioni in seno alla
Sezione Italiana, di favorire un'unione tra le due colonne italiane presenti in Spagna
nell'inverno del 1936; ancora nel successivo gennaio, dalle pagine del periodico “Giustizia e
Libertà”, avrebbe lanciato un appello per una «legione unica» che unisse tutti gli italiani.21 Il
resto della Sezione Italiana sopravvisse fino all’aprile 1937, quando i suoi membri, ormai tutti
anarchici, non volendo cedere alla militarizzazione portata avanti dalle autorità repubblicane
decisero di sciogliere il gruppo. Molti dei reduci si sarebbero trovati, rientranti dal fronte, a
Barcellona durante gli scontri del maggio di quell’anno. Il Battaglione Garibaldi condivise
invece la propria storia con quella delle BI. Nella primavera del 1937, mentre la Sezione
18 “Lettera del Comitato Centrale del Pcd’I”. Marzo 1937. Fondi del Comintern (FC), fascicolo 545-3-152, folio 16, Centro Russo per la Conservazione degli Archivi di Storia Politica e Sociale, Mosca (RGASPI).
19 Antonio Roasio, “Memorandum Organizzazione del Battaglione Garibaldi”. 24/06/1937. FC, fascicolo 545-3-174, folio 65, RGASPI.
20 Umberto Marzocchi, “Ricordando Camillo Berneri e gli avvenimenti della rivoluzione spagnole del 1936-37” in: AA. VV., Camillo Berneri nel cinquantesimo della morte, Pistoia, Edizioni Archivio Famiglia Berneri, 1986, p. 67.
21 Carlo Rosselli, Scritti dall’esilio – Volume II, dallo scioglimento della Concentrazione Antifascista alla Guerra di Spagna, Torino, Einaudi, 1992, p. 449.
6
Italiana si stava sciogliendo e alcune settimane dopo la celebre vittoria di Guadalajara, la
Garibaldi divenne una brigata autonoma composta esclusivamente da italiani e spagnoli.22 La
colonna sopravvisse fino all'autunno del 1938, quando il governo repubblicano prese
unilateralmente la decisione di ritirare i volontari stranieri e, di fatto, sancì lo scioglimento delle
BI.23
3. Ritratti di gruppo: per una prosopografia della Sezione Italiana e della Brigata
Garibaldi
Si cercheranno ora di fare alcune riflessioni partendo dai dati biografici di coloro che fecero
parte della Sezione Italiana e del Battaglione Garibaldi. Prima si rende però necessario un
chiarimento riguardo ai dati che si andranno ad utilizzare: negli ultimi anni chi scrive ha
elaborato una base di dati per ciascuno dei due gruppi di antifascisti italiani. Nel caso della
Sezione Italiana, il database è stato realizzato partendo da dei fondi documentali dell’Archivo
general de la guerra civil española di Salamanca, dove si è scoperto essere conservate (divise
tra le casse PS Barcelona 454, PS Barcelona 455, PS Madrid 485, PS Madrid 486 e PS Madrid
487) le carte dell’ufficio di arruolamento del gruppo. Per quanto riguarda i garibaldini si è
invece lavorato partendo da due liste conservate negli archivi del Comintern: la prima, più ricca
di informazioni, risale all’estate del 1938 e comprende circa 700 nomi; la seconda invece, più
scarna di dati, porta la data del 3 maggio 1938 ed elenca alfabeticamente i poco più di 2.300
italiani presenti nella brigata Garibaldi in quel momento.24 In entrambi i casi, i dati sono poi
stati incrociati con quelli, sia inediti sia editi, rintracciabili in Italia. Per i primi abbiamo fatto
riferimento a due importanti fondi dell’Archivio Centrale dello Stato: il Casellario Politico
Centrale e la Divisione Polizia Politica – Fascicoli Personali. I dati editi sono invece quelli già
raccolti in due lavori biografici: il primo è La Spagna nel nostro cuore, 1936-1939 frutto degli
sforzi dell’Aicvas e pensato per raccogliere le biografie dei circa 4.000 volontari italiani in
Spagna, mentre il secondo è il Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani, realizzato in anni
più recenti con il patrocinio della Fondazione Franco Serantini.25 I dati che emergono da queste
due basi di dati, se considerati in prospettiva comparata con gli altri casi nazionali, determinano
22 “Relazione di Luigi Gallo”. s/d. FC, fascicolo 545-1-073, folio 66, RGASPI
23 Mirta Núñez Diaz-Balart, La disciplina de la conciencia: las Brigadas Internacionales y sy artillería de papel, Barcellona, Flor del Viento, 2006, pp. 114-115 e Skoutelsky, Novedad en el Frente... cit., pp. 385-391.
24 Fascicolo 545-6-472 e fascicolo 545-6-473, RGASPI.
25 AA. VV., La Spagna nel nostro cuore... cit. e AA. VV., Dizionario Biografico degli Anarchici Italiani (Volumi 1 e 2), Pisa, BFS, 2003/2004.
7
un quadro molto interessante del volontariato italiano in Spagna.
Iniziamo da un dato sostanziale per capire chi furono i volontari italiani: quale fu la loro
età media? Incrociando i dati dei due gruppi emerge una media di 35 anni. Gli italiani
furono quindi sostanzialmente più “adulti” rispetto ai loro compagni d’armi inglesi o
francesi.
Età Italiani B. Garibaldi Italiani S.
Italiana
Francesi Inglesi Tedeschi Jugoslavi
Under 21 1,2% 1,3% 2,6% 4,2% 2,2% 1,9%
21-‐25 8,9% 6,8% 24,8% 32,1% 20,4% 19,7%
26-‐30 17,4% 16,5% 32,6% 23,6% 26,7% 29%
31-‐35 28,3% 25,3% 21,9% 20,4% 22,1% 25,4%
36-‐40 26,2% 29,9% 13,7% 12,3% 17,7% 16,4%
Over 40 17,7% 19,9% 4,4% 7,3% 10,9% 7,4%
Fig. 3.1 – Età media26
Come si evince dai dati contenuti nella tabella 3.1, le differenze rispetto ad altri casi
nazionali sono sensibili e, per trovare degli elementi di contatto, questi andrebbero
cercati in relazione più ai volontari jugoslavi e a quelli tedeschi che non a quelli inglesi o
francesi. Ancora più giovani, e quindi più lontani dagli italiani, gli statunitensi, il cui dato
oscillò tra i 23 ed i 25 anni.27 Gli italiani erano nati in larga parte nel decennio che va dal
1898 al 1908, l’anno che ricorre maggiormente è il 1903, e non pochi di loro avevano
preso parte alla prima guerra mondiale: tra i garibaldini che dichiararono di aver
ottemperato agli obblighi di leva, ben il 37% aveva partecipato a quel conflitto. Uno dei
personaggi de L’Espoir di André Marlaux nota, forse esagerando, come durante il primo
inverno in Spagna almeno il 60% degli italiani avesse più di 45 anni!28 Gli unici che
poterono competere in anzianità furono i tedeschi, tra i quali quasi il 30% aveva più di 36
26 Per il caso inglese, quello francese, quelle tedesco e quello jugoslavo si veda, rispettivamente: Baxell, British Volunteers..... cit., p. 24; Skoutelsky, L'espoir guidait leurs..... cit., p. 142; Michael Uhl, Mythos Spanien. Das erbe der internationalen Brigaden in der DDR, Bonn, Dietz, 2004, p. 60 e Hervé Lemesle, “Les volontaires yougoslaves en Espagne republicaine: un contingent specifique?”, in: Stanislav Demidijuk, Rémi Skoutelsky, (a cura di), Nouveaux regards sur les Brigades Internationales: Espagne 1936-1939, Barcellona, Indigene Editions, 2010, p. 40.
27 Skoutelsky, Novedad en el frente.... cit., p. 172.
28 André Malraux, L'Espoir, Parigi, Gallimard, 1937, p. 521.
8
anni.29
Essere più “maturi” significava aver conosciuto il periodo della “guerra civile” dei primi
anni venti: la nascita del fascismo, le violenze squadriste e l’avvento al potere di Mussolini
erano eventi traumatici, spesso nel senso più letterale del termine, che avevano segnato la
vita della maggioranza dei futuri volontari in Spagna.30 Esiste un altro dato che può essere
utile per trovare un sottile filo rosso che metta in relazione la scelta di partire per la
Spagna con quel periodo della storia italiana: prendendo in considerazione tre grandi
provincie (quella di Bologna, quella di Firenze e quella di Torino), si scopre che la maggior
parte dei volontari, ben il 70%, era originaria non del capoluogo bensì delle aree rurali
circostanti. Sappiamo come quella fascista fosse una violenza legata al territorio e come
colpisse duramente soprattutto nei centri minori: in una dimensione piccola, piuttosto
che in una grande città, era più facile essere pubblicamente conosciuti come “rossi” e
cadere quindi vittima delle violenze.31 Ci furono poi anche una quarantina di reduci
dall’effimera esperienza antifascista degli Arditi del Popolo, tra di loro Antonio Roasio,
Francesco Leone, Antonio Cieri, Virgilio Gozzoli e il pratese Dino Saccenti.32 Chi era troppo
giovane per avere un ricordo diretto di quel periodo, non di rado veniva da una famiglia
che ne aveva potuto tramandare la memoria; nel breve profilo biografico redatto da
Edoardo D’Onofrio su Luigi della Puppa, benché fosse nato solo nel 1918, era segnalato
come questo veniva da una famiglia duramente colpita delle violenze e dei soprusi fascisti
e poi costretta all’emigrazione.33
La memoria, in prima persona o raccontata, di quei primi anni venti sarebbe quindi stata
ben presente al momento di arruolarsi nelle BI; chi partì per la Spagna aveva, in linea
generale, dovuto abbandonare l’Italia abbastanza presto, il 47% se n’era andato prima del
29 Interessante il caso canadese. Come ha recentemente rilevato Michael Petrou, si registrò un volontariato stranamente “adulto”: la maggior parte dei volontari ebbe un’età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Questo dato trova una spiegazione nella sostanziale coincidenza tra quei volontari canadesi e degli europei recentemente emigrati, a volte per motivi politici, in nord America (Michael Petrou, Renegades. Canadians in the Spanish Civil War, Toronto, Ubc Press, 2008, p. 13).
30 Cf. Fabio Fabbri, Le origini della guerra civile. L'Italia dalla guerra al fascismo (1918-1921), Torino, UTET, Torino.
31 Marco Palla, “Il fascismo” in: A. VV (a cura di), Storia d'Italia - Le regioni dall'Unità ad ogg: l'Emilia Romagna, Torino, Einaudi, 1997, p. 581.
32 Cfr. E. Francescangeli, Arditi del Popolo. Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista (1917-1922), Odarek, Roma 2000.
33 “Profilo biografico di Luigi della Puppa”. 16/09/1940. FC, fascicolo 545-6-488, folio 11, RGASPI.
9
1926. Secondo Pierre Milza, l’emigrazione dei primi anni venti, non ancora definibile
“antifascista” in senso stretto, era però sostanzialmente formata dai militanti e dai
dirigenti del movimento operaio più colpiti dallo squadrismo; fu in questa prima ondata
che si confusero anche molti dei futuri volontari in Spagna.34 I flussi in uscita in quegli
anni erano caratterizzati: «dalla nutrita presenza di lavoratori la cui decisione di spostarsi
all’estero nasceva non solo da ristrettezze economiche patite in Italia, ma anche, e in molti
casi soprattutto, dal bisogno di “cambiare aria”, di abbandonare luoghi di residenza nei
quali la vita si era fatta rischiosa ed insostenibile a causa degli attacchi dello squadrismo
fascista e la possibilità stessa di conservare o trovare un’occupazione era compromessa
dalle intimidazioni, dall’emarginazione sociale e dai veri e propri “bandi” con cui i fascisti,
divenuti padroni del territorio, colpivano i militanti più in vista, sul piano locale, della
sinistra politica e sindacale».35
Quest’insieme di dati inducono a riflettere sull’importanza della categoria di
“generazione” messa in relazione al volontariato in Spagna. Stéfanie Prezioso, nel suo bel
volume su Fernando Schiavetti, è stata in grado di mostrare come i traumi vissuti da tutta
una generazione di europei incisero profondamente sulle scelte che questa avrebbe fatto
negli anni compresi tra le due guerre mondiali.36 La spiegazione che vorrebbe
l’impulsività ed il radicalismo, tipici dell’ardore giovanile, alla base del volontariato,
mentre può anche funzionare per i britannici o per gli statunitensi entra decisamente in
cortocircuito con gli italiani. Crediamo che le motivazioni che spinsero degli uomini di
mezza età ad abbandonare i propri impieghi e le proprie famiglie (il 41,1% dei partecipanti
alla Sezione Italiana era sposato, mentre il 26,3% aveva almeno un figlio) vadano ricercate
nel periodo a cavallo tra gli anni ’20 e ’30; nell’impossibilità di vivere nel proprio paese
d’origine; nelle difficoltà, socioeconomiche, e nel senso di sradicamento dato dalla
condizione di esule; nell’inevitabile precoce presa di coscienza del fascismo come
problema non esclusivamente italiano; nel sentimento di profonda impotenza dinnanzi
all’aggressività internazionale fascista.
In virtù di queste considerazioni sul lungo periodo “a ritroso”, può essere interessante
34 Pierre Milza, Voyage en Ritalie, Parigi, Payot, 1995, p. 261.
35 Leonardo Rapone, “Emigrazione italiana e antifascismo in esilio”, in: Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana", 1 (2008), p. 53.
36 Stefanie Prezioso, Itinerario di un "figlio del 1914" - Fernando Schiavetti dalla trince all'antifascismo, Manduria, Lacaita, 2004.
10
fare alcune considerazioni sulle regioni italiane di origine dei volontari.
Regione Garibaldi Percentuale S. Italiana Percentuale
Emilia-‐Romagna 253 15,6% 91 21,2%
Lombardia 184 11,4% 42 9,8%
Veneto 184 11,4% 31 7,2%
Toscana 163 10% 71 16,5%
Piemonte 143 8,8% 29 6,7%
Friuli Venezia-‐Giulia 138 8,5% 17 3,9%
Liguria 59 3,6% 21 4,9%
Marche 48 2,9% 18 4,2%
Umbria 45 2,7% 13 3%
Sicilia 45 2,7% 10 2,3%
Sardegna 42 2,6% 14 3,2%
Trentino Alto-‐Adige 42 2,6% 9 2,1%
Calabria 31 1,9% 5 1,1%
Lazio 25 1,5% 8 1,8%
Puglia 24 1,4% 3 0,7%
Abruzzo 13 0,8% 5 1,1%
Campania 11 0,6% 9 2,1%
Valle d’Aosta 6 0,3% 1 0,2%
Molise 4 0,2% -‐ -‐
San Marino 3 0,1% -‐ -‐
Basilicata 2 0,1% -‐ -‐
Altro/Estero 149 9,2% 31 7,2%
Fig. 3.2 – Provenienza regionale dei volontari italiani (1)
Dai dati emerge inequivocabilmente una preponderanza di volontari provenienti dalle
regioni del centro-‐nord; ancora una volta questa cartina, com’era scontato aspettarsi,
tende a combaciare con quella delle violenze squadriste. Emilia-‐Romagna, Lombardia,
Veneto e Toscana furono duramente colpite nel triennio 1920-‐1922; come ha sottolineato
Giulia Albanese, la conflittualità sociale raggiunse in queste aree livelli talmente alti che
dal gennaio 1921 aumentò il ricorso all’espressione “guerra civile”.37 Le lievi differenze
regionali tra garibaldini e componenti della Sezione Italiana, rispecchia quella che fu la 37 Giulia Albanese, La marcia su Roma, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 26.
11
diversa composizione politica delle due formazioni: Emilia-‐Romagna e Toscana, per il
caso della Sezione Italiana, erano le regioni con una tradizione libertaria più sviluppata.
Resta però un dato significativo che emerge chiaramente dalla figura 3.3: le aree di
origine dei volontari coincidono sostanzialmente con quelle che hanno una tradizione di
politicizzazione più forte. Nel corso della seconda metà dell’ottocento, la bassa area
padana e le campagne romagnole furono le culle del primo associazionismo politico, dove
videro la luce prima i movimenti anarchico e repubblicano e poi quello socialista. Fu in
queste zone che sorsero le prime società di mutuo soccorso, i luoghi dove prese il via la
politicizzazione delle classi subalterne italiane. Se è forse azzardato voler mettere in
relazione diretta la scelta del 1936 con un quadro di così lunga durata, crediamo
ugualmente che si possano individuare delle tradizioni, tramandate magari a livello
familiare, che possono sicuramente aver influito nella formazione politica ed umana dei
futuri volontari. L'immagine 3.3 ci dimostra, senza lasciare adito a dubbi, quanto sia
importante analizzare il volontariato internazionale in Spagna attraverso delle categorie
che prevedano la lunga durata.
Fig. 3.3 – Provenienza regionale dei volontari italiani (2)
Quello italiano, oltre ad essere “adulto”, fu un volontariato particolarmente “precoce”.
12
Nella figura 3.4 si possono vedere gli arrivi mensili in Spagna (dei 1.865 per i quali
abbiamo il dato) ed emerge chiaramente come questi si concentrarono nelle prime fasi
del conflitto (si deve ricordare che dall'aprile del 1937 la Sezione Italiana si sarebbe
sciolta ed ad accogliere gli italiani sarebbe rimasta solo il Battaglione Garibaldi). Il mese
che segnò il valore più alto è l’ottobre del 1936 con ben 321 ingressi, seguito dai 265 del
mese successivo.
Fig. 3.4 – Ingressi mensili in Spagna
Dall’aprile del 1937 (56), gli arrivi conobbero un progressivo calo fino ad assestarsi su
una media, nel successivo anno e mezzo, di 25 ingressi mensili. Queste cifre, relative a
circa 2.000 volontari, dovrebbero essere moltiplicate per 2 volte e mezzo per avere un
dato vicino a quello reale. Il dato saliente è sicuramente quello che vide quasi il 60% degli
italiani arrivare entro la fine del 1936, quando le Brigate Internazionali potevano vantare
solo poche settimane di vita. Rivolgendosi agli altri casi nazionali emerge la peculiarità
italiana. Gli inglesi, ad esempio, ebbero un primo picco di arrivi a cavallo tra il 1936 ed il
1937, con un ritardo rispetto al caso italiano, ma poi ne ebbero un altro tra il gennaio e
l’aprile dell’anno successivo ed in ogni caso ebbero un andamento più omogeneo negli
arruolamenti.38 Se gli inglesi aspettarono che fosse ben organizzato un sistema di
arruolamento, gli italiani tesero a partire sullo slancio emotivo delle prime notizie; ne
38 Baxell, British Volunteers..... cit., p. 20.
13
sono testimonianza i quasi 300 arrivi (il 15% del totale) entro il settembre, quando
ancora non erano neanche state istituite le BI e la Sezione Italiana aveva pochi giorni di
vita. Lo stesso fatto che nei mesi di ottobre e di novembre, quando il Comitato Centrale del
PCd’I “aprì” ufficialmente l’arruolamento, se ne registrassero in poche settimane quasi
600 è un dato sintomatico: evidentemente, tra i militanti comunisti doveva esserci una
volontà diffusa di partire per la Spagna che letteralmente esplose quando il partito diede
il via libera.
Se si vuole riflettere su questi dati ci si dovrà concentrare, visto il suo ruolo egemonico tra
le forze antifasciste impegnate in Spagna e che fu l'unica forza politica ad organizzare un
sistema di arruolamento, sul partito comunista. Il PCd’I s’impegnò a fondo nel favorire i
reclutamenti; nel gennaio del 1937 un confidente fascista, parlando del dipartimento delle
Alpi Marittime, riferì come lì si facesse il possibile per convincere a partire i «militanti del
partito di provata fede politica».39 A Charleroi, invece, sempre secondo fonte fascista, per
gli arruolamenti sarebbe stata istituita una commissione presieduta da un dirigente
socialista e da uno comunista.40 Le cose andarono bene finché il numero di volontari si
mantenne alto, ma quando, a partire dal giugno del 1937, ci fu un vero e proprio crollo,
emersero alcune tensioni in seno alla dirigenza comunista. In una riunione della
segreteria del novembre di quell’anno si palesò un certo nervosismo tra i massimi
dirigenti del partito.41 Solo il mese precedente Palmiro Togliatti aveva mandato una dura
lettera alla segreteria nella quale riferiva i problemi che aveva trovato durante una sua
recente visita alla Garibaldi; «la situazione è cattiva per quanto riguarda», scriveva
Togliatti/Ercoli, «la composizione nazionale della brigata. Tra gli elementi che si battono
in prima linea gli italiani non sono più del 9%. […] Bisogna ad ogni costo rafforzare il
reclutamento e inviare in un periodo di tempo molto breve, altri compagni italiani.
Reclutare in Francia, in Svizzera. Prendere misure speciali per il reclutamento in Italia. Lo
stesso vale per il reclutamento negli Stati Uniti e nell’America del Sud. Se non si hanno
rapidamente risultati notevoli, la situazione della brigata peggiorerà sotto tutti i punti di
39 “Relazione fiduciaria”. 12/01/1937. Dir Gen PS, DAGR, 1937 busta 62, 1936-1937 primo fascicolo, ACS.
40 “Nota del direttore capo della Divisione Polizia Politica”. 15/12/1936. Dir Gen PS, DAGR, 1937 busta 62, 1936-1937 primo fascicolo, ACS.
41 “Verbale della riunione di segreteria”. 12/11/1937. FPCdI, fascicolo 1434 – Verbali delle riunioni della segreteria del Pcd’I, Archivio Fondazione Gramsci, Roma (AFG).
14
vista».42 L’attitudine dei dirigenti comunisti verso il reclutamento lascia intravedere una
questione fondamentale del volontariato che sicuramente meriterebbe uno studio serio
ed approfondito: la lontananza tra la percezione che ebbero di se i combattenti (che si
sentivano, in tutto e per tutto, volontari) e quella che invece ne ebbero i vertici politico
militari delle BI (che li considerarono dei militari). Il comitato centrale del PCd’I, nel
momento in cui gli arruolamenti subirono un calo fisiologico (inevitabile dopo lo slancio
iniziale) rispose invocando una maggiore propaganda e non considerando come quella
volontaristica fosse una scelta personale; una scelta che andava ad investire
pesantemente la sfera degli affetti e che era, per questo, difficilmente influenzabile. Lo
slancio dei primi mesi sommato e la “fiacca” dei successivi contribuiscono a definire
meglio le caratteristiche del volontariato italiano e, ancora una volta, a metterlo
necessariamente in relazione con le sofferenze patite dagli antifascisti durate il
quindicennio precedente: coloro che avevano maturato, nel corso degli anni, i presupposti
che li avrebbero portati in Spagna, scelsero di partire non appena questo fu possibile. Si
trattò, più che in altri casi nazionali, di una scelta influenzata dallo slancio emotivo.
Continuiamo il nostro ritratto di gruppo. Ancora oggi, uno tra i luoghi comuni più diffusi
sui volontari spagnoli è quello che questi avrebbero formato “un’armata di poeti e di
scrittori”. Il caso italiano non potrebbe essere più lontano da questo stereotipo; secondo i
dati da noi raccolti, i mestieri più ricorrenti dichiarati al momento dell’arruolamento
furono: muratore (17%), operaio (10%), contadino/bracciante (8,5%) minatore (7,6%) e
meccanico (6,3%). A chiudere la lista c’era uno 0,49% di studenti, ed uno 0,2% di
avvocati. Tra i 643 componenti del Battaglione Garibaldi per i quali si è trovato anche il
livello d’istruzione, ci furono 53 (8,2%) con la licenza media, 20 (3,1%) diplomati e solo 9
(1,3%) laureati; il resto (86,9%), esclusi due analfabeti, aveva frequentato le scuole
elementari. La maggior parte dei volontari italiani erano quindi salariati con un’istruzione
non molto alta, un’immagine diametralmente opposta rispetto a quella del “combattente
intellettuale”. Potremmo invece dire che gli italiani furono lo specchio fedele del mondo
dal quale, in larga maggioranza, provenivano: quello dell’emigrazione antifascista.
L’ultimo dato che ci aiuterà ad avere un ritratto di gruppo abbastanza completo è quello
concernente l’appartenenza politica. Come si è visto, il processo di arruolamento venne in
larga parte gestito dai comunisti e già si è detto riguardo alla loro egemonia sull’intero 42 Palmiro Togliatti. “Lettera di Ercoli”. 04/10/1937. FPCdI, fascicolo 1440 – Corrispondenza di Ercoli con la dirigenza del Pcd’I, AFG.
15
sistema interbrigatista. Gabriele Ranzato ha avuto moto di sottolineare come ci sia
«un’inerzia fronte populista nel continuare a dire che nelle Brigate Internazionali si
batterono fianco a fianco comunisti, anarchici, socialisti, repubblicani, ecc. Fianco a fianco
si», continua Ranzato, «ma in una proporzione di almeno 2/3 contro 1/3».43
Effettivamente, molti dei vertici politico militari della Garibaldi arrivarono direttamente
da Mosca; in una lista conservata negli archivi del PCd’I sono elencati ben 45 quadri del
partito che, tra il 1936 ed il 1937, erano stati inviati in Spagna direttamente dal
Comintern, tra di loro anche Angelo Irico, Antonio Roasio e Aldo Morandi.44 Questa lista
contiene i nominativi di buona parte dei commissari politici e dei comandanti militari
della Garibaldi; secondo i nostri calcoli almeno il 75% dei commissari politici e degli
ufficiali furono comunisti. Non si deve però dimenticare che, per il caso italiano, a
“bilanciare”, in parte, la preminenza politica comunista ci fu la Sezione Italiana con la sua
maggioranza libertaria. La tabella 3.5 mostra la composizione politica delle due colonne.
Famiglia politica B. Garibaldi Sezione Italiana
Anarchico 4,5% 60,8%
Antifascista 9,1% 8,2%
Cattolico 1,4% -‐
Comunista 71,1% 14,1%
Democratico 0,5% 0,6%
Giellista 0,5% 6,6%
Repubblicano 1,4% 2,8%
Socialista 10,8% 6,5%
Fig. 3.5 – Appartenenza politica, in percentuale, dei volontari della
brigata Garibaldi e della Sezione Italiana
Rimanendo solo sulle Brigate Internazionali, se si confrontano i dati sugli italiani con
quelli che si hanno per altre nazionalità si può constatare come quello garibaldino sia il
caso che presenta una maggiore eterogeneità politica: gli inglesi furono in gran parte 43 Gabriele Ranzato, “Ripensare la guerra di Spagna” in: Enzo Collotti (a cura di), Fascismo e antifascismo – Rimozioni, revisioni, negazioni, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 143.
44 “Elenchi di emigrati politici partiti dall'URSS (1936-1938)”. s/d. FPCdI, fascicolo 65 (secondo inventario), AFG.
16
comunisti (87%) con una discreta presenza socialista (il 10%), mentre tra i francesi ci
furono meno comunisti (64%) ma i socialisti furono una minoranza molto piccola (1,8%)
e molti volontari non risultavano iscritti ad alcun partito.45 Anche gli statunitensi furono
in maggior parte se non comunisti, quanto meno simpatizzanti o iscritti alle centrali
sindacali vicine a quel movimento.46 Crediamo quindi che la peculiarità italiana risieda
non tanto nella percentuale di comunisti presenti in Spagna quanto più nella varietà di
forze politiche coinvolte tanto nell’esperienza della Garibaldi quanto in quella della
Sezione Italiana.
4. Conclusioni
Questi brevi ritratti di gruppo ci consegnano un’immagine, forse inconsueta, del volontariato
italiano; un’immagine per larghi tratti inaspettata, ma, al contempo, sicuramente interessante.
Uomini di mezza età, spesso con qualche capello bianco in più di quanto potessimo pensare,
che lasciarono, nel giro di pochi giorni, le proprie famiglie; volontari che partirono per la
Spagna ben coscienti del problema fascista in Europa perché ne avevano sperimentato la
violenza sulla propria pelle. Si trattò quindi di un volontariato che non può non avere legami
fortissimi, indissolubili, con la storia europea tra le due guerre mondiali, con la storia di quella
“Guerra Civile Europea” che si combatteva ormai dal 1914. Gabriele Ranzato si è chiesto, in
apertura del suo Eclissi della democrazia, che cosa unisse Esmond Romilly, rampollo di una
facoltosa famiglia inglese e nipote di Winston Churchill, e Giovanni Cuccagna, un meccanico
perugino che aveva la 4ª elementare e che appena sapeva leggere; «Perché così diversi erano
andati in Spagna a fare la guerra dalla stessa parte del fronte?»47 Entrambi avrebbero molto
probabilmente risposto che erano accorsi in Spagna per combattere il fascismo e per difendere
la democrazia. Come ci hanno dimostrato i dati citati, chi avrebbe combattuto in Spagna lo
avrebbe fatto perché sentivano l'antifascismo come una necessità europea e non solo italiana.
«L'antifascismo fu il collante di quell'epoca» avrebbe ricordato un ex-volontario francese,
«all'interno di quel campo potevano coesistere diverse tendenze, ma tutte erano unite dalla
comune volontà di intralciare il cammino al fascismo. Quello fu l'elemento essenziale del
nostro tempo».48 Lanciotto Corsi, era un anarchico originario di Livorno, in quell’estate del
45 Baxell, British Volunteers..... cit., p. 22 e Skoutelsky, L'espoir guidait leurs..... cit., p. 154.
46 Jackson, Fallen Sparrows..... cit., pp. 85-86.
47 Gabriele Ranzato, L'eclissi della democrazia – La guerra civile spagnola e le sue origini, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, pp. 3-6.
48 Skoutelsky, Novedad en el frente, cit., p. 193
17
1936 aveva 43 anni, era sposato ed aveva 3 figli; il 20 agosto scrisse una lettera alla moglie per
renderla partecipe della decisione di partire: «Debbo metterti al corrente che fra giorni partirò
per la Spagna», diceva in apertura, «giacché non mi è dato lottare la stessa causa in terra natale
lotterò in terra di Spagna poiché l’avversario è lo stesso nemico».49
49 Lanciotto Corsi, “Lettera alla moglie” 20/08/1936. CPC b. 1486, f. 13436 Corsi Lanciotto, ACS.