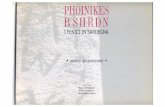Regimi patrimoniali della famiglia e prospettive di innovazione
Processi di integrazione ed europeizzazione nei regimi europei di welfare: un’analisi comparata...
Transcript of Processi di integrazione ed europeizzazione nei regimi europei di welfare: un’analisi comparata...
1
Processi di integrazione ed europeizzazione nei regimi europei di welfare:
un’analisi comparata con fini tipologici di Gabriella Punziano
I processi di integrazione e di europeizzazione, che hanno avuto il loro motore nelle istanze
politiche ed economiche, ma che nel loro impatto hanno segnato profondamente il tessuto sociale,
sono al centro dell’analisi qui proposta. Infatti, a partire dai risvolti sociali e dalla risposta che a
questi viene data dai diversi regimi di welfare europei, si mostrerà una possibile ri-sistemazione e
tematizzazione delle differenze entro i diversi regimi, delle loro relazioni e nuove caratterizzazioni.
Il punto di partenza del ragionamento proposto è rintracciabile nello studio, condotto da chi
scrive, Welfare europeo o welfare locali? I processi decisionali nel sociale tra convergenza ed
autonomia. In esso si è inteso approfondire la doppia spinta tra europeizzazione e decentramento
della politica sociale in alcuni paesi europei, considerati guida di specifici welfare regimes (Esping-
Andersen 1996), per comprendere a quale livello di governance siano imputabili le decisioni che
strutturano quest’ambito. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso un’analisi comparata
geografica e di policy basata su un approccio mixed methods da intendersi quale merge di approcci,
tecniche e strumenti standard e non standard. Nello specifico, a partire dai casi di Napoli, Milano e
Berlino, la citata analisi contempla congiuntamente lo studio delle direzioni sovranazionali, degli
sviluppi nazionali e delle dinamiche locali in merito alla diffusione di modelli specifici di
implementazione e decisione delle politiche sociali e dei regimi cui danno vita, sviluppandosi sia in
prospettiva macro (attraverso l’analisi multivariata e multilivello di indicatori sociali Eurostat e
conseguente cluster analysis) sia in prospettiva micro (attraverso l’analisi di progetti realizzati nei
differenti contesti locali ed in particolare applicando analisi di impatto, implementazione e
comparative network analysis). La conclusione cui si è giunti è stata la realizzazione di un modello
generale di interpretazione dei mutamenti nei differenti regimi di welfare europei e loro
classificazione, da sottoporre a ulteriori test empirici. L’analisi che in questa sede si propone, infatti,
intende superare i limiti del precedente studio ampliando la base comparativa dei paesi indagati ed
avviando la rilevazione in ulteriori nazioni e contesti locali. Pertanto, a Milano e Napoli per l’Italia
e Berlino per la Germania, si è aggiunta Monaco, come termine di comparazione, Parigi e Rouen
per la Francia, Barcellona e Vigo per la Spagna e Londra e Liverpool per l’Inghilterra.
Di seguito si presenterà, accanto ad una ripresa dei presupposti teorici e metodologici, i
principali risultati empirici della ricerca.
1. Presupposti teorici e metodologici: lo studio di partenza e i suoi sviluppi
Il concetto di europeizzazione, al centro di numerosi studi sulle trasformazioni nei regimi di
welfare e sulle dinamiche della governance nell’Unione Europea (Lebfried, Pierson, 1995; Le
Gales, 2002; Gullién, Palier, 2004; 2004; Giuliani, 2004; Ferrera, 2006; Naldini, 2007; De
Leonardis, 2012; Kazepov, 2009-2010), può essere considerato in un’accezione molteplice e
diversamente agente sui rispettivi contesti operativi sui quali incide. Nei rapporti fra istituzioni
comunitarie e stati membri, tale concetto riguarda il processo di integrazione comunitaria e sviluppo
della governance multilivello la cui dirittura di arrivo è una piena convergenza verso un sistema
unitario di governo delle politiche sociali omologato in tutto il territorio comunitario e fondato
essenzialmente sui principi di sussidiarietà ed attivazione (Bifulco, 2005). Ciò agisce sui singoli
sistemi politici nazionali, i quali, a loro volta, rispondono mostrando diversi gradi di adattamento e
intensità nel conformarsi allo scenario delineato. Se si considera lo stesso concetto a partire dai
contesti locali, intesi quali diversi centri di diramazione della governance sociale in maniera
decentrata, piuttosto che partendo dal fulcro di interesse comunitario (l’attore sovranazionale
europeo) vengono chiamate in causa dinamiche di implementazione e processo di natura contestuale
e differenziale, specchio della rivendicazione di autonomia locale nel processo stesso di governance
delle politiche sociali intrapreso attraverso modalità molteplici volte comunque alla convergenza
(Radaelli, 2003).
2
Differente dal concetto di europeizzazione è quello di integrazione comunitaria che, secondo
Giuliani (2004), si riferisce a qualcosa di impregnatamente normativo, regolativo e processuale, e
che coglie dinamiche macro e rapporti di sistema, mentre col concetto di europeizzazione ci si rifà
esplicitamente a dinamiche di origine micro inquadrabili come processo silenzioso, differenziato e
spesso contraddittorio rilevabile nei processi di governance, e nel quale sono gli attori a decidere e
dare forma alle differenti strutturazioni emergenti (Börzel, 2004). L’europeizzazione può essere
intesa quale processo attraverso il quale le strutture, procedure e politiche dell’Unione europea si
specializzano ed automatizzano dal livello nazionale, rispecchiando a pieno il processo più generale
di istituzionalizzazione dell’Unione europea stessa (Mörth, 2003) e delle sue strutture di
governance. Tanto è vero che l’istituzionalizzazione diviene il tratto distintivo ed insieme il tramite
d’unione tra una concezione di integrazione comunitaria di natura normativa ed una di
europeizzazione delle politiche di natura processuale nel corso della traslazione dell’hard come
della soft law legislation in materia di politiche sociali e regimi di welfare tra i differenti livelli di
governance sovranazionali, nazionali e locali. Il processo di europeizzazione punta su una
convergenza strategica verso una piena integrazione comunitaria perseguita, tuttavia, attraverso
meccanismi decentrati, sussidiarietà e metodo aperto di coordinamento che rivaluta la dimensione
territoriale della politica sociale. L’integrazione auspicata alla base di tale processo viene a
realizzarsi essenzialmente in due direzioni. Un’integrazione rivolta al contesto (politiche di coesione
territoriale e sociale), che punti a rivalutarlo e a renderlo competitivo ed in grado di affrontare le
sfide globali, ed un’integrazione rivolta alla persona (politiche di inclusione sociale), che punta alla
garanzia di standard di vita comuni e all’investimento sugli individui, rendendoli parte attiva e
partecipativa del processo di inclusione (place and people, Donzelot, 2003). Due modalità differenti
di concepire il processo di integrazione non sempre pienamente conciliabili, per il fatto comune
della scarsità di risorse da investire nel sociale e per il coinvolgimento di stakeholders differenti che
questo processo può implicare. Il fattore che governa queste spinte è da individuare nella capacità
dei contesti, siano essi nazionali o locali, di tendere verso una piena integrazione comunitaria
(welfare europeo) o di divergere da essa (net welfare locali). La variabile integrazione comunitaria
diventa, pertanto, la discriminante nel riconsiderare, attraverso uno studio comparato, una diversa
tipologia di regimi di welfare costruita sulla gradualità dell’integrazione, la strategia differenziale di
convergenza ed il recupero degli spazi di autonomia implementativa, fattori che spingono verso un
sistema unitario o sistemi locali. Una tipologia più incentrata sul ruolo assunto dal livello normativo
europeo quale attore direttivo e di indirizzo delle politiche di welfare (Punziano, 2012), lontana
dalle concezioni classiche basate sulla titolarità al diritto di prestazione sociale, sull’intervento più o
meno pervasivo dello stato-nazione, i livelli di spesa, i requisiti d’accesso, la copertura finanziaria, i
destinatari o i criteri di assegnazione dell’erogazione, nonché sul mix di attori coinvolti nella
governance locale (Titmuss, 1974; Esping-Anderson, 1990; Ferrera, 1994/2006; Naldini, 2007).
Questo in quanto, tali principi non sono più associabili ad un sistema di welfare come quello attuale
che è passato, in maniera più o meno generalizzata, dall’erogazione monetaria alla prestazione di
servizi, dall’assistenzialismo all’attivazione, dall’emersione da stati di emarginazione
all’autoimprenditorialità, rafforzamento delle capabilities e delle capacità competitive prima degli
individui e poi del sistema che vanno a comporre (Sen, 1993), dall’azione pervasiva dello stato
nazione all’emersione di altri attori sociali (Terzo Settore, Famiglia, Privato Sociale1), i welfare mix
(Ferrera, 2006). Questo processo di mutamento, sorretto da cambiamenti demografici, sociali ed
economici dei paesi membri, nonché dal passaggio da una legiferazione in ambito sociale di
competenza esclusiva dello Stato, ad un’opera di orientamento legislativo affidata agli organi
dell’Unione (anch’essa passata da soft ad hard law legislation), che ha portato i welfare states a
diventare una dimensione consolidata del sistema di solidarietà e condivisione del rischio (Beck,
2000) all’interno delle stesse trappole che sistemi e regimi talmente consolidati nella storia e nel
tempo hanno portato con sé (Ferrera, 2008).
1 Per un approfondimento sull’evoluzione del welfare si veda Paci, 2003; Ferrera, 2006; Bifulco, 2005; Naldini, 2007;
Kazepov, 2009; Punziano, 2012).
3
Ci si chiede pertanto da che punto si diramano e come vengono prese le decisioni sul sociale.
Così delineato, tale interrogativo mette in gioco più piani d’analisi e più oggetti analitici che
necessitano, per la loro congiunzione, di un approccio integrato, seppure non necessariamente
convergente, e che consenta di indagare il campo d’analisi sia in prospettiva macro che micro. Tale
approccio è rappresentato dai Mixed Methods (Tashakkori, Teddlie, 2003; Teddlie, Yu, 2007;
Creswell, 2012), un approccio integrato di metodi, tecniche e strumenti finalizzato all’elaborazione
di uno strumento interpretativo e conoscitivo che diviene esso stesso il risultato, perseguendo
strategie differenti sia sul versante standard sia sul versante non standard. Il meccanismo di metodo
essenziale all’integrazione in una siffatta strategia mix è stato individuato nella traduzione di ambo
due i linguaggi, standard e non standard, in un codice comune ad entrambi gli approcci coinvolti.
Ciò che ne deriva è la costruzione del modello generale di classificazione, risultato cardine
dell’analisi condotta, nel quale ogni risultato emerso dai diversi step è stato trasformato in
caratteristiche ed attributi che sostanziano i differenti tipi emersi e che possono in questo modo
convivere, senza particolari problematiche ontologiche ed epistemologiche, in un modello multi-
methods flessibile, dinamico ed in continua trasformazione, poiché integra il mutamento del sistema
indagato come variabile sistemica. Tale approccio integrato non ha la pretesa di mettere in
discussione l’efficacia classificatoria delle tipologie classiche precedentemente richiamate, ma
intende offrire nuove opportunità per fare emergere dettagli difficilmente gestibili o rilevabili
quando la realtà indagata è vasta per estensione, storia e retaggio culturale (come nel caso
dell’Europa), ma ancora di più quando si intende frammentare tale realtà ed inserirla in un disegno
comparato. Per approcciare tale complessità, lo schema d’analisi utilizzato è stato suddiviso in step
sequenziali che saranno di seguito sviscerati e che risultano costruiti l’uno dentro l’altro come sub-
disegni all’interno del più complesso disegno generale (nested, Crassewell, 2003) che prende il
nome di Complex Mixed Methods Design (Punziano, 2012). Rimandando altrove la discussione sui
dettagli tecnici statistico-matematici del modello proposto (Punziano, 2012), in questa sede si
descriveranno i principali obiettivi e risultati raggiunti nella prima analisi, nonché quelli sviluppati
per il test della tipologia ottenuta, qui appositamente elaborati.
2. Gli assi tipologici e il loro affinamento
Il primo step d’analisi, finalizzato all’emersione degli assi sottostanti la tipologia nel modello
generale di classificazione, sin dalla fase iniziale dello studio, è stato caratterizzato dal recupero di
un approccio comparato di policy, che non ha sostituito ma integrato la comparazione geografica.
Queste due caratterizzazioni di metodo sono andate ad inserirsi sulla delimitazione degli assi
tipologici legandosi alla possibilità di coprire i due piani, semantico e territoriale, nella realtà a più
livelli considerata in questo studio. Un continuum semantico (asse verticale), definibile come asse
dell’integrazione e generato nell’opposizione tra le due polarità di sviluppo, coesione ed inclusione
sociale, in un approccio metodologico incentrato, per l’appunto, sulla comparazione di policy. Un
continuum territoriale (asse orizzontale), che si fonda, invece, sulla comparazione geografica,
impregnato degli sviluppi e delle dinamiche evolutive dei sistemi di welfare (europeizzazione vs.
decentramento, convergenza vs. autonomia locale) fino a stirare un’opposizione tra un tipo di
welfare che può essere definito europeo in quanto unitario e convergente, ed un tipo di welfare
frammentato e locale, definibile come net welfare locale. Gli assi puntano, pertanto, ad estrapolare
l’effetto del metodo (analisi comparata di policy vs. analisi comparata geografica), i continuum
intersecanti (semantico vs. territoriale) e le principali trasformazioni intercorse nelle politiche sociali
(europeizzazione vs. decentramento/frammentazione; attivazione vs. assistenzialismo; convergenza
vs. autonomia locale; centro vs. periferia), presupponendo un distacco in termini di sviluppo
territoriale o sociale (coesione vs. inclusione) da una parte e tendenza all’europeizzazione o al
decentramento/frammentazione dall’altra, evidenziando tendenze in atto ma tuttavia non
escludentesi l’una con l’altra; particolari forme di commistione che portano al delinearsi di sistemi
particolari da trattare come modello e non come classificazioni assolute e generalizzabili. Si
pongono così le basi per l’emersione non solo di una tipologia in evoluzione, ma soprattutto per la
4
realizzazione di quel ricercato strumento analitico integrato che riesca ad accogliere elementi
differenziati e fortemente eterogenei per natura e provenienza (fig. 1). Benchè di natura teorica,
anche questo step è stato sottoposto a test nella seconda fase dello studio. In questa, gli assi
tipologici non subiscono mutamenti, e restano ancora valide le contrapposizioni evidenziate,
seppure queste tendano ad affinarsi. Emerge, accanto alla variabile discriminante integrazione
comunitaria, relativa alle dinamiche normative, quella dell’europeizzazione, relativa a fattori
procedurali, pratiche e prassi messe in atto nella ristrutturazione degli attuali regimi di welfare,
nonché nuove categorie di lettura del mutamento intervenuto nei deversi regimi indagati, ovvero le
categorie di convergenza ed autonomia. Avremo, pertanto:
- un asse di integrazione basato sul doppio versante politiche di coesione, rivolte ad uno sviluppo
connotato territorialmente e diretto ai contesti, e versante politiche di inclusione, rivolte ad uno
sviluppo connotato socialmente e rivolto ai soggetti (il continuum semantico fondato sulla
comparazione di policy);
- un asse di europeizzazione basato sul doppio versante convergenza al welfare europeo e
autonomia dei net welfare locali (il continuum territoriale fondato sulla comparazione
geografica).
Per comodità grafica, di seguito si riportano il modello di incrocio degli assi tipologici di
partenza (fig. 1) ed il suo test (fig. 2), alla luce degli sviluppi teorici e del ragionamento delineato. Fig. 1: Assi tipologici modello originario. Fig. 2: Assi tipologici modello testato.
Dunque, si arricchisce teoricamente la delimitazione dello scenario di base nel quale
europeizzazione ed integrazione continuano ad essere le variabili cardine per la definizione della
tipizzazione dei sistemi di welfare proposta. Ciò che muterà incrociando i due assi e fondandoli su
base empirica (analisi delle componenti principali sugli indicatori Eurostat – per la delimitazione
delle due componenti o assi intersecanti – e modello PLS – per la definizione delle polarità in
opposizione) è la composizione dei raggruppamenti delle nazioni (ottenuta tramite cluster analysis e
funzione rebus) e la loro posizione rispetto ai livelli di performance sugli indici sviluppati.
3. Analisi macro su indicatori sociali: quale posizione per nazioni e contesti locali?
Il secondo step d’indagine ha previsto l’analisi multivariata (Analisi delle Componenti Principali
– Pearson, 1901, Hotelling, 1933) e multilivello (analisi su livelli congiunti di variazione – Hox,
2002) degli indicatori sociali relativi a inclusione sociale, coesione territoriale e integrazione
5
comunitaria in ottica comparata2, al fine di costruire indici sintetici di performance dei differenti
contesti indagati con lo scopo di:
- evidenziare l’incisività decisionale del livello nazionale o subnazionale (modelli di regressione
multipli e per blocchi – PLS-Path Modeling, Esposito Vinzi, 2009 – sui livelli disgiunti prima
nazionale e poi regionale) nella costituzione delle politiche sociali in Europa;
- definire un piano di selezione di questi contesti in base alle differenze assunte sulla variabile
discriminante integrazione comunitaria;
- trarre da queste analisi gli elementi affinché le Nazioni (nuts03) e le Regioni (nuts2
4) europee
possano essere proiettati nello spazio tipologico ottenuto dall’incrocio degli assi (classificazione
in base all’algoritmo Rebus-PM – Esposito Vinzi et al., 2008 – e la Cluster Analysis).
Ci si è chiesti, a partire dalle tipologie classiche, cosa, come e quanto sia cambiato nei regimi
europei di welfare. L’analisi effettuata5 ha confermato la composizione degli assi individuati a livello
teorico avvalorando l’ipotesi di funzione lineare dell’integrazione. Ne emerge un asse unitario a due
polarità, una rivolta allo sviluppo economico-territoriale (coesione), l’altra a quello più
propriamente sociale e per l’individuo (inclusione) e questa configurazione si presta ad essere
assunta quale discrimine tra i sistemi di welfare, nel momento in cui si lavora in ambito comparato
di policy. Ciò che ne consegue è che i modelli classicamente intesi cui faceva riferimento Ferrera
(1998) cominciano a mescolarsi e a confondersi. Il discrimine dei modelli si sposta piuttosto che sui
fattori di differenziazione, fondamentali in un momento in cui prevale la soft law europea in materia
sociale, su quelli di convergenza, rilevanti nel momento in cui l’Europa comincia a stabilire e
delineare traiettorie precise e vincolanti rispetto alla crescita sociale. Questo è riscontrabile nella
componente territoriale nella quale spinte all’europeizzazione o alla localizzazione, portano allo
stiramento verso altre due tendenze, da una parte abbiamo un welfare europeo o
dell’europeizzazione fondato sulla piena convergenza delle Nazioni in un modello unico ed
integrato, dall’altra abbiamo la nascita di tanti net-welfare locali come piccoli centri di gravitazione
decisionali dai quali parte la spinta per l’autonomizzazione delle caratteristiche di sviluppo dei
differenti contesti, pur mantenendo saldo l’obiettivo fondamentale della convergenza nei risultati di
sviluppo economico-sociale raggiunti. Se si considera il livello nazionale, la disposizione delle
nazioni è ipotizzabile sia lo specchio di una convergenza guidata da un principio legislativo
piuttosto che di dinamica spontanea ed azione nei network locali. Considerando invece il livello
regionale, non è difficile intravedere quella dimensione territoriale tipica dell’attuazione delle
politiche sociali espressa nel recupero di ampi spazi di autonomia locale. Nel primo caso,
sembrerebbe prevalere l’ipotesi di cammino verso un welfare europeo o dell’europeizzazione, che,
fatta eccezione per i paesi scandinavi ormai già fortemente volti alla convergenza sistematica, è
quanto registrato in Germania, Francia e Gran Bretagna, il che ha spinto la selezione di questi
contesti nell’affondo micro. Nel secondo caso, invece, tale percorso è pienamente disatteso con
l’emergere di net welfare locali, differenti e non assimilabili ad un modello generale, ed è questa la
dinamica prevalente in paesi quali Italia e Spagna, scelti anch’essi per l’affondo micro in quanto
reduci da crisi di non poco conto, o ancora in paesi come la Grecia, per la medesima ragione, o
paesi dell’est e del centro europeo di recente ingresso in Unione e dalle economie e dinamiche
sociali nazionali ancora in affanno rispetto alle richieste dell’attore sovranazionale. Pertanto,
nonostante siano state usate per l’analisi macro tecniche di analisi puramente quantitative, nello
stadio di selezione dei contesti per l’analisi micro, la scelta diventa ragionata per cercare di spiegare
le reali differenze nei livelli di performance raggiunti da specifiche nazioni e regioni che lasciano
trasparire il mescolarsi dei regimi classici di welfare.
2 Fonte: rilevazione EU-SILC (European Survey on income and living conditions) e le Regional Statistics on Social
Cohesion, Eurostat, ultimo trimestre 2011 e comparazione con ultimo trimestre 2012. 3 Nomenclatura delle unità territoriali statistiche, in acronimo NUTS (dal francese nomenclature des unités
territoriales statistiques) che identifica la ripartizione del territorio dell’Unione europea a fini statistici (livello di
aggregazione nazionale). 4 Cfr.nota 3 (livello di aggregazione regionale).
5 Per il dettaglio dei risultati cfr. Punziano, 2012.
6
Il principale risultato ottenuto, in vista dell’integrazione dei risultati d’analisi dei singoli step al
modello generale di classificazione, concerne la disposizione delle nazioni e delle regioni rispetto
all’indice di integrazione comunitaria nonché dei conseguenti raggruppamenti (clusters) che ciò
comporta, i quali sono stati proiettati come caratteristiche ed attributi all’interno dei quadranti
emersi dall’incrocio degli assi presentati in precedenza. Si completa lo spazio di attributi e si
delineano quattro distinte modalità di integrazione. Nel quadrante in alto a sinistra, definito di
Convergenza, ricade il best performer europeo (il Lussemburgo) accompagnato ai paesi del Nord
social-democratico filo scandinavi (Paesi Bassi, Finlandia, Austria, Danimarca e Svezia). Si tratta di
Nazioni e contesti locali che hanno avuto già una fase di crescita e sviluppo socio-economico e che,
attualmente, sono impegnate a consolidare la loro posizione sia per competitività che per
sostenibilità. In questo quadrante prevale la caratterizzazione di welfare europeo e maggiore spinta
su policies che puntano allo sviluppo economico-territoriale e dunque sulla coesione. In alto a destra
abbiamo il quadrante Innovazione. La spinta dei contesti locali e degli attori che in essi si muovono,
dunque del net welfare locale, portano a slegarsi dall’omologazione comunitaria ed alla creazione di
vie alternative di sviluppo pur puntando ai medesimi obiettivi ed a policies rivolte a territorio,
sviluppo economico e competitività. È questo il caso del cluster definito mix liberal-continentale-
mediterraneo (Germania, Regno Unito, Italia, Belgio, Spagna e Francia). Questo ultimo gruppo
attraversa trasversalmente i quadranti, ponendosi come bisettrice tra gli assi. Difatti, un’appendice
consistente di contesti a questo afferente si trova invece in una situazione di Stasi ovvero un
appiattimento delle performance che evidenzia un punto limite di crescita in genere dovuto ad un
elevato livello di sviluppo economico-territoriale e ad una grande capacità competitiva
internazionale, ma con la pecca della presenza di un riduttivo sistema assistenziale che spinge a
puntare ancora su policy di inclusione. L’ultimo quadrante, in basso a destra, Emersione, è costituito
da un doppio gruppo di Nazioni sia quelle tra arretratezza e ritardo di sviluppo (Slovenia,
Portogallo, Irlanda, Repubblica Ceca, Estonia, Slovacchia, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia) sia
quelle tra Est e crisi (Bulgaria, Grecia, Romania, Lettonia e Lituania). In queste, in cui il gioco
locale degli attori e la
definizione delle proprie
strategie di sviluppo hanno
mirato in primis al recupero di
situazioni di esclusione e
povertà, viene a definirsi un
sistema che guarda ad una
modalità di integrazione non
finalizzata alla mera
convergenza di matrice
normativa, ma volta al
rinnovamento sociale in grado
di indirizzare nuove vie di
sviluppo e nuove stagioni di
competitività. Un recupero
sociale per un futuro recupero
territoriale. Fig. 3: Proiezione secondo l’indice di integrazione nel modello originario.
Pertanto, per quanto le nazioni tendano alla convergenza più che i contesti locali, è in questi
ultimi che si realizza concretamente la spinta adattiva attraverso modalità talvolta non perfettamente
in linea con gli andamenti nazionali. Si tratta di distinguere tra un’integrazione di forma ed una di
sostanza, direttivo/impositiva o di indirizzo in quanto l’Unione europea è tutta in linea col principio
di integrazione, tuttavia è nelle sue diverse nazioni che questa assume caratteri differenti. Emerge la
soggettività dei territori (Kazepov, 2009), il loro essere attori in sé e la forza che le dinamiche che li
pervadono ha nell’incidere sugli indirizzi stessi dettati dagli attori a livelli più elevati, ma dai quali i
territori non possono scindersi in quanto base della struttura multilivello della governance.
7
A poco più da un anno dalla conclusione dello studio Welfare europeo o welfare locali? è stata
riattualizzata ed aggiornata la base dati di indicatori sociali di partenza per ottenere una conferma
sia della persistenza della validità dell’indice di integrazione comunitaria come discrimine nella
classificazione di differenti regimi di welfare, sia della posizione delle Nazioni considerate e dei
relativi contesi locali indagati. Se la dinamica di traino normativo alla convergenza, registrata sul
livello nazionale, e la dinamica di traino volta al recupero processuale dei divari socio economici
che spingono all’autonomia, registrata invece sul livello regionale, continuano a mantenere distinti
gli andamenti ai due livelli, qualcosa cominci a registrarsi nell’analisi dei livelli congiunti. Si fa più
forte il peso dei regressori inclusione e coesione sull’indice di integrazione (evidente nel modello
multilevel), come se il distacco tra le due polarità si facesse sempre più marcato, e la componente
latente emersa come indice di europeizzazione viene nettamente a distinguersi e a caratterizzarsi
rispetto ai suoi due versanti, convergenza ed autonomia (evidente in fase di ACP e PLS su livelli
disgiunti nazionali e regionali). Si uniscono indicatori relativi alla dimensione normativa
comunitaria, da una parte, e indicatori relativi alla dimensione processuale dell’integrazione,
dall’altra, portando ad una delineazione netta dei due assi e fondando empiricamente la necessità di
non poter più parlare di un asse normativo di integrazione senza unirlo alla sua anima processuale
rispecchiata dall’asse di europeizzazione. Le modalità di integrazione per quadrante,
precedentemente descritte, e la disposizione dei gruppi nazione mutano. I gruppi si delineano
maggiormente rispetto alla connotazione geo-politica e rispecchiano pienamente la sofferenza nel
far fronte allo sviluppo sociale, da una parte, e allo sviluppo territoriale, dall’altra, quando ci si
riferisce a paesi in emersione e via di sviluppo. Di contro, queste stesse caratterizzazioni assumono
la connotazione di sviluppo umano e competitività quando associate a paesi con sistemi economici
più stabili e sviluppati. È interessante vedere come i paesi dell’Est europeo ed alcuni paesi minori
risultino nettamente scissi in due gruppi che recuperano retaggio storico e culturale e vengono a
formare un nuovo continuum trasversale ai quadranti: indipendenza vs dipendenza, rivalsa delle
proprie specificità contro orbitazione culturale e omologazione. Stiamo parlando dei Paesi dell’Est
e Paesi minori (Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Malta, Cipro e Slovenia) che, seppure vicini
a forti centri di influenza (ad es. Regno Unito per Irlanda o Russia per Repubblica Ceca che si
mostra la più europea tra le nazioni della cinta russa), hanno comunque rivendicato le loro tipicità e
promosso le specificità puntando su specificità molto più territoriali che sociali (si pensi a turismo e
competitività per Malta e Cipro). Il quadrante in cui si inseriscono è quello nato dall’incrocio tra
una tendenza marcata al puntare su politiche di coesione territoriale e un’organizzazione di fondo
basata su strategie di recupero di spazi d’autonomia che rilanciano a pieno l’afferenza a regimi di
net welfare locali. Questo porta a ripensare la strategia di integrazione che caratterizza tale
quadrante, che se nella ricerca originaria aveva preso la connotazione di Innovazione per rimarcare
le strategie differenziali contestuali, adesso assume quella di Sviluppo intesa come strategia di
crescita verso nuove forme di competitività. Differente il gruppo di Paesi dell’Est puri (Lettonia,
Bulgaria, Romania, Ungheria, Estonia, Lituania e Polonia) a lungo sotto l’egida russa che ne ha
caratterizzato i livelli di sviluppo. Distanti, socialmente ed economicamente, dal modello europeo,
attualmente sono paesi impegnati a reinventarsi nel recuperare un divario sociale fortemente sentito
che li mette in affanno rispetto alla espressa volontà di sviluppo anche sul versante territoriale ed
economico, sul quale tuttavia, in maniera differenziale nei contesti locali, risultano essere in rapida
scalata. Questo spiega la posizione nel quadrante che incrocia il protendere verso politiche di
inclusione sociale congiuntamente al recupero di ampi spazi di autonomia su struttura differenziale,
i net welfare locali. Qui la strategie di integrazione utilizzata non muta rispetto alla
caratterizzazione della precedente strutturazione tipologica in quanto di sviluppo integrativo si
tratta, ma nella forma di Emersione di specificità contestuali e da stati di arretratezza che
comportano la necessità di un deciso recupero del divario sociale ancora persistente, per l’appunto
in funzione del retaggio culturale che agisce con la sua decisa influenza. Non sorprende, invece,
ritrovare in maniera piuttosto coesa e ravvicinata i Paesi mediterranei colpiti da crisi (Grecia,
Spagna, Italia e Portogallo) e quindi accomunati da un rallentamento marcato del sistema che li
porta a decadere nei livelli di performance e nel ranking di sviluppo. Tali paesi più che
8
caratterizzare uno specifico quadrante, si pongono sulla media rispetto all’asse di integrazione,
quindi non spostandosi marcatamente né sul versante della coesione, né su quello dell’inclusione,
mentre sull’asse dell’europeizzazione protendono, in via non del tutto uniforme (il che sarà chiarito
nell’analisi dei casi di Milano e Napoli) verso l’autonomia e la differenziazione dei regimi locali, i
net welfare. A livello di performance sociali registrate dagli indicatori analizzati, queste risultano,
come evidenziato, in netto calo, il che, piuttosto che portare tali paesi a puntare su strategie di
integrazione volte a sviluppo in competitività o emersione in specificità, li spinge a diventare
emblema delle conseguenze della Crisi economica e del suo impatto sull’indebolimento del sistema
di protezione sociale, spostando questi paesi su un decisivo snodo costituito dalla necessità del
recupero di divari economici quanto sociali. L’Italia e la Spagna, come nazioni individuate per lo
svolgimento dell’indagine micro, finiscono per protendere l’una sul versante dell’emersione intesa
in qualità di recupero di problematiche sociali fortemente gonfiate dalla crisi economica (Italia), e
l’altra sul versante di sviluppo inteso in qualità di competitività puntando sul potenziamento delle
dotazioni territoriali in uno scenario nel quale è la crisi sociale che ha portato all’emersione delle
contraddizioni economico-contestuali (Spagna). Vi è, poi, il gruppo dei Paesi filo-scandinavi di
retaggio social-democratico (Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, Lussemburgo e Paesi Bassi) i
quali vivono attualmente una forma di stabilizzazione sistemica rispetto al welfare fatta di
andamento crescente nel tempo dei livelli di performance e da una corrispondente possibilità di
crescita congiunta dal punto di vista sociale e da quello competitivo territoriale. Il quadrante nel
quale vanno ad inserirsi è quello che adotta una marcata strategia integrativa definita di
Stabilizzazione che nello studio precedente aveva preso la connotazione di Stasi. Tale strategia
niente altro rispecchia che il raggiungimento di un regime di welfare fortemente connotato da
peculiarità e caratteristiche distintive, consolidato e funzionale, che non deve puntare al recupero di
arretratezze ma che spinge con decisone verso il potenziamento delle sue specificità, attirando verso
se nazioni orbitanti in decisivi meccanismi di convergenza a quel modello di welfare europeo cui
l’attore sovranazionale fortemente auspica (il Regno Unito ne risulta essere attratto). Infine, vi è il
gruppo dei Paesi del Centro di ispirazione liberale e matrice occupazionale nei sistemi di welfare
(Belgio, Francia, Germania e Regno Unito) che puntano ad una serrata confluenza sistemica, non al
modello funzionale scandinavo ma ad un modello dalle specificità tutte europee, più volte
identificato con quello che è stato definito Modello Sociale Europeo (Bifulco, 2005) e che nella
realtà degli ultimi anni ha mostrato tendenzialmente il suo carattere utopico nel momento in cui si
tenta di declinarlo convergentemente su contesti enormemente differenti e basandosi su principi di
rivalutazione differenziale come quello della sussidiarietà o del metodo aperto di coordinamento. Il
quadrante in cui ricadono queste nazioni è formato dall’incrocio tra un’integrazione che si fonda
chiaramente su strategie di sviluppo in senso di coesione territoriale, dotazione di servizi e
innalzamento di competitività, nonché dalla dinamica di convergenza intesa in senso di strategia
integrativa di Confluenza verso
dinamiche normative e prassi
procedurali che portano verso la
creazione effettiva di un regime
di welfare europeo finalmente
unitario. Se Germania e Francia
si legano senza dubbio a tale
quadrante, il Regno Unito si
sgancia di poco da questo gruppo
di nazioni al quale appartiene per
finire col protendere sul versante
della Stabilizzazione nel quale
già si trovava nel modello
originario. Fig. 4: Proiezione secondo l’indice di
integrazione nel modello testato.
9
4. Analisi micro sui contesti locali e le realizzazioni progettuali: spazi d’autonomie,
incongruenza legislativa e reti sociali come spazio relazionale e spazio decisionale
Gli ultimi due step portano la riflessione oltre il livello macro con un affondo micro su casi
specifici, passando dall’analisi di contesto attraverso gli indicatori sociali allo studio dei progetti
implementati nei contesti locali e delle reti di attori che vi operano. La prospettiva adottata è quella
dell’europeizzazione e delle differenti modalità in cui essa si presenta (Graziano, 2004), incluse le
possibilità di convergenza o incongruenza normativa che tale prospettiva genera nei contesti
singolarmente intesi. Nello studio originario il test del modello mix si è limitato ad una
comparazione intranazionale, Milano – Napoli (espressioni del divario nord/sud), ed una
internazionale, Milano – Berlino (tendenzialmente equiparabili per dimensioni e sviluppo). Nello
studio implementato, invece, sono state portate a termine le analisi condotte nelle restanti nazioni e
contesti locali (Monaco come termine di paragone con Berlino, Londra e Liverpool per il Regno
Unito, Barcellona e Vigo per la Spagna, Rouen per la Francia) al fine di completare di
caratteristiche ed attributi tutti i quadranti della tipologia emergente e per capire se è nelle
dinamiche micro che possono essere rintracciate effettivamente le dimensioni decisionali e di
indirizzo dei diversi regimi di welfare.
Riprendendo Graziano (2004), e dunque utilizzando la strategia di analisi di policy comparata,
sono stati selezionati due progetti per due ambiti di policy differenti, uno relativo alla coesione
territoriale (progetti di riqualificazione urbana con previsto impatto e ricadute sociali), l’altro
relativo all’inclusione sociale (progetti rivolti all’inserimento dei giovani disoccupati o inoccupati),
in quanto questi rappresentano i due estremi dell’emerso asse di integrazione comunitaria. Su
questi, per ciascuno e per ciascun contesto, sono state previste cinque interviste somministrate a
promotori, finanziatori, progettisti, operatori e tecnici impegnati nell’implementazione e nello
sviluppo dei progetti considerati. Con le interviste si è inteso contestualizzare i progetti, avviare
un’analisi di implementazione e di impatto basata sulla percezione dei testimoni privilegiati, fino a
giungere alla ricostruzione delle reti di attori che hanno concretamente agito e deciso nel contesto
locale indagato. Lo scopo è stato di definire gli effetti di europeizzazione e localizzazione sulle
effettive configurazioni relazionali locali e gli spazi di autonomia legislativa e decisionale che gli
attori nel contesto sono capaci di recuperare. Pertanto, se l’approccio per variabili utilizzato
nell’analisi degli indicatori sociali, ha puntato all’emersione delle differenze ai fini della selezione
dei casi e della classificazione degli stessi all’interno delle diverse dimensioni di integrazione
emerse usando i casi/paesi come luoghi per la misurazione, l’approccio per casi che viene proposto
in questo terzo step è stato utilizzato per riconosce la complessità degli eventi unici ed irripetibili e
indagarne gli sviluppi. Tuttavia, la comparazione tra policy ha mostrato che le differenze imputabili
al singolo ambito di policy considerato non incidono direttamente sulla strutturazione dei differenti
regimi di welfare sviluppati, mentre incidere significativamente sulle modalità con le quali viene
percepita e attuata l’integrazione dai diversi contesti analizzati. Pertanto, molto più interessante
risulta la comparazione intra e internazionale di stampo geografico che lascia emergere il peso della
componente territoriale e delle potenzialità decisionali espresse dai livelli di governance più bassi.
Tralasciando, in questa sede, le specificità di ciascun contesto e per ciascun progetto, ciò che è
interessante mettere in rilievo sono le differenze emergenti, da una parte in merito a vincoli
normativi, percezione di incongruenza, gradi di autonomia, impatti e procedure di implementazione,
dall’altra in merito alla conformazione delle reti, dinamiche decisionali, conflittuali e di mediazione.
Per Graziano (2004), i processi di convergenza o di autonomizzazione del livello locale di
governo rispetto a quello europeo traggono origine dai diversi modi di recepire e traslare le
normative ai diversi livelli di governance, generando anche incongruenze di applicazione
legislativa. L’esistenza di questo spazio di incongruenza e la percezione che ne hanno gli attori
coinvolti nella implementazione delle policy nei progetti possono essere funzionali alla
strutturazione di spazi d’azione e decisionali autonomi rispetto al sistema di vincoli legislativi
generali. Per rilevare tale connessione, ai testimoni privilegiati sono state poste domande inerenti la
10
questione normativa (tipo di vincolo normativo - impositivo, direttivo, coordinativo o di pressione
non formalizzata; percezione della discrepanza nella recezione e nell’applicazione di normative
europee sul livello locale; classificazione del tipo di discrepanza - facilitante o rallentatrice del
processo di integrazione europea e di implementazione progettuale; conseguenze rispetto ad un
possibile adattamento di policy - intese quali adattamento di policy, assorbimento del quadro
normativo o trasformazione del quadro di politiche considerato) e la rilevazione del grado di
autonomia percepito (rilevato sotto forma di scale graduate da 0 a 10 volte ad indagare la percezione
rispetto al recupero di spazi di autonomia dei soggetti implicati in: progettazione, gestione delle
spese, implementazione e decisioni strategiche per raggiungere gli obiettivi). L’ipotesi di base è che
l’aumento di autonomia percepita in ciascuna fase è direttamente connesso alla percezione di
incongruenza applicativa della normativa di riferimento ed alla natura vincolante da questa assunta.
Nelle fig.5-6-7-8-9 si riportano i trend medi rilevati rispetto al grado di autonomia percepito
nelle fasi strategiche descritte, congiuntamente sia all’indicazione della natura del vincolo
normativo sotto il quale si sviluppano i progetti indagati sia alla percezione di incongruenza. Ciò
che è stato constatato in generale è che l’unica differenza riscontrata per i diversi ambiti di policy
indagati sta nella quantità di fondi europei associata alle politiche di coesione, che è maggiore
rispetto a quelle di inclusione in tutti i contesti, il che rende la normativa in merito ovviamente più
vincolante ed il grado di autonomia percepito rispetto a questi progetti, in generale, per tutti i
contesti, più basso rispetto a quelli di inclusione. Passando alle differenze per comparazione
geografica, nel modello originario, il livello autonomia nelle differenti fasi coinvolte per Milano e
Napoli, per quanto concerne la comparazione intra-nazionale, è piuttosto elevato ed è associato ad
un vincolo normativo che va dall’impositivo al coordinativo per i differenti livelli di governance
coinvolti ed una percezione dell’incongruenza nell’applicazione e traslazione normativa riscontrata
ma differenziale per contesto. Se a Milano l’incongruenza più che liberare spazi di autonomia porta
a rallentamenti e ritardi nella possibilità di allinearsi allo scenario di welfare europeo, a Napoli
l’incongruenza viene percepita come un vantaggio nella possibilità di adottare strategie alternative
senza allontanarsi dal raggiungimento di obiettivi comuni. A Berlino, termine di paragone
internazionale, invece, il livello d’autonomia percepito è buono, il vincolo normativo è indicato
come direttivo, non viene riconosciuta nella forma mentis amministrativa la possibilità di esercitare
volontariamente il processo di incongruenza. Ciò a cui si punta è una piena convergenza in ogni
aspetto normativo e pratico, poiché si concepisce la buona riuscita come funzionale all’adattamento
normativo. Questa conformazione ha ovvie ricadute in termini di impatto, per cui se i migliori
risultati, sia su destinatari che su territorio, si ottengono a Berlino – dove l’implementazione viene
concepita come standardizzazione processuale e procedurale in funzione della convergenza e con
l’obiettivo trasversale di rendere l’intero processo burocratico, omologato e ligio ad un’applicazione
standardizzata – impatti di buon livello si registrano a Milano – dove l’implementazione tiene
maggiormente conto delle preoccupazioni di concordanza con le necessità emerse localmente
rispetto ad un’applicazione scandita di procedure e con l’obiettivo trasversale di fare rete localmente
– e impatti decisamente più limitati e relativi si ottengono a Napoli – la quale attua
un’implementazione differenziale per strategie applicate nel dovuto rispetto, però degli obietti
prefissati e nell’obiettivo trasversale di capitalizzare risorse decisionali, di potere, ma anche
economiche. I processi di integrazione ed europeizzazione si delineano nello scenario Italiano
ancora lontani dalla piena convergenza e dalla capacità strutturale di assorbimento normativo, legati
ad una visione di sviluppo differenziale su base territoriale della politica sociale. Con l’ampliamento
della base comparativa, riacquistando un termine di paragone intra-nazionale anche per la
Germania, a Monaco ritornano alti livelli di autonomia percepita, congiuntamente a vincoli
normativi direttivi e coordinativi ed assenza assoluta di percezione di incongruenza. Come per
Berlino, anche in questo contesto gli impatti rilevati sono ottimi e l’implementazione assume
caratteristiche standardizzate volte all’ottenimento del migliore dei risultati possibile. I processi di
integrazione ed europeizzazione si delineano nello scenario tedesco come volti alla convergenza
assorbendo pienamente gli indirizzi europei. Molto simile alla Germania rispetto alle caratteristiche
indagate è il Regno Unito con Londra e Liverpool, due contesti locali che risultano quasi
11
completamente intercambiabili rispetto alle caratteristiche rilevate, mostrando una decisa
inconsistenza della comparazione intra-nazionale. I livelli di autonomia registrati sono
estremamente elevati, la normativa di riferimento risulta essere poco stringente ed essenzialmente
coordinativa e basata su pressioni non formalizzate, l’incongruenza, nonostante l’ampio margine di
autonomia, non viene percepita e l’obiettivo di rilievo trasversale messo in evidenza risiede nel
rispetto della dimensione locale che risulta totalmente in linea e pronta per recepire gli obiettivi e le
procedure standard dettate dall’attore sovranazionale. Fondamentale diviene la riduzione dei
rallentamenti che possono innestarsi da implementazioni fortemente burocratizzate, promuovendo
più iniziativa locale e meno Europa, soprattutto rispetto alla progettazione ed al recupero di fondi
per finanziare lo sviluppo locale. Gli impatti che ne derivano risultano essere massimali sia rispetto
al territorio che ai destinatari degli interventi indagati. I processi di integrazione ed europeizzazione
si delineano nello scenario anglosassone come volti alla convergenza assorbendo pienamente gli
indirizzi europei ma rivendicando le proprie specificità di implementazione ed autonomia
decisionale locale. Differente il caso Francese, attualmente rappresentato esclusivamente dal
contesto di Rouen poiché le interviste su Parigi sono in via di svolgimento. In questo contesto i
livelli di autonomia riscontrati risultano discretamente buoni, la normativa di riferimento piuttosto
stringente è di natura impositivo direttiva e l’incongruenza più che manifestarsi nella sua
caratterizzazione normativa, si mostra con connotazione procedurale, gli ostacoli incontrati, di fatti,
sono di natura amministrativa, rendicontativa e burocratica nell’attuazione di procedure
standardizzate in un contesto che richiederebbe elasticità applicativa. Questa particolarità è dovuta
al fatto di avere come obiettivo trasversale quello del consolidamento di reti di partenariato, capaci
di ascoltare e conoscere profondamente il territorio seguendone le esigenze, ma senza distaccarsi
dall’auspicato obiettivo della convergenza. Gli impatti raggiunti pertanto sono buoni ma soffrono, in
fase implementativa, di quell’affanno all’adattamento legislativo per le peculiarità locali e necessità
contestuali richiamate, non totalmente coniugabili con le imposizioni europee. I processi di
integrazione ed europeizzazione si delineano nello scenario francese come volti alla convergenza
normativa rallentata dall’implementazione procedurale e dalla maggiore preoccupazione per il
locale. Infine, in Spagna, sia a Barcellona che a Vigo, la situazione che viene a registrarsi non
prevede un rilevante distacco in termini di comparazione intra-nazionale, è quella che prevede il più
basso grado di autonomia percepito, vincoli normativi impositivi stringenti, percezione di
incongruenza normativa su base differenziale per i diversi livelli di governance implicati, rilevata
soprattutto nelle traslazioni delle autonomie locali più che del contesto nazionale, e tuttavia non
considerata come fattore facilitante. L’obiettivo unificante sta nella volontà della creazione di reti di
comunicazione tra i vari livelli di governance che possano, per l’appunto, ovviare alla problematica
di applicazione differenziale fra livelli differenti. Questo porta ad impatti mediamente positivi, con
una tendenza al rispetto degli obiettivi stabiliti dall’attore europeo, più che alle procedure, ma
mostrando un’inevitabile affanno nell’adattamento normativo esplicitato nell’effettiva mancanza di
coordinamento tra i diversi livelli istituzionali implicati. I processi di integrazione ed
europeizzazione che si delineano nello scenario spagnolo, come per quello italiano, sono ancora
lontani dalla piena convergenza e dalla capacità strutturale di assorbimento normativo, legati ad una
visione di sviluppo differenziale su base territoriale. Fig. 5-6-7-8-9: Gradi di autonomia medi per ambito di policy e contesti locali e nazionali di riferimento
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
auton_prog auton_gest auton_impl auton_dec
Livelli d'autonomia percepiti per Germania
Berlino Inc
Berlino Coe
Monaco Inc
Monaco Coe
Vincolo notmativo:
Direttivo
Incongruenza non
percepita
0123456789
10
Livelli d'autonomia percepiti per Italia
Milano Inc
Milano Coe
Napoli Inc
Napoli Coe
Vincolo normativo:
Impositivo/
coordinativo
Incongruenza si:
rallentamento/
facilitatore
12
L’ultimo step d’analisi ha previsto l’analisi delle reti intese quali configurazioni relazionali e di
potere più o meno conflittuali. Policy network costituiti da attori, pubblici e privati, dotati di risorse
qualitativamente e quantitativamente diverse, ed operanti all’interno di uno spazio definito di policy,
intesi sia nell’accezione di configurazioni variabili di legami fra attori singoli e collettivi (Scott,
1991; Wasserman, Faust, 1998) sia nell’accezione di poli d’attrazione incentrati su problemi
socialmente percepiti e capaci di richiamare soggetti variamente qualificati ed interessati (Milward,
Wamsley, 1984). L’applicazione dell’analisi di rete è volta a comprendere se è nelle dinamiche
micro che possono essere rintracciate le dimensioni decisionali e di indirizzo effettivo dei diversi
regimi di welfare attribuendo alla struttura ed agli attori della rete il ruolo chiave nell’indirizzo di
tali dinamiche. Nello studio originario sono state prese in considerazione sei reti socio-centrate6
rappresentative di altrettanti progetti indagati (rispettivamente uno di inclusione ed uno di coesione
a Milano, Napoli e Berlino). Nell’ampliamento di tale studio sono state aggiunte ulteriori dodici reti
socio-centrate, sempre una di inclusione ed una di coesione per Monaco, Barcellona, Vigo, Rouen,
Londra e Liverpool. In esse i legami sono stati pesati sull’intensità della relazione intesa quale
molteplicità (multiplexity) ovvero possibilità che all’interno del legame evidenziato passi più di un
tipo di legame (professionale, amicale, parentale, istituzionale). Sono stati posti in evidenza gli
attori conflittuali e atti alla mediazione (economica per le risorse materiali; emotivo-personale;
decisionale relativa al potere informale), per capire in quale posizione si collochino all’interno della
rete e quanto questa possa essere funzionale ai fini decisionali. Analizzando i livelli di apertura della
rete, la sua densità e coesione, vengono messi in evidenza tre piani di importanza strategica su cui
operano gli attori: il piano posizionale (ufficiale-istituzionale), reputazionale (soggettivo) e
decisionale7.
Partendo dall’Italia, a Milano si riscontra l’emersione di network estesi, dinamici, inclusivi, a
maglia larga, organizzati per contenere e discutere la conflittualità esterna ed interna nell’ambito
dello spazio relazionale costituito, provvisti di molti punti di mediazione, basati su integrazione,
dinamicità, apertura, struttura orizzontale divisa per sfere d’influenza e composti da attori multipli
per ambiti coinvolti, molti stakeholders accanto a implementatori. La tendenza è a confluire nel
6 Le reti sono state elaborate attraverso il supporto informatico Ucinet 6.
7 Ai testimoni privilegiati è stato chiesto di indicare gli attori coinvolti rispetto ai tre piani di importanza e nelle loro
interconnessioni, indicando anche la natura del legame tra i soggetti.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
auton_prog auton_gest auton_impl auton_dec
Livelli d'autonomia percepiti per Francia
Rouen Inc
Rouen Coe
Incongruenza
procedurale non
normativa
Vincolo normativo:
Impositivo/ Direttivo
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Livelli d'autonomia percepiti per Spagna
Barcellona Inc
Barcellona Coe
Vigo Inc
Vigo Coe
Vincolo normativo:
Impositivo
Incongruenza
differenziale: si ma
non facilitatore
0
2
4
6
8
10
12
Livelli d'autonomia percepiti per Regno Unito
Londra Inc
Londra Coe
Liverpool Inc
Liverpool Coe
Incongruenza non
rilevata
Vincolo normativo:
Coordinativo/
Pressione non form.
13
sistema di net welfare locale il cui obiettivo resta l’integrazione comunitaria, ma le cui strategie
vanno a legarsi inscindibilmente alle peculiarità territoriali ed ai network di attori sfruttando gli
spazi di incongruenza ai fini della creazione di una strategia territoriale pienamente adattata al
contesto milanese. La struttura di rete rilevata, basata su un core di relazioni primarie e diramazione
da queste di relazioni secondarie, lascia intendere che le decisioni nascono e vengono messe in rete
proprio dal centro, identificato anche come sfera decisionale, che viene a configurarsi, in tal modo,
anche come centro di potere. Una capacità di centralizzazione e capitalizzazione funzionale di
comunicazione, informazioni e risorse, tipica degli issue network, che porta questo contesto a
protendere congiuntamente sia verso politiche d’inclusione sociale che di coesione territoriale. Fig. 10: Rete progetto inclusione Milano. Fig. 11: Rete progetto coesione Milano.
A Napoli emergono, invece, network lobbisti, ristretti e orientati, fatti di legami multipli, forti e
maglia stretta, all’interno dei quali il conflitto viene incluso nella rete e fatto partecipe della
condivisione di informazioni, possibilità decisionale, strategica e di esercizio del potere,
prevedendo, di contro, anche figure dedite alla mediazione. Basati su esclusività, poteri forti,
appartenenze incrociate a più ambiti di policy con strutture a vertice decisionale piuttosto che a
connessione orizzontale. Nel territorio napoletano, si finisce per puntare alle politiche di inclusione
in un sistema di net welfare locale il cui obiettivo resta l’integrazione comunitaria, ma le strategie
vanno a legarsi inscindibilmente alle peculiarità territoriali ed alle commistioni di interessi su questo
presenti, pertanto ai network di attori che queste riescono a muovere sfruttando sia gli spazi di
incongruenza normativa sia la possibilità di emersione e gestione del conflitto incorporandolo
internamente e facendolo diventare parte attiva del processo decisionale e di formazione del potere
di gestione locale delle scelte in merito al welfare. Gli attori coinvolti vanno da implementatori a
poteri forti, politici ed istituzionali, con assenza di stakeholders esterni. Fig. 12: Rete progetto inclusione Napoli. Fig. 13: Rete progetto coesione Napoli.
Infine, a Berlino troviamo network ristretti, coesi e strutturati, i cui attori fanno capo ad un unico
attore generale che è l’associazione di Terzo settore che si fa carico operativamente dell’attuazione
dei progetti stessi. Un carattere, questo, distintivo della non necessità di doversi aprire all’esterno
(Milano) o di includere interessi forti nella rete costituita (Napoli). Un network a maglia stretta, fitta
e fatta di legami multipli e forti, strutturato per contenere il conflitto, anche quando questo non
viene palesato, prevedendo sempre la presenza di eventuali mediatori. Stabilità, esclusività, chiusura
e sinergia sono i vantaggi di questa rete che porta alla strutturazione di veri e propri policy
community, nei quali vi è un interesse ad uno scambio non meramente materiale ma basato su di
14
una più estesa condivisione del medesimo sistema valoriale, che vedono la riuscita progettuale come
funzione dell’adattamento normativo. Gli attori coinvolti sono tutti implementatori ed operatori. La
propensione di Berlino è verso la convergenza normativa, istituzionale e comunitaria ed una
struttura di welfare europeo maggiormente focalizzata sugli impatti territoriali e quindi più dedita a
dare spazio a politiche di coesione. Fig. 14: Rete progetto inclusione Berlino. Fig. 15: Rete progetto coesione Berlino.
Con l’ampliamento dei contesti, si è utilizzato, come termine di paragone per Berlino, Monaco
rilevando su questo contesto network fortemente interconnessi, ristretti, coesi, a maglia stretta, fitta,
nei quali non emerge il conflitto ma è pur sempre prevista la figura del mediatore. Chiusura, poca
inclusività, stabilità e sinergia interna portano alla strutturazione tipica dei policy community nei
quali sono coinvolti sempre gli stessi attori per le tre sfere considerate (decisionale, reputazionale e
posizionale) che sono operatori e implementatori di unica associazione con assenza di stakeholders
esterni, non riconoscendo, come per Berlino, la necessità di aprirsi al territorio o includere poteri
forti. Il clima disteso, scandito e regolamentato (vincoli normativi stringenti) rende meccanica la
decisione e l’implementazione delle politiche sociali nei contesti locali, proprio come si trattasse di
protocolli standardizzati, nei quali prevale la propensione a regimi convergenti di welfare europeo e
il protendere verso politiche di coesione territoriale. Fig. 16: Rete progetto inclusione Monaco. Fig. 17: Rete progetto coesione Monaco.
Spostandoci in Francia, a Rouen, i network ritornano estesi, inclusivi, aperti, dinamici, a maglia
larga, senza appartenenze incrociate o legami multipli, strutturati su un core di relazioni primarie
nella sfera decisionale dalla quale si diramano aperture ad attori secondari e ambiti diversificati
nelle sfere posizionali e reputazionali. Il conflitto è palesato e scisso sul versante decisionale e su
quello procedurale e per arginarlo sono previsti molti mediatori interni alle diverse sfere. La
configurazione relazionale, per la rete di coesione, inoltre, risulta essere particolare, in quanto gli
stessi attori conflittuali vengono percepiti come principali mediatori del conflitto generato dalla
dinamica relazionale di rete. Apertura, inclusione delle dinamiche ed istanze territoriali, estensione,
struttura orizzontale divisa per sfere d’influenza, sono i caratteri che riportano ad una
conformazione da issue network meno stabile e formalizzata ma maggiormente elastica e flessibile.
Sono coinvolti attori a diversi livelli istituzionali e di governance, così come implementatori ed
operatori, stakeholders, attori esterni allo specifico ambito di interesse, proprio nella volontà di
recuperare l’anima strettamente locale della politica sociale. Il tutto senza allontanarsi da una decisa
tendenza verso la convergenza ad un welfare europeo e il fare leva su politiche di coesione
territoriale maggiormente incentrate sullo sviluppo di competitività e crescita economica.
15
Fig. 18: Rete progetto inclusione Rouen. Fig. 19: Rete progetto coesione Rouen.
Nel Regno Unito le situazioni rilevate a Londra e Liverpool sono totalmente equivalenti. Si tratta
di network basati su piccole cliques di attori massimamente connessi, senza una suddivisione in
struttura per sfere di influenza, che gestiscono le diverse fasi e responsabilità progettuali, con
assenza di palesamento del conflitto seppure siano ugualmente previste figure di mediazione nelle
reti londinesi, figure che scompaiono nettamente in quelle di Liverpool. Chiusura, poca inclusività,
ristrettezza, sinergia, sono le caratteristiche che portano alla conformazione di policy community,
costituite da operatori, implementatori e attori istituzionali in assenza totale di stakeholders o attori
esterni all’ambito di policy coinvolto. La tendenza prevalente è quella verso un regime convergente
di welfare europeo fondato, a differenza dell’andamento tedesco e francese, su una spinta marcata
verso politiche di inclusione sociale, settore che risulta ancora carente e sul quale si intende puntare
per portare a compimento uno sviluppo globale dell’individuo e del territorio. Fig. 20: Rete progetto inclusione Londra. Fig. 21: Rete progetto coesione Londra.
Fig. 22: Rete progetto inclusione Liverpool. Fig. 23: Rete progetto coesione Liverpool.
L’ultimo contesto nazionale considerato è la Spagna con Barcellona e Vigo che presentano
network massimamente interconnessi, ristretti, coesi, con appartenenze incrociate e forte
concertazione interna, con presenza di legami multipli, che accostato a quello professionale,,
vedono il prevalere di vincoli di parentela. Pertanto, tali network risultano inclusivi per livelli
16
operativi, ma chiusi all’esterno. Di fatti, chiusura, esclusività e concertazione interna sia
istituzionale che politica portano ad una struttura a vertice più vicina ai policy community. Il
conflitto è presente nella percezione dei testimoni privilegiati intervistati, ma, tuttavia, non è
specificato o personificato in attori o posizioni specifiche. La mediazione risulta, invece, essere
prevista sia internamente che esternamente alla rete, ed è di rilievo anche il fatto che, nelle reti di
Vigo, l’attore preposto al controllo sia menzionato come influente ma non abbia alcuna connessione
con gli attori della rete. Infine, nella rete sono coinvolti pochi attori, tra implementatori, operatori,
amministrativi, istituzionali e rappresentanti d’interessi forti, mentre risultano totalmente assenti
stakeholders e attori esterni. Per la conformazione strutturale, le reti di Barcellona risultano molto
simili a quelle tedesche, mentre quelle di Vigo risultano molto vicine a quelle rilevate nel contesto
anglosassone. Tuttavia a differenziarle è la natura dei legami che lega i soggetti, legami multipli ed
estremamente forti, ma soprattutto il fatto che siano sempre gli stessi soggetti, indipendentemente
dall’ambito di policy interessato, a manovrare decisione, implementazione ed esercizio di potere
nello sviluppo territoriale della politica sociale. Seppure i network in questione risultano essere così
fortemente connessi intra e inter ambito, le dinamiche locali portano all’emersione di un regime più
vicino ai net welfare locali, maggiormente rivolti alle politiche di coesione territoriale, nei quali il
contesto, limitato normativamente, ma stimolato proceduralmente e nelle strategie implementative,
diviene il soggetto responsabile degli indirizzi di welfare, piuttosto che delegare all’attore
sovranazionale lasciandosi spingere verso una forzata convergenza alla quale il territorio risulta non
essere ancora pronto. Fig. 24: Rete progetto inclusione Barcellona. Fig. 25: Rete progetto coesione Barcellona.
Fig. 26: Rete progetto inclusione Vigo. Fig. 27: Rete progetto coesione Vigo.
Le differenti configurazioni relazionali rilevate dimostrano che non è la struttura delle relazioni a
influenzare il campo (si pensi alle similitudini strutturali tra Napoli, Berlino e Barcellona, oppure tra
Londra e Vigo, o ancora tra Milano e Rouen), ma sono gli attori in esso coinvolti, con loro ruoli e
posizioni, a dare vita a implementazioni differenti.
17
5. Conclusioni: il modello generale di classificazione ed il suo test empirico
I risultati presentati rappresentano una tipologia in evoluzione, nata da uno studio pilota, ed
attualmente completata e testata nelle sue parti specifiche. Le conclusioni cui si è giunti nella prima
fase hanno portato le caratteristiche di implementazione progettuale, le conformazioni e la
propensione a particolari tipi di network, ad essere proiettati nello spazio di attributi costruito in fase
di analisi macro. Questo per completare dei dettagli necessari lo schema proposto e demarcare
nettamente i sistemi emersi e le direzioni di integrazione cui danno vita rispetto ai primi due
quadranti analizzati. Emerge una nuova polarità, issue network vs. policy community (Marin,
Mayntz, 1991), e rispetto a questa si dispongono i contesti locali e le connotazioni di network in
questi rilevate. È così che nel quadrante della convergenza oltre alla tendenza verso un sistema di
welfare europeo e politiche rivolte alla coesione territoriale ed alla competitività economica, si
possono riscontrare le caratterizzazioni di policy community e network ristretti, coesi e strutturati,
rappresentati da nazioni come la Germania, in particolare a Berlino. Sul versante opposto, nel
quadrante dell’emersione, accanto alle tendenze a net welfare locali e politiche rivolte all’individuo
ed alla sua inclusione, ritroviamo la connotazione di issue network divisi tra un versante di network
dinamici, inclusivi ed estesi e l’altro di network lobbisti, politici ma integrati. Biforcazione questa
non di poco conto, poiché mostra la capacità organizzativa e la gestione territoriale e differenziata
dei sistemi di net welfare. Fig. 28: Modello generale di classificazione.
Nel nuovo spazio di attributi
costruito attraverso
l’aggiornamento teorico e dei
dati macro, accanto alla
polarizzazione issue network vs.
policy community, che attraversa
come un asse trasversale il
quadrante in alto a sinistra e
quello in basso a destra, emerge
un’ulteriore contrasto tra
professionalised network e
concerted network with cross-
memberships, che a sua volta
attraversa come ulteriore asse
trasversale il quadrante in basso
a sinistra e quello in alto a destra.
Il quadrante della Confluenza,
pertanto, oltre a rilevare la tendenza convergente verso un welfare europeo e la propensione per
politiche di coesione territoriale, continua a caratterizzarsi per la presenza di network da intendersi
quali policy community, chiusi, ristretti, coesi e fortemente strutturati, incarnati, come nel disegno
originale, dai contesti tedeschi. Al centro di questa nuova polarizzazione e quindi al centro anche
dello spazio di attributi costituito, si trovano i contesti francesi, a metà strada tra la forte coesione e
l’evoluzione dei network verso gli issue network intesi quali reti aperte e dinamiche, inclusive ed
estese, pienamente incarnate all’estremo della polarità da contesti come quello milanese. Siamo,
pertanto nel quadrante dell’Emersione che incrocia regimi di net welfare locali e propensione per
politiche di inclusione sociale. Fa eccezione, in questo quadrante, il contesto napoletano, che
dimostra come quanto più ci si allontana dal centro tanto più gli estremi rivolti a sistemi di net
welfare locali possono mostrare caratterizzazioni del tutto inattese. In questo contesto i network
tornano ad essere chiusi, poco inclusivi e basati su dinamiche lobbiste, chiara espressione del fatto
che ci si stia spostando sempre più dal richiamo alla convergenza andando verso un’attuazione della
politica sociale come dimensione puramente contestuale e locale. Nel quadrante che incrocia
tendenze verso net welfare locali e propensione a politiche di coesione sociale, il quadrante dello
18
Sviluppo, ritroviamo i contesti spagnoli, che vengono a caratterizzarsi per l’aver sviluppato
localmente reti fortemente concertate e caratterizzate dalla presenza incrociata dei membri a più
ambiti di policy, risultando, pertanto, ristretti, fortemente coesi ed interconnessi ed estremamente
selezionati. Anche in questo caso il richiamo forte è all’autonomia, marcando la distanza dal
cammino alla convergenza, in quanto sono gli stessi contesti locali, già gravati da crisi economico-
sociali, a non prestarsi ad attuazioni sistematiche e standardizzate della politica sociale, luogo di
appiglio e conoscenza profonda del territorio sul quale viene implementata. Nell’ultimo quadrante,
quello della Stabilizzazione, costituito dall’incrocio tra regimi volti alla convergenza al welfare
europeo e propensione verso politiche di inclusione sociale, la strategia di network che viene ad
emergere è quella dei professionalised network, reticoli estremamente ristretti di attori, dai legami
non forti ma funzionali all’obiettivo, reti di scopo che tendono alla massimizzazione degli impatti
locali della politica sociale attuando il processo implementativo come processo professionalizzato
ed altamente specializzato, tanto da coinvolgere le “menti” (dirigenti e attori istituzionali) più che le
“braccia” (operatori ed implementatori) nel processo di attuazione locale della politica sociale,
dinamica inversa allo speculare tedesco comunque teso alla convergenza.
Fig. 29: Modello generale di classificazione testato completo.
La tipologia, così messa a punto,
rivela il suo carattere di strumento
integrato che accoglie i risultati di
differenti metodi analitici per metterli a
sistema in una visione complessiva. Così
testata, a parere di chi scrive, tale
tipologia può essere intesa quale
strumento di lettura dei mutamenti in atto
nelle differenziazioni e nelle tendenze
degli attuali regimi di welfare. Essa offre
categorie interpretative e spunti di
riflessione utili ad ampliare e corredare di
ulteriori elementi lo stesso strumento
tipologico-interpretativo generato, in
quanto in evoluzione continua e pronto a
raccogliere il mutamento e a renderlo
variabile sistemica integrante.
19
Bibliografia Anderson J. E. (1984), Public Policy Making: An Introduction, Houghton Mifflin, Boston MA.
Bifulco L. (2005), Come cambiano le politiche sociali europee, in Id. (a cura di), Le politiche sociali. Temi e prospettive, Carocci, Roma, pp.
13-36.
Bifulco L., de Leonardis O. (2006), Integrazione tra le politiche come opportunità poltica, in Donolo C. (a cura di), Il futuro delle politiche
pubbliche, Mondadori, Milano, pp. 31-58.
Börzel T. A., Risse T. (2004), One Size Fits All! EU Policies for the Promotion of Human Rights, Democracy, and the Rule of Law, in paper
presented for the Workshop on Democracy Promotion organized by the Center for Development, Democracy, and the Rule of Law,
Stanford University, October 4-5, 2004.
Capano G., Giuliani M. (1996), Dizionario di Politiche Pubbliche, NIS, La nuova Italia Scientifica, Roma.
Cremaschi M. (2006), Europeizzazione ed innovazione nelle politiche del territorio, in Donolo C. (a cura di), Il futuro delle politiche
pubbliche, Mondadori, Milano, pp. 205-218.
Cresswell J.W. (2003), Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches, Sage, London.
ID. (2012), Qualitative Inquiry and Reaearch Design: Choosing Among Five Approaches, Sage, London.
De Leonardis O. (1998), In un diverso welfare. Sogni ed incubi, Feltrinelli, Milano.
ID. (2003), Le nuove politiche sociali, in Bifulco L. (a cura di), Le politiche sociali. Temi e prospettive, Carocci, Roma.
Dye T. R. (1972), Understanding Public Policy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Donzelot J. (2003), Faire société, Seuil, Paris.
Edward O., Laumann F., Pappi U. (1976), Networks of collective action: a perspective on community influence systems, New York,
Academic Press.
Esping-Andersen G. (1985), Politics against Market. The social democratic road to power, Princeston University Press, Princeston.
ID. (1990), The three words of welfare capitalism, Polity Press, Princeton.
ID. (1996), After the Golden Age? State Dilemmas in a Global Economy, in G. Esping-Andersen G. (ed.), Welfare State in Transition, Sage,
London.
ID. (2002), Why we need a new welfare state, Oxford University Press, Oxford.
ID. (2005), Il welfare state senza il lavoro. L’ascesa del familismo nelle politiche sociali dell’Europa continentale, in «Stato e Mercato»
n.45, Il Mulino, Bologna.
ID. (2005), Le nuove sfide per le politiche sociali nel XXI secolo, in «Stato e Mercato» n.74, Il Mulino, Bologna.
Fargion V., Morlino L., Profeti S. (a cura di, 2006), Europeizzazione e rappresentanza territoriale, Il Mulino, Bologna.
Ferrera M. (1984), Welfare State in Italia. Sviluppo e crisi in prospettiva comparata, Il Mulino, Bologna.
ID. (1993), Modelli di solidarietà. Politica e riforme sociali nelle democrazie, Il Mulino, Bologna.
ID. (1995), The Rice and Fall of Democratic Universalism. Health Care Reform in Italy, 1978-1994, in «Journal of Health Politics, Policy
and Law», vol. 20, n. 3, pp. 275-302.
ID. (1996), The “Southern Model” of Welfare in Social Europe, in «Journal of European Social Policy», n. 6, pp. 17-37.
ID. (1998), Le trappole del welfare, Il Mulino, Bologna.
ID. (2006), Le politiche sociali. L’Italia in prospettiva comparata, Il Mulino, Bologna.
ID. (2008), Trent’anni dopo. Il welfare state europeo tra crisi e trasformazione, in «Stato e Mercato», n. 81, pp. 341-375.
Flora P., Heidenheimer A. (eds, 1981), The development of Welfare State in Europe and America, New Brunswick Transaction Press, New
Brunswick.
Giuliani M. (2004), Europeizzazione come istituzionalizzazione: questioni definitorie e di metodo, URGE Working Paper 4/2004, in “Rivista
italiana di politiche pubbliche”, 1/2004, pp. 141-161.
Graziano P. (2004), Europeizzazione e politiche pubbliche italiane, Il Mulino, Bologna.
Gullièn A., Palier B. (2004), Does Europe Metter? Accession to EU and Social Policy Developments in Recent and New Member States, in
“Journal of European Social Policy”, 14/3, pp. 203-209.
Hox J. (2002), Multilevel Analysis. Techniques and Applications, Lawerance Erlbaum Associates, London.
Jenkins W.I. (1978), Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective, Martin Robertson, London.
Jenson J. (1998), Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research, Canadian Policy Research Networks, CPRN Study, n° F/03
Kazepov Y. (a cura di, 2009), La dimensione territoriale delle politiche sociali in Italia, Carocci, Roma.
ID. (a cura di, 2010), Rescaling social policies: towards multilevel governance in Europe, Ashgate.
Lasswell H. D. (1959), Power and Society, Yale University Press, New Haven.
Le Gales P. (2002), European Cities. Social Conflicts and Governance, Oxford University Press, Oxford.
Leibfried S., Pierson P. (eds.) (1995), European Social Policy. Between Fragmentation and Integration, The Brookings Institution,
Washington.
Naldini M. (2007), Le politiche sociali in Europa. Trasformazioni dei bisogni e risposte di policy, Carocci, Roma.
Paci M. (1997), Welfare State, Ediesse, Roma.
ID. (2004), Le ragioni per un nuovo assetto di welfare in Europa, in «La Rivista delle Politiche Sociali», n.1/2004, pp. 333-373.
ID. (2007), Nuovi lavori, nuovo welfare, II ed., Il Mulino, Bologna.
ID. (2008), Welfare, solidarietà sociale e coesione della società nazionale, in «Stato e Mercato», n. 82, pp. 3-29.
ID. (a cura di, 2008), Welfare locale e democrazia partecipativa, Il Mulino, Bologna.
Palier B. (2000), Does Europa Matter? Europèanisation et rèforme des politiques socials des pays de l’Union Europèenne, in «Politique
Europèenne», n. 2, pp. 7-28.
Punziano G. (2012), Mixed Methods as mirror of Social Research, in (a cura di) C. Cipolla, A. de Lillo, E. Ruspini,Il sociologo, le sirene e le
pratiche di integrazione, Franco Angeli, Milano.
ID. (2012), Welfare europeo o welfare locali? I processi decisionali nel sociale tra convergenza ed autonomia, Diogene Edizioni, Napoli.
Radaelli C. M. (2003), The Europeanization of Public Policy, in K. Featherstone and C. M. Radaelli (eds), The Politics of Europeanization,
Oxford, Oxford University Press.
Scott J. (1997), L’analisi delle reti sociali, ed. it. Enrica Amaturo (a cura di), NIS, Roma.
Sen A. (1993), Capability and Well-Being, in Nussbaum M. C., Sen A., (eds.): The Quality of Life. Clarendon Press, Oxford, pp. 30-53.
Tashakkori A., Teddlie C. (2003), Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, Sage, London.
Teddlie C., Yu F. (2007), Mixed methods sampling: A typology with examples, Journal of Mixed Methods Research, n. 1, pp. 77-100.
Titmuss R. (1974), Social Policy, Allen &Unwin, Londra.
Wasserman S., Faust K. (1998), Social Network Analysis. Methods and applications, Cambridge University Press, Cambridge.
20
Allegato 1: Progetti selezionati per la comparazione intra e internazionale:
Allegato 2: Principali caratteristiche rilevate nei progetti indagati