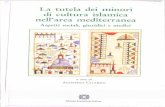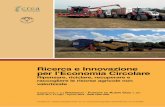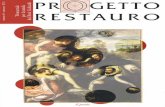La disciplina del matrimonio precoce nel diritto di famiglia marocchino
Regimi patrimoniali della famiglia e prospettive di innovazione
Transcript of Regimi patrimoniali della famiglia e prospettive di innovazione
Ras
segn
a di
dir
itto
civi
le
diretta da Pietro Perlingieri
Edizioni Scientifiche Italiane
Rassegnadi diritto civile
Post
e It
alia
ne s
.p.a
. -
Sped
izio
ne i
n A
.P.
- D
.L.
353/
2003
(co
nv.
in L
. 27
/02/
2004
n.
46)
art.
1, c
omm
a 1,
DC
B N
apol
i
114
9914105000
Edizioni Scientifiche Italiane, 80121 Napoli, Via Chiatamone, 7 ISSN 0393-182XFinito di stampare nel mese di febbraio 2014
Imprimé à taxe réduite - taxe perçue - tassa riscossaNapoli - Italie
cop rassdirciv:copertinas 27-01-2014 11:19 Pagina 1
Rassegna di diritto civile, pubblicazione trimestrale diretta da Pietro Perlingieriedita con la collaborazione scientifica della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell’Università di Camerino e del Dipartimento di Scienze Politiche «Jean Monnet» della Seconda Università di Napoli
Comitato editoriale: Mauro Pennasilico, Francesca Carimini, Anna Malomo, Benedetta Manfredonia,Ignazio Tardia, Gabriele Carapezza Figlia, Arianna Alpini, Giuliana Caso, Francesco Rossi, FrancescoLongobucco, Marco Angelone, Erika Giorgini, Lorenzo Bello, Stefano Deplano
Redazione Edizioni Scientifiche Italiane: Giuseppe Selo
Segreteria di redazione: Carolina Perlingieri e Giovanni Perlingieri
I lavori pubblicati in questo numero sono di: M. Angelone, ric. dir. priv. univ. Politecnica Marche; A. Bon-garzone, dott. ricerca univ. Catanzaro; R. Caprioli, ord. dir. priv. Napoli «Federico II»; N. Cipriani, ord.dir. priv. univ. Sannio; P. Corder, dr; A. De Franceschi, dott. ricerca univ. Ferrara; R. Di Raimo, ord. dir.priv. univ. Salento; R. Favale, ord. dir. comp. univ. Camerino; N. Ferraro, dott. ricerca univ. Torino; F. Man-cini, dott. ricerca univ. Napoli «Federico II»; A. Nervi, ass. conf. dir. priv. univ. Sassari; P. Perlingieri, eme-rito dir. civ. univ. Sannio; M. Semeraro, ric. dir. priv. univ. Catanzaro; S. Stanca, dott. ricerca univ. Salento;S. Vogenauer, prof. dir. comp. univ. Oxford.
Registrazione presso il Tribunale di Benevento al n. 99 del 27 marzo 1980. Responsabile: Pietro Perlingieri. Spe-dizione in abbonamento postale art. 2 comma 20/b legge 662/96 filiale di Napoli. Copyright by Edizioni Scien-tifiche Italiane - Napoli.
Criteri di selezione dei contributi pubblicati
La Rivista sottopone i contributi destinati alla pubblicazione ad un procedimento di valutazione preventiva che ga-rantisce l’obiettività e la ponderatezza del giudizio. A tal fine la Direzione potrà avvalersi di uno o piú Responsa-bili della valutazione, i quali disgiuntamente li potranno sottoporre ad uno o piú componenti del Comitato di va-lutazione in ragione della competenza specifica richiesta. Il referee riceve il contributo da valutare senza l’indica-zione dell’Autore; all’Autore non viene comunicata l’identità del referee. Il giudizio motivato potrà essere positivo;positivo con l’indicazione della necessità di apportare modifiche o aggiunte; negativo. Esso sarà trasmesso alla Di-rezione che, direttamente o tramite il Responsabile della valutazione, provvederà a comunicarlo all’Autore, sempregarantendo l’anonimato del referee. I contributi giudicati meritevoli di pubblicazione dai referees possono essere og-getto di pubblicazione nella Rivista in base alla insindacabile valutazione della Direzione. Qualora il referee esprimaun giudizio positivo con riserva, la Direzione autorizza la pubblicazione soltanto a seguito dell’adeguamento delcontributo, assumendosi la responsabilità della verifica. Nell’ipotesi di valutazioni contrastanti sarà la Direzione adecidere circa la pubblicazione del contributo. La Direzione può assumere la responsabilità delle pubblicazioni distudi provenienti da autori stranieri di consolidata esperienza o di studiosi anche italiani di anzianità e prestigio taliche la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista.
L’accettazione di un articolo implica l’impegno da parte degli autori a non pubblicarlo, o a non pubblicare partidi esso, in altra rivista senza il consenso scritto dell’Editore secondo le modalità concordate con l’Editore stesso.
Le medesime regole valgono anche per i Quaderni della Rassegna di Diritto Civile, sí che lo stesso Comitatosarà investito della valutazione dei lavori inviati alla Direzione dei Quaderni.
Responsabili della valutazione: Giovanni Perlingieri e Mauro Pennasilico
Comitato di valutazione: Fabio Addis, Francesco Alcaro, Giuseppe Amadio, Tommaso Auletta, Cesare MassimoBianca, Fernando Bocchini, Francesco Donato Busnelli, Raffaele Caprioli, Ugo Carnevali, Donato Carusi, RaffaeleCaterina, Ernesto Cesaro, Sebastiano Ciccarello, Giorgio Collura, Giuseppe Conte, Andrea D’Angelo, GiovanniDe Cristofaro, Enrico Elio Del Prato, Stefano Delle Monache, Carmine Donisi, Luiz Edson Fachin, Gilda Fer-rando, Giovanni Furgiuele, Enrico Gabrielli, Gianni Galli, Gregorio Gitti, Attilio Gorassini, Carlo Granelli, Mi-chele Graziadei, Giuseppe Grisi, Gábor Hamza, Peter Kindler, Agustín Luna Serrano, Francesco Macario, France-sco Macioce, Marcello Maggiolo, Maria Rosaria Marella, Gennaro Mariconda, Antonio Masi, Ugo Mattei, MarisaMeli, Daniela Memmo, Mario Nuzzo, Mauro Orlandi, Fabio Padovini, Gianfranco Palermo, Massimo Paradiso,Giovanni Passagnoli, Enrico Quadri, Pietro Rescigno, Vincenzo Ricciuto, Liliana Rossi Carleo, Ugo Antonino Salanitro, Vincenzo Scalisi, Michele Sesta, Gianluca Sicchiero, Michele Tamponi, Chiara Tenella Sillani, Gustavo Tepedino, Raffaele Tommasini, Mario Trimarchi, Francesco Venosta, Giuseppe Vettori, Gianroberto Villa, StefanVogenauer, Paolo Zatti.
Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.80121 NAPOLI - Via Chiatamone, 7 - Tel. 0817645443 pbx - fax 081764647700185 ROMA - Via dei Taurini, 27 - Tel. 064462664 - fax 064461308
Condizioni di abbonamento per il 2014:
Privati abbonamento € 190,00 Fascicolo € 55,00Enti abbonamento € 266,00 Fascicolo € 79,00Estero abbonamento € 350,00 Fascicolo € 110,00
I prezzi si intendono comprensivi di IVA.La sottoscrizione a due o più riviste, se effettuata in un unico ordine e direttamente presso lacasa editrice, dà diritto ad uno sconto del 10% sulla quota di abbonamento.Gli sconti non sono cumulabili.
L’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata,compresi quelli già pubblicati. Il pagamento può essere eseguito con queste modalità:
• Con versamento tramite bollettino postale sul n. c.c. 00325803, intestato a Edizioni Scienti-fiche Italiane S.p.a, via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli.
• Sul modulo devono essere indicati, in modo leggibile i dati dell’abbonato (nome, cognomeed indirizzo) e gli estremi dell’abbonamento.
• Mediante bonifico bancario sul c/c 70, intestato a Edizioni Scientifiche Italiane S.p.a., via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli; - BANCA DELLA CAMPANIAIBAN IT36K0539203401000000000070.
• A ricevimento fattura (formula riservata ad enti e società)
Per garantire al lettore la continuità nell’invio dei fascicoli l’abbonamento che non sarà disdettoentro il 30 giugno di ciascun anno si intenderà tacitamente rinnovato e fatturato a gennaio del-l’anno successivo.I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 15 giorni dal ricevimentodel fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono contro rimessa dell’importo. Perogni effetto l’abbonato elegge domicilio presso le Edizioni Scientifiche Italiane S.p.a.
Le richieste di abbonamento, le segnalazioni di mutamenti di indirizzo e i reclami per man-cato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all’Amministrazione presso la casa editrice:Edizioni Scientifiche Italiane S.p.a., via Chiatamone 7 – 80121 NapoliTel. 081/7645443 – Fax 081/7646477Internet: www.edizioniesi.ite-mail: [email protected]; [email protected]
Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun vo-lume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 dellalegge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra siae, aie, sns e cna, confartigianato,casa, claai, confcommercio, confesercenti il 18 dicembre 2000.Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell’ingegno (aidro)Via delle Erbe, 2 - 20121 Milano - Tel. e fax 02-809506; e-mail: [email protected] esonerato da B.A.M. art. 4, comma 1, n. 6, d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627.
cop rassdirciv:copertinas 27-01-2014 11:19 Pagina 2
EDITORIALE
1 Pietro Perlingieri, I valori e il sistema ordinamentale “aperto”
SAGGI
9 Marco Angelone, La nuova frontiera del «public antitrust enforcement»:il controllo amministrativo dell’Agcm avverso le clausole vessatorie
41 Amelia Bongarzone, La sicurezza dei lavoratori tra garanzie promesse egaranzie attuate
73 Raffaele Caprioli, La preferenza attribuita ai creditori dell’eredità bene-ficiata ed ai legatari sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori perso-nali dell’erede
89 Nicola Cipriani, Rapporti personali nella famiglia e successione di normenel tempo
126 Paolo Corder, Note in tema di procedimenti di famiglia e minorili allaluce dell’entrata in vigore della legge n. 219/2012
144 Nadia Ferraro, Accessorietà e circolazione della garanzia ipotecaria163 Ferdinando Mancini, Regimi patrimoniali della famiglia e prospettive di
innovazione180 Andrea Nervi, Beni comuni e ruolo del contratto204 Stefania Stanca, Informazioni ingannevoli e rimedi contrattuali: profili ri-
costruttivi
ESPERIENZE STRANIERE E COMPARATE
234 Rocco Favale, Invalidità del contratto di vendita e vizi della cosa: la lorointerferenza nel modello tedesco
246 Stefan Vogenauer, I princípi Unidroit dei contratti commerciali interna-zionali 2010
COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA
308 Raffaele Di Raimo, Interest rate swap, teoria del contratto e nullità: e sefinalmente dicessimo che è immeritevole e che tanto basta?
323 Maddalena Semeraro, La giurisprudenza sugli interest rate swap: specu-lazione, copertura, mancanza di causa?
Indice del 1° numero
Sommario: 1. Regime patrimoniale legale della famiglia. Attualità della comunione le-gale? – 2. Uno sguardo al regime patrimoniale della famiglia oltre i confini nazionali.– 3. Uno sguardo al regime patrimoniale della famiglia nel diritto comunitario e nelleconvenzioni internazionali. – 4. Conclusioni.
1. L’osservazione dei mutamenti della morfologia della famiglia italiananel corso del ’900 evidenzia una veloce evoluzione del sentire sociale. Unadeguato approccio operativo del legislatore nella sua attività di fattoredelle leggi deve partire dall’osservazione della realtà in cui si muove l’in-dividuo e in ciò la consultazione dei repertori di giurisprudenza consentedi cogliere gli aspetti concreti delle umane vicende che, in quanto giuntenelle aule di Giustizia, sono specchio della realtà medesima. Il diritto na-sce per rispondere all’esigenza di regolamentazione della vita del cittadinonei suoi molteplici aspetti e l’opera del legislatore deve essere adeguata adevitare ogni scollamento tra vivere sociale e sentire delle aule legiferanti.
La posizione e il rapporto tra coniugi nella famiglia nella società con-temporanea è aspetto che incide anche sul tema dei rapporti patrimonialitra coniugi. In particolare l’analisi della regolamentazione giuridica attualedel fenomeno, unita a quella del sentire della collettività sul tema, con-sentono una riflessione sulla predisposizione, in una prospettiva de iurecondendo, di misure idonee alla formazione di un modello speculare allastruttura e morfologia che la famiglia stessa assume nelle concrete dina-miche sociali, anche sotto il profilo della regolamentazione patrimonialedel fenomeno.
Anteriormente alla riforma del diritto di famiglia recata dalla novelladel 1975, il sistema positivo non prevedeva espressamente l’istituto dellaseparazione dei beni quale regime delle vicende patrimoniali della fami-glia, ma la sua applicazione derivava dai princípi generali di sistema inquanto, in assenza di un patrimonio familiare, una costituzione di dote ouna convenzione di comunione dei beni, i patrimoni dei coniugi rimane-vano separati, ossia in titolarità del coniuge acquirente1.
Saggi
1 In particolare, l’art. 159 c.c. ante riforma prevedeva testualmente «I rapporti patrimoniali
Regimi patrimoniali della famiglia e prospettive di innovazione
Successivamente la spinta verso la giuridicizzazione di un sistema dicomunione quale regime legale della famiglia, suggellato con la l. 19 mag-gio 1975, n. 151, recante la «Riforma del diritto di famiglia», derivò dal-l’intento di realizzare intenti solidaristici all’interno della famiglia a tuteladel coniuge debole. La comunione legale, infatti, innesca un regime pro-prietario vincolato a tutela del coniuge debole onde consentirgli una par-tecipazione alle fortune della famiglia, stante il suo apporto lavorativo, an-che eventualmente domestico, rivolto a sostenere gli oneri del nucleo fa-miliare. Lo stesso spirito che rappresenta il retroterra culturale ed emo-tivo sotteso alla comunione legale si coglie anche nella Relazione del Guar-dasigilli alla codificazione del 1942 (n. 113), ove si giustifica la previsionedella comunione come regime convenzionale della famiglia, osservando che«la comunione risponde pienamente oltre che alle esigenze della vita mo-derna, ad un alto senso di equità, poiché assicura alla moglie, che lavora,i frutti della sua collaborazione nella società familiare».
L’applicazione dell’istituto della comunione legale nel corso di quattrodecenni dal suo avvento ha manifestato, però, i propri limiti, dimostrandouna forte incisione del principio dell’autonomia dei coniugi2 con la con-seguenza che si è assistito ad un frequente ricorso alla scelta del regimeopzionale di separazione dei beni3. La diffusa stipula di convenzioni di se-parazione dei beni, in deroga al regime legale, deriva, fondamentalmente,da una lenta e costante erosione dei princípi che hanno rappresentato ilpresupposto dell’emersione della comunione legale, ossia del principio diindissolubilità del vincolo matrimoniale e della ripartizione dei ruoli al-l’interno del menage familiare. La possibilità, sempre piú concreta nei tempiodierni, che il vincolo matrimoniale si dissolva rende non piú «equo» eproporzionato alla ratio legis della comunione legale che l’un coniuge possapartecipare in via definitiva alle fortune dell’altro indipendentemente dal-l’esito della vita matrimoniale. Si aggiunga che non si riscontra piú una ri-partizione di ruoli all’interno della famiglia che vede la donna dedita a la-vori domestici e il marito dedito a lavori retribuiti, per cui non necessa-riamente le rispettive posizioni riflettono economie diverse all’interno della
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi164
tra coniugi sono regolati dalle convenzioni delle parti e dalla legge», e non era disposto, espli-citamente, un regime tendenzialmente universale di regolamentazione dei rapporti patrimonialitra coniugi. Nella Relazione del 26 settembre 1863 al primo codice civile dell’Italia unificata ilGuardasigilli Pisanelli, invece, giustificava la previsione della comunione come regime conven-zionale, anziché legale, sulla base della osservazione che «Nel Codice non viene ammesso di di-ritto il regime della comunione perché contrario alle nostre costumanze».
2 S. Patti, Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in Familia, 2002, p. 285.3 M. Sesta, Verso nuove trasformazioni del diritto di famiglia italiano, in Familia, 2003,
p. 149 ss.
coppia, circostanza che può giustificare meccanismi legali di riequilibriopatrimoniale, quale quello della comunione legale. Appaiono venute menole esigenze sottese alla predisposizione di un sistema di protezione a van-taggio del c.d. coniuge debole economicamente, che nell’ottica del legisla-tore italiano del 1975 è normalmente la donna (intenta a svolgere un la-voro domestico o piú umile dell’uomo), un sistema di protezione che con-senta allo stesso coniuge di assumere automaticamente la contitolarità deibeni acquistati dall’altro. Ragioni di tutela di un coniuge sull’altro appaionoanacronistiche in quanto la donna, lungi dall’essere soggetta ad una pri-mazia maschile, ha acquisito, nel corso di quarant’anni di storia civile esociale del paese, una piena emancipazione, anche sotto il profilo della col-locazione nel mondo del lavoro.
Dissolto il presupposto fenomenico e sociale che aveva giustificato l’av-vento del regime comunitario, si assiste all’attuale inadeguatezza dell’o-dierna disciplina legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi. La persistenzadi tale regime appare invischiare e rallentare la dinamica giuridica ed eco-nomica della famiglia attuale. Essendo mutato lo scenario sociale ed eco-nomico, esito necessitato e normale è la rivisitazione di quello normativoche, nella sua versione attuale, appare superato da un’evoluzione socialeche ha stravolto il dato fattuale di partenza.
Con la predisposizione di un regime legale patrimoniale della famigliail legislatore, prioritariamente, stabilisce, pur accordando libertà di sceltadi un regime opzionale, quale sia la regolamentazione patrimoniale dellafamiglia piú rispondente, secondo la sua valutazione, al reale persegui-mento degli interessi della famiglia. Ma anche sotto la lente di valutazionedegli interessi della coppia il regime di comunione legale appare non piúadeguato. La comunione legale è regime vincolato che non lascia spazi de-cisionali ai coniugi, che non possono prescindere dall’automatica instau-razione di un regime di contitolarità sul singolo acquisto (al di fuori delleipotesi di cui all’art. 179 c.c.). La possibilità di scegliere, in ragione dellecontingenti esigenze familiari, se dar séguito ad un acquisto personale oin comunione è impedita dalla vigenza del regime legale, né, manente ilmedesimo regime, vi è la possibilità di una deroga puntuale ed episodicaal singolo coacquisto4. Libertà, bensí, è garantita alla coppia nella pro-
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 165
4 Anche se in un suo arresto (Cass., 2 giugno 1989, n. 2688, in Giust. civ., 1989, I, p. 1997,in Foro it., 1990, I, c. 608) la Suprema Corte ha ritenuto possibile il c.d. rifiuto del coacquisto,ossia la possibilità che il coniuge non acquirente, pur prescindendo dalle ipotesi di cui all’art.179 c.c., possa dare assenso ad un acquisto personale in capo all’altro, la giurisprudenza suc-cessiva ha negato tale possibilità (tra le tante, cfr. Cass., 27 febbraio 2003, n. 2954, ivi, 2003, I,c. 1039). Una prima ragione che osta alla possibilità di una deroga episodica all’instaurazionedi un regime di comunione legale sul singolo acquisto è la considerazione della stessa comu-
grammazione della propria vita economica nella vigenza di un regime diseparazione dei beni in quanto lo stesso, consentendo di evitare forme diacquisto vincolate, assicura autonomia di pianificazione patrimoniale e li-bertà di scelta che si rinnova in ogni momento.
In considerazione del radicale cambiamento della realtà sociale e fami-liare italiana dal 1975 ad oggi e del contemporaneo manifestarsi di legit-time esigenze di un libero ed autonomo dispiegarsi dell’iniziativa econo-mica i tempi appaiono maturi per un ribaltamento della norma che com-porti l’avvento, come regime patrimoniale legale, della separazione dei beni.Rimanendo inalterato il panorama normativo di riferimento, le coppie sonocostrette, per conseguire una maggiore libertà nella programmazione dellavita economica della famiglia, a scegliere, al momento della celebrazionedel rito nuziale o successivamente, il regime della separazione dei beni.Del resto, il trascorrere del tempo è testimoniato dalla circostanza che, at-tualmente, il regime di separazione dei beni è il regime che, statisticamente,riceve il maggior favore delle coppie italiane rispetto al regime della co-munione legale, o almeno delle coppie di piú elevata estrazione economicae culturale.
Appare utile esaminare anche la realtà normativa degli altri Paesi, ondetrarre spunti di riflessione ed elementi di confronto.
2. Il filo conduttore della disciplina vigente negli altri Paesi in tema diregime patrimoniale della famiglia si coglie nella circostanza che, pur pre-vedendo il singolo ordinamento un regime legale, ritenuto dalle aule legi-feranti idoneo a garantire un adeguato assetto patrimoniale nei rapportifamiliari ed una tutela degli interessi del soggetto debole, vige un princi-pio di libertà di scelta per cui lo stesso regime legale è derogabile ad istanza
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi166
nione legale come comunione a mani riunite (senza la determinazione di quote) ovvero comecomunione di massa, come un’universitas di beni e rapporti considerata dalla legge in modounitario e non in modo atomistico come mera somma di diritti su singoli cespiti. A favore ditale lettura militano sia le norme che, in maniera generalizzata, indicano le categorie dei beniappresi alla comunione e dei beni personali, sia il disposto dell’art. 194 c.c. che, riferendo delladivisione dei beni della comunione effettuata ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo, fasupporre che il legislatore abbia inteso la comunione instaurata sui beni già in comunione le-gale come costituente un’universalità patrimoniale in cui la divisione stessa tra i condividenti av-viene non con l’attribuzione di porzioni di singoli beni ma di cespiti dell’intero asse. Sul temadella natura della comunione legale tra coniugi e su quello connesso dello scioglimento dellacomunione medesima per fallimento del coniuge sia consentito rinviare a F. Mancini, Falli-mento del coniuge imprenditore e scioglimento della comunione legale, Milano, 2011, p. 16 ss.Altro argomento contrario ad una deroga episodica al regime della comunione legale sta nelprincipio di tutela di affidamento dei terzi che verrebbe tradito se si consentisse un acquistopersonale in capo al singolo coniuge al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 179 c.c.
dei coniugi, e viene lasciata a questi ultimi la possibilità di optare per re-gimi convenzionali. In particolare, pur con il limite variamente individuato,che esclude la possibilità di stipula di convenzioni atipiche, si lascia spa-zio all’autonomia privata di scegliere diversamente dal modello legislativoche, quindi, si atteggia a regime residuale, regime applicabile solo nell’e-ventualità che i coniugi non decidano diversamente sulla regolamentazionepatrimoniale della loro vita familiare. Tale constatazione conduce alla con-clusione che siano assenti, come nel nostro ordinamento, princípi di or-dine pubblico che sottendano e giustifichino l’emersione di regimi legalinella disciplina patrimoniale della famiglia. L’opzione del legislatore per unregime legale è quella di un legislatore «padre» che, prescindendo da im-plicazioni cogenti sottese a princípi superiori fondanti l’ordinamento, va-luta, prioritariamente rispetto a considerazioni puntuali dei singoli, qualesia il regime piú rispondente a ragioni di «equità» giuridica e alla tuteladelle ragioni del nucleo familiare. Diversamente ragionando, ossia se si ri-tenesse che la previsione di un regime legale patrimoniale della famigliasia giustificata da princípi fondamentali in un ordinamento, non potrebbeessere consentita la scelta di un regime alternativo.
Dall’osservazione della realtà normativa vigente negli altri Paesi si con-stata, innanzitutto, la mancanza di una tipizzazione del regime patrimo-niale primario distinto dal regime patrimoniale della famiglia, cosí comeprospettata nell’ordinamento italiano, rispettivamente nel capo IV del ti-tolo VI del libro I del codice civile (artt. 143 ss. c.c.) e nel capo VI delmedesimo titolo (artt. 159 ss. c.c.). Negli altri Paesi, quindi, non è sem-pre riscontrabile una coscienza ordinamentale rivolta a garantire all’internodell’ambiente familiare, pur prescindendo dal regime patrimoniale speci-fico prescelto dai coniugi, l’applicazione dei princípi di solidarietà e con-divisione patrimoniale, che, come princípi di diritto naturale, dovrebberorappresentare la regola primaria ed imprescindibile di ogni sistema di di-ritto patrimoniale della famiglia. Si aggiunga che negli ordinamenti di Com-mon Law la celebrazione di un matrimonio non ha conseguenze per laproprietà e il diritto degli sposi di disporre dei loro beni, per cui è estra-nea a quegli ordinamenti anche la nozione di regime patrimoniale dellafamiglia propriamente inteso.
La regolamentazione dei rapporti patrimoniali della famiglia negli altriPaesi prevede una gamma di regimi alternativi i cui due estremi sono rap-presentati dalla separazione dei beni, la quale, sul presupposto che il ma-trimonio non implica alcuna conseguenza di ordine patrimoniale nella vitadei singoli, esclude ogni confusione dei patrimoni dei coniugi, e dalla co-munione universale dei beni, che, in quanto tale, comporta che siano og-getto di contitolarità sia i beni acquistati dai coniugi durante il rapporto
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 167
matrimoniale sia quelli di cui essi siano titolari al momento della celebra-zione del matrimonio. Tra le due soluzioni estreme si posizionano formeparziali di comunione che comportano una partecipazione immediata odifferita del coniuge alle fortune dell’altro, nonché regimi di separazionedei beni in cui l’assolutezza del principio della personalità di redditi e pa-trimonio è mitigato dalla previsione di conguagli patrimoniali da prestare,dall’un coniuge all’altro, al momento dello scioglimento del vincolo ma-trimoniale.
La scelta sottesa alla previsione, come regime legale, di una forma dicomunione trova la sua intima razionalità, come già detto in merito allacomunione legale in Italia, in ragioni di tutela della posizione del coniugec.d. debole sulla base della presunzione che quest’ultimo, svolgendo atti-vità di fatto non remunerata all’interno delle mura domestiche, contribui-sca allo sviluppo del nucleo familiare, nonché alla formazione delle for-tune familiari. Ma la considerazione di queste ragioni non resta, spesso,estranea ai regimi che prevedono, come sistema legale, quello della sepa-razione dei beni in cui quelle stesse motivazioni trovano un adeguato ri-scontro in meccanismi che consentono di creare, come detto, al momentodello scioglimento del matrimonio, una perequazione tra le posizioni deiconiugi5.
In particolare, è possibile individuare, facendo una superficiale osser-vazione del panorama normativo straniero, le seguenti principali categoriedi regimi patrimoniali della famiglia: la comunione degli acquisti (regimelegale in Francia6, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, nonché inPaesi dell’Europa centrale ed orientale quali Polonia, Repubblica Ceca, Re-pubblica Slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Federazione Russa), incui formano oggetto di contitolarità dei coniugi, diritti, proventi e redditiacquistati dopo il matrimonio, ad eccezione delle categorie di beni consi-derati personali (quelli ricevuti per successione o per donazione e quelli
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi168
5 Al riguardo basti considerare il caso del sistema anglosassone ove il giudice ha il poteredi attribuire al coniuge non proprietario parte dei beni dell’altro.
6 Nell’ordinamento francese, vigendo il regime della comunione degli acquisti, si assiste allaformazione di tre masse patrimoniali, due rispettivamente composte dai beni di titolarità per-sonale di ciascuno dei coniugi ed una dal patrimonio comune. Tra i beni personali vi sono: ibeni personali à raison de leur origine, ossia quelli di cui il coniuge era già titolare prima delmatrimonio, quelli acquistati a titolo gratuito per liberalità o successione mortis causa e quellisurrogati a beni personali; i beni propres par leur nature, ossia i beni o le rendite ottenute a ti-tolo di risarcimento del danno alla persona o del danno non patrimoniale, i beni di uso stret-tamente personale e quelli strumentali all’esercizio della propria professione. Il patrimonio co-mune è, invece, formato dai beni acquistati congiuntamente e disgiuntamente dai coniugi du-rante il matrimonio, dai proventi della rispettiva attività lavorativa e dai redditi dei beni perso-nali, percepiti nella vigenza del vincolo matrimoniale.
di uso strettamente personale) e in cui, corrispondentemente, si distinguetra obbligazioni gravanti sui beni comuni, in quanto relative alla gestionedella vita familiare, e obbligazioni personali, contratte prima delle nozze;comunione universale dei beni, che riguarda tutti i beni dei coniugi, adeccezione dei beni particolari e dei beni esclusi dai coniugi stessi, dai terzio per legge (regime convenzionale in Germania e regime legale nei PaesiBassi)7; comunione degli acquisti e comunione de residuo, in cui si assisteall’emersione, oltre delle categorie dei beni comuni e dei beni personali, diun patrimonio de residuo che va diviso, per quanto esistente e non con-sumato al momento dello scioglimento del regime, tra entrambi i coniugi(regime legale in Italia, in cui la c.d. comunione de residuo riguarda i fruttidei beni propri di ciascun coniuge, i proventi della rispettiva attività sepa-rata, beni e/o incrementi relativa all’impresa di uno dei coniugi, ex artt.177, lett. b e c, e 178 c.c.); la comunione degli incrementi, per cui i beni,nella vigenza del vincolo, sono personali, tendenzialmente liberamente di-sponibili ad opera del singolo coniuge8, e al momento dello scioglimentodel regime sorge un credito dell’un coniuge nei confronti dell’altro corri-spondente alla metà dell’incremento di valore conseguito dal patrimonio diquest’ultimo durante il vincolo matrimoniale (regime legale in Germania9,
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 169
7 La gemeenschap van goederen dei Paesi Bassi si compone di tutti i beni presenti e futuridei coniugi, salvo quelli donati o legati all’uno o all’altro con la condizione che rimangano per-sonali e dei beni strettamente personali, nonché dei debiti contratti prima e durante il matri-monio.
8 I poteri di disposizione del singolo coniuge sono tendenzialmente ampi in quanto i sin-goli ordinamenti prevedono limiti specifici agli stessi poteri. Ad esempio nell’ordinamento da-nese non si possono compiere atti dispositivi dell’immobile che funge da residenza familiare edei relativi arredi senza il consenso anche dell’altro coniuge. Anche nell’ordinamento tedesco èprevisto un analogo limite per i beni destinati a residenza domestica e al loro arredo, con laconseguenza che, in caso di disposizione autonoma da parte del coniuge proprietario, la san-zione predisposta dall’ordinamento è quella dell’inefficacia assoluta dell’atto negoziale con lasoccombenza anche della posizione del terzo acquirente di buona fede.
9 La comunione degli incrementi in Germania è la Zugewinngemeinshaft (§§ 1363 ss. BGB).In particolare alla cessazione del regime si procede alla determinazione dell’incremento (Zu-gewinn) del patrimonio di ciascun coniuge ed ad un conguaglio tra gli incrementi dei patrimoni(Zugewinnausgleich). La determinazione si effettua calcolando la differenza tra il valore del pa-trimonio del coniuge al momento della celebrazione del matrimonio e il valore del medesimopatrimonio al momento dello scioglimento del vincolo. Nell’ipotesi di patrimonio passivo nelmomento iniziale o finale il valore dello stesso viene considerato zero. Al patrimonio inizialesono ricondotti anche i beni che ciascun coniuge riceve durante il regime per successione o li-beralità, nonché al patrimonio finale sono da aggiungere anche i beni che un coniuge ha do-nato o dissipato. Al momento del sorgere del vincolo matrimoniale si dovrebbe procedere al-l’inventario del patrimonio dell’un e dell’altro coniuge onde rendere possibile, al suo sciogli-mento, il calcolo del conguaglio eventualmente dovuto, ma in mancanza di inventario inizialesi presume che il patrimonio finale di ciascun coniuge sia totalmente incremento, sia frutto del-
Grecia, Svizzera, Danimarca, regime convenzionale in Francia10, nonchénei Paesi Bassi, Spagna e Catalogna)11; separazione dei beni12 (regime le-gale in Austria, Inghilterra13, Grecia, Catalogna e nella maggior parte de-gli Stati degli Stati Uniti d’America14).
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi170
l’attività e del lavoro da lui svolto nella vigenza del regime. Allo scioglimento del regime si con-frontano gli incrementi dei due patrimoni, per cui se l’incremento ottenuto dal patrimonio del-l’un coniuge è inferiore a quello ottenuto dal patrimonio dell’altro quest’ultimo sarà tenuto aversare in denaro al primo la metà della differenza.
10 Nel diritto francese è riconosciuto il principio dell’autonomia dei coniugi nella scelta delregime patrimoniale della famiglia, nonché quello della modificabilità del regime medesimo nelcorso della vita matrimoniale. Ai coniugi, quindi, è data facoltà di optare con atto pubblico peril regime della participation aux acquets, di cui agli artt. 1569 ss. del Code Civil, ossia per lacomunione degli incrementi.
11 In tali regimi, ove si assiste ad una compartecipazione differita al valore degli incrementipatrimoniali (v. Zugewinngemeinschaft tedesca) o ad una partecipazione differita al valore degliacquisti (v. Errungenschaftsbeteiligung-participation aux acquets, di cui agli artt. 196 ss. del co-dice civile svizzero), il profilo comunitario emerge solo allo scioglimento del matrimonio, di-versamente da quelli in cui la comunione delle fortune è profilo genetico al sorgere del vincolomatrimoniale. Al riguardo sono previsti anche strumenti per preservare la legittima aspettativadell’un coniuge a conseguire le proprie spettanze e a non vedere depauperate le sostanze altrui.Si manifesta, quindi, una vicinanza di tale regime a quello, genericamente detto, di comunionedifferita (de residuo), in cui manca una contitolarità dei beni durante la vita coniugale ma si as-siste ad una forma di condivisione patrimoniale allo scioglimento della stessa. Si può osservareche anche in tema di comunione de residuo nell’ordinamento italiano tesi autorevoli ricono-scono che tale forma di comunione, lungi dal concretarsi in forme di contitolarità, si sostanzinel sorgere di un rapporto obbligatorio di credito-debito tra i coniugi. Si tratta, quindi, di unacomunione ideale che si concreta nell’attribuzione di somme dall’uno all’altro coniuge, a con-guaglio del valore dei beni che in essa ricadono. In tal senso cfr. F. Corsi, Il regime patrimo-niale della famiglia, I, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, 2a ed., Milano, 1984, p. 191.
12 Il regime della separazione dei beni è attenuato, nei Paesi ove lo stesso è previsto, dallapossibilità dell’assegnazione, in ipotesi di crisi coniugale, di un utilità economica (beni o crediti)da un coniuge all’altro ad opera del giudice sulla base di un giudizio di equità o in via auto-matica. Tale circostanza deriva dall’assunzione della presunzione che il coniuge meno abbienteabbia, comunque, contribuito alla formazione delle ricchezze altrui durante la vigenza del vin-colo matrimoniale. In tale eventualità nella ridistribuzione delle ricchezze familiari si terrà contodella durata del matrimonio, dell’apporto lavorativo realizzato dal coniuge da «beneficiare», del-l’entità degli incrementi patrimoniali in discussione. Al riguardo cfr. artt. 1400-1402 del codicecivile greco; art. 41 del codice civile della Catalogna; § 81 della legge sul matrimonio austriaca(Ehegesetz-EheG); Section 24 del Matrimonial Causes Act 1973, come modificato dal Matri-monial and Family Proceedings Act 1984 e dal Family Law Act 1996, in cui si prevede che ilgiudice inglese possa, in occasione di una crisi coniugale, provocare un meccanismo di ridistri-buzione delle ricchezze familiari a favore del coniuge piú debole, ossia possa procedere ad una«riallocation of property by issuing property adjustment orders upon divorce».
13 Si ricordi, come detto, che nella maggior parte degli ordinamenti di Common Law nonesiste la nozione di regime patrimoniale dalla famiglia, propriamente inteso, in quanto il vin-colo matrimoniale non incide sul regime proprietario e sulla distribuzione dei redditi tra co-niugi.
14 In pochi stati degli Stati Uniti d’America vige, come regime legale, quello della comu-
3. Nelle fonti comunitarie è assente la predisposizione di un regime pa-trimoniale primario della famiglia che, prescindendo da connotazioni po-litiche ed ideali dei singoli Stati, consenta di favorire la creazione di unambiente familiare in cui si affermino princípi di condivisione, solidarietàed assistenza reciproca. Anzi la Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea15, che proclama che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituireuna famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinanol’esercizio», sembra muoversi in senso inverso rispetto alla creazione diun tessuto normativo condiviso in materia. Un’eventuale opera di armo-nizzazione dei regimi patrimoniali della famiglia in campo europeo po-trebbe dar vita non solo a regole uniformi di diritto internazionale pri-vato in materia, ma anche ad un regime primario europeo in grado di fon-dare valori essenziali unanimemente condivisi, consentendo l’emersione diun sentire comune in un campo che presenta profonde connessioni tra di-ritto di famiglia e diritto patrimoniale propriamente detto.
Al riguardo riflessioni varie sul tema hanno dato vita ad un apposito«Libro verde»16 in tema di conflitto di leggi in materia di regime patri-moniale dei coniugi, competenza giurisdizionale e riconoscimento reci-proco delle decisioni17.
In particolare, tale Libro della Commissione europea, risalente al lu-glio 2006, si atteggia come atto di interpello per l’avvio di un’ampia con-sultazione pubblica sulle questioni giuridiche che sorgono a livello inter-nazionale in materia di regimi patrimoniali dei coniugi e di effetti patri-moniali delle altre forme di unione. Tale documento espone i vari aspettidella materia per i quali si ritiene necessario adottare una disciplina co-
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 171
nione degli acquisti, sopra illustrato. Si tratta, tra gli altri, degli stati del Texas, Arizona, Ca-lifornia, Nevada, New Mexico, Idaho e Lousiana.
15 Per la versione consolidata della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, v., daultimo, GUUE, 30 marzo 2010, c. 83.
16 «Il Libro verde. Sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, com-preso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco» (presentatodalla Commissione) [SEC(2006) 952], in http://eur-lex.europa.eu.
17 Cfr. anche lo studio prodromico alla presentazione di una normativa comunitaria in ma-teria di regimi patrimoniali tra coniugi e conviventi: Consortium Asser-Ucl, Analyse compa-rative des rapports nationaux et propositions d’harmonisation. Rapport final établi à l’intentionexclusive de la Commission Européenne. Etude sur les régimes matrimoniaux des couples ma-ries et sur le patrimoine des couples non maries dans le droit international prive et le droit in-terne des états membres de l’Union Européenne effectuée à la demande de la Commission Eu-ropéenne – Direction Générale Justice et Affaires Intérieures-Unité A3-Coopération Judiciaire enMatière Civile, in http://ec.europa.eu. Da tale studio si evince il favore verso un regime di co-munione differita avente ad oggetto gli incrementi conseguiti dal patrimonio di ciascuno dei co-niugi, ossia verso un regime che attribuisca a ciascun coniuge un diritto di credito al valoredella metà degli incrementi patrimoniali conseguiti dall’altro.
munitaria18, comprendendo anche il rapporto tra coppie non sposate le-gate da un «contratto registrato», ossia coppie che hanno registrato la lorounione davanti a un’autorità pubblica istituita dalla legge dello Stato mem-bro in cui risiedono. Il Libro nasce dalla constatazione di una maggioremobilità delle persone in uno spazio sprovvisto di frontiere interne, cir-costanza che si risolve, in particolare, in un aumento significativo delleunioni tra cittadini di Stati membri diversi o della presenza di coppie inuno Stato membro di cui non sono cittadini, cui spesso s’accompagna l’ac-quisizione di beni situati nel territorio di piú Stati dell’Unione19.
Oggetto di analisi nel Libro sono le norme di conflitto in tema di re-gime patrimoniale tra coniugi, prendendosi atto del rilievo in materia siadelle pronunce giudiziarie, sia della competenza delle autorità non giudi-ziarie, e degli atti da loro resi. Il Libro si sviluppa come sintesi di quesitivari sui temi illustrati e come invito agli interessati ad inviare risposte alledomande poste ad un indirizzo mail predisposto dalla Commissione eu-ropea. In tal modo il Libro diventa un tavolo di confronto tra diverseidee, da chiunque provenienti, al fine di avviare una riflessione sul tema,diventa cioè un documento dalle pagine bianche in cui si affida agli altrila possibilità di riempirle.
Il Libro, oltre a porre quesiti, su taluni aspetti assume anche interes-santi prese di posizione. Cosí in tema di responsabilità patrimoniale sitrova l’affermazione che, durante la vita in comune, i debiti derivanti daatti compiuti congiuntamente o singolarmente dai coniugi vadano impu-tati al loro patrimonio comune o individuale, al fine di ripartirne il caricotra loro e nei confronti dei terzi.
Il Libro affida ai soggetti interessati diversi quesiti: il quesito sulla pos-sibilità che i criteri di collegamento delle norme di conflitto possano es-sere unici per tutti gli aspetti dei regimi patrimoniali dei coniugi o pos-sano essere differenziati (ad es. per i beni immobili il criterio di collega-mento talvolta usato è la legge dello Stato in cui sono situati i beni); ilquesito se lo strumento normativo futuro possa incidere anche su aspettipersonali della vita di coppia, oltre su quelli patrimoniali; il quesito se og-
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi172
18 In materia si rammenti il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia ma-trimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il quale, però, non disciplina gli effetti pa-trimoniali dello scioglimento del matrimonio.
19 Da uno studio preliminare ordinato dalla Commissione nel 2002 è emerso che piú di 5milioni di stranieri, cittadini di uno Stato membro, vivevano in un altro Stato membro e chegli stranieri non cittadini dell’Unione europea che vivevano nell’Unione erano quasi 14 milioninel 2000. Stando allo studio, circa 2,5 milioni di immobili sono situati in Stati membri diversida quello in cui risiedono i coniugi che ne sono proprietari.
getto di regolamentazione possano essere aspetti del regime patrimonialetra coniugi insorgenti sia durante il vincolo matrimoniale, sia al suo scio-glimento; il quesito sul criterio di collegamento applicabile, ossia quellodella residenza abituale dei coniugi, della loro cittadinanza o altri ancóra;il quesito sui modi di applicazione dei criteri di collegamento previsti dallanorma di conflitto per il caso in cui si modifichino nel tempo20; il que-sito sulla possibilità di consentire ai coniugi di scegliere la legge applica-bile in materia di regimi patrimoniali e, in caso affermativo, in quale mo-mento e con quali formalità, nonché sulla possibilità di limitare tale pos-sibilità di scelta alla legislazione con cui esistano criteri di collegamentotali da manifestare un legame effettivo con la vita coniugale; il quesito sullapossibilità che il giudice chiamato a pronunciarsi su divorzio o separa-zione possa decidere anche sulle questioni relative al regime patrimoniale;il quesito sulla competenza in materia delle autorità non giudiziarie, inparticolare sulla possibilità che le coppie possano espletare alcune forma-lità presso le autorità dello Stato membro di residenza, anche se dallanorma di competenza principale sia stata designata un’autorità di un altroStato membro; il quesito sulla selezione di criteri uniformi per il ricono-scimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, nonché per il ricono-scimento degli atti emessi da autorità non giudiziarie; il quesito sulla se-lezione di un modo di pubblicità unitario dei regimi patrimoniali dei co-niugi nell’Unione, in modo da garantire la certezza del diritto per tutte leparti interessate, e esonerare i coniugi dall’obbligo di rinnovare le forma-lità pubblicitarie ogni volta che cambino residenza; il quesito sulla possi-bilità di estendere alle unioni registrate le norme di conflitto applicabili airegimi patrimoniali dei coniugi o di crearne diverse, nonché il quesito sullaselezione delle norme di conflitto applicabili in materia di unioni di fatto21.
Rimanendo in àmbito comunitario, si evidenzia che il regime patrimo-niale della famiglia resta escluso dal campo di applicazione della Conven-zione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giu-
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 173
20 La Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978, recante la disciplina sulla legislazione ap-plicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi (di cui in séguito), ad esempio, ammette il cambia-mento automatico della legge applicabile al regime patrimoniale dei coniugi quando questi cam-biano domicilio o cittadinanza (art. 7), salvo che i coniugi abbiano designato la legge applica-bile o stipulato un contratto di matrimonio. Gli effetti del cambiamento della legge applicabileal regime patrimoniale dei coniugi possono essere o meno retroattivi, a seconda delle soluzioninazionali.
21 Nel Libro verde si ritrova l’affermazione che, in linea di principio, in mancanza di normespecifiche si applichino alle unioni di fatto le norme di conflitto sui contratti (Convenzione diRoma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) e sulla responsabilità civileo, in generale, la legge del paese in cui si verifichi il danno.
risdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,che all’art. 1 contempla, tra le materie non oggetto di disciplina della me-desima convenzione, tra l’altro, il regime patrimoniale tra coniugi22.
Nell’àmbito degli interventi comunitari nella materia de quo assume ri-lievo anche la comunicazione del 16 marzo 2011 della Commissione alConsiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale euro-peo e al Comitato delle Regioni. In tale documento si manifesta l’esigenzadi eliminare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie inter-nazionali nell’insieme di un piú vasto programma rivolto alla creazione diuno spazio giudiziario europeo in grado di garantire la certezza del di-ritto ai cittadini europei e consentire loro di accedere facilmente alla giu-stizia nelle situazioni transnazionali. In particolare si intendono per cop-pie internazionali le coppie composte da cittadini di Stati membri diversio che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine23.
La stessa Commissione aveva riconosciuto già precedentemente, ossianella sua relazione sulla cittadinanza dell’Unione del 27 ottobre 2010, cheesistono ancóra numerosi ostacoli al pieno esercizio dei diritti connessi allacittadinanza dell’Unione, alla libera circolazione nello spazio europeo, etra questi ostacoli vi è l’incertezza in merito ai diritti patrimoniali dellecoppie internazionali. Si aggiunga che l’adozione di misure volte ad ar-monizzare le legislazioni nazionali o, comunque, a rendere certa la posi-zione dell’individuo con riguardo al suo status personale e familiare con-sentirebbe di agevolare la circolazione delle persone e, conseguentemente,la creazione del mercato interno di cui all’art. 26 del Trattato sul funzio-namento dell’Unione europea24.
Al fine di consentire obiettivi di certezza del diritto, la Commissione
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi174
22 La Corte di giustizia delle Comunità europee, con le sentenze del 27 marzo 1979 (C-143/78, de Cavel c. de Cavel, in Racc., 1979, p. 1055 ss.) e del 31 marzo 1982 (C-25/81 C.H.W.c. G.J.H., ivi, 1982, p. 1189 ss.), ha chiarito che la nozione di regime patrimoniale tra coniugidi cui all’art. 1 della Convenzione comprende non solo il regime dei beni contemplato specifi-camente dalle singole legislazioni nazionali, ma anche la disciplina di ogni rapporto patrimo-niale che derivi direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento dello stesso.
23 La Commissione europea nella comunicazione in oggetto stima che, su un totale ap-prossimativo di 122 milioni di matrimoni nell’Unione, 16 milioni circa (13%) hanno caratteretransnazionale; che nel 2007, circa 300.000 dei 2,4 milioni di matrimoni celebrati nell’Unionerientravano in questa categoria; che 140.000 dei 1.040.000 divorzi pronunciati nell’UE (13%) ri-guardavano coppie internazionali; che 8.500 unioni registrate internazionali si sono sciolte perseparazione personale e 1.266 per morte di un partner.
24 Cfr. la versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (pubbli-cata in GUCE, 9 maggio 2008, c. 115, e ripubblicata, da ultimo, ivi, 30 marzo 2010, c. 83),come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 (l. 2 agosto 2008, n. 130,in G.U., 8 agosto 2008, n. 185), in vigore dal 1 dicembre 2009.
nella sua comunicazione del 16 marzo 2011 immagina la formulazione didue proposte di regolamento del Consiglio, l’uno relativo alla competenza,alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni inmateria di regimi patrimoniali tra coniugi, l’altro relativo alla competenza,alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni inmateria di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
In particolare, nella proposta della Commissione relativa alle coppie co-niugate è lasciata ai coniugi la possibilità di scegliere la legge applicabile,limitando, però, l’àmbito di scelta ad ordinamenti con cui il matrimoniopresenti dei collegamenti, ossia alla legge della residenza abituale comuneo della cittadinanza. In mancanza di scelta, la proposta prevede un elencodi criteri di collegamento oggettivi che permettono di determinare la leggeapplicabile. Si consente, altresí, ai coniugi, in caso di trasferimento dellaresidenza abituale da uno Stato membro a un altro, di mutare, corri-spondentemente, la legge applicabile al loro regime patrimoniale.
Nell’ipotesi di un’unione registrata la proposta prevede che, stante lacircostanza che l’unione registrata non è riconosciuta da tutti gli Stati mem-bri dell’Unione, e che le disposizioni degli Stati membri che hanno in-trodotto questo istituto nel loro ordinamento giuridico variano notevol-mente, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni medesimesia quella dello Stato in cui l’unione è stata registrata.
Allo scopo di offrire ai terzi sistemi adeguàti di pubblicità sulla leggeapplicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ed effetti patri-moniali delle unioni registrate, si indica all’uopo il sito Internet della retegiudiziaria europea in materia civile e commerciale.
Infine, la Commissione propone, per rendere possibile una libera eduniforme circolazione delle decisioni all’interno dell’Unione, disposizionirivolte a consentire il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni mede-sime. In particolare, è previsto che le decisioni emesse in altro Stato mem-bro siano riconosciute in base a una procedura d’exequatur dinanzi al-l’autorità giurisdizionale dello stesso Stato in cui è chiesta l’esecuzione, inmodo da realizzare un controllo da parte delle autorità di quest’ultimoStato. La procedura si riassume in una verifica formale dei documenti pro-dotti dal richiedente, analogamente a quanto avviene attualmente in ma-teria civile e commerciale25.
Le due proposte esaminate, quindi, servirebbero ad integrare l’attualequadro normativo ed a garantire la coerenza richiesta nel territorio del-
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 175
25 Cfr. regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizio-nale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in G.U.,16 gennaio 2001, n. 12, p. 1).
l’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile, in particolare di di-ritto di famiglia, senza incidere sul diritto sostanziale degli Stati membrirelativo ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delleunioni registrate, diritto che, conformemente ai trattati, è di competenzanazionale.
Oltre le proposte normative e i progetti di cui si è detto, si segnalanocon riguardo al tema del diritto di famiglia nell’ambito del diritto comu-nitario, due strumenti di diritto internazionale privato, ossia il regolamento«Bruxelles II bis» del 27 novembre 200326 e il regolamento «Roma III»del 20 dicembre 201027. Si tratta di atti normativi rivolti alla riduzione de-gli ostacoli alla libera circolazione delle coppie c.d. «internazionali» e alperseguimento di obiettivi di certezza del diritto tali da consentire la pre-vedibilità, in base a criteri oggettivi, della legge applicabile e dell’autoritàgiurisdizionale competente.
Le norme del regolamento «Bruxelles II bis» individuano, in caso didivorzio o separazione di una coppia internazionale, l’autorità giurisdi-zionale competente a decidere, nonché disciplinano il modo in cui la de-cisione potrà circolare nell’àmbito dell’Unione ed essere riconosciuta edeseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa.
Il regolamento «Roma III» integra tali norme consentendo ai coniugidi scegliere la legge applicabile al procedimento di divorzio. Questo re-golamento è il frutto di una cooperazione rafforzata28 nel settore dellalegge applicabile al divorzio.
Comunque, nessuna disposizione dei regolamenti citati disciplina le que-stioni di diritto internazionale privato relative ai rapporti patrimoniali dellecoppie internazionali. Al riguardo, si può osservare che, come per il di-ritto sostanziale, anche le norme nazionali di diritto internazionale privatoapplicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi variano notevolmente da unoStato membro all’altro e ciò non garantisce sufficiente certezza per le cop-pie che decidano di esercitare il diritto di libera circolazione.
Dall’osservazione della realtà normativa comunitaria emerge, quindi,
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi176
26 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla com-petenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materiadi responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in G.U., 23 dicem-bre 2003, n. 338).
27 Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attua-zione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla sepa-razione personale (in G.U., 29 dicembre 2010, n. 343, p. 10).
28 Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata sono quattordici: Austria, Bel-gio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania,Slovenia, Spagna e Ungheria.
come gli obiettivi europei (perseguiti con progetti normativi e/o normepositive) siano piú modesti rispetto alla formazione di un ius comune nel-l’àmbito del diritto patrimoniale della famiglia. Si tratta della mera crea-zione di regole uniformi di diritto internazionale privato in materia di di-ritto di famiglia, senza che vi sia una reale volontà di incisione nel tessutodelle norme sostanziali. Tale circostanza deriva, probabilmente, dalla con-sapevolezza del legislatore comunitario delle notevoli differenze esistentinel sentire collettivo delle singole comunità nazionali in un settore, quellodel diritto della famiglia in generale, fortemente legato a convinzioni mo-rali, religiose e sociali, che rendono non percorribili soluzioni normativeuniformi.
Uscendo da un àmbito comunitario, si segnala come convenzione in-ternazionale nella materia in discussione la Convenzione dell’Aja del 14marzo 1978, recante la disciplina sulla legislazione applicabile ai regimi pa-trimoniali tra coniugi. Tale Convenzione (in vigore dal 1° settembre 1992),allo stato ratificata solo da Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, consente,entro certi limiti, la scelta da parte dei coniugi della legislazione applica-bile; in mancanza, vige la legislazione del paese in cui le parti hanno sta-bilito il loro luogo di residenza abituale dopo il matrimonio o la legisla-zione della loro nazionalità. Un cambiamento nelle circostanze (naziona-lità o luogo di residenza abituale) può pertanto dare luogo ad un muta-mento nella legislazione applicabile29.
4. Le osservazioni svolte inducono, ad avviso dello scrivente, due or-dini di riflessioni: la prima involge una valutazione circa l’attualità del re-gime di comunione legale tra coniugi, considerando il mutamento dei ca-ratteri socio-economici della nazione in circa quattro decadi di storia; laseconda riguarda la considerazione del fenomeno della regolamentazionedei rapporti patrimoniali tra coniugi come fenomeno interno ai confini na-zionali, intriso di valutazioni «domestiche» che riguardano la morale, lareligione e la storia e, in quanto tale, insuscettibile di essere oggetto di unasoluzione condivisa a livello sovranazionale.
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 177
29 La Corte di cassazione francese nella sentenza della prima sezione civile del 12 aprile 2012(10-27.016, n. 444 du 12 avril 2012) ha chiarito le modalità applicative degli articoli 4 e 8 dellaConvenzione dell’Aja del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile al regime patrimoniale tra co-niugi che prevedono, in mancanza di scelta, l’applicazione della legislazione della residenza abi-tuale. Al riguardo i giudici francesi, in un caso di due cittadini francesi che non avevano sceltola legge per regolare il regime patrimoniale e che avevano prima avuto la residenza negli StatiUniti e poi in Francia, hanno deciso che vada applicata la legge della residenza abituale, in par-ticolare che nel caso de quo vada separato il patrimonio ed applicato il diritto americano per ibeni acquisiti precedentemente al ritorno in patria e quello francese per gli altri.
Tale ultimo dato sembra trovare conferma, in àmbito comunitario, nellaprevisione, di cui all’art. 81, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’U-nione europea30, per cui il Consiglio delibera all’unanimità nell’adozionedelle misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazio-nali. La ratio di tale dettato è nella convinzione che, quando il legislatorecomunitario legifera su aspetti del diritto di famiglia, incide su princípifondamentali, costumi e tradizioni propri di ciascuno Stato membro31, ilche giustifica il potere di veto del singolo Stato. Appare, comunque, pre-vedibile che, in uno spazio come quello comunitario in cui i rapporti trale persone sono sempre piú frequenti, gli ordinamenti dei singoli Stati ver-ranno sempre piú influenzati dalle esperienze degli altri.
Le norme di diritto positivo nascono da una realtà storica e sociale alfine di far fronte ad esigenze sentite e condivise da una comunità nazio-nale e, in particolare, il regime patrimoniale tra coniugi è materia che pre-scinde da una mera valutazione economica in quanto ingloba anche, e pre-valentemente, interessi personali e familiari32. Si aggiunga che la storia delPaese ha registrato, dal tempo della riforma del diritto di famiglia ad oggi,enormi mutamenti nel vivere sociale e nel sentire collettivo. Premessoquanto detto, conseguenza necessitata di ciò dovrebbe essere la rivisita-zione di istituti che sono frutto di un vivere civile e di un sentire socialefortemente datato. Dimostrazione di ciò la si coglie anche dall’osserva-zione di altro istituto che nasce dal moto riformatore del 1975, il fondopatrimoniale. Infatti, il fondo patrimoniale, figlio riconosciuto del vecchiopatrimonio familiare, è istituto che ormai spesso trova applicazioni prati-che in situazioni che prescindono dalle esigenze di sostentamento delleesigenze della famiglia, che ne hanno condizionato la genesi, e che vienepiegato a finalità di dispersione del patrimonio del coniuge di fronte alleistanze dei creditori.
Istituti come quelli citati del fondo patrimoniale e della comunione le-gale rappresentano il frutto di una diversa realtà, di un’Italia in bianco e
Rassegna di diritto civile 1/2014 / Saggi178
30 Cfr. nota 24.31 Cfr. P. De Cesari, Principi e valori alla base della disciplina comunitaria in materia di
diritto di famiglia, in G. Pascuzzi (a cura di), La famiglia senza frontiere, Trento, 2006, p. 14.32 Cfr. E. Calò, Diritto internazionale privato, I, Regimi patrimoniali della famiglia nel
mondo, Milano, 2002, p. 14 s., in cui si evidenzia che la prevalenza dei caratteri personali ri-spetto a quelli patrimoniali nella regolamentazione del regime patrimoniale tra coniugi emergeanche dall’osservazione del sistema italiano di diritto internazionale privato ove, all’art. 30 dellal. 31 maggio 1995, n. 218, si dispone che la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugisia, in linea di principio, quella applicabile ai loro rapporti personali, con la conseguenza cheprevale quest’ultima anche se il collegamento piú stretto dei rapporti patrimoniali possa esserealtrove.
nero che non esiste piú, di un’Italia in cui sono cambiati attori, stili divita e realtà economica, per cui appare anacronistico il portato giuridicodi quella società.
Ferdinando Mancini
Abstract
I mutamenti della fisionomia della famiglia italiana e del sentire collettivo evi-denziano il venir meno del presupposto sociale che aveva giustificato l’avventodel regime comunitario nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Taleregime appare oggi inadeguato anche perché è regime vincolato che non lasciaspazi decisionali ai coniugi stessi, che non possono evitare l’automatica instaura-zione di una contitolarità sul singolo acquisto, e si pone, quindi, come limite difronte alle esigenze di un libero ed autonomo dispiegarsi dell’iniziativa econo-mica. L’osservazione della realtà legislativa degli altri Paesi, nella materia della di-sciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia, rappresenta un utile strumento diconfronto e di stimolo onde innescare un percorso di evoluzione ed innovazionenormativa anche nel nostro paese.
The transformations in the Italian family’s appearance and in the feelings ofthe people put in evidence the end of the social presupposition that justified thecoming of the community of goods in patrimonial law between husband andwife. Today the above law is inadequate because it is a bound regulations thatbind husband and wife, who can’t avoid the community of the single purchase,and so it is a limit to needs of the free and autonomous economic initiative. Theview of the other Countries’ legislation in the family patrimonial law representa useful instrument of comparison and stimulus to evolution and innovation inthe our legislation too.
Ferdinando Mancini / Regimi patrimoniali della famiglia 179