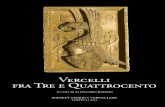Forme della legittimazione e aspirazioni dinastiche. Note sui regimi signorili dell'Italia...
Transcript of Forme della legittimazione e aspirazioni dinastiche. Note sui regimi signorili dell'Italia...
Forme della legittimazione e aspirazioni dinastiche. Note sui regimi
signorili dell’Italia nord-orientale (secoli XIII-XIV)
GIAN MARIA VARANINI*
Premessa È lapalissiano constatare che, perché si possa porre il problema di una rottura
dinastica e della sua legittimazione – o per meglio dire della legittimazione o ri-legit-timazione del potere esercitato dopo quel momento di rottura –, occorre innanzitutto che una dinastia si sia affermata, sia stata legittimamente riconosciuta, e veda messa in questione in un modo o in un altro la sua continuità. È quanto accade nelle diverse esperienze europee, che sono al centro della riflessione di questo convegno.
Ma per quanto riguarda l’Italia centro-settentrionale del Trecento, quantunque la storiografia italiana abbia a lungo adottato correntemente (in modo un po’ irriflesso) non solo il termine di “casata” o “famiglia” signorile, ma talvolta anche tout-court quello di “dinastia” signorile, quel dato di partenza non è affatto scontato; al contrario, la “dinastizzazione” e la trasmissione “automatica” del potere politico sono per i “regimi personali”1 così largamente diffusi nelle città italiane del tardo medioevo un traguardo agognato, che non è mai o quasi mai raggiunto una volta per tutte e consolidato in modo definitivo. E non lo sarà neppure nel Quattrocento: il momento della successione e della
* Gian Maria vaRanini (Pisa, 1950) és catedràtic d’història medieval a l’Università di Verona. Entre les seves obres destaquen: Il distretto veronese nel Quattrocento. Vicariati del comune di Verona e vicariati privati (Verona, 1980); Gli Scaligeri 1277-1387 (Verona, 1988); (ed. i comentaris) Marin Sanudo, L’Itinerario per la Terraferma veneziana del 1483 (Roma, 2014).
Il testo qui pubblicato riproduce, con poche integrazioni e con l’aggiunta delle note, la relazione letta al convegno. Nel tempo intercorso tra lo svolgimento del convegno di Balaguer del luglio 2012 e la pubblicazione di questi Atti, è stato pubblicato l’importante volume di Jean-Claude maiRe vigueuR (ed.), Signorie cittadine nell’Italia comunale, Viella, Roma, 2013, nel quale è compreso il saggio di Dario canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione e processo di dinastizzazione”, p. 439-464, dedicato a una tematica assai vicina a quella qui trattata. A questo saggio si fa in alcuni punti esplicito riferimento.
1 Per l’adozione di questa definizione, vedere qui sotto, nota 3 e testo corrispondente.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
172
trasmissione del potere continuerà ad essere – presso gli Sforza così come presso gli Estensi o i da Montefeltro – una congiuntura estremamente delicata.2
La cultura politica derivante dalla tradizione comunale della «civitas superiorem non recognoscens», infatti, e la consapevolezza del fatto che la legittimità del potere signorile affonda pur sempre le sue radici nella tradizione comunale, non perdono imme-diatamente di vigore e di consistenza nel momento nel quale – a partire dalla seconda metà del Duecento, ma con particolare diffusione nella prima metà del secolo successivo in molti centri urbani – si realizza il passaggio formale dal governo comunale al governo signorile, dal «regimen ad populum» al governo di uno solo. E ciò viene affermato con tanta maggior forza oggi, in un momento nel quale la contrapposizione netta tra “comune” e “signoria”, tra democrazia e tirannide, viene con forza contestata dalla storiografia, e si preferisce anzi usare il termine più generico e meno compromettente di “forme di governo personale” rispetto a quello tradizionalmente usato di “governo signorile”.3
Scopo di queste note è dunque quello di illustrare brevemente, per il “laboratorio italiano”, le lontane premesse di quei meccanismi di rottura/legittimazione che in Cata-logna o in Inghilterra o in altri regni europei sono effettivamente operanti nel corso del Trecento e del Quattrocento: per un verso la ricerca degli automatismi o delle garanzie dinastiche, per l’altro la legittimazione o ri-legittimazione dopo una usurpazione o una congiura all’interno della medesima casata, che deve continuare a gestire un “patrimonio simbolico” unitario e condiviso.
1. Ricerca della legittimazione (e dell’ereditarietà): legittimazione dal basso, legittimazione dall’alto. Il caso degli Estensi di Ferrara e degli Scaligeri di Verona tra Duecento e Trecento
Il problema della legittimazione del potere signorile, e quello connesso della sua trasmissione, è stato al centro della riflessione storiografica sulla signoria cittadina in Italia sin dai primi anni del Novecento : ma già in precedenza la storiografia tedesca se n’era occupata, con un saggio del celebre diplomatista Theodor von Sickel che in modo significativo si colloca proprio agli albori della storiografia scientifica sul me-
2 Per una narrazione évenémentielle molto precisa e affidabile, è ancora utile la vecchia compilazione di Luigi simeoni, Le signorie, Casa editrice dottor Francesco Vallardi, Milano, 1950, voll. I-II.
3 Questa scelta terminologica figura, ad esempio, in tre delle quattro relazioni-quadro che compongono la sezione I del volume Jean-Claude maiRe vigueuR (ed.), Signorie cittadine nell’Italia comunale, qui sopra citato: Paolo gRillo, “Signori, signorie ed esperienze di potere personale nell’Italia nord-occidentale [1250-1396]”, p. 19-44; Gian Maria VaRanini, “Esperienze di governo personale nelle città dell’Italia nord-orientale [secoli XIII-XIV]”, p. 45-76; Andrea zoRzi, “La diffusione delle forme di governo personale e signorile in Toscana”, p. 77-104.
GIAN MARIA VARANINI
173
dioevo europeo,4 e poi con un famoso studio di Salzer,5 prima ancora che in Italia si consolidasse la cosiddetta «scuola economico-giuridica». A lungo ha tenuto il campo la contrapposizione tra una legittimazione «dal basso», che riconosceva nella sovranità popolare e nell’arengo la fonte primigenia dell’autorità del dominus che riceve in tale sede l’arbitrium sugli statuti, e una legittimazione «dall’alto», mediante la concessione di un vicariato (imperiale o papale): in ogni caso, una concessione vitalizia e non ereditaria.
Secondo Francesco Ercole, il giurista e storico delle dottrine politiche che un se-colo fa impostò questo problema studiando in particolare le signorie venete del Trecento (gli Scaligeri di Verona, i Carraresi di Padova, i Caminesi di Treviso),6 la legittimazione «popolare» avrebbe prevalso in modo esclusivo nella prima fase delle vicende delle si-gnorie duecentesche e trecentesche dell’Italia nord-orientale (a quelle sopra menzionate va aggiunto il caso dei Bonacolsi di Mantova, al potere in quella città dal 1272 al 1329 quando furono soppiantati dai Gonzaga).
Per quello che concerne la legittimazione “dal basso”, è significativo il confronto tra le due signorie cittadine più precoci e più longeve dell’Italia duecentesca: gli Estensi di Ferrara e gli Scaligeri di Verona, che propongo in questo paragrafo. Gli Estensi erano signori della città dal 1240 (e lo sarebbero rimasti sino al 1598, quando dopo l’estinzione del ramo principale della casata i diritti sovrani su Ferrara tornarono alla Santa Sede, con la cosiddetta “devoluzione”); il primo ad affermare durevolmente e stabilmente la propria autorità sulla città fu Azzo VII, che vinse la “concorrenza” del leader del partito avverso, Salinguerra Torelli.7 È essenziale ricordare che Azzo VII era anche marchese della Marca Trevigiana e Anconitana: quanto alla trasmissione del potere ai successori, inserito com’era nella gerarchia ufficiale del potere pubblico, si trovava dunque in una posizione di grande vantaggio. Basterà ricordare al riguardo che il conseguimento del titolo di duca fu un traguardo che la maggiore “dinastia” signorile italiana, i Visconti, raggiunsero dopo un secolo di sforzi (nel 1395, con Gian Galeazzo Visconti),8 e che il titolo di marchese fu conseguito da Gian Francesco Gonzaga, signore di Mantova, negli
4 Theodor von sicKel, “Das Vikariat der Visconti”, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische klasse, 30 (Wien, 1859), 1, p. 3-90. Non va dimenticato che il 1859 è un anno importante per la formazione dello stato nazionale italiano: in quell’anno la seconda guerra d’indipendenza portò alla conquista della Lombardia da parte del regno di Sardegna.
5 Ernst J. salzeR, Über die Anfänge der Signorie in Oberitalien. Ein Beitrag zur italienischen Verfassungsgeschichte, Ebering, Berlin, 1900 (ristampa anastatica: Kraus, Vaduz, 1965).
6 Francesco eRcole, “Comuni e signori nel Veneto (Scaligeri Caminesi Carraresi)”, Dal comune al principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano, Francesco eRcole Vallecchi, Firenze, 1929; il saggio risale al 1909.
7 Anna Laura tRombetti budRiesi, “La signoria estense dalle origini ai primi del Trecento: forme di potere e strutture economico sociali”, Storia di Ferrara, V (Il basso medioevo), Corbo editore, Ferrara, 1987, p. 159-198; Andrea Castagnetti, Società e politica a Ferrara dall’età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII), Patron, Bologna, 1988.
8 Paolo gRillo, “Signori, signorie ed esperienze di potere personale…”, p. 41.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
174
anni Trenta del Quattrocento, oltre un secolo dopo che la sua famiglia aveva assunto il potere in città.9
Eppure, anche per gli Estensi il consolidamento di una tradizione “dinastica” in quanto signori di Ferrara fu tutt’altro che privo di ostacoli, di problemi, di rischi, no-nostante in partenza tutto sembrasse andare liscio. Nel 1262 Azzo VII d’Este convocò nella Cattedrale cittadina una curia vassallorum, che ne rinnovava una precedente del 1252: l’obiettivo era quello di manifestare attraverso l’esibizione dei vassalli la propria centralità, il proprio “capitale sociale” imperniato sui vincoli di fedeltà personale, per far avallare anticipatamente, dalla vassallità estense, la legittimazione del giovanissimo Obizzo II d’Este, nipote del signore e suo successore “designato”, quantunque fosse figlio illegittimo. Nella circostanza, si trattava di gestire non soltanto la successione nella carica di signore di Ferrara, quanto in generale tutti i beni e tutti i diritti della casa d’Este e la carica marchionale; e la cerimonia fu preparata con grande cura, nella piena consapevolezza del fatto che programmare una successione, creare un “precedente” dinastico, non era un’operazione né semplice né scontata. Pertanto, si previde minuta-mente nella stesura del testamento il fatto che Obizzo II sarebbe stato affidato al legato papale, all’arcivescovo di Ravenna e ai comuni guelfi. Ma al di là della documentazione ufficiale, conosciamo i retroscena di questo evento grazie all’attento racconto del cronista Riccobaldo da Ferrara, che mostra piena cognizione della situazione politica e degli orientamenti dei protagonisti. Il consiglio cittadino non è un attore passivo: vengono espressi dubbi sull’affidabilità di un dominus adolescente, sui comportamenti futuri del quale non v’è certezza. Il disincanto con il quale l’élite ferrarese guarda a questi eventi è espresso efficacemente dai pungenti giudizi raccolti da Riccobaldo: «Non debbono gioire gli avversari politici della famiglia estense: abbiamo questo adolescente, di buon carattere, che promette molto». «Se poi ci mancano i d’Este adatti a dominare, ci faremo un signore di paglia». «Acclamava la moltitudine presente, sic sic, ma non tutti i citta-dini lo facevano, bensì solo quelli che possedevano i beni degli esuli». Tutto procedette secondo le previsioni, dunque. Ma per quanto riguarda la legittimazione e i contraccolpi sull’ereditarietà della funzione signorile, a fare la differenza fu indiscutibilmente il fatto che gli Estensi erano sì i signori di Ferrara, ma erano anche una domus di marchesi, una casata dall’altissimo e indiscutibile prestigio aristocratico. Pertanto Obizzo II poté a tempo debito, alcuni decenni più tardi, riproporre come proemio degli statuti della città (1287) l’atto del 1264, e addirittura progettare gli eventi futuri: verum etiam post eius decessum heredem ipsius volumus in locum suum gubernatorem et rectorem et generalem dominum civitatis Ferrariae et districtus et habeat dominium et imperium et potestatem et iurisdictionem plenam sicut supra continetur in omnibus et per omnia.10
È però significativo che, nonostante questi elementi di facilitazione, in realtà anche a Ferrara gli avvicendamenti signorili, pur così attentamente preparati su queste basi,
9 Isabella LazzaRini, Fra un principe e altri stati: Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell’età di Ludovico Gonzaga, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma, 1996.
10 Anna Laura tRombetti budRiesi, “La signoria estense…”, p. 172-175, e p. 174 per le citazioni.
GIAN MARIA VARANINI
175
furono in più casi traumatici. Alla morte di Obizzo II, che non designò il proprio succes-sore come avrebbe potuto in forza del principio sopra affermato, fu eletto il primogenito Azzo VIII, e il figlio minore Aldobrandino si oppose duramente alleandosi con Padova e aprendo una seria crisi dinastico-familiare. E anche alla morte di Azzo VIII, nel 1308, l’aver forzato la situazione a vantaggio di Folco figlio dell’illegittimo Fresco determinò in ultima analisi la crisi con Venezia, una dura guerra e per qualche anno l’interruzione del dominio estense su Ferrara, la sottomissione al papa nel 1310 e il dominio angioino (sostenuto dai mercenari catalani).
Non meno interessante è il caso degli Scaligeri di Verona, che mantennero ininter-rottamente il potere in Verona dal 1260 al 1387. È essenziale osservare che in questo caso il punto di partenza fu diametralmente opposto a quello degli Estensi. Dal punto di vista della tradizione familiare, i della Scala non avevano carte da giocare: la loro era una famiglia di tradizione cittadina, non aristocratica, neppure troppo in vista in età comunale. Tutte le loro possibilità di legittimazione dovevano essere giocate sul piano delle istituzioni comunali, che a partire dal 1277 – quando Mastino I della Scala, che aveva gestito il potere in città in modo informale, da primus inter pares, fu ucciso da un avversario politico – conferirono ad Alberto I della Scala, che in precedenza aveva rico-perto (d’intesa col fratello) anche la carica di capitano del popolo e di podestà perpetuo della Domus mercatorum (dunque la più importante carica politica e la più importante carica economica previste dalla costituzione cittadina), l’arbitrium sugli statuti cittadini. Il consenso reale riconosciuto dalla società veronese ad Alberto I, che restò al potere per un quarto di secolo (1277-1301), fu ininterrotto e indiscusso, e sicuramente non meno efficace rispetto al potere degli Estensi a Ferrara. E Alberto I non mancò di svolgere una politica di annobilimento familiare, perseguendo una politica matrimoniale che lo portò a imparentarsi con i discendenti dell’imperatore Federico II. Ma per quanto riguarda il meccanismo di trasmissione del potere, consapevole del fatto che la sua legittimità derivava solo ed esclusivamente dal consenso della società cittadina, il capitano del popolo di Verona si mosse con estrema accortezza e con estrema prudenza, escogitando per primo tra i signori italiani l’espediente dell’affiancamento al potere da parte del figlio designato come successore, coinvolto anch’esso nella “fiducia” conferita dalle istituzioni cittadine. A partire dal 1290 infatti Bartolomeo della Scala, il primogenito di Alberto I, figura a fianco del padre come capitaneus penes se, una sorta di apprendista signore. Il meccanismo si riproduce anche nel primo decennio del Trecento, al momento dell’avvi-cendamento tra Bartolomeo (che fu signore soltanto per tre anni, dal 1301 al 1304) e i fratelli minori, Alboino e Cangrande I.11
11 Per una esposizione degli eventi Gian Maria vaRanini, “Istituzioni, società e politica nel Veneto dal comune alla signoria (secolo XIII-1329)”, Il Veneto nel medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, Andrea castagnetti, Gian Maria vaRanini (eds.), Banca Popolare di Verona, Verona, 1991, p. 379-382; Gian Maria VaRanini, “Della Scala, Alberto”, Dizionario biografico degli italiani, 37, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, p. 369; Gian Maria VaRanini, “Della Scala, Bartolomeo”, Dizionario biografico degli italiani, 37, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1989, p. 382.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
176
Come è noto, quest’ultimo fu vicario imperiale durante la spedizione italiana di Enrico VII di Lussemburgo (1310-1314), e poi nuovamente ottenne il vicariato impe-riale anche da Ludovico IV il Bavaro nel 1328: aspirò dunque anch’egli, come tutti i domini civitatis contemporanei, a una legittimazione “dall’alto” della propria autorità di signore, una legittimazione che prescindesse anche formalmente dal consenso delle istituzioni comunali; e anche i suoi successori cercarono ed ottennero la carica di vicari (Mastino II della Scala fu per qualche tempo vicario pontificio, negli anni Trenta).12 Si trattò in ogni caso, nonostante non siano mancati i tentativi di considerare ereditaria la concessione della funzione vicariale, di cariche vitalizie. Ma è importante osservare che – con particolarità che qui non è possibile illustrare, e corredato naturalmente dalle prevedibili eliminazioni violente di possibili rivali – il meccanismo del coinvolgimento di più successori funziona anche nella prima metà del Trecento, e soprattutto fu rispet-tata in tutti i casi la forma tradizionale della concessione dell’arbitrium al signore da parte del consiglio maggiore o dell’arengo. Gli avvicendamenti signorili, nel caso della signoria scaligera, sono un evento di delicatezza eccezionale, da “allarme rosso”, proprio perché da parte dei signori e del loro entourage c’è la netta percezione della persistente importanza del “riconoscimento” da parte dell’assemblea comunale.
Si badi: gli Scaligeri sono forse la famiglia signorile che, tra tutte quelle italiane, godette forse del consenso più pieno e indiscutibile da parte delle élites della propria città d’origine. Ancora alla metà del Trecento, il notaio e cronista visconteo Pietro Azario osservava con vero stupore omnes de Verona sunt de la Scala, abituato com’era alle lotte di fazione che devastavano le città lombarde. Eppure, nessun automatismo si afferma nella trasmissione del potere da un signore all’altro, tanto è forte, sul piano della cultura politica, la stigmata “comunale”, cittadina dell’origine di quel potere. I comportamenti concreti dei signori, la costante drammaticità e concitazione delle circostanze nelle quali il potere passa da uno Scaligero all’altro provano in modo quanto sopra in modo indiscutibile. Nel 1311, quando apprende della morte del fratello e co-signore Alboino della Scala, Cangrande I si trova a Genova, insieme con il re dei romani Enrico di Lussemburgo: ma abbandona precipitosamente la città ligure e accorre a Verona, conscio dei rischi che una sua assenza al momento del trapasso avrebbe potuto determinare. Allo stesso modo, quando tocca a Cangrande di passare a miglior vita (il 22 luglio 1329, nella città di Treviso appena conquistata), il suo cadavere è trasportato a tempo di record in Verona, con una marcia notturna a tappe forzate, perché possa con la sua presenza cerimoniale – addobbato regalmente – facilitare la concessione dell’arbitrium che l’arengo cittadino si apprestava a conferire ad Alberto II e Mastino II. Eppure, Cangrande I al momento della morte era all’apice del potere e del prestigio. Non solo era vicario imperiale, ma appena un anno prima, con l’esibizione della sua magnificentia e della sua munificentia aveva quasi umiliato lo stesso imperatore Ludovico IV il Bavaro, in occasione della sua
12 Aggiornamenti su Mastino II della Scala in Gian Maria vaRanini, “Immagini di Mastino II della Scala nei testi cronistici trecenteschi”, L’arca di Mastino II. Storia fortuna e conservazione del monumento scaligero, Maristella veccHiato (ed.), La Grafica, Vago di Lavagno (Verona, 2005), p. 9-28.
GIAN MARIA VARANINI
177
incoronazione a Milano. Ma chi è incaricato di redigere il verbale della riunione degli organismi collegiali del comune di Verona (il consiglio degli anziani e dei gastaldioni delle arti, e il consiglio minore del comune) che a fine luglio 1329, dopo il funerale del defunto signore, conferisce l’arbitrio ai due giovani nipoti, si premura di annotare che il signore morente aveva dato mandato a un suo stretto collaboratore di sollecitare presso il podestà del comune la procedura, che seguì pertanto un iter regolarissimo, conforme agli statuti. Il podestà infatti propone e requirit consilium, dopodiché si delibera di nominare Alberto II e Mastino II generales capitanei, rectores et domini comuni et populi civitatis et districtus Verone imperpetuum, menzionando i predecessores sui vale a dire Alberto I e i suoi figli Bartolomeo I, Alboino e appunto Cangrande I che si erano succeduti nel reggimento.
Invero, quando nel 1359 morì Cangrande II della Scala (che nel 1351 era succe-duto, insieme con i fratelli Cansignorio e Paolo Alboino, al padre Mastino II, rimasto al potere dal 1329 al 1351), compare per la prima volta nella documentazione concernente questa signoria la menzione del principio ereditario: alla morte di Cangrande II uno statuto recita infatti «stabiliamo e ordiniamo che i nobili e magnifici signori Cansignorio e Paolo Alboino della Scala e ciascuno di essi in solido per sé e per i propri eredi siano in perpetuo e in perpetuo siano considerati liberi e generali signori». Ma nonostante questo, l’esigenza di riferirsi a una qualche forma di “volontà”, o meglio di “ratifica” popolare dell’avvicendamento signorile, pur imposto con la forza, resta insopprimibile presso gli Scaligeri. Pochi giorni dopo in effetti Cansignorio della Scala e Paolo Alboino ricevettero nuovamente l’arbitrium dall’assemblea cittadina, e furono i cives a conferire ai signori l’autorità indiscriminata sugli statuti (arbitrium) e il merum et mixtum imperium.13
E lo stesso accadde 15 anni più tardi, all’avvicendamento successivo. Lo prova l’efficacissima narrazione di Conforto da Costozza: si tratta di un cronista di Vicenza, la sola città che a partire dal 1342 era rimasta insieme con Verona soggetta agli Scaligeri, dopo che Cangrande I aveva allargato i confini della dominazione scaligera all’intero territorio della Marca Trevigiana (entro il 1329), e dopo la fulminea espansione degli anni Trenta (dominante Mastino II della Scala) e la successiva crisi. Gli eventi raccon-tati da Conforto da Costozza si riferiscono al 1375, quando Cansignorio della Scala (al potere dal 1359), in punto di morte, fece uccidere il fratello Paolo Alboino della Scala (incarcerato già a partire dal 1365) e impose come propri successori i figli illegittimi Bartolomeo e Antonio della Scala.
Die lune XV octobris, summo mane, curialiter detempti fuerunt ultra LXXX ex melioribus civibus Vincentie, de quorum numero fui unus, in palatio comunis in quodam camino, ubi frequenter comedit potestas, ubi territi, ignorantes causam, steterunt usque ad
13 Aggiornamento bibliografico su Cansignorio della Scala in Gian Maria VaRanini, “Cansignorio della Scala: profilo di un signore del Trecento”, L’intervento di conservazione, restauro e valorizzazione dell’arca di Cansignorio della Scala a Verona, Ettore napione (ed.), Ministero per i Beni e le attività culturali-Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto-Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Verona, 2011, p. 22-38.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
178
horam terciarum, qua intraverunt ad eos dominus potestas, capitaneus et Gilinus tercius cum litteris Domini, de ipsius Domini gravi egritudine inter cetera specialem memoriam facientes et quod mandabat quod per maius consilium et populum vincentinum ipse et adolescentes filii sui Bartholomeus et Anthonius fratres crearentur in Dominos civitatis et districtus in solidum generales et quod, si contingeret ipsum ex humanis rebus ad me-liorem vitam transire, ipsi fratres deberent equaliter dominari. Quare omnes suprascripti cives descripti per nomina iuraverunt sacramento fidelitatem in manibus supradictorum trium rectorum pro Dominis antedictis, statimque pulsato consilio eoque coadunato et generali populi multitudine per generalem reformacionem creati fuerunt domini memorati in solidum, ut premissum est, in Dominos generales traditumque fuit dominium et vexi-lum populi per virum nobilem Iohannem Petrum de Protis, ad hec per ipsum consilium specialiter constitutum, ubi etiam omnes singulariter descripti iuraverunt fidelitatem in manibus sepedictorum trium ut supra.
Abbiamo dunque in successione l’imprigionamento di un gruppo informale di citta-dini maggiorenti; l’ordine del signore in carica, morente, che prevede un atto formale da parte del consiglio maggiore e del popolo; il giuramento e poi la riunione del consiglio. L’espediente adottato è quello consueto: collegialità signorile, perché è anche il signore stesso che chiede di essere creato dominus civitatis insieme coi due figli adolescenti (e ancora una volta illegittimi).14
Un’ultima prova, estremamente significativa a mio avviso, conferma in modo de-finitivo l’estrema difficoltà, per una signoria dalle indelebili stigmate “popolari” come quella scaligera, nata dal cuore stesso delle istituzioni comunali, di consolidare un principio “dinastico”. Due congiure particolarmente importanti scandirono, a distanza di un settantennio, la vicenda della signoria veronese. Nel 1277, proprio alle origini della parabola della “dinastia”, Mastino (I) della Scala fu ucciso, nei pressi del palazzo comunale. Nel 1354, un figlio illegittimo di Mastino II, Fregnano della Scala, sfruttando il malcontento di un certo numero di famiglie importanti dell’entourage signorile, ordì una trama contro il fratellastro e signore Cangrande II (figlio legittimo del citato Mastino II, e in quel momento al potere anche per conto dei giovani fratelli Cansignorio e Paolo Alboino), prese il potere in città per alcuni giorni, ma fu alla fine catturato e ucciso. Secondo una pratica piuttosto diffusa nella vita politica italiana, tanto nel 1277 quanto nel 1354 il potere signorile decise di immortalare le immagini dei traditori facendoli ritrarre – si presume impiccati –. Orbene, quale fu il luogo nel quale questa operazione, risarcitoria del bene comune e infamante per la memoria dei congiurati, fu realizzata? Ove furono dipinte le immagini di chi aveva osato assassinare il leader della famiglia della Scala, Mastino I, ovvero di chi aveva tramato contro il signore legittimo? Non in
14 Valorizzò questo passaggio, per primo, Girolamo ARnaldi, “Realtà e coscienza cittadine nella testimonianza degli storici e cronisti vicentini dei secoli XIII e XIV”, Giorgio cRacco (ed.), Storia di Vicenza, 3 (L’età medievale), Neri Pozza editore, (Vicenza, 1988), p. 306. Sulla cronaca di Conforto da Costozza, Marino zabbia, I notai e la cronachistica cittadina italiana del Trecento, Istituto storico italiano per il medioevo, Roma, 1999, p. 77-84, a p. 78-79.
GIAN MARIA VARANINI
179
piazza, o in un altro luogo pubblico ed aperto: bensì nella sala del palazzo comunale; e nel 1354 si scelse, appunto di dipingere le pitture infamanti sulla parete di fronte a quella che ancora ospitava le immagini dipinte nel 1277.15
In conclusione, il problema della dinastizzazione o della rottura dinastica si pone, almeno per alcune famiglie signorili italiane, sullo sfondo di un rapporto costante, sempre aperto, e non eliminabile con le istituzioni cittadine.
2.Le signorie cittadine di Treviso e Mantova fra Duecento e Trecento Mi sono soffermato sui casi degli Estensi e degli Scaligeri, e dunque su due re-
gimi signorili particolarmente longevi, perché il “fattore tempo”, la durata, è un dato essenziale, se si vuol anche semplicemente porre – come è negli intenti, eminentemente comparativi, di questo incontro di studio – il problema di una possibile dinastizzazione, e in prospettiva di una sua rottura. Ma al di là dei due casi sopra rapidamente esaminati, e dell’esempio visconteo (per il quale rinvio al contributo di Marco Gentile, compreso in questo stesso volume), gli esempi disponibili nell’Italia centro-settentrionale del Tre-cento e del primo Quattrocento non sono molti. E lo conferma un recente importante volume, che ha fatto il punto sul problema storiografico della signoria cittadina nell’Italia dei secoli XIII-XV, contestando la definizione stessa di “signoria” e la sua implicita “stabilità (tendenzialmente) dinastica”, insita nell’aggettivazione (“signoria scaligera”, “signoria estense”, “signoria viscontea”, e così via). Come si è detto all’inizio, è stata infatti proposta, efficacemente, l’adozione del termine più neutro e meno impegnativo “governo personale”. Questa definizione più generica e onnicomprensiva, priva di con-notazioni o di echi giuridici, si attaglia molto bene alla estrema varietà di situazioni che caratterizzano a partire dalla fine del Duecento tutta l’Italia centro-settentrionale, conducendola alle profonde trasformazioni della carta politica e territoriale, che si pos-sono facilmente constatare all’altezza cronologica della prima metà del Quattrocento e della pace di Lodi (1453).
È evidente che quanto or ora accennato riduce ancora i termini di confronto pos-sibili tra Italia ed Europa occidentale a proposito di Ruptura dinàstica y legitimacion, e configura il “caso italiano” come un’anomalia ancora più accentuata. Proprio per questo, tuttavia, è importante analizzare alcuni altri casi significativi, anch’essi concernenti città dell’Italia nord-orientale. Esamineremo pertanto sotto il profilo dei meccanismi di suc-cessione e della “possibile” ereditarietà i case-studies dei Caminesi signori di Treviso, dei Bonacolsi e Gonzaga al potere in Mantova, e infine dei da Carrara signori di Padova.
15 Per ambedue gli episodi citati cfr. Gian Maria vaRanini, “La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354)”, Studi storici Luigi Simeoni, XXXIV (Verona, 1984), p. 64-66. Per la pittura infamante in generale, Gherardo oRtalli, “…pingatur in palatio…”. La pittura infamante nei secoli XIII-XVI, Jouvence, Roma, 1979.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
180
La signoria sulla città veneta di Treviso, esercitata da alcuni esponenti di una grande casata aristocratica, solidamente radicata nel territorio prealpino e alpino, durò appena un trentennio, dal 1283 al 1314. In questo trentennio si colloca, nel 1306, l’avvicenda-mento tra Gherardo da Camino, capitano di Treviso, che godeva di altissimo prestigio e di grande popolarità, e il figlio Rizzardo. La casata dei da Camino è una delle magne et excellentes domus della Marca Trevigiana secondo la definizione del cronista Rolandino da Padova; e non sorprende che ancor prima di succedere al padre il giovane Rizzardo «avesse ottenuto dai cittadini di Treviso il medesimo titolo di capitano» (1301), e sin dal 1303 agisse non solo ex vigore sui arbitrii generalis, ma anche ex bailia sibi data et concessa ab egregio viro domino Gerardo de Camino eius patre et per comune Tarvisii. In queste condizioni, il problema della trasmissione del potere dal padre al figlio non si pone; e anzi alcuni anni più tardi, nel 1314, testimoniando in un celebre processo nel quale si discusse del “concetto” di tirannide, il giudice trevigiano Pietro de Arpo ricordò che egli stesso aveva confezionato il documento in base al quale il nuovo capitano di Treviso, Rizzardo da Camino, aveva giurato nel palazzo comunale:
interfuit una cum certis sapientibus ad dictandum statutum et instrumentum capita-narie… et (dominus Riçardus) fuit factus capitaneus dicte civitatis et districtus… et vidit dictum dominum Riçardum iurantem dictam capitanariam in palacio comunis Tervisii in plena concione… Dictus dominus Riçardus ipsam civitatem et districtum rexit tyranico modo et tanquam tyranus per dictum tempus septem annorum vel incirca, et plus efficie-batur tyranus tempore mortis sue quam fuerat dominus Gerardus pater eius.
Secondo un altro testimone, il giudice Rolandino de França, nel documento in questione
continebatur inter cetera quod de voluntate patris sui domini Gerardi homines Tervisii elligebant et faciebant dictum dominum Riçardum capitaneum generalem civitatis Tervisii et districtus, sicut erat ipse dominus Gerardus, ut capitaneus esset deberet post mortem ipsius… Eam civitatem et districtum [Riçardus] rexit… ad suum beneplacitum et volunta-tem et magis tyranico more quam pater fecerat per septem annos et plures… faciens ipse dominus Riçardus ultra iusticiam et contra fieri condempnaciones et processus, et quas et quos volebat pro suo libito voluntatis faciendo cancelari et exigi, et homines interfici et clam et furtive, sina causa, cognitione et sine iusticia…..
Infine, il notaio Iacopo de Arpo testimoniò che
ante mortem ipsius domini Gerardi dominus Riçardus eius filius fuit factus capitaneus generalis civitatis Tervisii et districtus et Paulus de Richardo notarius fecit instrumentum dicte capitanerie in palacio minori comunis Tervisii in arrengo publico ad sonum campa-narum, presentibus… pluribus trecentis hominibus civitatis Tervisii.
GIAN MARIA VARANINI
181
La pienezza illimitata dei poteri e del padre e del figlio è dunque indiscutibile; e si aggiunga che nei brevi anni del suo reggimento, Rizzardo da Camino ottenne anche la legittimazione “dall’alto” della sua autorità di capitano, conseguendo da Enrico VII (grazie a un cospicuo esborso in denaro) il titolo di vicario imperiale. Ma in nessun modo venne messa in questione la modalità della successione, e il fatto che essa avvenga mediante le istituzioni comunali viene percepito come un dato assolutamente scontato e fisiologico.16
Per quello che riguarda Mantova, i Bonacolsi, signori della città sin dal 1272, si uniformarono agli schemi elaborati dalla signoria scaligera, retta nella seconda metà del Duecento da Alberto I della Scala (che mantenne del resto, con la dinastia amica, una colleganza strettissima). La pratica della associazione al potere fu applicata due volte. Dapprima, già verso la fine degli anni Ottanta del Duecento, Pinamonte Bonacolsi (il fondatore della signoria) cooptò il figlio Tagino; ma nel 1291 Bardellone Bonacolsi depose entrambi. Nel 1308 poi fu la volta di Guido (detto Botticella) Bonacolsi, che con l’ap-provazione del consiglio cittadino associò al potere il fratello Passerino.17 Il successivo passaggio fu la concessione da parte di Enrico VII del vicariato imperiale, evidentemente non ereditario, che si venne anche in questo caso ad affiancare alla legittimazione dal basso: lo statuto cittadino infatti affermava che l’arbitrium concesso a Passerino e Bu-tirone Bonacolsi era stato riconosciuto loro per serenissimum dominum Henricum olim imperatorem et ex forma statutorum comunis Mantue et per comune Mantue.18 Ma quando nel 1328 si verificò l’avvicendamento tra Passerino Bonacolsi e Luigi Gonzaga, si tornò anche in questo caso a una mera legittimazione comunale e cittadina. Infatti il comune di Mantova approvò uno statuto de capitaneatu magnifici domini Loysii de Gonzaga comunis et populi Mantue capitanei generali, che prevedeva la possibilità di allium seu allios penes se in vita sua et post decessum eius eciam in locum suum capitaneum vel capitaneos elligere, instituere, constituere et substinere et ordinare.19
Nella seconda metà del Trecento, e nei primi decenni del secolo successivo, la signoria gonzaghesca su Mantova si manifestò come una delle più stabili: la famiglia arrivò a “identificarsi” con la città, e non si manifestarono quelle inquietudini e quelle
16 Per quanto sopra, resta valida la monografia di Giovanni Battista picotti, I Caminesi e la loro signoria in Treviso dal 1283 al 1312. Appunti storici, Tipografia di Raff. Giusti, Livorno, 1905 (ristampa anastatica Multigrafica editrice, Roma, 1975 [aggiornamento e documentazione fotografica a cura di Giovanni netto]), p. 169-171 e p. 303 ss. (doc. LIV) per l’edizione parziale della fonte documentaria, nota come “processo Avogari”. Questo importantissimo dossier processuale è stato integralmente edito in Giampaolo cagnin (ed.), Il processo Avogari (Treviso, 1314-1315), ed. Viella, Roma, 1999, con un saggio introduttivo di Diego Quaglioni (“Il processo Avogari e la dottrina medievale della tirannide”, p. V-XXIX).
17 Richiama questi eventi Pietro toRelli, “Capitanato del popolo e vicariato imperiale come elementi costitutivi della signoria bonacolsiana”, in Pietro toRelli, Scritti di storia del diritto italiano, Giuffré, Milano, 1959, p. 375-480; il saggio risale al 1921-23 (Atti e memorie della r. Accademia virgiliana di Mantova, n.s., XIV-XVI, 1921-23).
18 Francesco ERcole, “Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (secc. XIV-XV)”, in Francesco eRcole, Dal comune al principato…, p. 299 nota 1.
19 Pietro toRelli, “Capitanato del popolo…”, p. 461; puntuale ricostruzione in Dario canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione…”, p. 451, dal quale riprendo anche la citazione.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
182
rivolte che scossero ad esempio la signoria estense a Ferrara, negli anni Ottanta.20 Ma neppure in questo caso si giunse alla definizione di meccanismi di successione paci-ficamente riconosciuti, e l’assassinio politico e l’intrigo furono ripetutamente praticati. Come le altre signorie, i Gonzaga chiesero e ottennero dall’imperatore (in quel momento Carlo IV di Boemia) la legittimazione in quanto vicari imperiali, ma neppure questa carica poté garantire nulla. Emblematicamente, anzi, nel 1360, al momento dell’insigno-rimento di Guido Gonzaga il consiglio degli anziani del comune di Mantova recuperò deliberatamente la consuetudine istituzionale ormai quasi secolare della designazione di un capitano e signore: secondo quanto si osserva in quel momento, esso viene eletto a longis et longissimis temporibus citra, qui fere attingunt ad nonaginta annos continue. E in base a questo principio, fu ancora il consiglio ristretto del comune ad assumere l’iniziativa e a proporre al consiglio generale la nomina di Guido come capitano del po-polo.21 Dovevano passare ancora settant’anni, all’incirca, prima che i Gonzaga ottenessero dall’imperatore la carica marchionale, e grazie ad essa – nell’ambito della gerarchia del potere pubblico “imperiale” – regole almeno in via di principio più certe per la suc-cessione. Ma ancora nel 1430, pochissimi anni prima del conseguimento dell’agognato titolo, Gianfrancesco, il futuro «primo marchese», consultò informalmente i maggiorenti della popolazione cittadina in un famoso referendum conoscitivo, per acquisire pareri a proposito del governo della cosa pubblica.22
3.Padova carrarese nel TrecentoÈ degno di particolare interesse, infine, il caso di Padova, particolarmente ben
studiato negli anni recenti.23 Sino al secondo decennio del Trecento, la città era stata l’orgoglioso campione della democrazia comunale, rivendicando con grande enfasi cul-turale, grazie a intellettuali influenti come Albertino Mussato, la propria autonomia e libertas. Ma le discordie tra le grandi casate aristocratiche covavano sotto la cenere e il sistema politico padovano non resse allo stress politico-militare posto in essere dall’attacco di Cangrande I della Scala e dello schieramento politico e militare da lui coordinato. L’origine dell’autorità signorile dei da Carrara, a partire dall’arbitrium concesso a Iacopo da Carrara nel 1318, non è dunque paragonabile a quella fisiologica evoluzione che si riscontra a Verona; essa va al contrario concepita come l’affidarsi di una città disperata e discorde a un leader politicamente e militarmente autorevole, ma culturalmente estraneo
20 John Easton laW, “Popular Unrest in Ferrara in 1385”, The Renaissance in Ferrara and its European Horizons/Il Rinascimento a Ferrara e i suoi orizzonti europei, June salmons, Walter MoRetti (eds.), University of Wales Press- Mario Lapucci edizioni del Girasole, Ferrara, 1984, p. 41-60.
21 Pietro toRelli “Capitanato del popolo…”, p. 463, riportato anche da canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione…”, p. 451.
22 Maria Antonietta gRignani et al., Mantova 1430. Pareri a Gianfrancesco Gonzaga per il governo, Arcari, Mantova, 1990.
23 Seguo in particolare Silvana collodo, “I Carraresi a Padova: signoria e storia della civiltà cittadina”, Padova carrarese, Oddone longo (ed.), il Poligrafo, Padova, 2005, p. 19-48. Ma anche Dario canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione…”, p. 450, 452-454.
GIAN MARIA VARANINI
183
alla città e portatore, almeno alle origini, della “cultura politica” tipica dell’aristocrazia rurale che vive nei castelli del contado piuttosto che non in città.
Senza che vi sia alcun vulnus apparente al quadro costituzionale vigente, Iacopo da Carrara si vede attribuita nel 1318, dal consiglio cittadino che lo nomina capitano generale, una gamma di poteri molto ampia: oltre all’arbitrium sullo statuto, in materia di giustizia, di fiscalità, di patrimonio comunale, di nomina degli officiali del comune e di tutela sull’annona e sull’Università24. Gli avvicendamenti signorili, che si susseguirono numerosi nel corso del Trecento, furono spesso segnati dalla violenza e dall’assassinio politico. Ma in nessun caso mancò un “passaggio” in consiglio comunale; l’organo col-legiale ratificò sempre la presa di possesso da parte del nuovo signore.
Particolarmente interessante, come è stato di recente osservato, è l’episodio del 1350: al momento della presa di potere in sostituzione del padre Iacopo II, anch’egli assassinato, Francesco I da Carrara (poi detto Francesco il Vecchio), promosse la re-dazione di uno statuto che a quanto consta ha un solo precedente, quello dello statuto che aveva normato il conferimento della signoria a Iacopo I, nel 1318, proprio agli inizi dell’esperienza signorile carrarese.25 «Analogamente a quanto visto per Verona, dunque, lo statuto, risalente al 1351, può essere considerato una sorta di rifondazione della signoria padovana»,26 e segna uno scarto rispetto al tormentato decennio precedente quando si erano in breve tempo avvicendati Ubertino da Carrara, Marsilietto Papafava e Iacopo II. Non stupisce che questa normativa si guardi bene dal fare cenno alla successione.27
Anche nella seconda metà del Trecento, anche dopo che i signori di Padova avevano ottenuto la legittimazione imperiale con la concessione del titolo di vicario, anche dopo che «l’antico istituto di rappresentanza dei cittadini è stato pesantemente depotenziato dalla signoria», neanche allora «la supremazia del signore non riuscì mai a dissolverne del tutto l’impronta di legale depositario del diritto della comunità politica». Il consiglio resta in qualche modo un organo di legittimazione dei “dinasti”, e per esempio traduce nelle forme della tradizione comunale le loro iniziative normative: i decreti signorili vengono riscritti in forma di statuto e inseriti nel libro degli statuti cittadini. Al contra-rio una sapiente politica culturale condusse, negli anni più felici e vivi dell’esperienza signorile carrarese, quelli del reggimento di Francesco il Vecchio da Carrara (tra i primi anni Cinquanta e il 1388), a una identificazione molto stretta tra il signore carrarese, che si presenta come pater patriae, e la città.
24 Silvana collodo, “I Carraresi a Padova…”, p. 23. 25 Dario canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione…”, p. 452-453; Silvana collodo, “I
Carraresi a Padova…”, p. 23. 26 Dario canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione…”, p. 453. 27 Il testo fu pubblicato molti anni fa da Vittorio lazzaRini, “Statuto che conferisce la signoria a Francesco
I da Carrara”, Archivio veneto, n.s., XVI (1935), p. 289-290, come ricorda Dario Canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione”, p. 453. Cfr. anche Benjamin G. KoHl, Padua under the Carrara. 1318-1405, The John Hopkins University Press, Baltimore-London, 1998, p. 95-96.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
184
4.Il vicariato imperiale e papale: via alla legittimazione e a una successione ordinata?
Dunque un ostacolo vischioso, poco appariscente ma reale impedisce, in buona sostanza, l’affermazione di un principio di “successione dinastica” nelle serie talvolta lunghe di “esperienze di governo personale” che in varie città dell’Italia centro-setten-trionale (Verona, Padova, Treviso, Ferrara, Mantova) furono ripetutamente sviluppate da esponenti di una medesima famiglia: talvolta sino a costituire strisce cronologiche plurisecolari. Questo ostacolo è costituito dalla oggettiva, sorda resistenza frapposta dalla “dimensione città”, che accetta e metabolizza ogni torsione e ogni stravolgimento del quadro politico-istituzionale di tradizione comunale, ma non legittima e non riconosce, in quanto tale, la dinastizzazione.
Molte trasformazioni della vita civica, molti stravolgimenti della tradizionale costi-tuzione comunale vengono accettati o subiti dalle popolazioni cittadine trecentesche, alle quali non dev’essere anacronisticamente attribuita la passione o l’amore “moderno” per la democrazia partecipativa. I consigli cittadini possono essere aboliti o ridotti a una vita larvale; si creano nuovi spazi sociali per la vita della “corte” incipiente, e si sviluppa l’evergetismo e la politica della magnificentia. Ovviamente è importante lo sviluppo delle cancellerie, alimentate peraltro dalla cultura notarile di tradizione comunale, e difficile da ricondurre a una imitazione regia. Una delle più significative è sicuramente l’orga-nizzazione del sistema della supplica e della grazia come meccanismo di eccezione alla giustizia. In questo quadro costituzionale e culturale, con questi impacci è evidente che una ideologia regia non può che essere adottata in modo parziale e contraddittorio da questi regimi monarchici spurii, di incerta continuità dinastica e di incerta legittimità, che sono le signorie italiane del Trecento. Beninteso, il tema è sempre ben presente nella comunicazione politica e letteraria, anche se già i contemporanei accusarono i principali “tiranni”, come Mastino II della Scala o Gian Galeazzo Visconti, di aspirare al regno d’Italia e di essersi fatti fabbricare una corona d’oro, e i cronisti chiamano senz’altro “regno” il loro dominio.28
Si tratta comunque di un grandioso processo di trasformazione della vita politica e pubblica, ed è fondamentale osservare che si tratta di aspetti ai quali la storiografia degli ultimi venti o trent’anni ha guardato con molta attenzione, molto più di quanto non abbia guardato alle forme del governo (democrazia comunale versus tirannide). Si sono insomma studiate in modo acuto e attento le tante specificità locali, le modalità concrete che i tanti governi caratterizzati dal denominatore comune della forma personale di potere hanno adottato per governare l’economia, per gestire la fiscalità e l’esercito (professionale, e popolare), per creare e per mantenere consenso grazie alla politica
28 È impossibile in questa sede anche semplicemente individuare i rinvii più pertinenti in una massa di studi sconfinata; mi limito pertanto a richiamare l’importante volume di Paolo CammaRosano (ed.), Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Relazioni al convegno internazionale organizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École française de Rome e dal Dipartimento di Storia dell’Università degli studi di Trieste (Trieste, 2-5 marzo 1993), École française de Rome, Rome 1994, e l’impressionante bibliografia di Signorie cittadine nell’Italia comunale (cit. sopra, nota *), p. 561-616.
GIAN MARIA VARANINI
185
urbanistica e al mecenatismo, e anche costruendo un discorso propagandistico che non esita a usare il lessico nella regalità.
Ma senza il riconoscimento di un principio di successione l’evoluzione “monarchica” delle forme di governo personale delle città dell’Italia centro-settentrionale del Trecento resta inevitabilmente imperfetta. E mi sembra lecito sostenere a questo riguardo che il ruolo del vicariato imperiale o papale, al quale una tradizione storiografica pluridecennale ha conferito una grande importanza come allo strumento, alla “scorciatoia” adottata dai signori per conseguire stabilità e legittimazione, ha nell’interpretazione storiografica recente forse un significato meno rilevante di quanto non si pensasse alcuni decenni or sono.
Indubbiamente il vicariato sana quella condizione di illegittimità, quel defectus tituli che nella valutazione dei giuristi trecenteschi, e soprattutto di Bartolo da Sassoferrato, costituiva la stigmata “tirannica” del governo personale. E ovviamente sin dagli inizi del Trecento un buon numero di signori cittadini considerano insufficiente il consenso sempre precario dei consigli cittadini che fondano la loro autorità, desiderano eman-ciparsene, e aspirano a vedere la loro autorità legittimata dalle potestà universali. La legittimazione in forma vicariale del potere signorile indica l’aspirazione dei signori a «realizzare il proprio potere, distaccandosi dalla mera signoria di fatto e inaugurando la strada che avrebbe condotto allo Stato moderno», come è stato scritto (da Pierangelo Schiera,29 riallacciandosi all’impostazione di un saggio famoso di Francesco Ercole). Si tratta di un problema di grande importanza, che è come si sa al centro della spedizione in Italia di Enrico VII, tra 1310 e 1313, quando – come si è via via sopra accennato – l’imperatore conferisce il ruolo di vicario imperiale vitalizio a Matteo Visconti di Milano, ad Alboino e Cangrande I della Scala di Verona, a Passerino Bonacolsi di Mantova, a Rizzardo da Camino di Treviso, a Giberto da Correggio su Reggio Emilia e a Filippo d’Acaia su Vercelli, Novara e Pavia.30
Tuttavia, come si è cercato di dimostrare nelle pagine precedenti, il precario rico-noscimento imperiale non soppiantò né privò d’importanza il processo di legittimazione fondato sul consenso delle istituzioni comunali: un rapporto, quest’ultimo, che non poteva essere rimosso. Infatti, non appena l’imperatore morì, alcuni signori abbandonarono la carica di vicario imperiale e vollero trovare la base giuridica del loro potere ancora una volta nell’autorità dei consigli cittadini. Fu questa per esempio la scelta di Galeazzo Vi-sconti, che si fece eleggere «dominus perpetuus civitatis Placentie» dal partito ghibellino.31
29 Pierangelo scHieRa, “Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello stato moderno”, Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, eds. Giorgio cHittolini, Anthony molHo, Pierangelo scHieRa, il Mulino, Bologna, 1994, p. 17-48, a p. 19.
30 Vedere ora i saggi di Riccardo Rao, Federica cengaRle, Pierpaolo Bonacini, Paolo gRillo, Patrizia meRati, Vicari imperiali in Italia 1310-1313, ed. Gian Maria vaRanini, <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm>, 2014 fasc. 1. Read: 16 June 2014.
31 Riccardo Rao, Federica cengaRle, Pierpaolo Bonacini, Paolo gRillo, Patrizia meRati, Vicari imperiali in Italia 1310-1313, Gian Maria vaRanini (ed.), <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm>, 2014 fasc. 1. Letto: 16 Giugno 2014.
FORME DELLA LEGITTIMAZIONE E ASPIRAZIONI DINASTICHE
186
Inoltre, i giuristi si interrogarono sul problema se il vicariato vitalizio avesse valore anche dopo la morte del concedente, come si arriverà ad affermare alcuni decenni più tardi.
Solo raramente, e sui tempi medi e lunghi, la concessione del titolo di vicario ebbe effetti stabilizzanti sui meccanismi successori. Accadde ad esempio per gli Estensi nella seconda metà del Trecento, quando la signoria su Ferrara «passò con regolarità a ciascuno dei fratelli [figli di Obizzo III d’Este: Aldobrandino, Niccolò II e Alberto] investiti del vicariato», sia papale che dopo il 1361 anche imperiale.32
In ultima analisi, la vera svolta per quanto riguarda la successione e la creazione di una tradizione “dinastica” fu costituita, per le signorie italiane, dalla trasformazione tardo-trecentesca o quattrocentesca dei signori – titolari di vicariato, beninteso – in duchi e marchesi, cioè in principi dell’impero, dotati di una potestà sui territori in relazione ai quali rivestivano i rispettivi titoli completamente svincolata dal riconoscimento delle collettività urbane. Fu quello che accadde a Milano, con Giangaleazzo Visconti, nel 1395,33 e a Mantova, con Gianfrancesco Gonzaga, nel 1434. L’orientamento dinastico a quel punto poteva davvero svilupparsi iuxta sua propria principia, è il cordone ombelicale tra il potere del signore e la sua placenta cittadina e comunale risultava ormai defini-tivamente reciso; la legittimazione proveniva solo dall’alto e il distacco tra governanti e governati appariva, nei regimi principeschi, ormai incolmabile.34
32 Dario canzian, “Condivisione del potere, modalità di successione…”, p. 457.33 Vedere a questo proposito il contributo di Marco gentile in questo stesso convegno, e nell’ampia letteratura
recente su questo tema Jane Black, Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza 1329-1535, Oxford University Press, Oxford, 2009, p. 68 ss. (Chapter 3, «Giangaleazzo’s Investiture and its Legacy»).
34 Giovanni tabacco, “L’Italia delle signorie”, Signorie in Umbria tra medioevo e Rinascimento: l’esperienza dei Trinci, Deputazione umbra di storia patria, Perugia, 1989, p. 10.