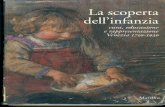DI BARTOLOMEO D. (2006). Il recupero dell'antico nella pubblicistica rivoluzionaria: il "Moniteur"...
Transcript of DI BARTOLOMEO D. (2006). Il recupero dell'antico nella pubblicistica rivoluzionaria: il "Moniteur"...
Daniele DI BARTOLOMEO
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria: il «Moniteur» (1789-94)(*)
1. Antichità e Rivoluzione nella storiografia: il posto dei discorsi
La riflessione sull’uso della storia antica nell’esperien-za rivoluzionaria francese impone alcune preliminari con-siderazioni sul posto riservato alla dimensione discorsiva nella pratica storiografica. L’evoluzione del dibattito no-vecentesco sul tema ha affermato un singolare rovescia-mento interpretativo: si è passati, infatti, a considerare il discorso (storico) da elemento insignificante a dato co-stringente le dinamiche evenemenziali. La prima opinio-ne, sedimentatasi nell’ambito dell’interpretazione sociale classica, negli ultimi tempi ha lasciato il posto alle più re-centi prospettive avanzate dalla storiografia revisionista1.
(*) Per condurre questa ricerca ho consultato i volumi originali del giornale, conservati presso la Biblioteca A. Barnave di Macerata. La de-nominazione per esteso del quotidiano in-folio, fondato da Charles Jo-seph Panckoucke nel novembre del 1789, è «Gazette nationale ou le Moniteur universel», da ora in poi «Moniteur».
1 Mi riferisco in particolare agli studi di Keith Baker, nei quali si de-linea l’esistenza di una dimensione discorsiva dotata di una peculiare capacità di presentarsi agli attori storici come un canone impositivo. In un primo momento Baker sembrava escludere il discorso storico dalla sua architettura interpretativa, svalutandone la centralità nel dibattito rivoluzionario: «cette bataille historiographique de toute une généra-
268 Daniele Di Bartolomeo
Tale approdo rischia però di soffocare l’idea di una sto-ria possibile, che all’opposto tenderebbe invece a ricono-scere agli attori storici una capacità di scelta, in una più complessa prospettiva che «non può separare lo studio dei discorsi dall’analisi dei comportamenti e, per così di-re, le parole dalle cose»2.
Occorre, pertanto, mettere da parte non solo l’ipotesi che ha prospettato una derivazione della dimensione ide-ologica dalla forza degli eventi, ma anche l’opposta e si-milare tendenza ad interpretare la dinamica evenemen-ziale e come proiezione immediata di un orizzonte discor-sivo che la precede.
In questo quadro concettuale, la storiografia specializ-zata negli studi rivoluzionari, con poche ma significative eccezioni, ha ignorato a lungo la necessità di analizzare l’uso politico della storia nella retorica della rivoluzione, affidando involontariamente una sorta di “supplenza” a-gli altri campi disciplinari.
Tuttavia è interessante osservare come questa vicenda storiografica si sia sviluppata proprio a partire da una singolare intersezione tra l’emergenza del paradigma so-ciale classico e l’elaborazione di una prima riflessione sul ruolo dell’antichità nella Rivoluzione francese. Alcune considerazioni espresse da Georges Lefebvre sulle «Anna-les» nel 1938, stimolate dalle suggestioni proposte da Ha- tion, dont l’effet allait être, finalement, de détruire la légitimité même de l’histoire comme source d’autorité. La répudiation révolutionnaire de l’histoire ne vint qu’après une âpre lutte politique pour la maîtriser et la diriger» K.M. BAKER, Au tribunal de l’opinion. Essais sur l’imaginaire politique au XVIIIe siècle, Paris 1993, p. 35. Tuttavia in un recente saggio, come avremo modo di vedere, lo storico inglese ha riconsiderato que-sta posizione. Per un’analisi più articolata delle tesi di Baker si veda F. BENIGNO, Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell’Europa moderna, Roma 1999, pp. 46-59.
2 ID., I pamphlet della Rivoluzione, in «Storica», 17, 2000, pp. 173-85, p. 184.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 269
rold Parker in The Cult of Antiquity and the French Revolu-tionaires3, esplicitarono infatti emblematicamente la svalu-tazione del discorso storico nel paradigma interpretativo che si andava elaborando in quegli stessi anni4.
La nostra prospettiva ci consente oggi di rivalutare il contributo di Parker, ponendolo a fondamento della ri-flessione sul recupero dell’antico nella Rivoluzione fran-cese. L’accantonamento di una tentazione interpretativa ricorrente, incline a ricondurre la genesi rivoluzionaria al-la diffusione di un culto dell’antichità5, permise allo stori-co americano di spostare l’attenzione sul tema della me-diazione retorica6.
Il dibattito sull’uso dell’antico, dopo questa fugace ma significativa apparizione, tornò alla ribalta nel dopoguerra, offrendo progressivamente nuovi spazi d’indagine e una pluralità di soluzioni interpretative, riconducibili alla va-riegata appartenenza disciplinare degli studiosi impegnati
3 T.H. PARKER, The Cult of Antiquity and the French Revolutionaires. A
study in the devolpement of the revolutionary spirit, Chicago 1937. 4 «Il me semble donc de résulter du livre de H. Parker […] que le
souvenir d’une antiquité, d’ailleurs toute conventionnelle, n’a pu four-nir à l’esprit révolutionnaire rien qui soit substantiel […] il est impos-sibile de voir en tout cela autre chose qu’un décor imposé par la forma-tion littéraire de ces hommes à la pensée que leur dictaient les événe-ments», G. LEFEBVRE, Bibliographie, in «Annales historiques de la Révo-lution française», 15, 1938, pp. 465-68, p. 467.
5 «In the mind of contemporaries and historians, both the juvenile and the more mature sympathy with republican antiquity acquired in retrospect an exaggereted signifiance. Even though we may not admit that sympathy with republican antiquity directly promoted this psycological change, yet it could be argued that indirectly it played a part», T.H. PARKER, The Cult of Antiquity …, cit., pp. 68-69.
6 «We may note that each – Desmoulins as well as the conservative – framed, as was natural, his vision of the past in accordance with his present hopes or fears and in armony with his present principles», ibidem, p. 88.
270 Daniele Di Bartolomeo
in questa riflessione7. In un breve excursus sulla «tradition de la démocratie grecque», proposto nel 1976, Pierre Vidal-Naquet enfatizzò l’importanza del fenomeno in questione, tornando proprio sul giudizio espresso dello storico nor-manno negli anni Trenta: «Ce que Georges Lefebvre appel-lait le “décor” et que nous appelons aujourd’hui “l’imma-ginaire” d’une société n’est pas indifférent. Il constitue un objet d’études en soi»8. Ma è la prospettiva adottata da Paul Martin in un saggio sulla «presenza della storia ro-mana nella Rivoluzione francese» a delineare un primo ten-tativo di sistematizzazione storiografica. Lo studioso fran-cese suggerì, infatti, la necessità di considerare «l’utilisation de faits historiques» come una pratica retorica che coinvol-ge il passato nella sua generalità, giudicando ininfluente il fatto che i rivoluzionari avessero o meno «une vision clai-re et juste de l’histoire antique», dal momento che
l’important, c’est que cette histoire ancienne, qu’ils con-naissaient par la fréquentation des textes antiques et non d’ouvrages critiques et scientifiques – donc familièrement et sans recul -, se soit tout naturellement imposée à leur esprit pour exprimer des faits, des situations ou des pro-jects contemporains.9
7 Si vedano i contributi di B. RÉCATAS, Quand l’Antiquité ispira les
hommes de la Révolution, in Mélanges I. Lévy, Bruxelles 1955, pp. 491-529; F. DÌAZ-PLATA, Griegos y Romanos en la Revolucion francesa, Madrid 1960; E. RAWSON, The Spartan tradition in European thought, Oxford 1969; P. CATALANO, Tribunato e Resistenza, Torino 1971.
8 P. VIDAL-NAQUET, Tradition de la démocratie grecque, prefazione a M. FINLEY, Démocratie antique et démocratie moderne, Paris 1976, p. 18. In questo stesso anno, le considerazioni di Vidal-Naquet furono riprese e sviluppate da M. OZOVF, La Fête Révolutionaire: 1789-1799, Paris 1976, pp. 327-35. Di Vidal si vedano anche i successivi saggi, ora ricompresi in La democrazia greca nell’immaginario dei moderni, Milano 1996.
9 P.M. MARTIN, Présence de l’histoire romaine dans la Révolution fran-çaise, in R. Chevallier (a cura di), Influence de la Gréce et de Rome sur l’Occident moderne, Paris 1977, pp. 215-26, p. 217.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 271
Mentre sembrava ormai consolidarsi tale riposiziona-mento interpretativo, che nella versione di Vidal-Naquet recuperava esplicitamente il contributo di Parker10, gli in-terventi di Luciano Canfora e di Jacques Godechot pro-spettarono invece una rivalutazione regressiva del punto di vista termidoriano: il primo, indugiando su una pre-sunta incapacità dei rivoluzionari di storicizzare il mondo antico11; l’altro, imputando al culto dell’antichità, sulla scorta dei giudizi espressi dai contemporanei, un’ipoteca sulle potenzialità progressive della Rivoluzione12. Alcuni contributi, elaborati a partire dagli anni Ottanta, hanno saputo tuttavia riportare l’attenzione sulla dimensione manipolatoria del discorso rivoluzionario13. Keith Baker,
10 Cfr. P. VIDAL-NAQUET, Tradition de la démocratie grecque …, cit., p. 20. 11 «I giacobini, nel loro fanatismo per Sparta (e soprattutto per Ro-
ma: le due “repubbliche” vengono non di rado accostate) sembrano aver perso – forse anche per l’idealizzazione fattane da Rousseau – questa dimensione storica e questa capacità di storicizzare. “L’idea che ci si è fatta della Grecia e di Roma ha spesso turbato le nostre genera-zioni – scriverà Fustel de Coulanges -: per aver male osservato le isti-tuzioni della città antica, si è immaginato di farla rivivere tra noi. Ci si è illusi sulla libertà degli antichi, e perciò l’unico risultato è stato che la libertà dei moderni è stata messa in pericolo”; e aggiungerà che re-sponsabile di questo fraintendimento è il classicismo senza “mediazio-ni” tipico di un sistema educativo che “ci fa vivere sin dall’infanzia in mezzo ai Greci e ai Romani e ci abitua a confrontarli continuamente con noi”», L. CANFORA, Immagini moderne della schiavitù di età classica, in «Index», 8, 1977-8, pp. 104-20, p. 106.
12 «Ainsi, vous le voyez, l’influénce gréco-romaine a été très grande à l’époque de la Révolution. D’abord cette influence semble avoir été assez superficielle […] Mais, malgré tout, je pense que Condorcet avait raison, et que le fait que les principaux meneurs de la Révolution étaient tournés vers l’antiquité et aient toujours dirigé leur régard vers le passé, les a empêché d’apercevoir l’avenir au moment où la révolu-tion politique économique et sociale transformait le monde atlanti-que», J. GODECHOT, L’influence de l’antiquité à l’époque de la Révolution, in «Index», 7, 1977, pp. 45-55, p. 54.
13 Si vedano in particolare i contributi di M. RASKOLNIKOFF, Des An-
272 Daniele Di Bartolomeo
invece, intervenendo di recente sulla questione con un breve saggio, ha riproposto una lettura del discorso rivo-luzionario sul repubblicanesimo classico che annulla lo spazio di mediazione retorica dell’attore storico rispetto ai diversi campi discorsi disponibili:
Il terrore non derivò da puro e semplice errore di preferi-re la libertà degli antichi a quella dei moderni, o il repub-blicanesimo classico al discorso dell’illuminismo. Derivò dalla maniera esplosiva nella quale durante la rivoluzio-ne francese le due componenti si fusero14.
Una riflessione più approfondita richiederebbe la rico-gnizione dell’intera stagione rivoluzionaria, dalla convo-cazione degli Stati generali alla genesi del regime bona-partista, al fine di analizzare un processo ininterrotto di rimescolamento dei discorsi, caratterizzato da un gioco di riflessi cangianti tra Rivoluzione e antichità, inteso come un fenomeno essenziale nel laboratorio rivoluzionario. L’unica indagine che ne ha cercato di proporre un’analisi complessiva, quella condotta da Jacques Bouineau, vede tuttavia la sua efficacia pesantemente debilitata da un’ec-cessiva inclinazione quantitativistica e dall’assenza di una contestualizzazione dei discorsi15.
ciens et des Modernes, Paris 1990, pp. 95-127, di C. MOSSÉ, L’Antiquité dans la Révolution française, Paris 1989 e di R. Chevallier (a cura di), La Révolution française et l’antiquité, Tours 1991. Sul versante degli studi rivoluzionari segnaliamo L. HUNT, Politics, culture and class in the French Revolution, Berkeley 1984.
14 K.M. BAKER, Le trasformazioni del repubblicanesimo classico nella Francia del Settecento, a cura di M. Visoli, Torino 2004, pp. 149-175. Si tratta della versione in italiano di un saggio apparso in precedenza su «The Journal of Modern History», 73, 2001, pp. 32-53. Su questo punto si vedano anche le critiche rivolte a Baker da R. MONNIER, Républicani-sme, patriotisme et Révolution française, Parigi 2005, 26-7.
15 Cfr. J. BOUINEAU, Les toges du pouvoir, ou la révolution de droit anti-que (1789-1799), Paris 1986.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 273
2. Il mondo degli antichi: un atelier di eventi simbolici
Il discorso storico si presenta come uno spazio retorico competitivo dove praticare uno scontro ideologico per l’attribuzione di significato agli eventi.
L’idea di una disponibilità retorica del passato, di una sua metaforica collocazione in uno spazio di interazione agonistica, fuga ogni dubbio sulla «capacità degli attori storici di controllare in profondità tale logica», così come esclude una «sottovalutazione dell’attività retorica come pratica cosciente di manipolazione del discorso»16. Non è la disponibilità del precedente storico che determina e co-stringe la scelta rivoluzionaria ma è, viceversa, la consa-pevole volontà dell’attore storico che illumina il presente con un gioco di specchi mutevole17.
Dalla lettura dei discorsi pronunciati dai rivoluzionari, emerge l’immagine di un’antichità classica identificata come uno spazio retorico dal quale evocare un exemplum, chiamare in causa un’auctoritas da spendere nel confronto pubblico per sostenere un’opzione politica, spiegare una scelta inedita, rendere intelligibile la transizione rivolu-zionaria, inserire il cambiamento in un orizzonte discorsi-vo e simbolico che ne esprima la giustificazione più im-
16 F. BENIGNO, Specchi della rivoluzione …, cit., p. 53. 17 A questo proposito, per descrivere l’assenza di un’implicazione
necessaria tra sentimento di ammirazione per le repubbliche antiche e svolgimento della transizione rivoluzionaria, Harold Parker ha parlato di «sterilità» del modello e Mouza Raskolnikoff di «sdoppiamento schizofrenico» nella mentalità degli attori storici. Mentre Parker ha ri-flettuto sulla tendenza di alcuni rivoluzionari a rivendicare ex post l’ori-gine del “gesto” rivoluzionario in un’imitazione degli antichi: cfr. H. PARKER, The cult of Antiquity …, cit., p. 71; Raskolnikoff ha segnalato, invece, una dichiarazione nella quale Talleyrand metteva in rilievo, riferendosi alla società d’antico regime, l’assenza di ricadute politiche conseguenti all’ammirazione degli antichi: cfr. M. RASKOLNIKOFF, Des Anciens …, cit., p. 95-96.
274 Daniele Di Bartolomeo
mediata. In altre parole, l’uso della storia antica permette di chiamare in causa un’analogia, un’assonanza con un mondo esemplare.
Una volta costruita la corrispondenza analogica con le atmosfere della storia antica, la disponibilità stessa di tale risorsa retorica, in un’arena pubblica ingombra di dina-miche conflittuali mutevoli, trasforma l’antichità in un terreno agonistico: diversi e opposti protagonismi politici vi giocano una competizione fazionale, ricorrendo a per-sonaggi, situazioni e avvenimenti esemplari nel tentativo di conquistare e ridefinire una preminenza politica.
L’interazione dei rivoluzionari francesi con tale reper-torio di avvenimenti e personaggi non è certamente una caratteristica peculiare della loro esperienza politica; piut-tosto, rappresenta un momento di accelerazione impre-vedibile di una pratica, l’uso pubblico della storia (antica), che è parte importante non solo del dibattito culturale e politico francese – e più in generale europeo, a partire dal Rinascimento18 – ma anche delle precedenti esperienze ri-voluzionarie19.
Come ha sostenuto Elisa Romano, parlare dell’antichi-tà in età moderna segnala la volontà di individuare «una genealogia delle epoche successive in Occidente», ovvero di aprire un confronto con un orizzonte politico originario che, a seconda dei punti di vista e delle esigenze politiche
18 E. ROMANO, L’antichità dopo la modernità. Costruzione di un para-digma, in «Storica», 7, 1997, pp. 7-47, pp. 14-15.
19 «Mais lorsque s’écroule l’ordre monarchique, etraînant dans sa chute les valeurs spirituelles qui lui étaient associées, c’est l’image idéalisée des républiques de l’Antiquité que l’on invoque, références rassurantes pour ceux qui ont à inventer un avenir neuf à la fois contre l’ancien régime et la tradition chrétienne. Un siècle plus tôt, dans des circonstances analogues, les républicains anglais s’étaient eux aussi tournés vers la Gréce et Rome», M. RASKOLNIKOFF, Des Anciens …, cit., p. 200. Per la Rivoluzione americana si vedano le considerazioni intro-duttive di T.H. PARKER, The Cult of Antiquity …, cit., pp. VII-VIII.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 275
contingenti, può apparire come un modello esemplare da riprodurre o come una «galleria di anticipazioni»20.
L’esperienza rivoluzionaria francese, proprio in ragione della sua ineluttabile modernità, percepì il confronto con il mondo degli antichi nell’ambito di una competizione idea-le, segnata dalla consapevolezza di una non riproducibilità e da una conseguente volontà di superamento di tale refe-rente originario21, del quale all’occorrenza evidenziare le inevitabili degenerazioni. Il mondo degli antichi appariva così come un atelier denso di eventi simbolici: orizzonte primordiale per il “gesto” della fondazione politica di una società nuova e, allo stesso tempo, collezione di “esiti” che si presentavano all’attore storico come scogli insidiosi nella navigazione rivoluzionaria, prospettando approdi meravi-gliosi ma anche derive funeste22. L’antichità conservava co-
20 Cfr. E. ROMANO, L’antichità dopo la modernità …, cit., p. 24. 21 Sull’inattualità delle repubbliche antiche risulta esemplare que-
sta dichiarazione del montagnardo Pierre Joseph Robert: «Les Romains avaient leurs esclaves; les Lacédémoniens avaient leurs ilotes. C’était une réelle aristocratie que la qualité de citoyen de Rome et de Sparte; aujourd’hui tout est changé, le grand livre de l’égalité est ouvert, il n’y a plus d’esclaves que les esclaves du vice et du crime. Si, comme à Rome, il n’y avait en France, que quelques milliers de citoyens Fran-çais, je vous dirais: Lacérez la déclaration des droits de l’homme; créez, comme il vous plaira, des magistrats à vie; ordonnez de frequens ras-semblemens des corps aristocratiques, des citoyens exclusifs, et vous aurez tout fait, vous aurez fait la constitution. Mais comme vous avez reconnu la souveraineté nationale, comme principe fondamental de vo-tre gouvernement est l’admission de tous les citoyens à l’exercice de cet-te souveraineté, je vous défie de dire que vous ayez une route tracée, ni que vous puissez copier aucune des constitutions anciennes ou mo-derne», ibidem, VIII, n. 117, Convention nationale, séance du vendredi 26 avril 1793, suite de la discussion sur la constitution, p. 518.
22 A tal proposito è interessante questo intervento di Robespierre, in risposta alle accuse rivoltegli da Desmoulins: «les François sont le premier Peuple du Monde qui ait établi la véritable démocratie, en ap-pelant tous les hommes à l’égalité et à la plenitude des droits du ci-toyens […]. Nous ne prétendons point de jeter la République Française
276 Daniele Di Bartolomeo
sì inalterata la sua esemplarità, aldilà del segno positivo o negativo della sua caratterizzazione: archetipo dello sfor-zo titanico dei popoli oppressi e specchio dell’esperienza politica dei rivoluzionari, trasmetteva l’immagine compo-sita di un mondo irrimediabilmente sospeso tra il fugace trionfo della libertà e l’ineluttabilità della sua fine, conse-gnando al presente rivoluzionario i termini di una sfida drammatica. In questo senso, la consapevolezza della non riproducibilità del modello, l’evocazione della sua esem-plarità e la critica selettiva o addirittura complessiva della sua caratterizzazione storica sono riconducibili, inscindi-bilmente, allo stesso orizzonte retorico23. I rivoluzionari
dans la moule de celle de Sparte; nous ne voulons lui donner ni l’auste-rité ni la corruption des cloîtres. […] Lorsqu’après quatre cents ans de gloire, l’avarice a enfin chassé de Sparte les moeurs, avec les lois de Lycurgue, Agis meurt en vain pour les rappeler; Demosthene a beau tonner contre Philippe, Philippe trouve dans le vices d’Athênes degé-nerée des avocats plus éloquens que Démosthene. Il y a bien encore dans Athênes une population aussi nombreuse que du tems de Miltia-de et d’Aristide; mais il n’y a plus d’Atheniens. Qu’importe que Brutus ait tué le tyran: la tyrannie vit encore dans le coeurs, et Rome n’existe plus que dans Brutus», ibidem, X, n. 139, Convention national séance du 17 pluvoise on ii (S II 1794), Discours de Robespierre sur le principes de la mo-rale politique qui doivent guider la Convention dans l’administration inté-rieure de la République, pp. 561-563.
23 Esemplare, in tal senso, risulta questa dichiarazione di Rabaut Saint-Ėtienne: «Personne n’ignore quelle était à cet égard l’éducation des Crétois, des autres peuples Grecs, et surtout de ces Spartiates qui passérent leurs jours dans une societé continuelle, et dont toute la vie était une apprentissage et un exercice de toutes les vertus. Lorsque j’ai voulu méditer sur les moyens de nous appliquer quelque chose de ces institutions antiques, j’avoue que ma pensée c’est allangourie et débili-tée. Trop de difference avec ces peuples et avec leur tems, défend de porter nos voue aussi haut. […] Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il faut, il faut absolument renouveller la géneration présente, en formant en même tems la génération qui va venir; il faut faire des Français un peuple nouveau …», ibidem, VII, n. 357, Convention nationale, séance du 21 décembre 1792, p. 1520.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 277
inscenarono, così, una sorta di rappresentazione differita del vasto repertorio della classicità.
La storia antica poneva il problema della degenerazio-ne delle esperienze repubblicane come un fatto storico, imponendo alla Rivoluzione una strada necessariamente alternativa: in questo processo, la discussione sull’antichi-tà più remota era conseguentemente un modo per rivol-gere lo sguardo al futuro di una società che ormai si per-cepiva come l’avanguardia dell’umanità24.
Il problema della mancata storicizzazione del mondo antico e il topos dell’identificazione immediata come fonte di un tragico fraintendimento, sulla base di queste ultime considerazioni, perdono ogni rilevanza dirimente nella spie-gazione degli esiti della Rivoluzione. L’immagine di Roma evocata da Saint-Just25 e quella di Sparta affrescata da Robe-spierre26, dopotutto, disvelano semplicemente l’esigenza di riannodare i fili della storia, attraverso la costruzione reto-rica di un’anticipazione storica della svolta rivoluzionaria.
3. Uno sguardo d’insieme
La diffusione del ricorso all’uso politico della storia è riconducibile all’esplosione di quella disputa pubblica scatenatasi in Francia tra 1788 e 1789, a seguito della ri-chiesta governativa di chiarificazioni in merito alle moda-
24 Per una riflessione sulla prospettiva temporale nella vicenda rivolu-zionaria, si vedano le recenti considerazioni di P. PERSANO, Tempo, rivolu-zione, costituzione: un bilancio storiografico, in «Storica», 31, 2005, pp. 52-62.
25 «Le monde est vide depuis les Romains, mais leur mémoire le remplit et prophétise le nom de liberté», in «Moniteur», X, n. 192, Convention nationale, séance du 11 germinal II (31 III 1794), p. 778.
26 «Le siecles et la terre sont le partage du crime, et de la tyrannie; la li-berté et la vertu se sont à peine reposées un instant dans quelques points du globe - Sparte brille comme un éclair dans une nuit éternelle», ibidem, X, n. 229, Convention nationale, séance du 18 floréal II (7 V 1794), p. 928.
278 Daniele Di Bartolomeo
lità di convocazione e riunione degli Stati generali27. Un tale ed esplicito riconoscimento dell’autorità del prece-dente storico innescò una competizione inedita, nel corso della quale il passato divenne il campo della legittimazio-ne originaria per ogni rivendicazione sul futuro assetto del Regno: la vicenda storica della monarchia francese, il precedente inglese di metà Seicento e l’antichità si tra-sformarono in serbatoi inesauribili per un discorso politi-co alla ricerca spasmodica di un’auctoritas da spendere in un’arena pubblica in rapida evoluzione28.
A partire da questo momento, il succedersi incessante di avvenimenti rivoluzionari, dalla presa della Bastiglia fino alla demolizione del mito dell’Incorruttibile, vide i pro-tagonisti di questa cruciale stagione cercare nella storia antica e moderna ogni possibile analogia, per trasformare i topoi storici in risorse strumentali del confronto politico.
Nel corso della transizione costituente i legislatori francesi evocarono gli exempla antichi a sostegno di pro-poste normative inconciliabili29. Esemplare, a tal proposi-to, è l’uso delle repubbliche antiche messo in campo dai
27 «Improvvisamente il dibattito sulla storia francese cessa di essere
un tema culturale, di interesse politico indiretto, e diviene un tema di attualità immediata. La nuova congiuntura costringe cioè i partecipanti al dibattito a misurarsi su un nuovo terreno, quello della ricostruzione della storia francese, una forma di intervento politico che oggi chiame-remmo uso pubblico della storia», F. BENIGNO, I pamphlet della Rivolu-zione …, cit., p. 176.
28 Una traccia interessante di questo dibattito è lo scritto di Chail-lon DE JOINVILLE, Apologie de la Constitution française ou Ėtats républicain et monarchique, comparés dans les Histoires de Rome et de France, Paris 1789, pubblicato poco prima della riunione degli Stati generali.
29 Su questo punto rimando all’interessante contributo di M. DU-
COS, La Révolution française et le droit romain, in R. Chevallier (a cura di), La Révolution française …, cit., pp. 55-74.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 279
monarchiens nella battaglia a sostegno del veto monarchico e della soluzione bicamerale30.
L’indebolimento dell’immagine della Corona dopo la fuga di Varennes aprì, invece, una nuova stagione rivolu-zionaria, nella quale maturarono i presupposti evenemen-ziali e politici per una progressiva assimilazione delle vi-cende francesi all’epopea della repubblica romana: dap-prima nella costruzione del mito della Patria in armi − carat-terizzata anche dal ricorso ai topoi della storia greca31 −, suc-cessivamente nel corso della transizione repubblicana32.
30 Sul veto è interessante questa dichiarazione di Mounier: «Dans
la république romaine, le Peuple délibérait sur les propositions des tri-buns, et ceux-ci avaient un véritable veto, non-seulement à l’égard du sénat, mais même à l’égard du Peuple; leur consentement était tou-jours nécessaire, puisqu’ils étaient les maitres absolus des propositions. Chez les Athéniens, une loi fondamentale ordonnait que toute décision du Peuple serait précédée par un décret du sénat […] et malgré ces sa-ges réglemens, vous savez si l’on a pu défendre la liberté des Grecs et des Romains, des funestes conséquences de leurs délibérations, dictées par des démagogues qui voulaient ou les gouverner ou les trahir», in «Moniteur», I, n. 52, Assemblée nationale, suite de la séance du 4 septembre 1789, suite du discours de Mounier sur l’organisation du corps législative et la nécessité de la sanction royale, p. 213.
31 Il «Moniteur» riporta un estratto del discorso sulle potenze stra-niere, tenuto da Brissot al club dei giacobini nel luglio del 1791, nel quale prese corpo questo parallelismo: «Qui êtes vous? Un peuple li-bre; et on vous menace de quelques brigands couronnés et de mentes esclaves! Athênes et Sparte ont-ils jamais craint les armées inombrables que les despotes de la Perses traînaient à leur suite? A-t-on dit à Mil-tiade, à Cimon, à Aristide, recevez un roi ou vous périrez? Ils auraient répondu dans un langage digne des Grecs: Nous nous verrons à Mara-thon, à Salamine… Et les Français aussi auront leur Marathon, leur Sa-lamine, s’il est des puissances assez folles pour les attaquer […] Nos Thermopyles seront toujours couvertes de légions nombreuses», ibi-dem, V, n. 195, Variétés, de Paris, extrait du discours prononcé par M. Bris-sot, à l’assemblée des amis de la constitution, le 10 juillet 1791, p. 803.
32 È stata più volte rilevata la preponderanza del precedente roma-no rispetto a quello greco, in particolare per quel che riguarda l’evo-
280 Daniele Di Bartolomeo
È opportuno osservare come la comparazione tra l’espe-rienza delle repubblice antiche e la vicenda rivoluzionaria risulti intrinsecamente connessa all’evoluzione dello scena-rio politico: la libertà degli antichi, prima ancora della svol-ta repubblicana del ’92, era stata già assimilata alla stagione della Rivoluzione con il re, che aveva visto il popolo france-se occupare «sa place entre les Grecs et les Romains»33.
4. La transizione repubblicana
La cesura del 10 agosto 1792 trasformò profondamente l’orizzonte rivoluzionario: gli attori storici ripensarono nuovamente quel confronto con il mondo degli antichi i-naugurato all’alba della Rivoluzione, prima di risolverlo definitivamente a vantaggio della modernità francese34.
cazione di analogie evenemenziali con l’esperienza rivoluzionaria: su questo si veda, ad esempio, C. MOSSÉ, L’Antiquité …, cit., p.155-156.
33 «Moniteur», III, n. 197, Variétés, Jean-Baptiste Clootz à Madame de Beauharnois, 16 VII 1790, p. 810. Ma su questo punto è interessante il se-guente passo, tratto dalla recensione di una rappresentazione teatrale del Brutus di Voltaire, apparsa sul «Moniteur» nel novembre del 1790: «Jamais assemblée au théatre n’a été, en France, plus nombreuse, ni plus auguste […] Dès les premiers vers de la premiere scene, les ap-plaudissemens ont éclaté. Les maximes républicains ont été saisies, et les acclamations se sont fait entendre. Le triomphe de la liberté a été complet; mais la liberté n’a pas triomphé seule; la loi et le roi ont par-tagé sa victoire […] Enfin, comme le pouvoir monarchique est quel-ques fois présenté dans la piece, sous un aspect désavorable à la cause des bons rois, et que le peuple français n’a pas voulu être accusé de confondre Tarquin avec le petit fils de Henri IV, on a saisi un des vers qui marquent le plus dans la bouche de Brutus, la haine de la royauté, pour crier vive le roi! La salle entiere a répondu avec ivresse à ce cri de coeur …», ibidem, III, n. 323, Théatre de la Nation, 19 XI 1790, p. 1336.
34 Su questo punto vorrei segnalare due interventi (nell’ordine del cittadino Fortin alla Convenzione e di Robespierre ai giacobini) per dimostrare come l’evoluzione politica portò con sé la consapevolezza
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 281
Nella sfida per la conquista di uno spazio politico ine-dito, ormai privo del tradizionale vertice esecutivo mo-narchico35, il ricorso agli exempla storici rese possibile la necessaria legittimazione della transizione repubblicana36 e immediatamente riconoscibili i tentativi di appropria-zione dispotica della sovranità popolare37.
che il “gesto” rivoluzionario potesse ormai rivendicare, al cospetto del-le repubbliche antiche, il compimento di una profezia: «Citoyens re-présentans, vous avez fondé la République sur la base immuable de la vertu. Rien de ce qui en retrace les actes, ne nous est étranger, et les faits des siecles passés appartiennent aux générations présentes. C’est ainsi que l’héroisme de nos législateurs et de nos guerriers instruira la derniere postérité, et effacera ce que l’histoire lui dira de Sparte et de Rome», ibidem, X, n. 274, Convention nationale, séance du 3 messidor, II (21 VI 1794), p. 1119; «Une nation n’est pas illustrée pour avoir abbatu des tyrans ou enchaîné des Peuples; ce fut le sort des Romains et de quel-ques autres Nations; notre destinée, beaucoup plus sublime, est de fonder sur la Terre l’empire de la sagesse, de la justice et de la vertu …», ibidem, XI, n. 300, Société des Amis de la Liberté et de l’Egalité, discours de Robespierre dans la séance du 21 messidor II (9 VII 1794), p. 1228.
35 Per una visione d’insieme sulle dinamiche costituzionali cfr. R. MARTUCCI, L’ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799), Bologna 2001.
36 Sull’uso della storia come risorsa per legittimare il processo al re e inscrivere questa pratica nella consuetudine dei popoli antichi e mo-derni, è molto interessante il rapporto del Comitato di legislazione, let-to alla Convenzione da Maihle, sulle «questions relatives au jugement de Louis XVI»: cfr. «Moniteur», VII, n. 314, Convention nationale, suite de la séance du mercredi 7 novembre 1792, pp. 1130-32.
37 Su questa dinamica Benigno ha fatto notare giustamente «la stretta affinità esistente tra la ricostruzione violenta del potere dispoti-co posta in atto da Robespierre e la fase di lotta del “tutti contro tutti” che l’aveva preceduta. L’Incorruttibile realizza nei fatti ciò che altri a-vevano su più modesta scala e con ancora più modesti risultati tentato: la conquista del potere assoluto attraverso l’eliminazione fisica dei dis-senzienti (hébertisti e dantonisti) e la distruzione dei poteri politici al-ternativi all’unico centro di direzione esecutiva, il governo rivoluzio-nario espresso dal Comitato di salute pubblica», F. BENIGNO, Il Terrore, in «Storica», 20-21, 2001, 285-98, p. 295.
282 Daniele Di Bartolomeo
La storia antica si trasformò in un’arena retorica sulla quale definire in modo esclusivo un’identità politica uni-taria, mentre nel presente rivoluzionario s’inscenava un drammatico scontro fratricida.
4.1 Un’eredità contesa: Bruto e la repubblica romana
Le due atmosfere topiche della repubblica romana – le origini e la stagione convulsa della crisi38 – rappresenta-rono l’orizzonte comparativo della nuova vicenda rivolu-zionaria, a partire dall’assimilazione della caduta di Luigi XVI all’episodio della “cacciata” dei Tarquini. Una volta evocato questo parallelismo e riconosciuta l’utilità del pre-cedente romano nell’interpretazione della transizione re-pubblicana39, le sorti della Rivoluzione furono mutevol-mente inscritte nel quadro di tale comparazione. Il discor-so sulla storia di Roma permetteva di leggere il presente rivoluzionario sulla base di una corrispondenza evene-menziale indiscussa ma, allo stesso tempo, aperta alle più disparate manipolazioni fazionali.
Nel corso del processo al re gli avvenimenti e i prota-gonisti della repubblica romana segnarono profondamen-te il vocabolario rivoluzionario: mentre il precedente ro-
38 Una frase di Desmoulins sintetizza al meglio il parallelismo fra
presente e classicità: «Différents entre nous d’opinions, nous nous ac-cordons tous à nous disputer à l’envi le surnom de Brutus, et voilà qua-tre mois que sept cent quarante Brutus délibèrent gravement si un ty-ran n’est pas inviolable», Convention National, Discours de Camille Des-moulins dans le procès de Louis XVI, sur la question de l’appel au peuple, p. 3.
39 Nell’ottobre del 1792 comparve sul «Moniteur» la recensione de Les Histoires de Tacite di Dotteville, con questa nota dei redattori: «Il est d’autant plus utile à lire, cet ouvrage, dans les circonstances présentes, qu’il est le vrai portrait de ces tyrans qui, sous le masque de la popula-rité, ont été et seront toujours les plus grands ennemis du peuple qu’ils flattent pour mieux l’enchaîner», in «Moniteur», VII, n. 289, Livres nou-veaux, 15 X 1792, p. 1226.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 283
mano si imponeva come una giustificazione esemplare per l’immediata condanna a morte di Luigi Capeto nei di-scorsi di Saint-Just e Robespierre40, tra i banchi della Con-venzione diversi riflessi dall’antichità supportavano stra-tegie alternative41.
Essenzialmente si trattava di una disputa giocata tra gli “eredi” di Bruto, l’archetipo ambivalente della rivoluzio-ne repubblicana, riducibile a un’unica identità politica ma all’occorrenza distinguibile nelle figure del console fonda-tore della repubblica e del cesaricida42. Intersecando abil-mente questi stessi topoi, i convenzionali prospettarono soluzioni alternative nel corso del processo, dividendosi tra i sostenitori dell’esilio e dell’appello al popolo e quelli della morte immediata al tiranno43. Questa controversia
40 Robespierre: «Les peuples ne jugent pas comme les cours judi-ciaire; ils ne vendent point le sentences, ils lancent la foudre […] Dans quelle République la necessité de punir le tyran fut-elle litigeuse? Tar-quin fut-il appelé en jugement? Qu’aurait-on dit à Rome, si des Ro-mains avaient osé se déclarer ses défenseurs?», ibidem, VII, n. 340, Conven-tion nationale, suite de la séance du lundi 3 décembre 1792, p. 1442.
41 Manuel si oppose alla linea sostenuta da Robespierre sulle sorti del re ricordando che «Brutus donna la mort à César sans aucune for-me de procès, sans doute; mais il l’assassina en plein sénat. Si César eût été en prison, certainement ce généreux Romain aurait demandé que l’ennemi vaincu fût jugé», in «Moniteur», VII, n. 343, Convention nationale, suite de la séance du jeudi 6 décembre 1792, suite de la discussion sur le jugement de Louis XVI, p. 1445.
42 Esemplare a questo proposito la posizione di Marey: «L’expulsion des Tarquins ensanta la République, et la mort de César le triumvirat», ibidem, VIII, n. 20, Convention nationale, séance du mercredi 16 janvier 1793, suite de le troisieme appel nominal sur le jugement de Louis Capet, p. 108.
43 Propongo un solo esempio, dei numerosissimi riscontrabili in questo periodo, che vede opposti Saint-Just e Faye. Mentre il primo reiterava il suo ragionamento, opponendosi all’ipotesi dell’esilio: «Bru-tus chassa les Tarquins pour assurer la liberté de Rome; mais ici, je ne sais pas si l’on ne chasse point les Bourbons pour faire place à d’autres Tarquins. Rome avait des lois; Rome avait Brutus, je ne le vois point ici; quand nos Tarquins seront chassés, j’attends Catilina avec son ar-
284 Daniele Di Bartolomeo
durò fino all’ultimo giorno di votazione e vide ancora una volta due convenzionali confrontarsi in modo “agonisti-co” sul terreno di questo stesso exemplum, arringando la platea con un’eloquente esortazione a “consultare” la sto-ria: mentre Basire ricordò ai deputati che «Tarquin, exilé, se présenta bientôt devant Rome avec une armée. Corio-lan, simple sénateur banni, mit en péril la République Romaine. Consultez l’histoire, vous verrez que les despo-tes ne pardonnent jamais à leur patrie»; a sua volta Alas-soeur invocò l’autorità del medesimo precedente antico per sostenere la soluzione opposta44.
La propaganda girondina rilevò, nel tentativo di rico-stituire una preminenza politica ormai fortemente debili-tata, un’ulteriore e insidiosa assonanza con la vicenda romana: il paragone tra il duca d’Orléans e Lucio Tarqui-nio Collatino, ambedue legati indissolubilmente alla dina-stia reale45. Lanjuinais denunciò in questi termini l’esi-
mée […] Je demande qu’on chasse tous les Bourbons, excepté le roi qui doit rester ici, vous savez pourquoi», ibidem, VII, n. 353, Convention na-tionale, séance du dimanche 16 décembre 1792, p. 1501; Faye contestava tale uso del precedente romano: «On a cru, en vous citant l’exemple des Romains, entraîner votre dècision; mais citoyens, voyez ce qu’était la République romaine, lorsque les Tarquins en furent chassés, et voyez ce qu’est la République française au jour où l’on vous propose de chasser les Bourbons», ibidem, VII, n. 355, Convention nationale, séance du 19 décembre 1792, p. 1512.
44 «Pour établir mon opinion, j’ai consulté l’histoire. Rome chassa ses rois, et eut la liberté; César fut assasiné par Brutus, et eut un successeur; les Anglais immolarent leur tyran, mais bientôt ils rentrerent dans les fers qu’ils venaient de briser. Je pense donc que pour établir la liberté, Louis doit être enfermé jusqu’à la paix, et à cette époque, banni», ibi-dem, VIII, n. 20, Convention nationale, séance du mercredi 16 janvier 1793, suite de le troisieme appel nominal sur le jugement de Louis Capet, p. 107.
45 «Tarquin le superbe été rappelé par eux, sans le terrible courage de Brutus sacrifiant la paternité au salut de la République naissante, et un successeur lui eût peut-être été donné, sans la sagesse du même consul déterminant le peuple à bannir Lucius, le dernier du sang des Tar-
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 285
stenza di un complotto giacobino teso alla restaurazione monarchica:
Comment se sont faites les élections populaires de Paris, dont le dernier député se trouve être Ėgalité? sous la ha-che populaire, par les ordres de ceux qui devaient parta-ger le protectorat qui lui était destiné. Ce n’est peut-être pas sans dessein qu’on a amené ce nouveau Collatin parmi nous.46
I rivoluzionari francesi, alla ricerca di orizzonti di legit-timazione alternativi per sostenere la fondazione della Repubblica, rappresentarono una competizione “agonisti-ca” sul terreno della storia, contendendosi apertamente l’eredità dell’archetipo del repubblicanesimo47.
4.2 Fazioni contro: la roche Tarpeïenne e le ragioni del Terrore
La competizione per l’occupazione del “trono vuoto” si espresse anche sottoforma di un duello per l’attribuzio-ne di significato alla transizione repubblicana; uno scon-tro che disegnava, giocando con i riflessi della storia anti-ca, le possibili evoluzioni nefaste di questo processo48.
quins», ibidem, VII, n. 353, Convention nationale, séance du dimanche 16 dé-cembre 1792, p. 1500. Si tratta di un intervento del convenzionale Buzot.
46 Ibidem. 47 Il passo che segue, tratto da un discorso di Louvet, esprime in
modo esplicito la competizione tra girondini e giacobini sull’eredità di Bruto: «Représentans du peuple, ce n’est pas moi qui viens appuyer la proposition de Buzot, c’est l’immortel fondateur d’une République fa-meuse, c’est le pere de la Liberté Romaine, Brutus … (On murmure) Oui, Brutus […] Oui, Brutus; et son discours, prononcé, il y a plus de mille ans, est tellement applicable à notre situation actuelle, qu’on croi-rait que je l’ai fait aujourd’hui […] Francais, je jure que c’est Brutus qui parle; je ne suis que son interprete fidelle, écutez attentivement Brutus […] Ainsi parla Brutus: et qu’il me soit permis de faire entre la France et Rome, entre les Tarquins et les Bourbons, un rapprochement que je pourrais étendre, mais que j’abrégerai», ibidem.
48 Come avremo modo di dimostrare nel corso di questo paragrafo
286 Daniele Di Bartolomeo
Nei mesi che precedettero la nascita del Comitato di salute pubblica e la proscrizione girondina, i membri di questa stessa fazione si adoperarono per attribuire a Ro-bespierre la volontà di una restaurazione dispotica della sovranità esecutiva, accusandolo di ambire alla dittatura, al protettorato, al triumvirato, al tribunato, addirittura al-la corona, sulle orme di Cesare, Silla, Catilina e Crom-well49. Barbaroux evocò l’immagine del supplizio riserva-to ai traditori nell’antica Roma, esplicitando in termini i-nediti la radicalizzazione dello scontro politico:
je les ai dénoncés, je les dénonce, je les dénoncerai, et il n’y aura de repos pour moi que lorsque le assassins se-ront punis, les vols restitués, et les dictateurs precipités de la roche Tarpeïenne. Voyez la conduite de Robespierre [...] Avant le 10 aout, il nous fait appeler chez lui, Rebec-qui et moi; il ne nous parle que de la necéssité de se ral-
conclusivo, lo scontro retorico tra montagnardi e girondini si giocò es-senzialmente sulla storia di Roma – e su quella della prima rivoluzione inglese – ma non sull’antagonismo Sparta-Atene, a meno che non si voglia chiamare in causa anacronisticamente la polemica promossa da Camille Desmoulins contro Robespierre sul finire del 1793.
49 A tal proposito è indicativo il seguente passo, tratto da un dis-corso nel quale Louvet attaccò pesantemente Robespierre: «cet homme qu’on n’entendait parler que de son mérite, des perfections, des vertus sans nombre dont il était pourvu, et qui, après avoir vanté la puissan-ce, la souveraineté du peuple, ne manquait jamais d’ajouter qu’il était peuple, ne maquait jamais d’ajouter qu’il était peuple lui-même, ruse aussi grossiere que coupable, ruse dont se sont toujours servis les usurpateurs, depuis César jusqu’à Cromwel, depuis Sylla jusqu’à Ma-zaviel […] Il parut incontestable qu’entre ces hommes existait un pacte secret dont le but devait être de faire tourner au profit de leur ambition personnelle la révolution qui se préparait, puisqu’ils tentaient de faire tomber la représentation nationale, et qu’après avoir contribué à ren-verser les rois, ils voulaient devenir rois eux-memes […] Je me ressou-vins de Sylla […] mais dans un chemin où les attendaient des hommes de quelque résolution, et qui, ils l’avaient juré par Brutus, ne leur au-raient pas laissé la dictature plus d’un jour», in «Moniteur», VII, n. 305, Convention nationale, suite de la séance du lundi 29 octobre 1792, pp. 1293-4.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 287
lier à un homme jouissant d’une grande popularité, et Panis, en sortant, nous désigne Robespierre pour dicta-teur [...] Les méchans? oui, ceux-là vous entournent, et c’est Catilina qui les commande50.
L’Incorruttibile contrattaccò stigmatizzando l’ambiguo comportamento dei suoi avversari, con un’esplicita allu-sione alla subdola condotta inscenata da Marco Antonio dopo l’uccisione di Cesare51.
È evidente come la quasi totalità dei rivoluzionari ese-crasse l’ipotesi dittatoriale come segno della degenerazio-ne politica della repubblicana romana e, più in generale, di ogni esperienza rivoluzionaria, sulla scorta del prece-dente inglese52.
La stagione politica apertasi con la condanna a morte del re, vide consumarsi tragicamente lo scontro tra Mon-tagna e Gironda, inaugurando la pratica del Terrore. La
50 Ibidem, VII, n. 306, Convention nationale, séance du mardi 30 octobre 1792, p. 1298-9.
51 «De quoi suis-je accusé? D’avoir conspiré pour parvenir à la dic-tature ou au triumvirat, ou au tribunat […] Quand le consul de Rome eut étoussé la conspiration de Catilina, Clodius l’accusa d’avoir violé les lois […] cessez d’agiter sous mes yeux la robe sanglante du tyran: ou je croirai que vous voulez remettre Rome dans les fers», ibidem, VII, n. 311, Convention nationale, séance du lundi 5 novembre 1792, p. 1319. Saint-Just riprese questo stesso riferimento per giustificare le ultime eccellen-ti esecuzione nella primavera del 1794: «Où sont-ils les Antoine qui regrettent Hébert, qui voulut égorger la représentation nationale et les patriotes; qui regrettent Danton qui a tout fait contre la liberté? Mal-heur à ceux qui prendraient la défense des cospirateurs!», in «Moniteur», X, n. 207, Convention nationale, séance du 26 germinal II (15 IV 1794), p. 840.
52 «Que l’histoire des révolutions dont le succès fut malheureux, soit utile du moins à la nôtre. Les hypocrites amis du Peuple ont porté dans tous les tems le même masque et parlé le même langage que les nôtres; et Cromwel et ses partisans ne conduisirent pas autrement le Peuple anglais du gouvernement républicain au protectorat, et du pro-tectorat à la royauté», ibidem, VII, n. 304, Convention nationale, rapport fait au nom de la Commission de neuf, par M. Buzot, dans la séance du samedi 27 octobre 1792, p. 1287.
288 Daniele Di Bartolomeo
sedimentazione di un discorso politico incline alla costru-zione ideologica dell’avversario portò alla riduzione di ogni alterità al fantasma dell’aristocrate, assimilando il nemico politico allo straniero per eccellenza53:
J’habite les hauteurs (continuant de montrer l’amphithéa-tre du coté gauche) que l’on désigne ironiquement sous le nom de la Montagne; mais je les habite sans insolence. Ce passage, que l’on attaque, deviendra celui des Ther-mopyles. Là, des Spartiates sauront mourir, s’il le faut; mais en mourant, ils sauront sauver la Liberté.54
L’antichità si apprestava così a fornire un’ulteriore le-gittimazione alla violenza politica55. Nella primavera del 1794, all’alba dell’ennesima “infornata”, tra i banchi della Convenzione risuonò ancora la tragica esortazione di Saint-Just: «Où est donc la roche Tarpeienne? Et n’avez-vous point le courage d’en precipiter l’aristocrate, de quelque masque il couvre son font d’airan?»56.
5. Conclusione
Il discorso rivoluzionario sul mondo antico, pienamen-te riconducibile alla pratica retorica che definiamo uso po-litico della storia, costruì un orizzonte storico comparati-vo in presenza di una trasformazione radicale della socie-tà: gli stessi riflessi della storia chiamati a supportarla of-
53 Cfr. F. BENIGNO, Il cittadino …, cit. 54 «Moniteur», VII, n. 363, Convention nationale, séance du 26 décembre
1792, p. 1544. Si tratta di un intervento del convenzionale montagnar-do Jean Julien.
55 Uno scontro verbale tra Hébert e Brissot, giocato sul topos della congiura di Catilina, esemplifica al meglio questa dinamica. Cfr. ibidem, Tribunal révolutionnaire, séance du 5 brumaire II (26 X 1793), p. VIII/2° feuille.
56 Ibidem, X, n. 207, Convention nationale, séance du 26 germinal II (16 IV 1794), p. 839-40.
Il recupero dell’antico nella pubblicistica rivoluzionaria … 289
frirono agli attori storici, inevitabilmente, strumenti di analisi, ragioni e spazi retorici per pensarne ed esprimer-ne la contestazione.
Tale pratica, in un continuo processo di rimescolamen-to dei discorsi, è sopravvissuta al Terrore, garantendo alla retorica termidoriana una spiegazione rassicurante del dé-rapage giacobino e all’ascesa napoleonica una prospettiva di legittimità; senza soluzione di continuità si è sedimen-tata nel patrimonio genetico della storiografia ottocente-sca, contestualmente all’emergere dei suoi presupposti di scientificità. Si può escludere, conseguentemente, la sussi-stenza di una differenziazione sostanziale tra l’uso politi-co dell’antichità promosso da Robespierre e le Leçons d’histoire tenute da Volney all’Ecole Normale nei primi mesi del 179557.
In tal senso andrebbe evitata la tentazione di rinvenire nella trasformazione termidoriana della relazione antichi-tà-Rivoluzione un dato storiografico che svilisca la suc-cessiva rilevanza del discorso storico nella sfera pubblica francese; addirittura, eleggendola a criterio interpretati-vo circa la conclusione della Rivoluzione stessa, in rela-zione al divenire sempre più formale e infrequente della referenza al mondo antico58. L’assonanza tra la Rivolu-zione francese e l’esperienza delle repubbliche antiche, e-laborata e riconosciuta dai rivoluzionari stessi, non può pertanto essere assunta come elemento di valutazione in-terpretativa della processualità rivoluzionaria, in una pro-spettiva constraining che ne sottovaluti la caratterizzazio-ne manipolatoria.
Il tema in questione andrebbe ripensato valutando le potenzialità di una comparazione con l’uso dell’antico
57 Sul discorso di Volney si veda l’analisi proposta da T.H. PARKER,
The Cult of Antiquity …, cit., p. 2. 58 Cfr. C. MOSSÉ, L’antiquité …, cit., p. 12.
290 Daniele Di Bartolomeo
praticato in altre fondamentali esperienze rivoluzionarie della modernità, senza sottovalutare l’interazione retorica dei rivoluzionari francesi con altri passati: la storia nazio-nale e, soprattutto, il precedente inglese di metà Seicento. Con l’obiettivo di rilevare la poliedrica utilità offerta dalla comparazione storica, il suo porsi come elemento di valu-tazione e comprensione delle possibili virtualità evolutive della dinamica politica, per cogliere nella sua complessità l’interazione tra la dimensione concreta dell’evoluzione storica e i tentativi di concettualizzazione retorica messa in atto dagli attori storici59.
Questa panoramica sul recupero dell’antico nel dibatti-to rivoluzionario evidenzia, da un’angolazione inevita-bilmente parziale, le potenzialità di una prospettiva sto-riografica che rivaluta la dimensione discorsiva nell’am-bito di una storia possibile.
59 Come ha scritto Francesco Benigno, occorre «sorvegliare da vici-
no la continua trasformazione, durante la temperie rivoluzionaria, del discorso politico in relazione al rapido succedersi degli eventi e alle condizioni di straordinaria incertezza degli attori storici», F. BENIGNO, Specchi della rivoluzione …, cit., p. 59.