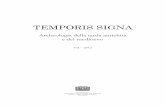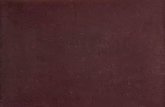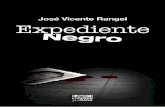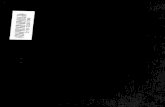Geografía de Río Negro. Unidad III - El Clima de Río Negro. 1989
La villa genovese nella Bormida Astigiana: il palazzo Di Negro Pallavicini a Mombaruzzo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of La villa genovese nella Bormida Astigiana: il palazzo Di Negro Pallavicini a Mombaruzzo
1
La villa genovese nella Bormida Astigiana:il palazzo Di Negro Pallavicini a Mombaruzzo
DAVIDE CANAZZA, MARIA TERESA CAPRILE*
Fig. 1- Il palazzo feudale diMombaruzzo visto d’infilatatra le case del borgo.
Premessa
Quasi quattro secoli di dominazione da parte di famiglie genove-si hanno lasciato un’impronta ancora riconoscibile sul territoriodi Mombaruzzo, soprattutto per quanto riguarda l’architetturaresidenziale: è il caso del palazzo marchionale, meglio conosciu-to come Palazzo Pallavicini, edificato in posizione dominante dalpunto di vista visivo, in antitesi coi ruderi dell’antico castello acui il nuovo centro del potere si sostituisce, diventando il nuovofulcro del borgo. Esso costituisce non solo un esempio mirabiledi residenza in stile genovese del secolo XVII, ma anche un casounico nel suo genere in un territorio tradizionalmente soggetto atipologie tipicamente piemontesi. Rappresenta inoltre un piccolomiracolo architettonico, se si considera che è giunto sino ai gior-ni nostri mantenendo pressoché inalterate molte delle sue carat-teristiche originali.Per ricostruire la storia dell’edificio è stato necessario ripercor-rere i passaggi di proprietà del feudo di Mombaruzzo, documen-tato tra i possedimenti delle più facoltose famiglie aristocratichedi Genova, ed affrontare lo studio delle tipologie architettonichegenovesi e di alcune loro esemplari applicazioni. Questi passag-gi si sono resi necessari per la scarsità di fonti scritte e graficherelative alla paternità e al percorso progettuale del palazzo, con-siderato il taglio prettamente storico architettonico del presentestudio. Per quanto concerne l’inquadramento stilistico e architet-tonico, si è proceduto alla consultazione della bibliografia relati-va ai palazzi cittadini genovesi e alle residenze di villa, a cominciare dalla più antica pubblica-zione sull’argomento, vale a dire la raccolta di rilievi di edifici genovesi dei secoli XVI e XVIIedita ad Anversa nel 1622 per opera di Pietro Paolo Rubens. La storia dell’assetto proprietariodella dimora di Mombaruzzo si può ricostruire agevolmente grazie alla pubblicazionedell’Inventario dell’Archivio Pallavicini1 di Genova. È invece in corso lo spoglio dei carteggi ori-ginali teso ad indagare le tematiche individuate in questa prima parte del lavoro.
Architetture genovesi nei Feudi Imperiali Liguri.
Fin dal medioevo a Genova si sviluppa la cultura della villa, ossia l’edificazione di residenzenobiliari suburbane attorniate da aree agricole più o meno estese, affidate alla cura del “villano”.Successivamente al 1528, anno in cui la nuova costituzione repubblicana conferisce alla nobiltàgenovese un ruolo ancora più predominante, si assiste ad una crescita economica tale da per-mettere agli esponenti delle famiglie più importanti di investire in campo edilizio.I nobili genovesi abbelliscono e riedificano i palazzi cittadini, mentre il numero delle ville subur-bane aumenta in maniera esponenziale, grazie anche al nuovo stile architettonico importato dal-l’architetto perugino Galeazzo Alessi e dai suoi allievi, tra i quali vale la pena ricordareDomenico e Giovanni Ponzello, Bernardo Spazio e Bernardino Cantone. Proprio nei palazzi di
* A M.T. Caprile si deve il paragrafo Elementi di cultura materiale: la cucina del palazzo Di Negro Pallavicini aMombaruzzo, a D. Canazza tutte le restanti parti.
1 L’inventario dell’Archivio Pallavicini è stato pubblicato dagli Atti della Società Ligure di Storia Patria, a cura di M.BOLOGNA, 1994.
2
Fig. 2 - Il palazzo Spinola diRocchetta Ligure (AL): pro-spetto principale.
villa le teorie di Alessi trovano la massima applicazione, essendo questi, per la stragrande mag-gioranza, costruiti ex novo e non provenendo invece, come per gli esempi cittadini, dall’accor-pamento di più cellule di origine medievale.La dimora alessiana si presenta a volume cubico, separato dal suolo da un ampio zoccolo (su cuisi affacciano le finestre del piano seminterrato) e culminato da un tetto a piramide. Sulla faccia-ta le scansioni dei piani sono sottolineate per mezzo di cornici e fascioni, e le ripartizioni deglispazi orizzontali attraverso l’uso di lesene o rientranze dei volumi centrali.La pianta è assiale, con la parte centrale che svolge funzioni distributive: ospita i loggiati (ovestiboli) e l’atrio (o portico) sul quale si innestano ampie rampe di scale. Le ali laterali, ciascu-na di larghezza inferiore rispetto alla parte centrale, sono suddivise in sale.I palazzi cittadini, quasi sempre rimodellati su preesistenze medievali, faticano ad adattarsi allesimmetrie alessiane e presentano quindi maggiori irregolarità ed incongruenze stilistiche; tuttociò, naturalmente, non avviene quando gli edifici sorgono su aree rese sgombre da demolizionio in nuove lottizzazioni, come nel caso di Strada Nuova (via Garibaldi) e Strada Balbi.Tra la fine del XVI e tutta la prima metà del XVII secolo, le principali famiglie genovesi, giàfeudatarie di numerosi territori dell’entroterra ligure, acquisiscono titoli nobiliari direttamentedall’imperatore o da monarchi stranieri, spesso come risarcimento di prestiti pecuniari.Intorno alla metà del XVII secolo si diffonde un terzo tipo di residenza: il palazzo feudale. Lostile adottato è di chiara derivazione alessiana, tuttavia vi si può intravvedere un irrigidimentoverso forme più scarne ed austere, forse a causa della scarsa disponibilità di manodopera spe-cializzata.Due casi esemplificativi sono forniti dal palazzo Spinola di Rocchetta Ligure e dal palazzoPallavicini di Cabella Ligure, entrambi in provincia di Alessandria.Il primo si presenta come un imponente cubo scandito in piano terra, primo ammezzato, pianonobile, secondo e terzo ammezzato. La pianta rispecchia i dettami compositivi dell’epoca: laparte centrale consiste in un ampio atrio rettagolare, alle cui estremità si attestano due vestiboliabsidati2 sui quali si aprono l’ingresso principale da una parte e l’accesso al retro dall’altra. Sullato sinistro dell’atrio centrale si innesta lo scalone che conduce al piano nobile, costituito da unampio salone su cui si affacciano le sale laterali. Il secondo sorge sui ruderi del castello medievale e appare come un grosso cubo, appoggiato adun basamento in pietra che conferisce al complesso l’aspetto di una vera e propria fortezza. Laresidenza è formata da piano terreno, primo ammezzato, piano nobile e secondo ammezzato; le
2 La pianta appare molto simile al “Palazzo E” di Rubens, vale a dire villa delle Peschiere a Sampierdarena, termina-ta nel 1556 su progetto di Galeazzo Alessi per Tobia Pallavicini.
Fig. 3 - Comune di RocchettaLigure, Ufficio Tecnico,Pianta del primo pianoammezzato del palazzo Spi-nola di Rocchetta Ligure:sono visibili i due vestiboli ela scala che si innestasull’atrio.
3
Fig. 4 - Pianta del piano terra di villaPallavicino detta “delle Peschiere”,progettata intorno alla metà del XVIsecolo da Galeazzo Alessi, nel rilievodi Pietro Paolo Rubens, “I palazzi diGenova”, del 1622.
Fig. 5 - Il palazzo Pallavicini di CabellaLigure (AL), costruito in posizionedominante rispetto al borgo, sul sito diun preesitente castello medievale.
Fig. 6 - Facciata del palazzo Spinola diArquata Scrivia (AL).
Fig. 7 - Palazzo Spinola di Pietrabissara(GE)
ali laterali sono leggermente avanzate rispetto alla parte centrale3. Vale la pena ricordare anche il palazzo Spinola di Pietrabissara4, dalle forme più spartane, maallo stesso tempo meno imponente. Esso è costituito dal piano terreno, primo ammezzato, pianonobile e secondo ammezzato; in pianta presenta una forma ad U, unico elemento in grado dimovimentare la severità del volume, accentuata dalla totale mancanza di elementi decorativiesterni, sia plastici che pittorici.Il palazzo Spinola di Arquata Scrivia (AL) esce leggermente dalla norma: esso è, infatti, piùparagonabile ad una residenza di città che a una villa suburbana, a causa delle trasformazionisubite dal medioevo fino alla metà del XVII secolo. Lo schema seguito in pianta è il solito: atriocentrale, suddiviso in due parti da tre arcate poggianti su due pilastri quadrangolari; nella por-zione posteriore sinistra si innesta lo scalone. Al piano nobile si trova un salone centrale fian-cheggiato da una serie di stanze: a causa della mancanza di spazio in profondità (l’edificio èaddossato alla collina retrostante), il palazzo si sviluppa in larghezza. I piani sono tre: seminter-rato, terreno e nobile; la parte centrale, corrispondente a tre assi di finestre, è sopraelevata di unpiano allo scopo di equilibrare la sproporzione data dall’eccessiva lunghezza rispetto all’altezza.Queste caratteristiche rendono il palazzo arquatese un caso particolare nell’insieme dell’ediliziaresidenziale seicentesca dell’oltregiogo ligure.
3 L’aspetto esterno ricorda quello di villa Lomellini Doria-Podestà a Genova Pra, opera di Bartolomeo Bianco.4 Oggi la località è frazione di Isola del Cantone, in provincia di Genova, ma un tempo era Feudo Imperiale a sé stante.
4
Fig. 8 - Palazzo Ambrogio DiNegro a Genova Prospetto suPiazza Banchi
Fig. 9 - Pietro Paolo Rubens,pianta del palazzo Ambrogio Di Negro.La pianta è stata raddrizzataper mezzo di strumenti infor-matici, poichè quella originaleè stampata capovolta.
Assetto storico - proprietario del feudo di Mombaruzzo
Il feudo di Mombaruzzo viene ceduto nel 16245 da Ferdinando Gonzaga, duca diMantova e marchese del Monferrato, a Lelia6 Di Negro, per appianare un debitocontratto col nonno della beneficiaria, quell’Ambrogio Di Negro che fu doge dellaRepubblica di Genova dal 1585 al 1587.La prima feudataria genovese di Mombaruzzo è l’unica ereditiera di una rilevan-te proprietà immobiliare nel capoluogo ligure. Tra gli edifici da lei posseduti, valela pena ricordare il palazzo Di Negro posto alla confluenza tra via San Luca7 epiazza Banchi, cuore economico della città del secolo XVI. Esso fu eretto pervolere di Ambrogio Di Negro (1519-1601) tra il 1569 e il 1572, in seguito all’ac-corpamento di alcuni lotti medievali acquistati dal committente all’interno delproprio clan famigliare8.L’edificio presenta ancora un ampio cortile loggiato, aperto sul vicolo retrostante;sul lato occidentale si innesta lo scalone che conduce ai due piani nobili superio-ri, entrambi adibiti ad abitazione privata. La facciata era decorata con motivi clas-sici, come si può vedere nel rilievo di Pietro Paolo Rubens del 1622. Il palazzo era
iscritto ai rolli della pubblica ospitalità9 per gli anni1576, 1588, 1599, 1614 e 1664.Notevole importanza ricopre anche il palazzo di villaa Fassolo, località della periferia occidentale diGenova a circa 1,5 km dal centro; l’edificio, meglioconosciuto come “Villa Rosazza”, dal nome dei pro-prietari ottocenteschi, venne fatto costruire daOrazio Di Negro, padre di Lelia, su un’altura detta lo“scoglietto”, in un’area appartenente alla famiglia DiNegro fin dal secolo XV. In origine la villa era cir-condata da un immenso giardino all’italiana10, riccodi peschiere e ninfei, viali e rampe che si sviluppa-vano sul terrazzamento della collina retrostante.Nel 1787 l’architetto Andrea Tagliafichi, su incaricodel nuovo proprietario Giovanni Luca Durazzo, pro-cede ad un riadattamento in forme neoclassiche delpalazzo e del giardino; successivamente la villaviene acquistata dalla famiglia Rosazza. Attualmente
appartiene al Comune di Genova e ospita un istituto scolastico.Lelia Di Negro sposa il consanguineo Gio Gerolamo Di Negro q. Francesco11, proprietario di unaltro palazzo suburbano, situato anch’esso a Fassolo: villa Di Negro Brignole Sale-Negrone, ora
5 Gli avvenimenti antecedenti a questa data non sono fondamentali allo scopo del presente studio; basterà ricordareche Mombaruzzo viene inserito nel X secolo nella marca Aleramica. In seguito diventerà possedimento dei marchesidel Monferrato e quindi dei Gonzaga.6 F. Guasco confonde Lelia Di Negro con Letta Alberici, andata in sposa a Gerolamo Di Negro, marchese diMombaruzzo; in realtà Giovanni Gerolamo Di Negro q. Francesco assume tale titolo nobiliare grazie al matrimoniocon la consanguinea Lelia Di Negro, figlia di Orazio q. Ambrogio (cfr. M. BOLOGNA, 1994).7 Via San Luca costituisce la via principale della Genova medievale, all’epoca denominata carrubeus rictus.8 La realizzazione di una dimora di tali dimensioni comporta l’impegno, da parte di Ambrogio, a destinare gli spazial piano terreno alle botteghe, dal cui affitto si ricavano finanziamenti per le ragazze povere dell’albergo dei Di Negro.Genova nel XVI secolo è divisa in alberghi, ossia consorterie nobiliari di cui fanno parte sia i nobili appartenenti alclan, sia membri di classi popolari e artigiane da loro protetti (E. POLEGGI, 2002).9 Nei secoli XVI e XVII i titolari dei più fastosi palazzi cittadini erano tenuti ad essere inseriti in un elenco di dimo-re obbligate ad ospitare le personalità straniere in visita nella città, dal momento che non esisteva una reggia. Quandose ne presentava l’occasione, il palazzo veniva estratto a sorte tra i nominativi posti all’interno di un contenitore chia-mato bussolo. Il prescelto era tenuto a dare ospitalità e ad assistere l’ospite per tutto il tempo della sua permanenza aGenova. 10 Il parco è stato ampiamente rimaneggiato in seguito alla realizzazione della ferrovia nella seconda metà del secolo XIX.11 Giovanni Gerolamo Di Negro era il cugino primo di Orazio, padre di Lelia: Francesco, padre di Gio Gerolamo, erainfatti il fratello di Ambrogio Di Negro.
5
Fig. 10 - Facciata di villaRosazza, già dei Di Negro epoi della famiglia Durazzo.L’aspetto attuale è quello con-feritole in seguito alla trasfor-mazione operata da AndreaTagliafichi nel 1787.
dei Preti della Missione.Dalla loro unione nasce Ambrogio, il quale, tra il 1635 e il164512, fa edificare il palazzo marchionale di Mombaruzzo13,arricchendo quindi il suo già cospicuo capitale immobiliare.Tuttavia, verso la metà del secolo XVII, gli affari della famigliaDi Negro sembrano navigare in cattive acque: Ambrogio è a suavolta debitore di una grossa cifra nei confronti del procuratore disua madre, Ansaldo Imperiale Lercari14. Nel 1652 quest’ultimo riceve come pagamento il feudo diMombaruzzo, cessione ratificata con l’investitura da parte diCarlo III duca di Mantova e del Monferrato.Alla sua morte, avvenuta nel 1673, Ansaldo lascia tutti i suoibeni, tra cui il feudo monferrino, al primogenito DomenicoImperiale Lercari, il quale ha, come uniche eredi, due figlie femmine, Caterina e Giovanna: essericevono investitura dal duca di Mantova nel 1693.Giovanna Imperiale Lercari muore in convento nel febbraio del 1705, lasciando come unica pro-prietaria della fortuna paterna la sorella Caterina: quest’ultima, nello stesso anno, sposa PaoloGerolamo Pallavicini, portando tutti i suoi beni in dote al marito.Negli anni successivi i coniugi Pallavicini sembrano intenzionati a liberarsi dei loro possedi-menti monferrini: nel 1710 è già avviata la pratica di cessione al conte Carlo Saluzzo. Tuttavial’affare non va in porto; anzi, da quella data, Caterina e Paolo Gerolamo risiedono stabilmentenel loro palazzo di Mombaruzzo. Nel 1734, dopo varie suppliche, i coniugi Pallavicini ottengo-no l’infeudazione anche dal Re di Sardegna Carlo Emanuele, diventato signore del Monferratoa scapito dei Gonzaga.Nel 1752 Domenico Pallavicini, primogenito di Caterina e Paolo Gerolamo, eredita il feudo: allasua morte, avvenuta nel 1788, trovandosi egli senza eredi diretti, lascia Mombaruzzo a RanieriPallavicini, figlio del cugino Giovanni Carlo, a condizione di mutare il proprio nome inDomenico.Ranieri alias Domenico muore improvvisamente a Pisa nel 1798 senza lasciare alcun erede. Ilfeudo15 passa quindi al fratello Paolo Gerolamo, che assume anch’egli il nome di Domenico.Con la morte di quest’ultimo nel 1833, le proprietà di Mombaruzzo passano al figlioIgnazio Alessandro; in seguito saranno amministrate da Teresa Pallavicini Durazzo e dalladi lei nuora Matilde Giustiniani Negrotto Cambiaso. Questi possedimenti rimangono inmano genovese sino al 1978, anno in cui la marchesa Carlotta Giustiniani Pallavicinivende la maggior parte delle sue proprietà alla famiglia Damiano di Asti.
Il palazzo Di Negro Pallavicini di Mombaruzzo: un’interpretazione stilistica e artistica.
Come anticipato nell’introduzione, non si conosce la paternità progettuale dell’edificio,tuttavia si può affermare che l’architetto, sicuramente di formazione ligure, si sia ispiratomaggiormente agli esempi del periodo alessiano piuttosto che a quelli, a lui più vicini intermini cronologici, di Bartolomeo Bianco16. Per quanto riguarda le maestranze, è verosimile supporre l’impiego di manodopera locale,
12 Si apprende ciò dal contratto di cessione del feudo ad Ansaldo Imperiale Lercari nel 1652: in particolare, è citatala Domus Magna di Ambrogio di Negro.13 Proprio a causa della fondazione del palazzo ad opera di un membro di questa famiglia, si ritiene più appropriatala doppia denominazione di palazzo Di Negro – Pallavicini, come d’ora in poi sarà chiamato nel corso del presentestudio.14 L’origine del doppio cognome è dovuta al fatto che Giovanni Carlo Imperiale, nel 1587, viene nominato erede daFranco Lercari, con la clausola dell’assunzione del doppio cognome. Ansaldo, nato nel 1610, è il figlio di GiovanniCarlo.15 I feudi sono stati in realtà soppressi da Napoleone il giorno 8 luglio 1797. La famiglia Pallavicini rimane proprie-taria dei beni terreni e immobiliari di Mombaruzzo.16 Architetto lombardo che operò a Genova tra la fine del ‘500 e la prima metà del secolo successivo. Tra le sue operepiù importanti vanno ricordati i palazzi di via Balbi, tra cui la sede dell’Università di Genova, e la chiesa del Gesù inpiazza Matteotti.
Fig. 11 - Prospetto principaledel palazzo Di Negro Palla-vicini di Mombaruzzo; in primopiano il sistema di scale checonduce all’accesso principale.
6
particolarmente versata nell’utilizzo del laterizio, materiale ampiamente disponibile in loco, concui il palazzo è stato edificato17.L’edificio si presenta come un cubo suddiviso in basamento (su cui si affacciano le finestre delpiano seminterrato, adibito a magazzino), piano terra, piano nobile e ammezzato; il volume ècoronato da una copertura piramidale, come nei più classici esempi di stile genovese.La facciata è suddivisa verticalmente da sette assi di finestre18, mentre gli orizzontamenti sonoscanditi da fascioni marcapiano. L’accesso è posto in corrispondenza dell’asse centrale del pianoterreno: la quota di entrata, più alta rispetto al piano stradale, viene guadagnata per mezzo di unsistema a doppia rampa di scale opposte tra loro.Il portale di accesso è circondato da una struttura a baldacchino, consistente in due lesene sovra-state da una trabeazione barocca; sulla sua sommità sono impostate due volute, al centro dellequali campeggia un tondo su cui si intravede ancora il blasone dei Pallavicini. La pianta è quadrata, con un lato di circa 23 metri, e rispetta l’assialità alessiana; il corpo cen-trale, più largo rispetto a quelli laterali, è, nella parte posteriore, arretrato di qualche metro; essoè inoltre suddiviso in due spazi separati da tre arcate poggianti su due pilastri quadrangolari.La stanza verso il fronte, più profonda, corrisponde all’atrio d’accesso (lettera A in planimetria);l’altro spazio (B), su cui si apre l’ingresso posteriore, costituiva in origine un vero e proprio log-giato verso il giardino retrostante19; sul lato sinistro di quest’ultima sala si innesta lo scaloneprincipale: la prima rampa, perpendicolare all’asse longitudinale dell’atrio, conduce ad un pia-
nerottolo su cui è impostata una seconda scala, ruotata di 180°, che porta sino al piano nobile.Entrambi gli ambienti mantengono le volte originali a padiglione lunettate; non si sono conser-vati, invece, gli elementi pittorici decorativi, mentre il pavimento originale in cotto è stato sosti-tuito da moderne piastrelle ceramiche. Le sale sul lato sinistro (C e D), adibite a locali di servizio (uffici dell’azienda agricola deiPallavicini), presentano volte a padiglione affrescate con motivi floreali e geometrici; quelle sullato destro ospitano la cucina (E), le dispense (F e G) ed altri locali di servizio (H, I e L). Dallacucina, attraverso una scala secondaria, si accede al primo piano ammezzato20, sempre riserva-
17 Contrariamente a quanto è avvenuto a Mombaruzzo, sia a Genova che nei Feudi Imperiali Liguri il materiale uti-lizzato è prevalentemente la pietra.18 Al piano terra, in corrispondenza dell’atrio, non ci sono finestre ai lati dell’ingresso. Per mantenere la simmetria conil piano superiore, le aperture erano state dipinte sulla facciata, come si può ancora vedere osservando il prospetto.19 Nel prospetto posteriore sono ancora visibili le grandi finestre ad arco in seguito tamponate.20 Non si tratta di un piano completo, bensì è solo la prima stanza a destra in facciata ad essere soppalcata.
Fig. 12 - Planimetrie dei pianiterreno e nobile del palazzo DiNegro Pallavicini di Momba-ruzzo.
7
to alla servitù. Anche in questi ambienti si sono conservate le volte (tutte a padi-glione) e le pavimentazioni originarie in cotto; comprensibilmente non appaionodecorazioni pittoriche, data la destinazione d’uso dei locali.Salendo al piano nobile si entra nell’anticamera posta sopra la loggia (M); la stan-za, che prende luce da tre finestre allineate sullo stesso lato, è coperta da una voltaa padiglione ed è interamente affrescata con motivi geometrici monocromatici.Dall’anticamera si passa al salone centrale (N), il quale rispecchia nelle dimen-sioni l’atrio sottostante (circa 11 x 8 metri) ed è illuminato da tre finestre; è sicu-ramente uno degli ambienti più interessanti per la sua ricca decorazione pittorica.La stanza a destra sul fronte dell’edificio (O) è una camera di ragguardevolidimensioni (circa 6 x 6 metri), voltata a padiglione e completamente affrescata:sulle pareti si aprono tre finestre (due in facciata, una sul lato); sul muro verso ilsalone è inserito un caminetto in marmo di Carrara, da cui si deduce un probabi-le utilizzo a salotto della stanza. Da qui si accede ad una camera di dimensioni minori (P), voltata a padi-glione e circondata su tre lati da locali di servizio, mentre l’unica paretefinestrata si affaccia sul lato destro del palazzo21.Un’altra ampia stanza (circa 6 x 6 metri), situata sul lato sinistro verso ilfronte del palazzo (Q), prende luce da due finestre aperte sulla facciata eda una posta sul lato sinistro dell’edificio: affacciandosi da queste apertu-re si gode la miglior vista che il palazzo offre sul borgo e la campagna. Da questa sala si accede ad un’altra camera più piccola (R), raggiungibiledirettamente anche dal salone centrale e illuminata da una sola finestraaffacciata sul lato sinistro del palazzo; altri due ambienti (S e T), attual-mente non visitabili, sono situati sul retro dell’edificio, raggiungibili dal-l’anticamera. Tutte le stanze del piano nobile conservano ancora i pavi-menti originali in cotto.Attraverso due scale di servizio (una situata tra le due camere del latodestro e l’altra accessibile dall’anticamera del salone), si raggiunge ilsecondo piano ammezzato e il sottotetto, dove si trovano gli alloggi dellaservitù. Dal locale posto sopra il salone è possibile accedere ai meccani-smi di controllo dell’orologio visibile centralmente in facciata, subitosopra il cornicione.Dal pianerottolo collocato tra le due rampe dello scalone principale sigiunge alla cappella privata dei feudatari, dedicata alla Vergine Assunta (inplanimetria contrassegnata col n° 1), passando prima attraverso la loggiadel matroneo. Volendo cercare una similitudine con esempi “importanti” di edilizia resi-denziale genovese, si può affermare che, almeno per quanto riguarda ladistribuzione planimetrica, il palazzo più simile a quello di Mombaruzzoè la villa Pallavicino “delle Peschiere”, corrispondente al “palazzo E” pub-blicato da Rubens. Circa il piano terreno, la dimora genovese presenta undoppio vestibolo loggiato (schema ripreso a Rocchetta Ligure, cfr. fig. 3 e4), mentre nel palazzo monferrino ne compare uno solo sul retro; i pianinobili, invece, sono pressoché identici22. La facciata può essere associata, dal punto di vista pla-stico, volumetrico e dimensionale, al “palazzo F” di Rubens, e cioè alla dimora di AngeloGiovanni Spinola in Strada Nuova (via Garibaldi), con la differenza che quest’ultima è ricca didecorazioni pittoriche, mentre l’edificio del borgo monferrino ne presenta una quantità minore. Meritano invece attenzione gli affreschi che abbelliscono gli interni del palazzo di Mombaruzzo,in particolare quelli del salone centrale (N) e delle due stanze laterali attigue (O e Q).Per quanto concerne il primo, il soffitto, voltato a botte con teste di padiglione, presenta un roso-
21 Considerata la presenza di figure umane dormienti disegnate sulla volta, si presume che questa stanza fosse unacamera da letto.22 La pianta di Rubens, come tutti i suoi rilievi, è pubblicata al contrario: la scala di “villa delle Peschiere”, in realtà,si innesta sul lato sinistro e non sul destro, come appare invece nell’illustrazione.
Fig. 13 - Il palazzo marchio-nale di Mombaruzzo vistodalla strada laterale.
Figg.14 - 15Pietro Paolo Rubens,Pianta del piano nobile divilla Pallavicino “dellePeschiere” e prospetto delPalazzo di Angelo GiovanniSpinola in Strada Nuova (viaGaribaldi) a Genova.
8
ne centrale policromo circondato da un’ampia cornice ottagonale, la quale dà origine, sulle vele,ad altre cornici e greche. Sulle testate delle volte campeggiano, da una parte, gli stemmi gentili-zi dei Pallavicini e dei Negrotto, dall’altra quello della famiglia Giustiniani: sono tutti dipinti concolorazione monocromatica a gradazioni di ocra e oro; proprio queste persistenze araldiche per-mettono di attribuire il ciclo pittorico ad un periodo immediatamente successivo all’anno 1833,quando i beni di Mombaruzzo passarono ad esponenti dei casati sopra citati, imparentati coiPallavicini. Nei quattro spigoli delle volte sono ricavate delle ornamentazioni a fantasia vegeta-le allusive alle arti, mentre al livello inferiore scorre un fascione con festoni dorati a motivi vege-tali interrotto, al centro di ciascun lato, da quattro tondi raffiguranti i poeti Dante, Ariosto,Petrarca e Tasso; per determinare un netto contrasto con le pareti verticali, è disegnato un fintocornicione in sfumature di giallo e oro. Tutto l’apparato pittorico del soffitto è dipinto in campobianco, in modo da creare un suggestivo effetto di stacco con lo sfondo azzurro delle pareti.Queste ultime presentano candelabre ornamentali a lato delle quattro porte sui lati più lunghi,contornate da cornici e greche. Sopra le porte si trovano scenette bucoliche che illustrano le quat-tro stagioni: la trebbiatura per l’estate, la vendemmia per l’autunno, l’atmosfera domestica perl’inverno e il paesaggio campestre per la primavera; sulla porta centrale è dipinto un riquadrodedicato ai giochi e alle feste della tradizione contadina. Al centro delle pareti maggiori, alcunecornici delimitano cinque riquadri (uno grande centrale e quattro più piccoli su ciascun lato) che,oggi spogli, ospitavano probabilmente altrettante tele (o arazzi). La volta della stanza laterale di destra (O) presenta, su sfondo bianco, una scena mitologica centra-le avente Giove come soggetto, contornata da grottesche policrome; al centro delle vele sono dise-gnati dei tabernacoli absidati, mentre negli angoli trovano posto dei riquadri a motivi mitologici.Sulle pareti spiccano grottesche policrome e finti tendaggi su campo verde acqua; un finto corni-cione pittorico divide le pareti dal soffitto.La volta a padiglione della stanza Q è abbellita da un rosone centrale ad ombrello, ai cui lati siscorgono candelabre decorate da vasi fioriti e lunette ornamentali, queste ultime circondate dacornici ricamate da fogliame, grappoli d’uva e figure incoronate di pampini. Al centro dellelunette si trovano delle fruttiere ornate con motivi fantastici, frutti, cacciagione e altri cibi: daquesti elementi è lecito ipotizzare che si trattasse di una sala da pranzo; sulle pareti, infine, è rea-lizzato un finto tendaggio policromo. La datazione del ciclo pittorico delle sale O e Q non è age-vole, per la mancanza di riferimenti indiretti, come gli stemmi per il salone, o di documenti inproposito; considerati i temi classicheggianti e le grottesche, riferibili ad una moda cinquecente-sca ripresa nel tardo settecento e primo ottocento, si può azzardare un’esecuzione avvenuta trala fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Maggiori informazioni potrebbero derivare da un’ac-
Fig. 16 - Veduta del salonecentrale del piano nobile(lettera N in planimetria.Si possono notare le decora-zioni della volta e delle pareti.
9
curata consultazione del già menzionato Archivio Pallavicini23.La qualità delle decorazioni interne unite al raffinato gusto architettonico fanno del palazzo DiNegro Pallavicini di Mombaruzzo un esempio notevole di residenza nobiliare e motivo di vantoper il territorio astigiano. Queste peculiarità meritano di essere annoverate tra i beni artistici e archi-tettonici meritevoli di tutela, non solo per il valore storico dell’edificio, ma anche allo scopo di ser-vire da esempio e termine di paragone per il restauro di altri edifici in condizioni più precarie.
Elementi di cultura materiale: la cucina del palazzo Di Negro Pallavicini a Mombaruzzo
Se ci si trova al pianterreno dell’edificio, e si oltrepassa la seconda porta sul lato destro dell’a-trio, non sfuggirà la bellezza e il notevole stato di conservazione della cucina che ci si apre dinan-zi: su questa ci si sofferma, proponendo in questo paragrafo i risultati della prima ricognizioneeffettuata su tale manufatto. Si può condividere l’importanza qui attribuita a un tale ritrovamen-to se si considera l’abbondanza di celebri testi sulla storia dell’alimentazione, cui non corri-sponde un’altrettanto cospicua produzione di pubblicazioni sulla cucina intesa come ambiente ecome storia del cucinare. La cucina di Mombaruzzo, databile alla fine del XVIII o agli albori delXIX secolo, riflette un’evoluzione dei metodi di cottura, che incidono evidentemente sul “come”e “cosa” mangiare, per ricostruire la quale si è ricorsi a contributi letterari, storici e soprattuttoetnografici. L’oggetto cucina, infatti, è sensibile alle innovazioni e alle mode, e non è raro, dun-que, che venga modificata, o, più spesso, ricostruita in base a nuove consuetudini, soprattuttoladdove c’è disponibilità di denaro e di spazio, come è certamente il caso dei palazzi nobiliari.Un contributo rilevante è offerto dall’etnografia, capace di evidenziare le strutture del quotidia-no, strutture di “lunga durata” attraversate, nei secoli, “dai petits mouvements, frutto dell’inven-tiva contadina”24, col suo poter ricorrere a informazioni vive, quale quelle fornite dai testimoniinterpellati, e visive, soprattutto laddove tacciano, o non siano accessibili, le fonti archivistiche.E’ necessario, dunque, collocare innanzitutto il manufatto al “momento giusto” nella storia dellacucina, intesa come evoluzione dello spazio dedicato alla manipolazione e trasformazione deicibi, e, naturalmente, anche a quella dei sistemi di cottura. In generale, prima del XII secolo, non esiste camino, e il fuoco domestico è solitamente allesti-to in un focolare posto al centro di una stanza: talvolta nel soffitto si pratica una piccola apertu-
23 Tutto l’apparato pittorico del palazzo è databile ad un periodo compreso tra la fine del XVIII secolo e la metà diquello successivo, eseguito per i Pallavicini. Non è possibile stabilire se gli affreschi attuali siano stati realizzati sopradecorazioni seicentesche, o se in precedenza le pareti dell’edificio fossero completamente spoglie. 24 P. SCHEUERMEIER, 1980, p. XV, introduzione all’edizione italiana a cura di G. PEDROCCO.
Fig. 17 - Affreschi dellavolta della sala O. Al centro,nel rosone, campeggia lafigura di Giove.
10
ra per lo sfogo del fumo, ma più spesso quest’ultimo “doveva trovare da solo una via d’uscita”(SEYMOUR, 1997)25. Un ambiente che, ancora ai giorni nostri, rispecchia questa pratica secolare è l’essiccatoio per lecastagne, di cui è possibile rinvenire esemplari funzionanti in varie zone della Liguria26, e che ècitato anche nella raccolta di Scheuermeier:
“nelle abitazioni viene usato già da molto tempo il camino normale, tuttavia si trovano ancora saltuaria-mente vecchie cucine di contadini al centro delle quali si è conservato il focolare quadrato di mattoni o dilastre di pietra. In questo ambiente vengono arrostite le castagne” (SCHEUERMEIER, 1980, vol. I, pp. 60-61).
Alla fine del medioevo il focolare viene gradualmente spostato dal centro del pavimento versouna parete, dove il fuoco può essere acceso direttamente sul terreno o poggiare su una lastra dipietra. Il caminetto con la cappa e la canna fumaria si diffonde gradualmente in ogni tipo di abi-tazione, anche se la sua progettazione resta a lungo imperfetta: le cappe sono molto larghe, ifocolari profondi, il tiraggio difficoltoso, e la stanza si riempie rapidamente di fumo27. Nel cami-no pende una catena che, tramite ganci, può variare in lunghezza, e alla cui estremità è sospesa,sul fuoco una pentola dotata di gancio o un paiolo, dove l’acqua ribolle in continuazione. Sulfocolare si cucina, dinnanzi al fuoco, avvicinandosi alle fiamme grazie a padelle dai lunghimanici, o approfittando della brace. Nelle dimore dei ricchi il camino diverrà nel tempo un ele-mento decorativo di cui far sfoggio nelle sale in cui si installa, ma nelle cucine resta caratteriz-zato da un corpo aggettante, con un’enorme cappa, e indubbiamente ingombrante. Forse non c’è descrizione più efficace e suggestiva, a questo proposito, di quella della cucina delcastello di Fratta, che ci testimonia una realtà abitativa che doveva essere abbastanza diffusaancora agli inizi del XIX secolo: le immagini sembrano provenire dal racconto di un bambino
25 Cfr. pp. 25-28.26 Sulle forme e caratteristiche dell’essiccatoio, denominato in Liguria, a seconda delle località, abergu o secchèisuconfronta: G. MERIANA, L’ulivo e il castagno, Genova, Sagep, 1985; D. MORENO , S. DE MAESTRI, Casa rura-le e cultura materiale nella colonizzazione dell’Appennino genovese tra XVI e XVII secolo, in I paesaggi rurali euro-pei: atti del Convegno Internazionale, Perugia - Città di Castello, pp. 3-21; H. PLOMTEUX, Abergu “essiccatoio perle castagne” e simili, in “Novinostra”, 17, 1977, pp. 17-23; H. PLOMTEUX, Cultura contadina in Liguria. La ValGraveglia, Genova, Sagep, 1980; P. FRIGERIO , A. PICCIONE, Schede sull’architettura rurale dell’AppenninoGenovese nel XVIII e XIX secolo, in Archeologia Medievale, III, 1976, pp. 447-472.27 Cfr. anche ROCHE, 1986, pp. 182-183.
Fig. 18 - La cucina a fornellidel Palazzo Di Negro Pallavi-cini di Mombaruzzo.
11
che sgrana gli occhi di fronte ad uno spazio che gli appare colossale, mitico, spropositato, cari-co di meraviglie e sorprese come nelle favole, ma, pur nel suo tono romanzesco, resta un docu-mento storico valido e indimenticabile:
“La cucina di Fratta era un vasto locale [ º] oscuro anzi nero di fulligine secolare, sulla quale splendeva-no come tanti occhioni diabolici i fondi delle cazzerruole, delle leccarde e delle guastade appese ai lorochiodi; ingombro per tutti i sensi da enormi credenze, da armadi colossali, da tavole sterminate [ º] nelcanto più buio e profondo di essa apriva le sue fauci un antro acherontico, una caverna ancor più tetra espaventosa, dove le tenebre erano rotte dal crepitante rosseggiar dei tizzoni [ º] là un fumo denso e vorti-coso, là un eterno gorgoglio di fagiuoli in mostruose pignatte, là sedente in giro sovra panche scricciolan-ti e affumicate un sinedrio di figure gravi arcigne e sonnolente. Quello era il focolare e la curia domesti-ca dei castellani di Fratta [ º] ”28.
Nel XVII secolo la città all’avanguardia, per quanto concerne la distribuzione degli spazi inter-ni, è Parigi, dove anche nelle case borghesi, costruite a più piani e divise in camere, non si cuci-na più nel focolare centrale, ma in una stanza attrezzata esclusivamente per questo scopo, anchese “la funzionalizzazione delle stanze è [ancora] un lusso” e “le cucine esclusivamente utilizza-te per la preparazione degli alimenti sono altrettanto rare alla fine che all’inizio del secolo[XVIII]”29. Delle abitazioni borghesi seicentesche tipiche dei Paesi Bassi si sa che “inizialmen-te gli ambienti, a parte la cucina, non avevano funzioni specifiche”30.
E’ a partire dal XVIII secolo che si assiste ad una vera trasformazione delle cucine, con scoper-te e perfezionamenti che costituiscono già le premesse di quelle moderne. Innanzitutto, ilSettecento è un secolo ricco di ricerche nel campo della combustione e della sua applicazione (iconfini fra gli studi sul riscaldamento e quelli sulla cottura dei cibi erano molto sfumati), che per-mettono il passaggio decisivo dal
“secolare sistema del fuoco a vista (tanto il grande camino delle dimore ric-che come il povero focolare dei tuguri) a un sistema di occultamento e diconcentrazione sempre maggiore della fonte di calore” (RICCINI, 1989).
In seguito a tali scoperte si diffonderà la pratica di organizzare unospazio specificamente adibito a cucina, e perderà forza la tradizionedi concepire “ambienti indifferenziati dove coesistono diverse fun-zioni dell’abitare” (RICCINI, 1989)31.E’ negli anni Ottanta del XVIII secolo, ad esempio, che in un palaz-zo del cremonese vengono ricavate dalle cantine una cucina dotata diforno e una serie di dispense; in una dimora degli anni Venti del XIXsecolo32, eretta demolendo tutte le strutture precedenti, si crea unacucina “com’è pratica dei gran Signori”, comprendente un forno,vari fornelli, un lavandino con tanto di pompa per l’acqua e vasca dimarmo (JEAN, 1998).Un contributo fondamentale e innovativo è quello apportato dalle ricerche di BenjaminThompson, conte di Rumford (1753 – 1814)33, le cui applicazioni sono ancora riconoscibili, tra
Fig. 19 - La stanza del pozzo;sullo sfondo la porta che con-duce alle cucine, subito aldilàsi intravede il lavello in pietraposto sotto la finestra.
28 Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano, prima pubblicazione 1867, qui in edizione Mondadori – GrandiClassici, citazione pp. 7-8. Le “leccarde” erano recipienti in cui si lasciava colare il grasso degli arrosti, le “guastade”erano una sorta di caraffa in metallo. Il castello di Fratta si trovava nel comune di Portogruaro, in provincia di Venezia,e fu demolito nel 1798; ad esso l’autore attribuisce molte caratteristiche che appartengono in realtà al castello diColloredo di Mont’Albano, di proprietà della nonna Ippolita.29 ROCHE, 1986, p. 158.30 W. RYBCZYNSKI 1989, p. 70.31 “Soltanto nei grandi complessi conventuali, nei castelli e nelle dimore principesche si possono ritrovare spazi specializzati aquesto fine, con una loro tradizione architettonica e una loro organizzazione funzionale”: R. RICCINI 1989, p. 284.32 “In generale, gli inventari tardo-settecenteschi cominciano a registrare una maggiore varietà degli elementi di cot-tura: al classico camino erano quasi sempre affiancati fornelli in muratura…” (G. JEAN, 1998).33 La sua opera principale, Sui camini, con proposte per migliorarli e risparmiare combustibile, rendere le abitazionipiù confortevoli e salubri, e prevenire efficacemente l’emissione di fumo dalle canne fumarie, scritto nel 1795, resta tut-tora un riferimento prezioso e imprescindibile per chi si occupa di progettazione e costruzione dei caminetti aperti.
12
l’altro, nella cucina del palazzo Di Negro Pallavicini, oggetto della presente trattazione. I suoistudi, concentrati inizialmente sulla tecnica di costruzione dei caminetti e quindi sul riscalda-mento, influenzeranno naturalmente anche l’idea di cucina, rivoluzionandola: è la nascita della“cucina razionalizzata” (RICCINI, 1989). Egli comprende che, in merito alla distribuzione delcalore, il problema maggiore è costituito dal raffreddamento dei fumi, con conseguente rallenta-mento della spinta verso l’alto, dovuto alle grandi dimensioni delle cappe e delle canne fumarie:queste erano giustificate dalla necessità di garantire uno spazio sufficiente agli spazzacamini perinfilarsi nei condotti e ripulirli. Rumford dimostra che è sufficiente restringere la canna fumariaper ottenere una migliore combustione ed evitare quindi la necessità di pulizie tanto impegnative;stabilisce inoltre che le superfici interne del camino siano lisce, per favorire lo scorrimento deifumi, e che la canna fumaria venga eretta, il più verticale possibile, con l’imbocco direttamentesopra il piano di fuoco. Il camino subisce modifiche anche nella forma: diminuisce quanto aprofondità e i lati vengono inclinati con angoli scelti matematicamente per accentuare la rifles-sione del calore verso l’ambiente, per cui si presenta strombato, alto, stretto e poco profondo.
Anche per quanto concerne le cucine
“i suoi modelli si basavano sul principio della “protezione” del calore, per evitare dispersioni e utilizzar-ne tutta la forza per cucinare. Il fuoco, attraverso un sistema di condotti, forniva un calore indiretto allepentole sistemate in fori predisposti sulla superificie” (RICCINI, 1989).
Dai fornelli in muratura deriverà successivamente la “cucina economica” a legna o a carbone:ma questa è già storia più vicina ai giorni nostri, che non è penetrata negli ambienti del palazzodi Mombaruzzo. Certo è che i fornelli di Rumford, rivoluzionano anche i gesti del cucinare: nonci si china o accovaccia più, muovendosi tra gli oggetti necessari raccolti nei pressi del camino,ma, protagonisti di un ambiente riorganizzato, “si comincia a cucinare in piedi” (ROCHE, 1986)34.Nel caso della cucina visibile nel palazzo Di Negro Pallavicini, è evidente che si è al cospettodei tipici fornelli con bocchette quadrate, sul piano orizzontale delle quali erano poste a cuocerepentole e padelle: siamo di fronte ad un esemplare piuttosto ben conservato e funzionale, data lapresenza dei due grandi piani di lavoro. Il sistema di Rumford prevedeva che il sistema di cot-tura fosse costruito in forma semicircolare, per permettere all’operatore di controllare tutto illavoro da un solo punto centrale: i fornelli di palazzo Di Negro Pallavicini invece, come quellicitati in numerose ricerche italiane, sono rettilinei, una struttura in muratura della forma e altez-za di un tavolo, addossati contro una parete e dotati di più fori, nei quali vengono posti i reci-
Fig. 20 - La cucina a fornellidel Palazzo Spinola diRocchetta Ligure (AL). Ilsistema adottato è lo stesso diMombaruzzo, anche se didimensioni assai ridotte; lostato di conservazione è quimolto precario.
34 ROCHE, 1986, pp. 194-196.
13
Fig. 21 - Cucina a runfò aMasone (GE)
pienti di cucina35. La cucina è costituita da due corpi rettangolari di diverse dimensioni e dispostiad “L”, come si può osservare dalla riproduzione fotografica. La parte più vicina all’entrata (a sini-stra nell’illustrazione), più corta, ospita un fornello dall’ampia apertura circolare, e sul fronte ver-ticale è visibile la bocca che ospitava la legna ardere, con lingue di fuliggine che lambiscono ilpiano di cottura; la cappa che lo sovrasta è annerita dall’uso e attigua a quella più grande che siinnalza sulla parte destra, composta da un forno per il pane e da altri tre fornelli. Qui il piano di lavoro offre ampio spazio di movimento per le operazioni di cottura del cibo; essoconsiste in uno strato di mattoni e non permette di risalire ad un eventuale rivestimento imper-meabilizzante originario. Sempre sul piano di cottura si aprono i fori per l’introduzione dellepentole: in particolare, uno presenta ancora alcuni cerchi metallici di diverso diametro, che ser-vivano per adattarsi alle dimensioni dei recipienti di cottura.Come si può osservare in planimetria, alla cucina sono collegate due stanze rettangolari poste sulretro: una contiene il pozzo per l’approvvigionamento idrico (probabilmente la stanza sottostan-te ospitava una cisterna, come in altri palazzi di villa36), la seconda era adibita a dispensa. Difronte al lato breve dei fornelli, sotto ad una finestra, è ancora posizionato il lavello lapideoappoggiato su un basamento in cotto intonacato; tra quest’ultimo e il sistema di cottura si apreinfine una porta che conduce alla “stanza del pozzo”. Quest’ultimo presenta la classica forma atamburo, elevata da terra di circa 80 cm, sopra la quale si nota il meccanismo a carrucola perl’approvvigionamento idrico.Al di là dell’interesse in termini di cultura materiale, ciò che ci preme sottolineare è che siamodi fronte ad una cucina che è un esempio non di tradizione, ma di innovazione: tracce del foco-lare più antico sono verosimilmente quelle leggibili sul pavimento in cotto, laddove, coperta dalcorpo dei fornelli, in prossimità del forno, si notano porzioni di un pavimento in mattoni dispo-sti diversamente dagli altri, e che probabilmente delimitavano il camino ad angolo, poi abbattu-to e adeguatamente sostituito dai più moderni “fornelli alla Rumford”, che, a partire dalla finedel XVIII secolo, conobbero fortuna e diffusione in Europa. Molto interessante, per le opportunità comparative che offre, è il caso del castello di Saluggia, inprovincia di Vercelli: esso contiene ancora una “cucina grande” che, come sarà ipotizzato ancheper palazzo Di Negro Pallavicini, includeva il camino-focolare, oggi non più esistente, mentresono ancora visibili, ed in buon stato di conservazione, “il forno da pane e il fornello sormonta-to da cappa con le griglie per il carbone, gli sportelli per il tiraggio dell’aria e i voltini per la legnae la spazzatura” (DONATO, VASCHETTA, 1996).
35 E’ utile ricordare che, nella cucina concepita da Rumford, un ruolo importante è rivestito dalle pentole: egli si occu-pa attentamente anche delle piccole attrezzature, ideando la pentola a pressione e coprendo quasi tutta la gamma delleattrezzature per cucinare, compresi gli utensili da cucina portatili e la prima caffettiera a gocciolamento.36 In alcuni rilievi di Rubens, contenuti nel suo volume Palazzi di Genova, è spesso presente la cisterna al pianoseminterrato.
14
Come affermano i due autori del ritrovamento, “è lecito utilizzare la documentazione iconogra-fica relativa a contesti più popolari, in quanto per gli ambienti signorili i banchetti ufficiali […]sono preclusi solitamente alle cronache lucide e accattivanti della pittura in genere”37: da qui l’u-tilità di ricorrere ai contributi dell’etnografia per effettuare ulteriori paragoni e osservazioni sullacucina di Mombaruzzo. La vasta opera di Scheuermeier, messa a punto negli anni Trenta del XXsecolo, rappresenta ancora “la più approfondita ricerca ‘sul campo’ che sia mai stata svolta nelnostro paese attorno alla cultura materiale del mondo rurale” (SCHEUERMEIER, 1980). Essa docu-menta tra l’altro che tali fornelli, diffusi in tutta Italia38, sono noti come fornelli o fornetti nelleregioni settentrionali e centrali, e spesso come fornacelle in quelle meridionali. In Liguria, inve-ce, sono più conosciuti come runfò: la denominazione deriva appunto dal cognome, volgarizza-to e contratto, dell’inventore Rumford, e registrarono un’ampia diffusione: popolarmente, però,l’origine del termine è creduta onomatopeica, perché il fuoco, all’interno del runfò, produce unrumore più borbottato e insistente che crepitante, come di chi russa (in dialetto: runfa)39.
“Questo fornello, quasi sempre alto quanto un tavolo, può essere annesso lateralmente al camino, oppurepuò trovarsi da solo contro la parete, in un angolo, in un vano della finestra. Di solito è costruito in mat-toni; gli esemplari più belli o più grandi, ad esempio nelle osterie, possono anche essere rivestiti di pia-strelle smaltate; quelli più piccoli sono talvolta di terracotta. Il fornello può avere un unico foro, special-mente quando si trova di fianco al tradizionale camino contadino; nelle cucine più grandi si trovano piùfori l’uno accanto all’altro. Attraverso una griglia metallica, la cenere della carbonella cade in un vano sot-tostante, la cui parete anteriore è sempre aperta in maniera da poter creare un forte tiraggio, specie conl’aiuto della ventola [ º]. L’effetto del calore è molto più forte e il funzionamento più economico che nelgrande camino [ º]” (P. SCHEUERMEIER, 1980)40.
In Caprile (1995) sono documentati quattro esemplari di fornelli rilevati nei comuni di Masonee Rossiglione (GE); in genere furono smantellati a partire dagli anni Cinquanta del XX secolo,quando si diffuse nella zona il gas in bombole ed essi finirono con l’essere considerati oggettiinutili, simboli di povertà e, date le loro dimensioni, anche ingombranti. Laddove si sono con-servati hanno assunto il significato di “monumenti della memoria”, meritevoli di sopravvivere inquanto “ricordi di famiglia”, soprattutto se il piano di cottura era rivestito di belle piastrelle smal-tate (come nel caso del runfò masonese, la cui immagine viene qui riprodotta). In ogni caso i for-nelli non vengono più adoperati almeno dagli anni Sessanta – Settanta del XX secolo, e a voltesono ridotti ad essere usati come piccolo ripostiglio. Ci sembra interessante citare, sempre rife-rendosi alla Liguria, l’iniziativa del Museo Storico della Valle Scrivia, allestito al piano superio-re dell’antica trattoria “Rosin” in località Tre Fontane (Montoggio, GE), tuttora operante nellostesso edificio da circa 140 anni (l’attività fu infatti fondata nel 1876). In esso è stato ricostruitol’aspetto di un’antica osteria, completa di pentolame e oggetti d’epoca: in particolare, è possibi-le osservare il forno a legna e soprattutto i fornelli a legna e carbone, fedeli a quelli che erano infunzione nelle case e nei locali di ristoro ancora per buona parte della prima metà del XX seco-lo; nelle didascalie che illustrano l’ambiente si può leggere che “il cibo veniva preparato nelrunfò, una serie di fuochi alimentati a legna o a carbone, sovrastati dalla cappa, o nel forno sot-tostante”. I fornelli in muratura del palazzo Di Negro Pallavicini, dunque, non più antichi del XVIII seco-lo, costituiscono, come altri casi documentabili (certamente quelli dei castelli di Saluggia e diCasotto41), un esempio di modernità della cucina europea: l’intero sistema funzionale di pozzo-lavabo-fornello si presta all’approfondimento del tema della destinazione e uso degli spazi inter-ni delle abitazioni, un argomento, questo, che meriterebbe un maggior riconoscimento eapprofondimento da parte di storici e architetti.
37 G. DONATO, L. VASCHETTI 1996, pp. 22-23.38 “Il fornello si trova in tutta Italia, specialmente nelle città e nelle famiglie poco numerose, dove spesso costituiscel’unico mezzo per cucinare; ma anche nelle famiglie contadine e nelle osterie viene usato quando si devono cuocerein poco tempo piccole quantità di cibo” (P, SCHEUERMEIER, 1980, vol. II, p. 65).39 Cfr. M.T. CAPRILE (1995), pp. 34-40.40 Sui fornelli e le cucine economiche: cfr. P. SCHEUERMEIER 1980, vol. II, pp. 65-66.41 G. DONATO, L. VASCHETTI, 1996, p. 23.