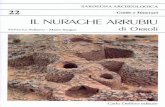IL NARCISISMO E L'ARTE CONTEMPORANEA. IL CONTRIBUTO DELLA PSICOLOGIA DELL'ARTE
Tesi di Laurea: Arredi e Suppellettili di vita quotidiana dell'Antico Egitto, fra il Medio Regno e...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Tesi di Laurea: Arredi e Suppellettili di vita quotidiana dell'Antico Egitto, fra il Medio Regno e...
Università di Pisa
CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE
Corso di Laurea Specialistica in Archeologia
Tesi di Laurea in Egittologia
Arredi e Suppellettili di vita quotidiana
dell’Antico Egitto, fra il Medio Regno e il
Secondo Periodo Intermedio.
Relatrice Candidato
Prof.ssa Marilina Betrò Veronica Cirillo
Matricola (448545)
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
Indice
Indice delle Abbreviazioni ................................................................................ 4
Introduzione ................................................................................................... 8
Capitolo 1: Definizione, Metodologia e Cenni Storici dell’Arredamento. ............
1.1. Definizione dei concetti Arredi e Arredamento……………………………….
1.1.1. Gli Arredi domestici. .................................................................... ..
1.2. Una metodologia d’indagine. ............................................................... .
1.3. Cenni storici. ...................................................................................... .
1.3.1. L’origine degli arredi nella Preistoria. ............................................ .
1.3.2. L’arredamento e la coscienza arredativa nell’Antico Egitto. ............ .
1.3.3. Hesi-Ra e la regina Hetepheres: l’importanza della varietà……………
Capitolo 2: La natura degli elementi di studio. ................................................. .
2.1. Le fonti e i problemi posti dalle fonti…………………………………………….
2.1.1. Fonti Materiali. ............................................................................. .
2.1.2. Fonti Figurative. ........................................................................... .
2.1.3. Fonti Testuali. .............................................................................. .
2.2. La comparazione dei dati come mezzo d’integrazione e confronto……….
Capitolo 3: Gli arredi e le suppellettili fra il Medio Regno e il Secondo Periodo
Intermedio. .................................................................................... .
3.1. I Sedili. ............................................................................................... .
3.1.1. Lo Sgabello. .................................................................................. .
3.1.2. La Sedia. ...................................................................................... .
3.1.3. La Poltrona. .................................................................................. .
3.1.4. L’uso dei sedili. ........................................................................... ..
3.2. Il tavolo. .............................................................................................. .
3.2.1. L’uso del tavolo. ........................................................................... .
3.2.2. Struttura Sedili-Tavolo. ................................................................. .
3.3. Il Letto. ............................................................................................... .
3.3.1. L’uso del letto .............................................................................. ..
3.4. Teriomorfismo e simbologia: dal toro al leone passando per il
cielo. .................................................................................................. .
3.5. Il Poggiatesta. ..................................................................................... .
3.5.1. Le Iscrizioni. ................................................................................. .
3.5.2. Dagli apotropaia al poggiatesta. .................................................... .
3.5.3. La duplice valenza del poggiatesta………………………………………
3.5.4. Paure di vita e paure di morte ....................................................... .
3.5.5. L’elevazione della testa e la simbologia solare ............................... .
3.5.6. I poggiatesta nelle fonti figurative e letterarie ................................ .
3.5.7. Struttura Letto-Poggiatesta. .......................................................... .
3.6. Contenitori lignei ................................................................................ .
3.6.1. L’uso e i contenuti ......................................................................... .
3.7. L’arredamento egiziano al di fuori dei confini……………………………..
Capitolo 4: La provenienza degli elementi d’arredo e la loro duplice vita: dalla vita
alla morte, dalla casa alla tomba. .................................................. .
4.1. Città e villaggi: la difficoltà di studio dei contesti abitativi nell’Antico
Egitto. ................................................................................................ .
4.1.1. I contesti abitativi fra il Medio Regno e il Secondo Periodo Intermedio.
.................................................................................................... .
4.1.2. Gli arredi provenienti dai contesti abitativi………………………………
4.2 Usi e costumi funerari fra il Medio Regno e il Secondo Periodo Intermedio.
....................................................................................................... ….
4.2.1. Gli arredi e le suppellettili come corredi funerari……………………..
Conclusioni. .................................................................................................... ..
Appendice: Le fasi di studio tra archeologia, storia e informatica:costruzione del
data base .................................................................................... ….
Catalogo. ......................................................................................................... ..
Indice delle Abbreviazioni
Riviste
ASAE = Annales du Services des Antiquités de l’Égypte (Cairo).
BIE = Bulletin de l'Institute d'Égypt (Cairo)
BM Stelae = Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae &c., in the Brithish
Museum.
BMFA = Bulletin of the Museum of Fine Arts (Boston).
BMMA = Bullettin of Metropolitan Museum of Art (New York).
BIFAO = Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale (Cairo).
CRIPEL = Cahier de recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Egyptologie de
Lille.
CT = Coffin Texts, notably: 'The Egyptian Coffin Texts', 7 vols., ed. A. de Buck,
1935-1961 (Chicago).
EVO = Egitto e Vicino Oriente: Rivista della sezione orientalistica dell'Istituto di
Storia Antica, Università degli Studi di Pisa (Pisa).
GM = Göttinger Miszellen, (Göttingen).
JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt.
(Boston/Princeton/New York/Cairo).
JNES = Journal of Near Eastern Studies (Chicago).
JSSEA = The Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiwuities.
LÄ = Lexikon der Ägyptologie, 7 vols., ed. W. Helck, E. Otto, W. Westendorf,
1972/5-, Wiesbaden.
MDAIK = Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung
Kairo (Mainz/Cairo/Berlin/Wiesbaden).
MDOG Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin (Berlin).
PM = B. Porter and R. Moss, 'Topographical Bibliography of Ancient Egyptian
Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings', 7 vols, , 1927-1951
RecTrav. = Recueil de traveaux relatifs à la philologie et à l'archéologie
égyptiennes et assyriennes.
RdE = Revue d'Égyptologie (Paris)
VA = Varia Aegyptiaca (San Antonio, Texas)
Wb = ERMAN ADOLF und GRAPOW ERMANN 1971, Wörterbuch der
Aegyptischen Sprache, Berlin.
ZÄS = Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft (Berlin)
Musei
ÄM = Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatlichen Museen zu
Berlin.
Ashmolean = Ashmolean Museum of Art and Archaeology, University of Oxford.
Atene = Εθνικο Αρχαιολογικο Μουσειο (Museo Archeologico Nazionale di Atene).
BM = The British Museum of London.
Brook.Mus. = Brooklyn Museum, New York.
Canolfan = Egypt Centre Canolfan Eifftaidd, Wales.
Cairo = Museo egizio del Cairo.
Cliveland = Cliveland Museum.
DIA = Detroit Institute of Arts.
Fitzwilliam = Fitzwilliam Museum, Cambridge.
IPEL = Institut de Papyrologie et D'égyptologie, Université De Lille III.
IES = Institut d’Égyptologie Strasbourg.
Ipswich = Ipswich Museums, Colchester, UK.
Irlanda = National Museum of Ireland, Dublin.
KhM = Kunsthistorisches Museum Wien.
KMKG = Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Musée Royaux d’Art et
d’Histoire), Brussel.
Louvre = Musée du Louvre, Paris.
MAN = Museo Arqueológico Nacional, Madrid
Manchester = Manchester Museum, the University of Manchester.
MFA = Museum of Fine Arts, Boston.
Milano = Museo Civico di Milano.
MMA = The Metropolitan Museum of Art, New York.
MVMS = Medelhavet Världskultur Museerna, Stoccolma
MUT = Museum der Universiät Tübingen.
NMGM = Liverpool Museum.
NY Carlsberg = NY Carlsberg Glyptotek, Copenaghen.
OIM = Oriental Institute Museum of Chicago.
Périgord = Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord, Périgueux.
Penn Mus. = Penn Museum, University of Pennsylvania Museum of Archaeology
and Anthropology, Philadelphia.
Phoebe A.Hearst = Phoebe A. Hearst Museum of Anthropology, Berkeley-
California.
Pitt Rivers = Pitt Rivers Museum, Oxford.
RMO = Rijksmuseum Van Oudheden, Leiden.
ROM = Royal Ontario Museum, Toronto.
RPM = Roemer und Pelizaeus Museum Hildesheim.
San Josè = San Josè Museum, California.
SAT = Museo Archeologico di Firenze.
Scozia = National Museum of Scotland, Edinburgh.
SHM= The State Hermitage Museum, San Pietroburgo.
Torino = Fondazione Museo delle antichità Egizie di Torino.
UC = Petrie Museum, University College of London.
Übersee-Mus. = Übersee-Museum Breme.
VAM = Victoria and Albert Museum, London.
Introduzione
Il seguente lavoro di tesi è incentrato sullo studio degli arredi e delle
suppellettili di vita quotidiana degli antichi egizi vissuti fra il Medio Regno e il
Secondo Periodo Intermedio.
Lo scopo iniziale era di reperire e analizzare i soli manufatti provenienti da
contesti domestici, dunque rinvenuti nell’ambiente originario d’impiego. Con il
passare del tempo ci si è resi conto che sarebbe stato alquanto difficile
approntare uno studio esaustivo, vista la scarsità di oggetti con tali
caratteristiche e d’informazioni, soprattutto per gli scavi effettuati agli inizi del
‘900, quando raramente erano raccolti dati quali l’esatta collocazione degli oggetti
rinvenuti.
L’obiettivo di approntare un’associazione fra gli oggetti della casa e la casa
stessa, in modo da conoscere meglio le esatte modalità di vita dell’uomo egiziano,
si è dunque rivelato alquanto arduo da raggiungere per il periodo preso in
considerazione, argomento che invece è stato possibile affrontare per l’età
successiva (Nuovo Regno), grazie a siti come Tell el-Amarna e Deir el-Medina.
L’accento è stato dunque posto sugli oggetti provenienti da qualsiasi
contesto (domestico e funerario), ma analizzati a 360°. Infatti, ho cercato di non
approntare una semplice e sterile descrizione dei manufatti, ma d’individuare
un’evoluzione temporale e geografica, laddove la quantità dei manufatti l’avesse
permesso (poggiatesta), delineare i rapporti fra gli oggetti e l’uomo, le modalità e i
contesti di uso e d’impiego, e il valore simbolico e religioso. Tutto ciò è stato
diretto nel tentativo di dimostrare l’esistenza, presso gli antichi egizi, di una
coscienza arredativa e la consapevolezza della dimensione spaziale.
A tale scopo ho ritenuto fondamentale definire nel primo capitolo i tratti
generali del concetto di arredamento. Nella prima parte è stato delineato
puntualmente ciò che s’intende per arredi e arredamento, concetti a prima vista
banali per i moderni, ma che necessitano di essere ben compresi quando
impiegati in un ambito antico e lontano dal loro utilizzo usuale quale quello
odierno. Fondamentale è stata la lettura di materiale non propriamente
egittologico, ma prezioso per la definizione di una metodologia di studio. La
seconda parte consiste invece in alcuni cenni storici, in cui si è cercata l’origine
degli arredi, risalendo indietro fino all’epoca preistorica. Sono stati illustrati
anche i caratteri generali che identificano l’arredamento egiziano, definendo quali
arredi e suppellettili sarebbero stati analizzati, in quanto ho escluso alcune
categorie di oggetti che a giusto titolo sarebbero rientrate in un siffatto studio
relativo agli oggetti della casa; mi riferisco agli strumenti, alla cesteria e
soprattutto alla ceramica. Quest’ultima categoria, più di ogni altra suppellettile,
denota l’aspetto domestico dello spazio abitativo, ma afferisce ad un campo
d’indagine troppo ampio, e dunque impossibile da affrontare nel seguente lavoro.
Il secondo capitolo prende in considerazione le diverse fonti e le
problematiche derivanti dal loro utilizzo. È stato, infatti, necessario ricorrere a
diversi tipi di informazioni, in grado di illustrare i mutevoli aspetti che si volevano
indagare.
Il terzo capitolo costituisce la porzione più ampia del lavoro, ovvero l’analisi
arredo per arredo, suppellettile per suppellettile.
In ogni paragrafo relativo ad un dato manufatto sono stati analizzati vari
aspetti, come:
1. I termini impiegati per designare quel dato oggetto.
2. Le modalità d’impiego, ossia l’utilizzo materiale e dunque lo scopo per cui
fu ideato.
3. Gli elementi costituenti e l’evoluzione che subirono nel corso della storia
faraonica.
4. Le tipologie in cui far rientrare i vari manufatti reperiti, nel tentativo di
individuare eventuali pattern geografici o temporali.
5. I significati più profondi attribuiti agli oggetti, sia dal punto di vista
simbolico che religioso.
Fra un paragrafo e l’altro ve ne sono alcuni che uniscono gli aspetti comuni
dei diversi arredi e/o suppellettili, evidenziandone i rapporti o l’assenza di questi
quando invece sembrerebbe naturale vi siano.
La parte finale di questo capitolo è dedicata ad un breve excursus sugli
arredi e le suppellettili con evidenti tratti egiziani ma rinvenuti in contesti
stranieri, al di fuori cioè dei confini propriamente egiziani. Questa parte si è resa
necessaria in corso d’opera, poiché ci si è resi conto che sarebbe stato
interessante esplorare, seppur brevemente, questo ulteriore aspetto.
Il quarto capitolo è destinato a indagare i manufatti considerati nel contesto
di rinvenimento. La prima parte prende in considerazione le difficoltà di studiare
i contesti urbani e più precisamente quelli abitativi. Sono state prese in analisi
alcune raffigurazioni, ma soprattutto gli oggetti recanti chiari segni d’impiego
antico e soprattutto quei pochi manufatti rinvenuti nei contesti domestici. La
seconda parte si è invece articolata nel considerare gli arredi e le suppellettili nel
momento del loro impiego funerario, ovvero come corredi all’interno delle tombe. I
due diversi usi hanno condotto inevitabilmente ad una modificazione del
significato dell’oggetto.
Nonostante il seguente lavoro si sia concentrato su un arco temporale ben
preciso, quale quello del Medio Regno e il Secondo Periodo Intermedio, in molti
casi è stato necessario far riferimento a età più antiche o più moderne, sia per
costruire un quadro che fosse il più ampio ed esaustivo possibile, creando una
linea evolutiva completa degli oggetti, ma soprattutto perché in alcuni casi non si
è in grado di fornire prove per questo specifico periodo e dunque è necessario
rifarsi a tempi diversi pur di comprendere e completare il quadro delineato.
Ho tenuto vivamente a corredare questo lavoro di una piccola appendice,
nella quale è descritto brevemente, senza alcuna pretesa di precisione tecnica,
l’utilizzo fatto dello strumento informatico per la creazione di un data-base,
grazie al quale è stato possibile raccogliere in maniera ordinata e differenziata le
varie informazioni derivanti dallo studio degli oggetti; si è rivelato uno strumento
prezioso, poiché ha consentito un’immediata disponibilità e facilità di accesso ai
dati, fornendo l’opportunità di interrogazioni mirate e di correlazioni fra gli
oggetti.
L’ultima parte è dedicata al catalogo in cui è stato raccolto il materiale
analizzato nel seguente studio.