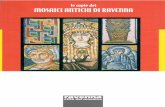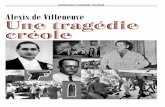Il mercato delle copie nella Roma di primo Seicento
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Il mercato delle copie nella Roma di primo Seicento
Percorsi di ricerca 3Collana del Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla Conservazione
Università Roma Tre
Senza titolo (1992) di Marco Tirelli
Percorsi di ricerca:Progetto di Giovanna Sapori e Bruno Toscano
Comitato scientifico:Liliana Barroero, Barbara Cinelli, Daniele Manacorda, Danilo Mazzoleni, Serenella Rolfi, Giovanna Sapori
La CopiaConnoisseurship, storia del gusto e della conservazione
Giornate di Studio del 17-18 maggio 2007Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme
a cura di Carla Mazzarelli
Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla ConservazioneUniversità Roma Tre
Libro Co. itaLia
Progetto e coordinamento scientifico: Carla MazzarelliCoordinamento organizzativo: Sonia Amadio, Francesca Romana Chiocci
Atti a cura di: Sonia Amadio, Carla Mazzarelli, Francesca Romana Chiocci
Si ringraziano gli amici e i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questo volume, con consigli, suggerimenti e cortesie di ogni genere: Giovanna Capitelli, Beatrice Cirulli, Giovanni Duranti, Marco Fabiano, Laura Gori, Fabrizio Musetti, Danilo Renzulli, Maria Cristina Terzaghi.
Progettazione e implementazione grafica: Fabrizio MusettiLaboratorio Informatico – Dipartimento di Studi Storico-artistici, Archeologici e sulla Conservazione
© 2010 LibroCo. itaLia
via Borromeo, 4850026 San Casciano V.P. (FI) – Italia
P.O. Box 23Tel. +39-55-8228461 – Fax +39-55-8228462E-mail: [email protected] - www.libroco.itISBN: (da inserire)
Sommario
L. barroero, Presentazione 9
D. ManaCorDa, Introduzione 11
C. MazzareLLi, La copia. Per un «diagramma parallelo» 15
iL ‘vaLore’ DeLLa Copia. MetoDi, fonti, teCniChe
Premessa 37
G. CaLCani, Alle origini della copia 41
a. aGresti, La Madonna del Pugliese-Dudley, Pontormo, Amico Aspertini.Precisazioni e novità sulla fortuna di Donatello 65
f. Mariani, Una copia spagnola dell’Allocuzione del marchese delVasto di Tiziano 85
M. CarDinaLi, M.b. De ruGGieri, Da copia evidente a replica presunta.Le tracce materiali nei doppi di Caravaggio 99
C. MazzareLLi, La parola alle fonti: copia servile versus copia libera(XVIII-XIX secolo) 127
Copia e CuLtura DeL restauro. DaLLa restituzione aL reCupero
b. tosCano, Premessa 149
f. papi, Il dibattito sulla conservazione nell’Italia della seconda metàdell’Ottocento: Boito e la ricomposizione dell’altare di Donatello a Padova 153
G. Duranti, L’autonomia della copia. Il Foro Italico di Roma Capitale(Piazza Venezia e le sue quinte prospettiche) 167
f. Donati, Non solo copie! La Gipsoteca di Arte antica a Pisa:storia di un recupero 187
f. vaLentini, Sostituzione, copia, replica nella conservazionedell’arte contemporanea: critica e prassi in Italia e in Europa 201
forMazione, MerCato, CoLLezionisMo (Xvi-Xviii seCoLo)
G. sapori, Premessa 219
G. eXterMann, Copie e falsificazioni: l’industria dell’antico nellabottega di Guglielmo della Porta 225
p. Cavazzini, Il mercato delle copie nella Roma di primo Seicento 257
s. aMaDio, I ‘disegni Barberini’ dalla pittura paleocristiana:l’équipe Lagi, Montagna, Eclissi 271
v. Di Giuseppe Di paoLo, La fortuna di Guercino in Francia ela copia del Seppellimento e Assunzione di santa Petronilla diJean-Antoine-Théodore Giroust 291
DaLL’aCCaDeMia aL Museo (Xviii-XX seCoLo)
L. barroero, Premessa 309
v. rotiLi, La fortuna delle copie in gesso nella bottega diAlexander Trippel e il ruolo dei formatori 313
f. r. ChioCCi, L’arte italiana negli acquarelli di Ernest Hébert 337
G. Montani, Le copie dagli antichi maestri nel XIX secolo e il loro impiego 369
L. D’anGeLo, La Galleria nazionale d’arte moderna e le copie d’artecontemporanea tra XIX e XX secolo 385
inDiCe Dei noMi 395
257
Il mercato delle copie nella Roma di primo Seicento
Nella Roma di primo Seicento venivano prodotti sia molti dipinti in serie che molte copie, in parte su richiesta di committenti e collezionisti, ma anche per altri motivi 1. Innanzitutto, in una città in cui era venuto meno il tradizionale ruolo delle botteghe, il copiare era parte fondamentale del pro-cesso di apprendimento. Molti pittori si dichiaravano autodidatti, non solo per sottolineare il mito della propria originalità, ma anche perché l’apprendi-stato era divenuto estremamente flessibile2. Nel famoso processo al Cavalier d’Arpino, accusato nel 1607 di avere sfregiato il rivale Cristoforo Roncalli, si nota come molti aspiranti pittori potessero avere solo un tenue legame con un maestro3. Passavano gran parte del loro tempo girovagando per la città, copiando facciate, affreschi e monumenti; poi portavano i loro disegni ad un artista affermato per farli correggere, magari in cambio di qualche minimo favore, ad esempio lavare le scodelle dove si mescolavano i colori.
A Roma, durante l’apprendistato, si disegnava per molti anni, senza tocca-re i pennelli; non veniva incoraggiata o stimolata la capacità inventiva, ma la capacità di imitare un’altra opera d’arte. Anche quando finalmente un giovane pittore passava all’uso del colore, all’inizio non dipingeva di invenzione, ma copiava un dipinto. Molti pittori affermati che avevano istituito scuole, ad esempio Andrea Sacchi, possedevano collezioni di copie di dipinti celebri per scopi didattici 4. Spesso gli allievi copiavano i lavori del proprio maestro, il quale poteva poi correggere l’opera verbalmente, offrendo consigli e suggerimenti, oppure poteva intervenire direttamente sul dipinto, ritoccandolo. In questo modo si venivano a creare lavori dall’autografia ambigua, che ovviamente non venivano distrutti, ma venduti. Si vede bene dagli infiniti processi in cui fu coinvolto Agostino Tassi come dipinti di questo genere potessero essere spac-ciati per autografi dal maestro stesso o dagli allievi, con o senza il suo consenso. Potevano essere destinati a persone di ceto relativamente modesto, ma a volte anche a cardinali, magari tramite l’intervento di un mercante.
Ciò che è narrato nei documenti è anche riscontrabile nella produzione
258
P. Cavazzini
del pittore. Esistono infatti versioni quasi identiche dei suoi dipinti, tutte riconducibili al suo ambito, ma di qualità variabile. Ad esempio L’imbarco della Regina di Saba (olio su tela, cm. 94x136, fig. 1), in collezione privata romana, è certamente autografo, così come il più tardo Commercio in un porto (olio su tela, fig. 2), basato su uno schema compositivo praticamente identico, mentre la Scena di porto con architetture, passata sul mercato napoletano molti anni fa, deve essere stata eseguita da un collaboratore (olio su tela, fig. 3)5. Le figurette estremamente allungate e un po’ rigide di questa tela caratterizzano forse l’intervento del cognato del Tassi, Filippo Franchini.
In maniera analoga, L’imbarco di sant’Elena del Tassi, ora sul mercato anti-quario parigino, fu chiaramente imitato da Claude Lorrain nel bellissimo Imbarco di una regina in collezione privata giapponese (olio su tela, cm. 72,5x91,5, fig. 4; olio su tela, cm. 75x97, fig. 5). Come è noto, il pittore lorenese fu allievo del Tassi e la tela in questione denuncia nelle figure anche l’intervento del suo maestro6. Nel caso specifico però, dato il divario qualitativo tra i due pittori, la fattura della copia, o meglio della variante, è infinitamente superiore a quella dell’originale.
I pittori di paesaggi e nature morte, generi che rendevano relativamente poco rispetto ai quadri di figura, tendevano a lavorare più sulla quantità che sulla qualità e per questo a produrre numerosi dipinti simili uno all’altro, con minime varianti, se non vere e proprie copie, spesso tramite l’uso di lucidi o spolveri. Inventari di pittori che contengano un vasto numero di lucidi, come quello di Tommaso Salini, fanno sospettare che venissero usati soprattutto per produrre copie7. Le numerose nature morte che si trovano negli inventari di persone di condizione modesta intorno al 1630 tendono a essere valutate pochissimo, intorno a uno scudo. Non saranno certo state composizioni originali, ma piuttosto copie da disegni, dipinti o stampe, dato anche che il costo dei fiori rappresentati sarebbe probabilmente stato superiore a quello dei dipinti stessi. Il centinaio di disegni di frutti e fiori nell’inventario del pit-tore Antonio Zalli serviva probabilmente a questo scopo, cioè come matrici da cui ricavare dipinti eseguiti in serie, che venivano poi venduti nella bottega del mercante Giovanni Anselmo a Campo Marzio, il quale vendeva nature morte di fiori per uno scudo8.
Gli inventari romani del primo Seicento tendono ad essere estremamente generici e scarni di informazioni; è difficile perciò dire quanti dei dipinti da pochi scudi (o da pochi giulii) che si trovavano presso mercanti e collezionisti minori fossero copie e quanti opere originali. Dai primi anni del secolo sono ben riconoscibili, presso entrambe le categorie, alcuni soggetti che ricorre-vano con estrema frequenza. Comunissime erano le Madonne miracolose delle principali chiese romane (e queste ovviamente saranno state copie), ma anche temi un po’ meno prevedibili, come le serie delle dodici Sibille o
259
Il mercato delle copIe a roma nel SeIcento
dei dodici Apostoli (a cui a volte veniva aggiunto il ritratto di Cristo), o delle Quattro Stagioni. Tra le figure femminili Maddalena, spesso insieme a Marta (in un’unica tela o in due separate), Giuditta e Susanna erano abbastanza fre-quenti. Si trovavano anche rappresentazioni dei Cinque Sensi, e serie di profeti ed evangelisti, oltre che di ritratti di uomini illustri. Queste ultime, che erano comuni anche a Venezia nel Cinquecento, e che derivavano in ultima analisi dall’esempio di Paolo Giovio, comprendevano molti re e imperatori, oltre a filosofi e letterati 9.
Si ha l’impressione che vari pittori, specialmente tra i caravaggeschi, dipin-gessero certi temi perché più facili da smerciare. Ad esempio, i soggetti dipinti dal giovane Jusepe de Ribera a Roma circolarono molto presto nelle botteghe. Ritratti di uomini illustri, compresi filosofi, venivano venduti a centinaia nella bottega del pittore indoratore Nicola Ventura da Fano a San Lorenzo in Lucina, di cui conosciamo un inventario del 161610. È ben possibile perciò che i Filosofi di Ribera, così come la sua serie dei Cinque Sensi, sparsa tra varie collezioni, e quella degli Apostoli, in parte ora alla Fondazione Longhi, derivi-no dalla conoscenza di ciò che era comune nelle botteghe. Se è vero che tanto gli Apostoli quanto i Cinque Sensi erano opere commissionate dallo spagnolo Pietro Cussida, non create per il mercato, va ricordato che il Ribera dipinse certamente più di una serie di Apostoli 11. Un suo San Bartolomeo, insieme a una Maddalena, furono donati ai Savelli da un ricamatore che evidentemente trafficava in dipinti 12.
Alcuni pittori, tra cui Antiveduto Gramatica, sembra smerciassero a riven-ditori repliche dei quadri che avevano eseguito per committenti famosi. È infatti singolare che il Gramatica vendesse a un barbiere mercante un Cristo tra i Dottori nel 1616, composizione che aveva dipinto per Ciriaco Mattei pochi anni prima13. Verso la fine della sua vita Antiveduto cercò di vendere tramite intermediari una serie di sante a mezza figura, che aveva eseguito di propria iniziativa, senza avere un committente: è ben possibile che avesse dipinto varie versioni anche di questa serie, forse con l’aiuto del figlio Imperiale14.
Anche il caravaggista francese Nicolas Régnier produceva probabilmente repliche dei propri dipinti per il mercato: un contratto notarile del giugno del 1623 ci rivela che il Régnier acquistò una ventina di metri di seta di qualità scadente, chiamata tabì di Sicilia, dal pittore lorenese Crispino Tommasino (spesso coinvolto in traffici poco chiari con mercanti di dipinti), per 31 scudi e 35 baiocchi. Per pagare il tessuto, il Régnier si proponeva di dipingere per il Tommasino quattro tele rappresentanti i quattro evangelisti, della misura da imperatore, cioè di circa un metro per un metro e venti. A opera ultimata i due pittori avrebbero valutato congiuntamente se il valore dei dipinti effet-tivamente corrispondesse al costo della stoffa. Ci si domanda se nel 1623 il
260
P. Cavazzini
Régnier, per una cifra così esigua, fosse disposto a eseguire dipinti originali, o se egli riciclasse composizioni già sfruttate15. Esisteva chiaramente almeno una sua serie completa di evangelisti, di cui ora sono noti solo il San Matteo e l’angelo del Sarasota Ringling Museum e il San Luca a Rouen. Non si sa per chi fossero stati dipinti, ma probabilmente non si tratta di quelli citati nel contratto del 1623, dato che solo le misure del San Matteo corrispondono e pare che questa tela sia stata tagliata. Una serie completa di Evangelisti, non autografa, è invece sopravvissuta a Firenze; anche in questo caso non dovreb-be trattarsi dei dipinti eseguiti per il Tommasino, in quanto il Régnier si era impegnato a dipingerli personalmente16.
Il sarto fiammingo Cristiano Stringherlandt, che morì nel 1634 e che chiaramente commerciava sia dipinti originali che copie, costituisce un caso interessante: come sarto aveva tra i suoi clienti personaggi importanti, ad esempio Taddeo Barberini e il cardinal Giovanni Battista Pamphilj, ed era sicuramente a contatto con artisti a noi ben noti17. Curatore della sua eredi-tà fu lo scultore fiammingo François Duquesnoy, e l’inventario dei dipinti fu redatto dal pittore Karel Philip Spierincks, separatamente dal resto dei beni, che furono invece stimati da un rigattiere. Il fatto stesso che i dipinti venissero valutati da un pittore, che alcuni fossero costosi, e che una copia dell’inventario si trovi tra le carte dei Barberini, ci porta a pensare che varie tele fossero di artisti ben noti. Quadri da stanza valutati dai 120 ai 50 scudi, come vediamo nell’elenco dei beni del sarto, sicuramente non erano anoni-mi, dato che a Roma non era poi così facile, al di là di una ristretta cerchia di artisti che aveva raggiunto l’apice della fama e che poteva richiedere cifre elevatissime, ottenere valutazioni simili. Il dipinto più costoso in possesso del sarto era una grande Incoronazione di spine, valutato 120 scudi; vi erano poi una Presa di Cristo nell’orto e un Ritrovamento di Mosè stimati 50 scudi l’uno, anch’essi descritti come «grandi». L’origine belga del sarto, i suoi contatti con artisti stranieri, compreso Wilhelm Baur, il fatto che uno dei suoi dipinti fosse una copia da Cornelis van Poelenburgh, suggeriscono che gli autori dei suoi quadri fossero per lo più pittori olandesi e fiamminghi (e certamente alcuni soggetti fanno in particolare pensare a pittori caravaggeschi).
Di vari dipinti, e di tutti quelli di maggior valore, il sarto possedeva sia gli originali che una o più copie, evidentemente commissionate da lui. Due copie dell’Incoronazione di spine, una con la cornice e una senza, furono valu-tate rispettivamente 35 e 25 scudi; le copie della Presa di Cristo e del Mosè 20 scudi l’una. La forte differenza di prezzo rispetto agli originali indica che si trattava di tele eseguite da altri autori, forse anche questi di una certa leva-tura, dato che all’incirca negli stessi anni, una versione della Peste ad Ashdod di Nicolas Poussin, eseguita da Angelo Caroselli, fu valutata 35 scudi18.
261
Il mercato delle copIe a roma nel SeIcento
Lo Spierincks stesso era evidentemente attivo anche come copista, poiché è certamente lui il «Carlo Filippo fiammingo» che nel 1634 eseguì per Urbano VIII una copia di una Madonna su rame, pagatagli 16 scudi19.
Nell’inventario dello Stringherlandt copie di dipinti di paesaggio di pic-cole dimensioni erano invece valutate molto meno, solo pochi scudi l’una. La disposizione dei quadri nella sua dimora, con gli originali esposti nella sala e le copie in un ambiente separato, rivela che egli si rivolgeva a clientele diverse, o comunque che non voleva mostrare, a chi era disposto a spendere cifre elevate per un dipinto, che si poteva ottenere una composizione analoga per una cifra molto inferiore.
Il sarto non pare avesse copie di autori cinquecenteschi, né di immagi-ni miracolose, che erano invece in genere frequentissime presso i mercanti di quadri. Si nota infatti, già nel tardo Cinquecento, la popolarità di certi dipinti rinascimentali, ad esempio della Madonna del Velo di Raffaello, ora al Musée Condé a Chantilly, che veniva esposta a Santa Maria del Popolo in occasioni particolari ed era considerata miracolosa20. La Santa Cecilia dello stesso pittore, nonostante l’originale non si trovasse a Roma, era copiata spesso, così come l’Ecce Homo del Correggio e il San Girolamo di Girolamo Muziano. Anche Paul Bril, insieme al figlio Ciriaco, nel 1620 doveva essere coinvolto nella riproduzione di dipinti famosi per il mercato, dato che fece copiare una Madonna del Tiziano in suo possesso da almeno due pittori, un Pietro di Giacomo de Rubeis (la cui abilità però non lo soddisfaceva pienamente) e un «Thomasso figlio di Mastro Veneziano»21.
Molto interessante al fine di esaminare il successo di certe immagini è l’in-ventario del pittore mercante Pietro Paolo Giglio, del 1637, che contiene copie dei dipinti più diffusi, e cioè Madonne da Raffaello e Andrea del Sarto, oltre all’immancabile Santa Cecilia del pittore urbinate. Nel documento si trovano anche menzionate numerose copie dal Caravaggio, a ulteriore testimonianza della sua popolarità: una (o più probabilmente due) Madonna dei Pellegrini, una Madonna non meglio identificata, un’Incredulità di san Tommaso, una Crocefissione di san Pietro, una Cattura di Cristo e una Cena in Emmaus 22.
Il pittore indoratore Nicola Ventura, attivo dall’inizio del Seicento, tra le centinaia di quadri in vendita nella sua bottega, teneva anche copie di immagini religiose, in particolare Madonne, da Raffaello, Tiziano e Muziano23. Doveva però trattare anche copie di composizioni seicentesche, poiché già nel 1610 vendette allo scultore Cristoforo Stati «quattro favole del Tasso di larghezza di palmi 7 et alti 6 in tela di tre e quattro pezzi l’una», per 100 scudi24. Vista la data così precoce, per temi tratti dalla Gerusalemme Liberata è possibile si trattasse di copie da composizioni dei Carracci, anche in questo caso eseguite da pittori almeno discreti, dato che 25 scudi non erano una cifra irrilevante.
262
P. Cavazzini
La maggior parte dei dipinti in possesso del Ventura doveva valere molto meno, dato che vendette molti ritratti di uomini illustri per uno scudo l’uno ai Colonna e quattro Dottori della Chiesa, per la stessa cifra, agli Altemps25. Alla morte del Ventura, nel 1642, sembra che la sua attività si fosse notevolmente ridotta, oltre che in parte adeguata a nuovi gusti dato che, insieme a qualche ritratto e ad alcu-ne immagini miracolose, possedeva anche «otto quadri in tela d’imperatore con frutti e animali e figure diverse con cornici indorate»26.
I mercanti di dipinti potevano assumere a tempo pieno pittori scono-sciuti per produrre copie. Sappiamo ad esempio di un Giovanni Battista Cremonese che nel 1628 si impegnò a tenere presso la propria abitazione per dieci mesi un tal Desiderio Pietone con l’unico compito di produrre copie. Il mercante, prima di assumere il pittore, controllò la qualità delle sue opere e gli promise un salario soddisfacente, cioè sei scudi al mese, più vitto e alloggio. Il pittore dichiarò di non voler sistemarsi presso il mercante solo per produrre «bagattelle», e sarebbe interessante sapere che cosa intendesse esattamente con questa parola27.
Anche le opere esposte nelle botteghe potevano essere copiate: un calzolaio chiamato Pietro Falchino, sempre nel 1628, acquistò nella bottega di Ronaldo de Sanctis, situata alla Sapienza, una tela imprimita, della misura da imperatore, per 5 giulii, e la consegnò al pittore Ambrogio Erbano con l’incarico di dipingergli «un bagno di Diana con un paese et arbori e altre figurine conforme a uno che stava lì nella [...] bottega». Secondo un testimone, che era il compagno di stanza del pittore, il dipinto poteva valere 8-10 scudi28. Era forse una copia di una copia, probabilmente di derivazione carraccesca visto il soggetto, ed eseguita da uno sconosciuto: sorprende certo che la sua valutazione fosse equivalente a quella di una tela di ugual misura eseguita da Nicolas Régnier.
Oltre alle copie esistevano anche i falsi, ma non è facile avere la percezione esatta del fenomeno. Terenzio Terenzi era chiaramente un falsario e Giovanni Baglione ben lo descrive come «pittore di quelli che le loro pitture moderne vogliono per antiche spacciare»29. Terenzio si procurava tavole vecchie e tar-mate, già dipinte, possibilmente con la cornice, e su queste lavorava e riusciva ad ingannare «i più saccenti ingegni del suo tempo». Quando però cercò di spacciare come Raffaello una sua opera al cardinal Montalto, suo protettore, fu prontamente scoperto. Ma il Baglione ha sicuramente ragione ad affermare che il Terenzi era solito agire in questo modo, poiché in un processo lo vedia-mo come l’autore di «una Madonna con un Cristo e San Giovanni» e di una sant’Anna «finte antiche»30. È possibile che anche il Sassoferrato producesse (o facesse produrre) falsi, in quanto nell’inventario redatto alla sua morte nel 1685 si trovano anche «sei altri pezzi di paesi in tela di mezza testa et otto in tela di tre palmi tutti affumicati», evidentemente per farli sembrare antichi31.
263
Il mercato delle copIe a roma nel SeIcento
Angelo Caroselli era apparentemente capace di imitare esattamente le opere di Raffaello, Tiziano e Correggio, ma secondo il Passeri fu accusato a torto di volerle venderle per originali 32. Sappiamo che copiava il Poussin, forse anche in questo caso senza produrre falsi, cioè senza cercare di spacciare le copie per autografi del maestro francese: una sua copia di un dipinto di Poussin, di cui non conosciamo il soggetto, era in possesso di Agostino Tassi, il quale la vendette appunto come copia, insieme ad altri dipinti, per acquista-re una carrozza33. Il Tassi possedeva anche «una tela di testa della maniera di Mons. Poussin d’uno fiume e puttini e paese», quasi certamente fatta fare da lui, e venduta nella stessa occasione insieme ad un originale del Poussin. Nella lista dei dipinti barattati con la carrozza si osserva una minuziosa distinzione tra originali, copie e imitazioni del Poussin. Forse la correttezza del Tassi in questa occasione era dovuta al fatto che i dipinti furono valutati dal pittore Jean du Champs, originario di Cambrai e noto a Roma come Giovanni del Campo, che era certamente un esperto. Ma il Tassi, che notoriamente era privo di scrupoli, non deve sempre avere agito in maniera così irreprensibile: è anche possibile che dalla sua bottega uscissero imitazioni dei dipinti giovanili di Claude Lorrain e che proprio la capacità di contraffazione dell’ambiente intorno al Tassi avesse spinto il pittore lorenese a creare il Liber Veritatis, al fine di certificare le proprie opere originali34.
Il pittore più falsificato nel primo Seicento sembra essere stato il Caravaggio: Luigi Spezzaferro ha mostrato come Prospero Orsi, già nella seconda decade del Seicento, spacciasse per originali copie dei dipinti giovanili del Caravaggio, mentre vendeva le copie di opere più tarde come dipinti non autografi35. È sor-prendente però come negli inventari della famiglia Altemps, che acquistava sovente da mercanti e in particolare dall’Orsi, il concetto di autografia e copia si perda rapidamente36. È noto un altro caso in cui i concetti di copia, falso o originale dal Caravaggio sono estremamente confusi. Il pittore mercante Antonio Ursino, padre di Marzio Ganassini, aveva incaricato Alessandro Bazzicaluva, figlio di Ercole, di eseguire una copia di una versione dei Bari del Caravaggio in possesso del marchese Sannesi, per venderla a un suo cliente37. Tanto il quadro dei Sannesi, che era creduto un originale dal proprietario, ma non è affatto detto lo fosse, quanto la copia del Bazzicaluva furono rubate una notte, forse con la complicità del guardarobiere dei Sannesi, Marino Buonamici, che era un paren-te di Agostino Tassi. Un pittore amico e collaboratore di Agostino, Francesco Torrigiani, portò una di queste tele ad un calzolaio mercante di dipinti, Pietro Ancina, e tentò di vendergliela come autografo del Caravaggio per 200 scudi. Ma il calzolaio, che sarebbe stato disposto ad acquistare un originale per quel prezzo, mostrò il dipinto a Giulio Mancini e al pittore indoratore Francesco Modello, i quali non ne confermarono l’autografia. Modello affermò che per
264
P. Cavazzini
quanto fosse una buona copia, ve ne erano molte in giro e che al calzolaio non conveniva comperarla personalmente. Ancina la fece acquistare, per un prezzo irrisorio, a un gentiluomo milanese, e considerò l’affare di pochissimo conto, fino a quando non fu accusato, probabilmente a torto, visto il coin-volgimento di personaggi dell’entourage di Agostino Tassi, di essere l’autore del furto. Secondo la testimonianza del calzolaio, il dipinto che gli venne mostrato era eseguito su un telaio vecchio e recava sul retro la scritta «del Caravaggio» e un numero, presumibilmente di inventario. Più che una copia il dipinto era perciò un falso, visto che tanto il Mancini quanto Modello dichiararono che non si trattava di un autografo.
È interessante notare sia la familiarità del calzolaio con Giulio Mancini, sia come il giudizio del famoso esperto e quello dello sconosciuto pittore indorato-re per l’Ancina si equivalessero. Praticare la professione della pittura, a qualsiasi livello, era infatti considerato una garanzia delle proprie conoscenze in materia. È molto facile trovare nelle testimonianze seicentesche dichiarazioni di pittori, a volte del tutto sconosciuti e presumibilmente di qualità infima, che attestano la propria competenza a valutare dipinti. Un Pietro Lescot fiammingo affermò che «ogni sorta di pittore è bono e atto a stimare pitture ... e mi basta l’animo di stimare una pittura qualsivoglia et sia il suo giusto prezzo»; l’altrettanto oscuro Giovanni Battista Mandoni, anch’egli pittore, dichiarò che «qualsivoglia che dipinge potrà stimare e valutare pitture»38. Nelle parole di Ventura Salimbeni la mano di un pittore è altrettanto riconoscibile di una calligrafia: «noi pittori siamo come voialtri notai che conoscete le lettere l’un dall’altro et così rico-nosciamo noi le pitture et opere di noi pittori a un altro»39. È invidiabile la sicurezza che questi esperti ostentano e ci si domanda se fossero veramente così abili nel distinguere l’autografia di un’opera.
Si nota dalle vicende narrate quanto spesso i mercanti e gli intermediari fossero coinvolti nella produzione, oltre che nello smercio, di copie: come abbiamo visto fu Antonio Ursino, pittore di grottesche e proprietario di una bottega destinata alla vendita dei dipinti, ad accordarsi con i Sannesi e a incaricare un altro pittore di copiare i Bari per un suo cliente. Annibale Durante, pittore indoratore, scelse Innocenzo Tacconi per fargli eseguire una copia di un ritratto della regina di Francia in possesso dell’ambasciatore francese e che era destinata allo scultore Tommaso della Porta40. Pare anche che i mercanti potessero prestare ai collezionisti dipinti di loro proprietà per ricavarne copie. Questo almeno è quello che sostennero due fratelli, Francesco e Cristoforo Lupi, alla morte di monsignor Costanzo Patrizi. Secondo loro, dietro pressanti richieste del monsignore, gli avevano prestato un’Arca di Noè e un Seminatore del Bassano (probabilmente di Francesco il giovane) «ad effetto se ne servisse per farli copiare»41. Per riaverli, intendevano farli sequestrare, in
265
Il mercato delle copIe a roma nel SeIcento
quanto sospettavano che tutti i quadri dell’eredità del monsignore sarebbero stati venduti per appianare i debiti della famiglia. Anche se secondo Francesco Patrizi i quadri erano invece stati acquistati dal fratello Costanzo per 50 scudi, la storia raccontata dai mercanti doveva almeno essere plausibile. Doveva cioè essere concepibile avere in prestito dipinti da un mercante per copiarli.
Tra l’altro questi soggetti del Bassano dovevano avere una certa diffusione, dato che sono identificabili in varie collezioni romane del primo Seicento. Un’Arca di Noè era tra i pochi dipinti posseduti dal conte Nicola Soderini nel 1625 e già compariva nell’importante collezione di Filippo Guastavillani nel 1587; un certo Lorenzo Frangi, che certamente aveva grandi disponibilità economiche, possedeva invece forse un altro Seminatore, descritto nel suo inventario del 1619 come «un quadro da contadino copia del Bassano con un paro di bovi et altre figure»42. Inoltre anche le innumerevoli Quattro Stagioni presenti negli inventari romani sono a volte descritte come derivazioni dal Bassano. Come tali le troviamo, insieme ai Quattro Elementi, anche nella bottega del pittore mercante Pietro Paolo Giglio il quale, come discusso in precedenza, vendeva copie di immagini particolarmente diffuse43. Oltre ai «paesi di Fiandra» perciò, anche la produzione dei Bassano deve avere un peso nel collezionismo di dipinti di paesaggio a Roma all’inizio del Seicento.
Patrizia Cavazzini
1 M.C. Terzaghi, Caravaggio tra copie e rifiuti, «Paragone», 59, 2008, 82, pp. 32-71.2 Vari argomenti qui accennati sono stati trattati più ampiamente in P. Cavazzini, Painting as Business in Early Seventeenth Century Rome, University Park 2008, a cui si rimanda anche per ulteriore bibliografia.3 Ibidem, pp. 53, 179-180, nn. 22, 25, 26, 27. Per il processo, vedi L. SiCkeL, Künstlerrivalität im Schatten der Peterskuppel: Giuseppe Cesari d’Arpino und das Attentat auf Cristoforo Roncalli, «Marburger Jahrbuch für Kunstwissenchaft», 28, 2001, pp. 159-189; a. Cirinei, Conflitti artistici, rivalità cardinalizie e patronage a Roma fra Cinque e Seicento. Il caso del processo crimi-nale contro il Cavalier d’Arpino, in La nobiltà romana in epoca moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali, a cura di M.A. Visceglia, Roma 2001, pp. 255-305; h. röTTgen, Il Cavalier Giuseppe Cesari d’Arpino. Un grande pittore nello splendore della fama e nell’incostanza della fortuna, Roma 2002.4 a. SuTherLand harriS, Andrea Sacchi. Complete Edition of the Paintings with a Critical Catalogue, Oxford 1977, pp. 119-122 per l’inventario del Sacchi.5 Agostino Tassi (1578-1644): un paesaggista tra immaginario e realtà, catalogo della mostra, a cura di P. Cavazzini, Roma 2008, pp. 44-45, p. 178.6 Ibidem, p. 69, p. 202.7 d. Pegazzano, Documenti per Tommaso Salini, «Paragone», 48, 1997, 15-16, pp. 131-146.8 P. Cavazzini, Painting as Business, cit., p. 135, p. 198, n. 114; G. PeS, Nuovi documenti su Agostino Verrocchi e la sua cerchia a Roma, in Luce e ombra. Caravaggismo e naturalismo
266
P. Cavazzini
nella pittura toscana del Seicento, catalogo della mostra, a cura di P. Carofano, Pisa 2005, pp. CCLII-CLVI. Per ulteriori tracce del mercante Anselmo, F. niCoLai, Mecenati a confronto. Committenza, collezionismo e mercato d’arte nella Roma del primo Seicento. Le famiglie Massimo, Altemps, Naro e Colonna, Roma 2008, p. 190, pp. 243-244, p. 303.9 M. hoChMann, Le collezioni veneziane nel Rinascimento: storia e storiografia, in Il collezio-nismo d’arte a Venezia. Dalle origini al Cinquecento, a cura di M. Hochmann, R. Lauber, S. Mason, Venezia 2009, pp. 3-40, in part. p. 32.10 A. BerToLoTTi, Artisti Urbinati in Roma prima del secolo XVIII: notizie e documenti raccolti negli archivi romani, Roma 1881, pp. 30-31, per l’inventario.11 G. PaPi, Ribera a Roma, Soncino 2007, specialmente pp. 140-141, pp. 162-166.12 arChivio di STaTo di roMa (d’ora in poi ASR), Archivio Sforza Cesarini, parte prima, b. 1. Ringrazio Elena Fumagalli per la segnalazione.13 G. PaPi, Antiveduto Gramatica, Soncino 1995, pp. 94-95. Come nota Papi, anche il cardinal Del Monte possedeva un dipinto dello stesso soggetto. F. CaPPeLLeTTi, La committenza di Asdrubale Mattei e la creazione della galleria nel palazzo Mattei di Giove, «Storia dell’Arte», 76, 1992, pp. 256-295.14 P. Cavazzini, Oltre la committenza: commerci d’arte a Roma nel primo Seicento, «Paragone», 59, 2008, 82, pp. 72-92.15 ASR, Trenta Notai Capitolini (d’ora in poi TNC), uff. 19, giugno 1623, vol. 128, f. 781. Obbligo di Niccolò Rainiero fiammingo a favore di Chrespino Tommasino «che d. Niccolò debba fare quattro quadri delli quattro evangelisti della grandezza di un palmo di tela da imperatore tanto in altezza quanto in larghezza, in detto tempo, li quali quattro quadri essendo d’accordo tra loro d. Crispino li pigliarà per il prezzo che saranno d’accor-do et se compenserà pro rata il prezzo di detto tabì et non essendo d’accordo nel prezzo tra loro d. Nicolò debbi pagare d. prezzo di d. tabì come sopra non ostante che habbi fatto detti quadri liberamente». Non è del tutto chiaro che cosa significhi «un palmo di tela da imperatore», in quanto a Roma la definizione «tela da imperatore» denota una misura standard, non una qualità di tela. Per il Tommasino cfr. P. Cavazzini, Painting as Business, cit., pp. 35, 36, 54, 119, 127, 204.16 A. LeMoine, Nicolas Régnier: (alias Niccolò Renieri) ca. 1588-1667; peintre, collection-neur et marchand d’art, Paris 2007, pp. 221-222. Il San Matteo misura cm. 108x124, il San Luca cm. 148x120, le copie cm. 150x120. Un’altra versione del San Matteo, di cm. 165x141, posta in asta da Sotheby’s, New York, il 25 gennaio 2007, non è considerata autografa dalla Lemoine. Un San Matteo del Régnier apparteneva a Vincenzo Giustiniani, vedi M.C. Terzaghi, Caravaggio tra copie e rifiuti, cit., p. 39. L’autrice suppone fosse una copia del Caravaggio dello stesso soggetto di proprietà del marchese.17 P. Cavazzini, Painting as Business, cit., pp. 139-143, pp. 160-161.18 J. CoSTeLLo, The Twelve Pictures Ordered by Velasquez and the Trial by Valguarnera, «Journal of the Warburg and Courtauld Institute», 13, 1950, pp. 237-284, p. 272.19 A. BerToLoTTi, Artisti belgi e olandesi a Roma nei secoli XVI e XVII. Notizie e documenti raccolti negli archivi romani, Firenze 1880, p. 124.20 B. keMPerS, The Pope’s Two Bodies: Julius II, Raphael and St. Luke’s Virgin in Santa Maria del Popolo, in The Miracolous Image, Roma 2004, pp. 135-195. M. hoChMann, À propos de quelques collections de prélates: le goût pour les peintres vénetiens et Corrège à Rome à la fin du XVI° siècle, in Curiosité. Études d’histoire de l’art en l’honneur d’Antoine Schnapper, a cura di M. hochmann, V. gerard Powell, Paris 1998, pp. 277-283. A. BerToLoTTi, Gian Domenico Angelini pittore perugino e i suoi scolari, «Giornale di erudizione artistica», V, 1876, pp. 65-87,
267
Il mercato delle copIe a roma nel SeIcento
per l’interessante elenco di alcuni quadri rubati dalla dimora del pittore mercante Angelini.21 ASR, Tribunale Criminale del Governatore, Investigazioni, b. 451, 3 agosto 1626, f. 218v.22 F. niCoLai, Mecenati a confronto, cit., p. 297. Giglio possedeva sia una «Madonna che viene da Caravaggio copia di Sant’Agostino di palmi 8 e 5» che una «Madonna di Loreto con Cristo in braccio e due pellegrini palmi 8 e 6». Quest’ultima ricorda ovviamente il dipinto in Sant’Agostino, anche se in questo caso non è descritta come copia dal Caravaggio.23 P. Cavazzini, Painting as Business, cit., p. 150.24 ASR, TNC, uff. 19, b. 81, f. 376, 13 giugno 1610.25 F. niCoLai, Mecenati a confronto, cit., pp. 217, 264-265.26 P. Cavazzini, Painting as Business, cit., p. 150.27 ASR, Tribunale Civile del Governatore, b. 138, f. 563, 29 luglio 1628.28 ASR, Tribunale Civile del Governatore, b. 138, f. 558-59, 28 luglio 1628.29 G. BagLione, Le vite de’pittori, scultori et architetti dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fine a’ tempi di Papa Urbano VIII nel 1642, [Roma 1642] Città del Vaticano 1995, p. 157.30 ASR, Tribunale Civile del Senatore, b. 2070, 8 ottobre 1616, f. 1059, 1060v.31 L’inventario è stato discusso in occasione del convegno sul pittore che si è tenuto a Sassoferrato nel luglio 2009 e verrà pubblicato negli atti in corso di stampa.32 G.B. PaSSeri, Die Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, a cura di J. Hess, Worms 1995, p. 191 (prima edizione Roma, 1772).33 Vedi P. Cavazzini, Towards a Chronology of Agostino Tassi, «The Burlington Magazine», 144, 2002, pp. 396-408, per la lista dei dipinti venduti dal Tassi in cambio di una carrozza.34 P. Cavazzini, Claude’s Apprenticeship in Rome: The Market for Copies and the Invention of the LIBER VERITATIS, «Konsthistorisk tidskrift», 74, 2004, pp. 133-146.35 M.C. Terzaghi, Caravaggio, cit., p. 51. L. SPezzaferro, Caravaggio accettato. Dal rifiuto al mercato, in Caravaggio nel IV centenario della Cappella Contarelli, a cura di C. Volpi, Roma 2002, pp. 23-50.36 Idem; F. niCoLai, Mecenati a confronto, cit., pp. 59-79, pp. 216-240.37 La vicenda è stata spesso analizzata, vedi M.C. Terzaghi, Caravaggio, cit., pp. 70-71, nota 111 con ulteriore bibliografia, e M. Gregori, Un altro autografo dei Bari del Caravaggio, in Caravaggio. I Bari della collezione Mahon, catalogo della mostra, a cura di D. Benati, A. Paolucci, Forlì 2008, pp. 20-30, per un’interpretazione differente. Il documento è stato ripe-tutamente trascritto, vedi S. MaCioCe, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Fonti e documenti 1532-1724, Roma 2003, pp. 286-288, con qualche minima imprecisione, che però impe-disce di identificare alcuni dei personaggi coinvolti. Per questo vedi P. Cavazzini, Painting as Business, cit., pp. 131-133, p. 197, nota 97.38 ASR, TCG, processi, b. 298, 29 ottobre 1634, f. 665v, 671, citato e parzialmente tra-scritto in G.L. MaSeTTi zannini, Ebrei, artisti, oggetti d’arte. Documenti romani dei sec. XVI e XVII, «Commentari», 25, 1974, pp. 281-301. Vedi anche P. Cavazzini, Painting as Business, cit., pp. 126-127.39 A. BerToLoTTi, Gian Domenico Angelini, cit., pp. 65-87, p. 73.40 ASR, Tribunale civile del Governatore, b. 135, 4 marzo 1626, f. 149v. Durante aveva cono-sciuto Tacconi nel cantiere di San Sebastiano fuori le mura, vedi E. FuMagaLLi, Le fabbriche dei Borghese. Committenza di una famiglia nel Sei e Settecento, Tesi di dottorato, Roma, Università La Sapienza, a.a. 1992, pp. 466, 468. Ringrazio l’autrice per l’osservazione.41 ASR, TCG, Atti di Cancelleria, b. 95, fasc. 5, 1624.42 ASR, TCG, Atti di Cancelleria, b. 231, fasc. 9, per Soderini; ASR, TNC, uff. 19,
268
P. Cavazzini
marzo 1619, f. 67. M. HoChMann, À propos de quelques collections de prélates, cit., per Guastavillani, p. 279.43 Ivi, per una serie di stagioni dal Bassano nella collezione del cardinal Acquaviva. Vedi nota 22 per Giglio.
Fig. 1 – Agostino Tassi, Imbarco della Regina di Saba, Roma, collezione privata.
269
Il mercato delle copIe a roma nel SeIcento
Fig. 2 – Agostino Tassi, Commercio in un porto, ubicazione ignota.
Fig. 3 – Bottega di Agostino Tassi, Scena di porto con architetture, ubicazione ignota.