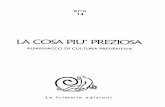Vibration responses of the organ of Corti and the tectorial membrane to electrical stimulation
Servizio al principe ed educazione cavalleresca: i paggi nelle corti italiane del Seicento, Parte...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Servizio al principe ed educazione cavalleresca: i paggi nelle corti italiane del Seicento, Parte...
ALESSANDRO CONT
SERVIZIO AL PRINCIPE
ED EDUCAZIONE CAVALLERESCA:
I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE
DEL SEICENTO.
PARTE SECONDA
F I R E N Z E
L E O S. O L S C H K I E D I T O R EMMXII
Estratto da:
STUDI SECENTESCHIRIVISTA ANNUALE
FONDATA DA
CARMINE JANNACO e UBERTO LIMENTANI
DIRETTA DA
MARTINO CAPUCCI e DAVIDE CONRIERI
Vol. LIII - 2012
SERVIZIO AL PRINCIPE ED EDUCAZIONE CAVALLERESCA:
I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
PARTE SECONDA
Gli assicuro che non ho mai provato la corte maadesso che la provo Gli dico che e il medesimoinferno
Scipione Lodovico Chieppio, 1683
1. UNA PALESTRA DELLE VIRTU?
Nel suo testamento del 9 marzo 1702, il marchese Bonaventura GuerrieriGonzaga, canonico primicerio della basilica di Sant’Andrea a Mantova, racco-mandava ai suoi fratelli ed eredi universali Tullo e Cesare di continuare a vi-vere nel timore di Dio, aborrendo le risse, le contese, e gli omicidi. «La nobiltadel sangue», rammentava solennemente l’austero prelato, «bene spesso rima-ne oscurata da cattivi costumi e da operationi improprie e perverse». Cosı,Guerrieri Gonzaga mirava a scongiurare, per quanto gli era possibile, che quelsangue della nobilta scorresse corrotto e impuro nelle vene dei suoi «posteri»,vale a dire dei futuri rappresentanti della sua casata.1
Al pari di altri esponenti dell’aristocrazia mantovana, e non solo di questa,anche Bonaventura Guerrieri Gonzaga si era consacrato alla vita ecclesiasticarelativamente tardi, dopo avere percorso una carriera di corte e diplomatica.2
1 Cfr. Archivio di Stato di Mantova (ASMn), Archivio Notarile, n. 6221, Mutti Giulio Cesare,1702-1703, Testamentum ill.mi et rev.mi d. marchionis Bonaventure Guerrerii primicerii ecclesiæ colle-giate S. Andreæ, Mantova, 9.III.1702.
2 Per la personalita e le parentele di Bonaventura Guerrieri Gonzaga (ca. 1651-1708) cfr. ASMn,Archivio Gonzaga (AG), s. F.II.3, b. 2074, appuntamento del consiglio riservato nel Palazzo Ducaledi Mantova, 11.X.1705; Archivio privato De Moll-Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina (TN), n.n.,PARMENIO TERZINIO, Memorie istoriche della famiglia de’ Guerrieri di Fermo e di Mantova, ms.,1756, p. 154; nello stesso archivio, n.n., Arbore della famiglia Guerrieri, disegno acquerellato, sec.XVIII; ASMn, Documenti patrii raccolti da Carlo d’Arco, CARLO D’ARCO, Annotazioni genealogichedi famiglie mantovane che possono servire all’esatta compilazione di queste, ms., sec. XIX, IV,p. 396; MICHELE MAYLENDER, Storia delle Accademie d’Italia, III, Bologna ecc., Cappelli, 1929, p. 365.Altri cortigiani suoi contemporanei che, in eta matura o avanzata, abbracciarono la condizione eccle-
10
Vi fosse approdato per una vocazione sacra oppure per l’anelito a un portodi quiete e di certezza, in ogni caso egli aveva certamente assimilato nellapropria esperienza quella cultura che trovava anche nella «scienza chiamatacavalleresca» un imprescindibile punto di riferimento per le aristocrazie e peri loro giovani figli inviati a formarsi presso le scuole delle paggerie di corteitaliane.3
La cinquecentesca dottrina dell’onore si era evoluta in un difficile com-promesso tra razzismo dell’antica nobilta del sangue e tensione post-tridentinaverso un disciplinamento spirituale e comportamentale della societa.4 L’ag-gressiva penetrazione, nel secondo Seicento, di modelli culturali d’improntafrancese corroboro e ingentilı un atteggiamento ideale e uno stile comporta-mentale che, al fondo, perpetuavano il carattere guerresco dell’aristocrazia.5
L’onore estrinseco che la scienza cavalleresca aveva posto come fine del nobilelaico era infatti vincolato al valore delle armi, alla difesa generosa dei deboli edegli oppressi e alla risposta franca e immediata alle offese ricevute.6 Gli scrittidi Ascanio Gonzaga di Vescovato, Giovanni Pietro de’ Crescenzi, Giacomo
142 ALESSANDRO CONT
siastica furono i mantovani Lelio Ardizzoni, Francesco Chieppio e Ascanio Gonzaga di Vescovato,nonche il modenese Bonifacio Rangoni. Cfr., rispettivamente, C. D’ARCO, Annotazioni genealogiche,cit., I, p. 230, e III, p. 240; ALESSANDRO CONT, Ascanio Gonzaga di Vescovato (1654-1728). Dalla spadaal pastorale, parte I: La spada, «Atti e Memorie», Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettereed Arti, Mantova, LXXV, 2007; POMPEO LITTA, Rangoni di Modena, Milano, Giulio Ferrario, 1833,tav. V.
3 «Prelato di somma edificazione» lo definı il Fioretto di Mantova annunziandone la morte nel1708: cfr. C. D’ARCO, Annotazioni genealogiche, cit., IV, p. 396.
4 Cfr. in part. GIANCARLO ANGELOZZI, La proibizione del duello. Chiesa e ideologia nobiliare, inIl concilio di Trento e il moderno, a cura di Paolo Prodi e Wolfgang Reinhard, Bologna, Il Mulino,1996; CLAUDIO DONATI, La trattatistica sull’onore e il duello tra Cinquecento e Seicento. Tra consenso ecensura, «Studia borromaica», XIV, 2000, pp. 39-56; G. ANGELOZZI e CESARINA CASANOVA, La no-bilta disciplinata. Violenza nobiliare, procedure di giustizia e scienza cavalleresca a Bologna nel XVIIsecolo, Bologna, CLUEB, 2003; A. CONT, Ascanio Gonzaga di Vescovato, cit.
5 Per l’influsso della Francia sulla cultura nobiliare in Italia cfr. C. DONATI, Guerra, carriera mi-litare e nobilta delle armi in Scipione Maffei, in Scipione Maffei nell’Europa del Settecento, a cura diGian Paolo Romagnani, Verona, Consorzio editori veneti, 1998, pp. 32-33; ID., L’idea di nobilta inItalia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 291-296.
6 Cfr. WALTER BARBERIS, Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda, Torino, Ei-naudi, 1988, pp. 104-122; GUSTAVO DI GROPELLO, La nobilta piacentina e la funzione delle armi,in I Farnese. Corti, guerra e nobilta in antico regime, a cura di Antonella Billotto et alii, Roma,Bulzoni, 1997, pp. 47-52; G. ANGELOZZI e C. CASANOVA, La nobilta disciplinata, cit.; ANGELANTO-
NIO SPAGNOLETTI, Onore e spirito nazionale nei soldati italiani al servizio della monarchia spagnola,in Militari e societa civile nell’Europa dell’eta moderna (secoli XVI-XVIII), a cura di C. Donati eBerhard R. Kroener, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 227-229; A. CONT, Ascanio Gonzaga di Vesco-vato, cit., in part. pp. 189-198. Sulla predominanza che in campo militare conservarono le nobiltaeuropee d’eta barocca cfr. HAMISH M. SCOTT e CHRISTOPHER STORRS, The Consolidation of NoblePower in Europe (c. 1600-1800), The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centu-ries, I, a cura di H.M. Scott, London-New York, Longman, 1995, pp. 41-46. Per il caso savoiardocfr. C. STORRS, War, Diplomacy and the Rise of Savoy, 1690-1720, Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1999, pp. 235-236, 243-248.
Natta d’Alfiano, figure emblematiche di tutta un’epoca, tutelavano proprio ta-le concezione della realta.7
Ancor piu della coeva dottrina dell’‘economica’, deputata alla buona ge-stione della casa in quanto cellula fondamentale della societa e modello primi-genio di ogni governo terreno, la scienza cavalleresca era riuscita veramente asoddisfare le esigenze spirituali dell’aristocrazia.8 Complesso di principi dog-matici e di regole pratiche volti alla comprensione e alla pronta risoluzione deicasi quotidiani, con una letteratura specializzata e tanto di superciliosi ‘profes-sori’, la scienza cavalleresca era assurta a vangelo secolare dell’uomo blasona-to. Non solo, poiche era riuscita a penetrare sino negli spazi piu reconditi del-le reggie, nei recessi dell’anima e della mente dei sovrani.
Ma il potere esercitato dalla scienza cavalleresca sulla personalita uma-na e politica dei regnanti era destinato a creare un’intima contraddizione,tale da influire anche sugli indirizzi educativi dettati dai sovrani stessi perla loro corte e quindi per le scuole dei paggi che in questa trovavano sede.Il principe ‘assolutista’ e cristiano, infatti, doveva forzatamente conviverecon il principe ‘cavaliere’.9 Per un verso, duchi e granduchi puntavano aumiliare l’arroganza della nobilta e a promuovere la pace sociale controla pratica del duello d’onore, dalla quale la scienza cavalleresca aveva trattoorigine.10 Nel contempo, tuttavia, molti di essi amavano sfoggiare l’abito diprimi cavalieri del loro Stato, fungendo da paladini di un credo profanoche asseriva l’indipendenza dell’onore estrinseco, cioe sociale, dall’inter-
7 Per Gonzaga cfr. A. CONT, Ascanio Gonzaga di Vescovato, cit.; invece per Crescenzi cfr.C. DONATI, Scipione Maffei, cit., p. 33; infine per Natta cfr. ivi, pp. 61-63. Nel 1699 il duca FerdinandoCarlo di Mantova dichiarava che la casata dei Natta marchesi d’Alfiano in Monferrato «non ha bi-sogno d’alcuna pruova di nobilta, virtu e valore, poiche traendo dalli piu antichi, illustri e famosistipiti d’Europa degna e chiara l’origine [...] apparisce». La stessa famiglia, proseguiva il Serenissimo,«e stata sempre cosı feconda di soggietti riguardevoli che non ha saputo invidiarne alcun’altra nellescienze, nell’armi e nella religione, essendo dalla stessa provenuti e prudenti ambasciatori, e gran ca-pitani e religiosi consiglieri»: ASMn, AG, s. F.II.12, Libri delle Patenti, n. 14, c. 1r, patente di mastrodi camera a favore di Giacomo Natta d’Alfiano, Venezia, 15.II.1699. Per un approfondimento suiNatta d’Alfiano cfr. GIACOMO NATTA e VIRGINIO NATTA GUISCARDI, Genealogia et relatione della fa-miglia Natta, Alessandria, Giovanni Battista Tavenna, 1710.
8 Sulla «Economica», cfr. DANIELA FRIGO, Il padre di famiglia. Governo della casa e governo ci-vile nella tradizione dell’Economica tra Cinque e Seicento, Roma, Bulzoni, 1985.
9 Cfr. MARCO CAVINA, Il sangue dell’onore. Storia del duello, Roma-Bari, Laterza, 2005, pp. 165-
205; A. CONT, Ascanio Gonzaga di Vescovato, cit.10 Cfr. MARCO BELLABARBA, Adeliges Leben und Territorialstaaten in Norditalien im Ubergang
vom XVI. zum XVII. Jahrhundert, «Geschichte und Region/Storia e regione», III, 1994, pp. 189-
210; ID., Nobility and Justice in Northern Italy, Fifteenth to Seventeenth Centuries, in Institutionen,Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im fruhneuzeitlichen Europa – Insti-tutions, Instruments and Agents of Social Control and Discipline in Early Modern Europe, a cura diHeinz Schilling, con la collaborazione redazionale di Lars Behrisch, Frankfurt am Main, Kloster-mann, 1999, pp. 225-248.
143I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
vento della potesta principesca, in quanto bene esclusivo e inalienabile del-l’individuo nobile.11
Con le loro disposizioni, i principi tendevano a plasmare un ceto aristocra-tico che ammettesse la superiore autorita del sovrano ma insieme si riconosces-se in un comune sostrato di cultura morale e cavalleresca, cosı da contemperarele finalita di governo e di prestigio del regnante con le aspettative delle casate diprovenienza dei giovinetti.12 Considerati dai sovrani alla stregua di sudditi, ipaggi lo rimanevano infatti nei limiti consentiti dall’etica dell’onore cavallere-sco e dalle limitazioni oggettive frapposte al concreto dispiegarsi del potereprincipesco.13 Nei confronti dei paggi, il vertice della corte doveva ottemperareal ruolo di sovrano dispotico e nel medesimo tempo alla funzione di pedagogo-affidatario della crescita spirituale e intellettuale di giovani nobili.
«Nostro desiderio e nostro peso», dichiarava dunque il granduca CosimoIII de’ Medici nel 1670, e «di provvedere che i paggi che servono nella nostracorte ricevano una educazione proporzionata alla loro nascita e siano indiriz-zati per un cammino che conduca all’acquisto della virtu e de’ buoni costu-mi».14 Un compito simile era particolarmente delicato, poiche si fronteggiavacon i problemi umani di adolescenti spesso indocili e fieri, a cui faceva dausbergo il blasone della nobilta dei natali e l’autorevolezza politica delle fami-glie di provenienza.15 Per tale ragione, i paggi delle corti dei Medici, dei Sa-voia, degli Este, dei Gonzaga e dei Farnese dovevano essere accolti presso«uno de’ palazzi» di Sua Altezza, regola che corrispondeva alla qualita dellaloro origine sociale e alla reputazione del loro servizio rivolto al sovrano,ma che nello stesso tempo era funzionale all’esercizio di un piu efficace con-trollo, da parte di quest’ultimo, sulla loro condotta.16
144 ALESSANDRO CONT
11 Cfr. Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Bentivoglio d’Aragona, Lettere, b. 397, c. 220r,Ascanio Gonzaga al cugino Luigi Bentivoglio, Mantova, 3.IX.1698.
12 Cfr. Archivio della Fondazione d’Arco di Mantova (AFAMn), Archivio Chieppio (AC), b. 45,nn. 1-3, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Mantova?, 24.VI.1683, 2.VII.1683 eMantova, 9.VII.1683.
13 Cfr. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), Ms. Gal. 168, cc. 71r e 73r, Bruto An-nibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, [1661 circa].
14 BNCF, Fondo Gino Capponi, ms. 241, Instruzione e capitoli da osservarsi nell’educazione de’signori paggi rossi, Firenze, 14.IX.1670.
15 Della «pocca applicazione con la quale studia la gioventu» e delle «infinite dissipazioni inse-parabili dal loro [dei paggi] stato» sarebbe stato ben consapevole anche l’anonimo estensore dellaMemoria intorno agli studii dei pagi d’onore della corte di Torino (post 1752): cfr. Archivio di Statodi Torino, Archivio di corte, Materie economiche, Istruzione pubblica, Accademia Reale, m. 1 d’ad-dizione, n. 15.
16 Cfr. Archivio di Stato di Modena (ASMo), Archivio segreto estense (ASE), Casa e Stato (CS),Corte, b. 454, Capitoli de’ paggi, sec. XVI (ante 1597), capp. 1, 3, 31; ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454,fasc. Casa, paggeria. Capitoli e regolamenti (sec. XVI-1775), Capitoli in libro pei paggi, sec. XVI, cap. I;BNCF, Ms. Gal. 161, c. 227r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Firenze, 17.VI.1660;
Alle medesime finalita erano ordinate le norme con le quali la corte assi-curava al corpo dei paggi uno o piu servitori nonche un vitto di eccellenza.«Cavalieri di nascita», i paggi del duca di Savoia avevano diritto a essere «tuttispesati a spese di Sua Altezza Reale, e per loro servigio si tiene uno stato aparte, con suoi ufficiali e servienti in esso».17 Invece i cinquecenteschi Capitolide’ paggi della corte estense di Ferrara, in vigore anche dopo l’ ‘esilio’ dellastessa a Modena, avevano stabilito che il governatore ispezionasse la cucinaaccertandosi che a tavola i ragazzi fossero sempre serviti con vivande conformial loro rango di «gentilhomeni».18 Tuttavia, i Capitoli prevedevano anche uncorrispettivo da parte dei paggi, i quali alla mensa dovevano comportarsi «co-me conviene a servitori d’un tanto prencipe, dimostrando in ogni attione granpolicia».19
La garanzia di un trattamento adeguato escludeva inoltre la possibilita diuna autogestione individualista da parte del giovinetto, la quale minacciavadi compromettere il buon esito di un ben mirato progetto educativo impostatodal principe.20 Ogni mossa del paggio era quindi subordinata all’approvazionee alla sorveglianza dei superiori, in modo da avvolgere il giovane in una sorta dicortina protettiva, confinandolo entro uno spazio fisico e morale immune dallecontaminazioni e dalla promiscuita del mondo. In questo spazio si doveva es-sere in grado di predisporre gradatamente il ragazzo al contatto con la realtacircostante.21 Pertanto al paggio veniva proibito di recarsi in qualsiasi luogo
Instruzione e capitoli, cit., cap. XIII; Memorie per il regolamento delle fonzioni spettanti alle tre carichedi corona, alle cariche di gran mastro della guardarobba, e delli elemosinieri di S.A.R. ed alle cariche adessa subordinate, e da essa dipendenti, 1679-1680, libro III, capp. 17 e 18, in Raccolta per ordine di ma-terie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798sotto il felicissimo dominio della real casa di Savoia in continuazione a quella del senatore Borelli, acura di Felice Amato Duboin, VIII, X, Torino, Eredi Bianco & C., 1832, pp. 214 (da cui la citazione),216; SERGIO BERTELLI, Modena. Una corte barocca, in Il Palazzo Ducale di Modena. Regia mole maioranimus, a cura di Elena Corradini et alii, Modena, Fondazione Cassa di risparmio di Modena, 1999,pp. 160-161; ID., Palazzo Pitti dai Medici ai Savoia, in La Corte di Toscana dai Medici ai Lorena, a curadi Anna Bellinazzi e Alessandra Contini, Roma, Ministero per i beni e le attivita culturali. Direzionegenerale per gli archivi, 2002, pp. 32-33; ROBERTO SABBADINI, La grazia e l’onore. Principe, nobilta eordine sociale nei ducati farnesiani, Roma, Bulzoni, 2001, p. 51; IOLANDA PROTOPAPA, La paggeria. Unascuola per la giovane nobilta, in Vivere a Pitti. Una reggia dai Medici ai Savoia, a cura di S. Bertelli eRenato Pasta, Firenze, Olschki, 2003, pp. 36-41; Il Palazzo di Sassuolo. Delizia dei Duchi d’Este, a curadi Filippo Trevisani, fotografie di Luciano Romano, design di Laura Casalis, Parma, Grafiche STEPeditrice, 2004, p. 79. Il maggiordomo maggiore Giovanni Vincenzo Salviati, tuttavia, avvisava Giu-seppe Chieppio che i paggi del granduca di Toscana sprovvisti di una «propria casa» a Firenze ve-nivano fatti alloggiare presso lo speziale maggiore del Serenissimo: cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc.LXXIV, n. 92, da Val di Marina, 13.VII.1683.
17 Memorie per il regolamento, cit., libro III, cap. 17, in Raccolta, cit., p. 214.18 Capitoli de’ paggi, cit., cap. 42. Inoltre, cfr. ivi, cap. XXXII; Capitoli in libro, cit., cap. 42.19 Capitoli de’ paggi, cit., cap. 42.20 Cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. 5.21 Cfr. I. PROTOPAPA, La paggeria, cit., pp. 29-30, 36. Questa strategia e espressamente dichiarata
145I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
senza autorizzazione, e senza l’accompagnamento di un servitore della pagge-ria.22 Gli era inibita la familiarita con i camerieri, con gli altri aristocratici, con isuoi stessi cugini, tutti potenziali fautori di traviamento e di svilimento del suoaulico carattere: 23 «Ai paggi sia conservato il rispetto dovuto alla nascita e pro-fession loro», ammoniva infatti il granduca toscano Cosimo III.24
Di necessita, anche i rapporti interpersonali tra i paggi erano regolamentaticon la massima attenzione, in modo da schivare per quanto possibile i contattidei «grandi» e piu smaliziati con i «piccoli» e piu ingenui, e badando che i ra-gazzi «trattino fra loro co’ i riguardi della dovuta modestia».25 E il Serenissimodi Toscana non esitava a prescrivere che il maestro intercettasse regolarmente,«con la discretezza conveniente», le lettere in entrata e in uscita dalla paggeria,onde sottoporre a rigoroso vaglio ogni pensiero e ogni azione dei giovani.26
Sotto l’autorita e la supervisione del governatore, e a Firenze del maestro, iservitori cooperavano a mantenere l’ordine interno della paggeria e la discipli-na personale dei paggi.27 Nella deprecata eventualita di una colpevole negli-genza o complicita con i ragazzi, erano previste per gli stessi servitori delle pe-ne che potevano giungere sino alla perdita del loro posto, in quanto lo statosociale del paggio e l’immaturita di adolescente e pre-adolescente richiedeva-no la piu grande cautela.28
La stessa scienza cavalleresca, che pure sosteneva l’ereditarieta della virtucome dotazione precipua dell’uomo nobile, ammetteva quanto debole e peri-coloso fosse il ragazzo per se stesso, per la sua famiglia e per la societa in ge-nere.29 Se abbandonato alla «lusinga dell’ozio» o a cattive compagnie, alla suainesperienza e alla sua irrequietezza, l’adolescente metteva a repentaglio l’ono-re proprio e della casata d’origine, e contribuiva nel suo piccolo a minare ifondamenti del primato aristocratico.30 Per la sua labilita caratteriale egli ma-
146 ALESSANDRO CONT
anche nelle regole per i paggi della corte di Federico da Montefeltro (1444-1482): cfr. Ordini et offitijalla corte del serenissimo signor duca d’Urbino. Dal codice manoscritto della Biblioteca Vaticana N.1248, a cura di Giuseppe Ermini, Urbino, Regia Accademia Raffaello, STEU, 1932, cap. XVII, p. 26.
22 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit., capp. 7, 23; Instruzione e capitoli, cit., capp. 6, XIII.23 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit., capp. 14, 22, 35; Capitoli in libro, cit., cap. 7; Instruzione e capitoli,
cit., capp. 3, 8.24 Cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. 8.25 Ivi, cap. 4. Cfr. altresı Capitoli de’ paggi, cit., passim.26 Instruzione e capitoli, cit., cap. XX. La disposizione e gia stata segnalata da I. PROTOPAPA, La
paggeria, cit., p. 30.27 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit.; Instruzione e capitoli, cit., capp. 7, XIIII, XVII, XXIII.28 Cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. XXIII.29 Cfr. Mantova, Biblioteca Comunale Teresiana, ms. 683 (F.II.29), ASCANIO GONZAGA DI VE-
SCOVATO, Pareri cavallereschi, sec. XVII, Parere XIV, pp. 146-147, Parere XXI, p. 206, Parere XXIII,pp. 224-225.
30 Cfr. RENATA AGO, Giovani nobili nell’eta dell’assolutismo. Autoritarismo paterno e liberta, in
nifestava inquietanti rassomiglianze con la donna, soggetto ‘debole’ e ‘imper-fetto’ per eccellenza, «difetto o errore della natura», «animale prodotto a sortee per caso».31 La missione dell’educatore consisteva pertanto nel permettere algiovinetto, individuo acerbo, ambiguo, di sviluppare pienamente le potenzia-lita insite nella sua natura di maschio forte e generoso, perche esplicasse atempo debito le virtu «che le sono di precisa necessita a non meditar che passiheroici in qualunque sorti di camino intraprendera».32 Cosı veniva rispettatol’equilibrio cosmico che un sistema di concetti aprioristici, secondo la domi-nante mentalita aristotelica, fondava sulla incorrotta e stabile ripartizione dellefunzioni e delle competenze vitali tra le molteplici componenti della societaumana.33 Sulle caratteristiche delle pulsioni dell’eta biologica e sui tratti dellafigura ideale del giovinetto cristiano sia gli autori ecclesiastici che i professorid’onore, sia i prelati che i principi erano in buona sostanza concordi.34 Comeinsegnava sant’Ambrogio,
Est igitur bonorum adulescentium timorem Dei habere, deferre parentibus, ho-norem habere senioribus, castitatem tueri, non aspernari humilitatem, diligere cle-mentiam ac verecundiam, quæ ornamento sunt minori ætati.35
Storia dei giovani, I, a cura di Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt, Roma-Bari, Laterza, 1994,pp. 392, 407-415; I. PROTOPAPA, La paggeria, cit., pp. 29-30. La citazione e tratta da ASMo,ASE, CS, Carteggi tra principi estensi, Principi non regnanti, Rinaldo di Alfonso III, b. 245,n. 1768.LXIII.22, card. Rinaldo d’Este al cugino Cesare Ignazio d’Este (minuta), 24.IX.1670.
31 A. GONZAGA DI VESCOVATO, Pareri cavallereschi, cit., Parere X, pp. 104-105. Sul tema cfr.R. AGO, Giovani nobili, cit., p. 392; D. FRIGO, Principe e capitano, pace e guerra. Figure del ‘politico’tra Cinque e Seicento, in Il ‘‘perfetto capitano’’. Immagini e realta (secoli XV-XVII), a cura di MarcelloFantoni, Roma, Bulzoni, 2001, p. 304; A. CONT, Ascanio Gonzaga di Vescovato, cit. Il radicato con-cetto della donna quale essere inferiore affiora anche da due lettere spedite dai fratelli conti Vialardiall’amico Giuseppe Chieppio in occasione della nascita di due figlie. Carlo Maria rassicurava che«sintanto che vi rimane la forma si puo sperare di stampare de’ maschi, onde per la prima feminanata non bisogna sgomentarsi» (AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIII, n. 65, da Guastalla, 8.XII.1682).Alcuni anni piu tardi, dopo un altro parto, Romualdo se ne compiaceva «a quel segno che si praticaquando nascono femine»; e confessava che «una spinta di piu vi faceva il totale» (AFAMn, AC, b. 38,fasc. LXXVI, n. 84, da Venezia, 17.XI.1685). La stessa mentalita veniva esibita dal paggio ScipioneChieppio, pur con un atteggiamento piu ingenuo. Scipione, infatti, augurava al fratello maggioreGiuseppe «un bell figliolone maschio e a me un bell nipotino»; tuttavia, «se mai Dio volesse maiche fosse una femina Gliela auguro bella e buona come sono Lor due che Dio Gliela conceda»(AFAMn, AC, b. 38, fasc. LXXV, n. 2, da Firenze, 3.I.1684).
32 ASMo, ASE, CS, Carteggi tra principi estensi, Principi non regnanti, Rinaldo di Alfonso III,b. 245, n. 1768.LXIII.21, card. Rinaldo d’Este al cugino Cesare Ignazio d’Este (minuta), s.d. Una vivaaspirazione alla propria ‘virilita militare’ era coltivata dal diciannovenne paggio Bruto della Molara:cfr. BNCF, Ms. Gal. 161, c. 161, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Roma, 11.V.1658.
33 Cfr. D. FRIGO, Il padre di famiglia, cit., in part. pp. 32-33, 75-82, 103-116, 139-145; M. BELLA-
BARBA, La giustizia nell’eta moderna (XVI-XVIII secolo), Roma-Bari, Laterza, 2008, p. X; A. CONT,Ascanio Gonzaga di Vescovato, cit.
34 Al proposito sono illuminanti le lettere indirizzate dal cardinale e principe Rinaldo d’Este se-niore al cugino adolescente Cesare Ignazio d’Este (1666-1672): cfr. ASMo, ASE, CS, Carteggi traprincipi estensi, Principi non regnanti, Rinaldo di Alfonso III, b. 245, n. 1768.LXIII.
35 AMBR., De officiis ministrorum, libr. I, cap. 17, 65.
147I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
Tempio dell’anima e immagine esteriore della nobilta dei natali e dellamaesta del sovrano, il corpo dei giovinetti, e quindi il loro portamento e i lorogesti, dovevano modellarsi secondo i precetti socialmente riconosciuti del de-coro e della modestia. Tenere «le mani nette» era proprio dei «gentilomini»,36
e «disdicevole cosa» era «ch’il paggio il qual ha da servire principi sia spor-co».37 La moda del secolo prevedeva che i paggi tenessero una lunga chioma,ma il granduca Cosimo III imponeva che il barbiere addomesticasse quellaleonina cresta almeno una volta la settimana.38
Anche gli abiti dovevano essere decenti, vale a dire dignitosi senza inutili evani orpelli. L’impiego della livrea, fornita, come le calze, dalla guardaroba dicorte, era d’obbligo non solo durante il servizio, ma anche in occasione delleuscite in ‘privato’ dalla reggia.39 La livrea, infatti, qualificava il ragazzo sullabase della sua professione, lo identificava allo sguardo dei superiori che nescrutavano i movimenti e agli occhi degli estranei che dovevano portargli ri-spetto, in piu garantiva una conveniente uniformita a un preciso livello gerar-chico della corte.40 Era indispensabile, dunque, che il paggio fosse sempre inordine, che egli non tralasciasse, per trascuratezza o spavalderia, di portare ilcolletto, ne vendesse o impegnasse i propri vestiti.41 Rispetto alle spese per icapi dell’abbigliamento privato, inoltre, bisognava che i ragazzi «aggravinole case loro meno che sia possibile, e che salva una decente pulizia osservinoanche nel vestire la modestia».42
Analoghi criteri di ordine e compostezza valevano per la gestualita, votataa esprimere il pieno dominio, nel paggio, delle proprie emozioni e l’amabile
148 ALESSANDRO CONT
36 Capitoli de’ paggi, cit., cap. 4.37 Ivi, cap. 30.38 Cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. XVIII; I. PROTOPAPA, La paggeria, cit., p. 43. Le regole cin-
quecentesche per i paggi estensi avevano invece ordinato che il capo dei ragazzi rimanesse rasato: cfr.Capitoli de’ paggi, cit., cap. 30.
39 Cfr. Capitoli in libro, cit., capp. 43, 44, 45.40 Cfr. M. FANTONI, La corte del Granduca. Forme e simboli del potere mediceo fra Cinque e Sei-
cento, Roma, Bulzoni, 1994, pp. 77-91.41 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit., capp. 16, 39; Capitoli in libro, cit., capp. 43, 44, 45.42 Instruzione e capitoli, cit., cap. 5. Quanto fosse rilevante la personale apparizione in ordine a
una buona accoglienza del giovane aristocratico nella societa dei suoi pari e a una sua fruttuosa car-riera a corte, viene attestato da un episodio fiorentino del 1683. Alcuni cavalieri discorsero con la can-tante Maria Bonzi sulla «assai spilorcia comparsa» del novello paggio Scipione Chieppio. La «canta-trice», discorrendone poi con l’abate mantovano Antonio Tarachia, che aveva accompagnato ilconterraneo adolescente a Palazzo Pitti, non gli aveva taciuto che quei nobiluomini «tra l’altre cosegli havevano osservato [al paggio] un collarino di punti di quelli che bisognava che fossero in guar-darobba di suo avo». Irritato, Tarachia tento di giustificare il povero ragazzo, ma quello che piu ditutto lo indispose, fu «il sentire quanto presto havevano fatto ad osservarlo e trinciarle i panniadosso, mentre era un sol giorno che si ritrovava in corte, riflettendo cosa havrebbero fatto in pro-gresso di tempo». Cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 90, Antonio Tarachia a Giuseppe MariaChieppio, Mantova, 13.VII.1683.
grazia di un autentico cavaliere. «Savii et accostumati»,43 i giovinetti avrebbe-ro assistito alla santa messa «con devotione e rispetto»,44 dalla tavola nonavrebbero strillato all’indirizzo dei cuochi,45 ma sempre e dappertutto sareb-bero fruttificati nella «diligenza e la modestia, non disgiunte da maniere nobilie cortesi con ogni sorte di persona».46 Se qualcuno avesse errato, se, predadella gola, avesse profanato i rinfreschi del principe e dei suoi ospiti o se sifosse macchiato nel mentre recava le pietanze alla mensa del Serenissimo,una buona dose di sfilettate avrebbe ricondotto il giovane sul giusto sentiero.47
Una postura corretta, un armonioso procedere nei movimenti, quali siconfacevano a un ragazzo aristocratico, avevano per i paggi una immediatatraduzione pratica in termini di quotidiano ‘impiego professionale’. Nei semi-naria nobilium retti dai Gesuiti o da congregazioni di ecclesiastici secolari, lostato di avanzamento nel processo educativo dei giovinetti si esplicitava alpubblico esterno attraverso periodiche «accademie di lettere e d’armi» e inter-mezzi teatrali.48 Invece i paggi venivano esaminati e giudicati ogni giorno sulcampo, dallo stesso ambiente che essi avrebbero frequentato poi da adulti.Proprio l’essenziale concomitanza del servizio pratico svolto in parallelo conl’applicazione agli studi rappresentava una interessante peculiarita delle pag-gerie.
2. CAVALIERI A SCUOLA
L’importanza solenne che i programmi di educazione per i paggi attribui-vano al servizio reso al principe e alla corte non aveva corrispondenze nei pia-ni didattici preposti all’attivita dei collegi gesuitici o dei seminari diocesani.49
Nemmeno la partecipazione alle funzioni ecclesiastiche prestata per statuto oper altre motivazioni da alcuni o da tutti gli alunni di un seminario diocesano
43 Capitoli de’ paggi, cit., cap. 16.44 Ivi, cap. 24.45 Cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. XIIII.46 Ivi, cap. 9.47 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit., cap. 29; ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Ca-
pitoli e regolamenti (sec. XVI-1775), Capitoli per i paggi che servono alla tavola ducale, sec. XVI.48 Cfr. GIAN PAOLO BRIZZI, La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria
nobilium nell’Italia centro-settentrionale, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 252-254; ANTONIO G.G. ME-
RENDONI, L’arte cavalleresca e il duello pubblico nel ducato dei Farnese, 1537-1731, in I Farnese, cit.,pp. 316-317; ALESSANDRA CHIARELLI, Per un profilo delle feste d’armi a Modena nel Cinque e Seicento,in Musica in torneo nell’Italia del Seicento, a cura di Paolo Fabbri, Lucca, Libreria musicale italiana,1999, pp. 51-54.
49 Cfr. G.P. BRIZZI, La formazione, cit., pp. 207-256.
149I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
era paragonabile alla rilevanza che il servizio cerimoniale assumeva all’interno
dei regolamenti per i paggi delle corti.50 Lezioni frontali, studio a tavolino e
servizio cortigiano da parte dei paggi venivano regolamentati come aspetti im-
prescindibili e interdipendenti dell’istruzione di un perfetto cavaliere.Il calendario giornaliero dei paggi, per come era scandito dalla legislazione
della corte, presentava infatti una significativa alternanza di «scuole» e «servi-zio».51 Tra la mattina e la sera le lezioni frontali e gli esercizi cavallereschi era-
no intercalati e talora, per quanto riguardava i paggi che il governatore sceglie-
va ad hoc, sostituiti dalle funzioni cerimoniali alla messa e alla tavola del
principe nonche dal servizio con le torce allorquando il sovrano si trovava
«fuori di casa» di sera o bisognava accompagnare le dame ai ricevimenti attra-
verso lo scalone d’onore della reggia.52
Per parte loro, i Capitoli de’ paggi estensi esoneravano del tutto dalla fre-
quenza della scuola quanti erano quotidianamente assegnati, sempre dal go-vernatore, perche «faciano la guardia ala camera di Sua Altezza et tenghino
serati gli usci che nissuno entrar possi eccetto li camerieri e particularmente
le feste».53 Questi ultimi giovinetti, inoltre, erano gli stessi che la mattina se-
guente avrebbero prestato servizio alla santa messa.54 Con ciascuna delle fun-
zioni di corte, eccetto quelle che richiedevano l’impiego del cavallo, dovevano
venire familiarizzati i piu giovani, affinche potessero servire al piu presto ac-
canto agli altri paggi.55
Per quello che invece concerneva il programma degli studi scolastici dei
paggi rossi, Cosimo III de’ Medici stabiliva una priorita assoluta tra le disci-
150 ALESSANDRO CONT
50 Sulla parte attiva di cui i «figlioli» e i «chierici» frequentanti le scuole del seminario potevanoessere investiti nelle cerimonie liturgiche della cattedrale cfr. Archivio storico del Seminario Vesco-vile ‘‘Giovanni XXIII’’ di Bergamo, b. 1, fasc. 2, class. 4.1.1, Elenco delle azioni principali della rev.macongrega del venerando seminario dall’anno 1647 sino al 1782, sec. XVIII, ad diem 8.XI.1668; CARLO
FANTAPPIE, I problemi giuridici e finanziari dei seminari tridentini, in Chiesa chierici sacerdoti. Cleroe seminari in Italia tra XVI e XX secolo, a cura di Maurizio Sangalli, Roma, Herder, 2000, p. 94,nota 26.
51 I due termini si trovano nella Instruzione e capitoli, cit., capp. 2, 9.52 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit. (da cui, al cap. 15, la citazione); Instruzione e capitoli, cit.; Memorie
per il regolamento, cit., libro III, cap. 17, in Raccolta, cit., pp. 212-216; S. BERTELLI, Modena. Una cortebarocca, cit., p. 161.
53 Capitoli de’ paggi, cit., cap. 18. Per la guardia che alla camera del duca di Savoia prestavanosempre due paggi, scelti dal governatore «nel modo che a lui pare piu proporzionato», cfr. inveceMemorie per il regolamento, cit., libro III, capp. 17 e 18, in Raccolta, cit., pp. 213, 215-216.
54 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit., cap. 19. Il governatore doveva badare che fossero di eguale sta-tura.
55 L’equitazione non era reputata confacente ai piu piccoli. In piu, il maneggio rivestiva il carat-tere di un premio per la buona condotta e la diligenza nello studio. Cfr. Capitoli de’ paggi, cit., cap. 6;Instruzione e capitoli, cit., cap. 3; AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 132, Scipione Lodovico Chiep-pio al fratello Giuseppe Maria, Firenze, 12.X.1683.
pline dettata dalla sua particolare venerazione per la lingua latina. Il granduca,infatti, non ammetteva che «si consenta a’i minori di passare ad altri studi seprima non saranno in quella sufficientemente avanzati».56 Ma colui che puoessere considerato il piu colto tra i principi italiani del secondo Seicento, enel contempo il meno interessato alle materie cavalleresche e militari, qualeera Cosimo III, interveniva con precise disposizioni anche nel campo del di-sciplinamento etico-morale.57 Cosı, dopo la scomparsa del granduca Ferdinan-do II, la paggeria toscana si adeguava al nuovo clima della corte di Pitti, alme-no esteriormente ancora piu devoto e pio di quanto non fosse stato inprecedenza.58
Nello stabilire per i paggi l’ascolto quotidiano della messa e la recita, oltreche delle orazioni serali, anche del piccolo officio della Madonna ogni giorno,dell’officio dello Spirito Santo ogni giovedı, dell’officio della Croce ogni ve-nerdı, il Serenissimo fissava quasi nei dettagli un calendario devozionale mi-rando alla metabolizzazione, da parte dei ragazzi, di una religiosita di stampocontroriformista.59 Perfino nel linguaggio, l’intransigente e dispotico granducaadottava uno stile affatto pastorale, quasi da vescovo ordinario che si impegnanel governo del suo gregge.60
Tale comportamento, tipico della mentalita cosimiana, si discosta per lasua intensita dallo spirito, pur sempre ‘tridentino’, dei Capitoli per i paggi fer-raresi risalenti alla seconda meta del secolo XVI. Basti notare che questi ultimiesigevano che i giovinetti si accostassero al sacramento della penitenza «inanziil Natale et inanzi la Pascha», ossia due volte all’anno su modello del resto del-la corte estense.61
56 Instruzione e capitoli, cit., cap. 2.57 Sulla figura di Cosimo III cfr. soprattutto La Toscana nell’eta di Cosimo III, a cura di Franco
Angiolini et alii, Firenze, EDIFIR, 1993; Storia della civilta toscana, III, a cura di Elena Fasano Gua-rini, Firenze, Le Monnier, 2003, passim.
58 Cfr. HELENE CHAUVINEAU, La cour des Medicis (1543-1737), in Florence et la Toscane XIVe-XIXe siecle. Les dynamiques d’un Etat italien, a cura di Jean Boutier et alii, Rennes, Presses univer-sitaires de Rennes, 2004, pp. 290-291. Sulla carita cristiana del maggiordomo maggiore Giovanni Vin-cenzo Salviati cfr. VALERIA PINCHERA, Lusso e decoro. Vita quotidiana e spese dei Salviati di Firenzenel Sei e Settecento, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1999, pp. 182-188.
59 Cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. 1; quindi MARIA PIA PAOLI, Di madre in figlio. Per unastoria dell’educazione alla corte dei Medici, «Annali di Storia di Firenze», III, 2008, http://www.dssg.unifi.it/SDF/annali/annali2008.htm, p. 120. Le disposizioni sabaude del 1680 si restringe-vano a ordinare che ciascun giorno i paggi udissero «la santa messa» e recitassero «le loro orazioni»:cfr. Memorie per il regolamento, cit., libro III, capp. 17 e 18, in Raccolta, cit., pp. 214, 216.
60 Per la politica ecclesiastica di Cosimo III, cfr. M. FANTONI, La corte del Granduca, cit.,pp. 201-229; GAETANO GRECO, Provvedimenti e pratiche nel governo politico della Chiesa locale nel-l’eta di Cosimo III, in La Toscana nell’eta di Cosimo III, cit., in part. pp. 445-449; M.P. PAOLI, Leragioni del principe e i dubbi della coscienza. Aspetti e problemi della politica ecclesiastica di CosimoIII, in La Toscana nell’eta di Cosimo III, cit.
61 Cfr. Capitoli de’ paggi, cit., cap. 43.
151I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
Al contrario, Cosimo III imponeva la confessione «almeno una volta il me-se e tutte le feste piu principali col veder che si communichino quelli che sa-ranno in eta».62 Inoltre, il granduca non tralasciava di confermare l’impegno,cui i paggi «piu piccoli», quali giovinetti della loro epoca, non potevano sot-trarsi, di frequentare la loro scuola domenicale della Dottrina Cristiana.63
Tuttavia, pur con questi accenti umanistici e religiosi, la notevole impor-tanza conferita alle arti cavalleresche tra le materie d’insegnamento rimanevauna caratteristica basilare della paggeria di Cosimo III al pari di tutti gli altriistituti del suo genere.64 Arti cavalleresche erano dunque la musica, la calligra-fia, il disegno, le lingue toscana e francese, la storia, la geografia, l’aritmetica, eancora la matematica, la fortificazione, l’architettura civile, la danza, l’equita-zione, la scherma, gli esercizi con armi diverse e in parte anche il nuoto.65 Ad-dirittura nelle norme per i paggi sabaudi del 1680 lo studio del latino scompa-riva del tutto, lasciando libero campo proprio a queste discipline che venivanoinsegnate, come in ogni paggeria, da appositi maestri.66 Sull’equitazione, sullacalligrafia, sul ballo, sulla scherma e sul volteggio, tuttavia, a Torino prevalevala matematica, con la quale i giovinetti avrebbero appreso «la maniere d’atta-quer et de deffendre les places» in vista delle loro future azioni militari.67
Rispetto ad altri istituti, gli esercizi cavallereschi avevano trovato nellepaggerie la loro arena di elezione, una sorta di habitat naturale. L’insegnamen-to che i seminari diocesani e i monasteri cittadini impartivano ai chierici diestrazione aristocratica escludeva decisamente tali discipline, per privilegiarele materie letterarie, filosofiche, teologiche e giuridiche.68 I Gesuiti erano staticostretti ad ammettere gli esercizi cavallereschi presso accademie interne ai lo-
152 ALESSANDRO CONT
62 Instruzione e capitoli, cit., cap. 1. Alcune preziose riflessioni sulla pratica confessionale in etapost-tridentina si trovano nel nuovo studio di M. BELLABARBA, La giustizia, cit., pp. 71-75.
63 Cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. 1.64 Cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIII, n. 69, Francesco Preti al cognato Giuseppe Maria
Chieppio, Firenze, 13.XII.1682; ivi, fasc. LXXIV, n. 74, allo stesso, Firenze, 19.VI.1683.65 Cfr. G.P. BRIZZI, La formazione, cit., pp. 235-256; VINCENZO V. PRUITI, La Cavallerizza Reale,
2008, www.socistara.it/studi/cavallerizza_reale.pdf, pp. 1-2. Alla «bagnatura», in particolare, e dedi-cato un intero paragrafo delle regole del 1670 (cfr. Instruzione e capitoli, cit., cap. XII), come gia eraavvenuto nella normativa per i paggi ferraresi del secondo Cinquecento (cfr. Capitoli de’ paggi, cit.,cap. 45).
66 Cfr. Memorie per il regolamento, cit., libro III, cap. 17, in Raccolta, cit., p. 214. Per l’orienta-mento nel secolo successivo cfr. Memoria intorno agli studii, cit.; Archivio di Stato di Torino, Archi-vio di corte, Materie economiche, Istruzione pubblica, Accademia Reale, m. 1 d’addizione, n. 15,[Memoria sugli studi dei paggi del re di Sardegna], in francese, sec. XVIII.
67 Cfr. Memorie per il regolamento, cit., libro III, cap. 17, in Raccolta, cit., p. 214. L’espressionein francese e tratta dal manifesto del 1677 per la fondazione dell’Accademia Reale di Torino: cfr.W. BARBERIS, Le armi del Principe, cit., p. 178.
68 Cfr. A. CONT, Il Capitolo della Cattedrale di Bergamo (1708-1773). Un corpo ecclesiastico ai mar-gini della Terraferma veneta, Bergamo, Litostampa istituto grafico, 2008, in part. pp. 42-45.
ro collegi dei nobili, cedendo alle istanze delle nobili famiglie e alle esigenze diceto non piu eludibili «poiche la spada et il cavallo sono gli segni che distin-guono con evidenza un cavagliere in mezzo ad una turma di plebei».69 Ma,almeno formalmente, nei seminaria nobilium lo studio del latino, del catechi-smo e, a un livello scolastico superiore, quelli della filosofia e del diritto resta-vano, in armonia con le finalita della Compagnia di Gesu, dominanti e cuoredell’intera proposta didattica.70
Al contrario, le accademie per nobili istituite nell’Italia del secolo XVII trasuggestioni culturali europee (francesi in particolare) e stimoli patriottici era-no consacrate propriamente alle materie cavalleresche.71 A proposito di taliistituzioni, non bisogna dimenticare come, attraverso l’Accademia Reale diTorino aperta nel 1678, la reggente Maria Giovanna Battista di Savoia-Ne-mours intendesse migliorare anche l’educazione dei paggi di corte, ai qualivenne aperta la cavallerizza del nuovo istituto, e come la sopraintendenza diquest’ultimo venisse demandata al gran scudiere Carlo Ludovico San Martinod’Aglie il quale era altresı superiore degli stessi paggi.72 Interessante da notaree il caso dell’Accademia dei Nobili inaugurata a Firenze nel 1689, la quale, or-ganizzandosi con spirito e struttura singolarmente agili e aperti, accoglieva so-prattutto nobili un po’ piu anziani dei paggi, nobili che vi si sarebbero potutirecare, a proprio agio, di mattina, pomeriggio ovvero la sera per frequentarein tutta liberta l’uno oppure l’altro insegnamento, cordiale autogestione orga-nizzata tra i membri della medesima aristocrazia locale e cittadina.73
Non sarebbe corretto contrapporre alla personale autonomia fruita dagliaccademici fiorentini una situazione di subordinazione dei paggi in generale,ingabbiati in un rigido programma di apprendimento. Non solo calando nellapratica le regole fissate per l’ammaestramento degli stessi paggi si teneva con-
69 AFAMn, AC, b. 45, n. 29, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio,Mantova, 29.X.1683. Sull’argomento cfr. G.P. BRIZZI, La formazione, cit., pp. 227-229, 235-256. Giu-seppe Chieppio, appena entrato nel collegio di Parma, garantiva a suo padre Annibale di avere«datto principio alli studii tanto letterarii quanto cavallereschi», ed esprimeva la speranza «con lamagiore applicatione [...] d’inoltrarmi sempre piu, con profitto, come sapra mostrare la picciola ha-bilita»: AFAMn, AC, b. 33, fasc. LXI, n. 136, da Parma, 7.IX.1677.
70 Cfr. G.P. BRIZZI, La formazione, cit., pp. 209-235. Per una concreta esperienza individuale cfr.AFAMn, AC, b. 33, fasc. LXI, nn. 93 e 141, Giuseppe Maria Chieppio al padre Annibale, Parma,4.XII.1678 e 15.V.1679.
71 Cfr. NORBERT CONRADS, Ritterakademien der fruhen Neuzeit. Bildung als Standesprivileg im16. und 17. Jahrhundert, Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1982, pp. 238-265; J. BOUTIER, L’ ‘‘Ac-cademia dei Nobili’’ di Firenze. Sociabilita ed educazione dei giovani nobili negli anni di Cosimo III, inLa Toscana nell’eta di Cosimo III, cit., pp. 221-222.
72 Cfr. N. CONRADS, Ritterakademien, cit., pp. 248-249; W. BARBERIS, Le armi del Principe, cit.,pp. 177-179; C. STORRS, War, Diplomacy, cit., p. 237; PAOLA BIANCHI, La corte dei Savoia. Disciplina-mento del servizio e delle fedelta, in I Savoia. I secoli d’oro di una dinastia europea, a cura di W. Bar-beris, Torino, Einaudi, 2007, p. 160; V.V. PRUITI, La Cavallerizza Reale, cit., p. 7.
73 Cfr. J. BOUTIER, ‘‘L’Accademia dei Nobili’’, cit.
153I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
to dell’esigenza di temperare le prescrizioni, ma anche nelle tendenze generalidei superiori si rintracciano casi specifici in cui prevalsero la duttilita e la tol-leranza, l’intelligenza del caso. Per esempio nel 1683 il primo maestro dei paggidi Palazzo Pitti, Amadore Magnelli, assicuro Giuseppe Maria Chieppio che ilfratellino di costui Scipione Lodovico «per gli studi si portera avanti in quelliove avra piu inclinazione».74 E in questo modo il giovane subito pote gettarealle ortiche il paludamento latino per consacrarsi agli studi di lingua francese,musica e canto, a lui piu congeniali.75
Ma soprattutto quanto premeva alle casate della nobilta era la garanziache i figli laici introdotti presso collegi e paggerie ricevessero almeno le cogni-zioni di base nelle discipline umanistiche e cavalleresche.76 Esibire un conte-gno di garbata naturalezza, rivelare uno spirito vivace e arguto, dispiegare untalento diplomatico, palesarsi abile negli svaghi nobiliari, il tutto con qualchenozione di lingua (latina, francese, spagnola, magari anche tedesca), di storia edi tecniche militari era l’indispensabile conditio sine qua non per cementarefortune familiari e individuali.77
Mosso da questa consapevolezza, nella primavera del 1660 il ventunenneBruto Annibaldi della Molara poteva supplicare umilmente il granduca Ferdi-nando II de’ Medici
d’avanzarmi nel Suo servizio [...] parendomi che poco piu abile possa rendermi in questo
col star piu paggio di quello habia fatto col procurare di impossessarmi piu che ho possuto
ne’ studii ne’ quali ci favoriscie Vostra Altezza accertandoLa che fuora piu che mai pro-curero d’abilitarmi per godere de’ favori della grazia di Vostra Altezza quale intendo go-
dere col mio sudore e con quel poco merito che la fortuna mi dara e non altrimenti.78
154 ALESSANDRO CONT
74 AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 80, Amadore Magnelli a Giuseppe Maria Chieppio, Fi-renze, 6.VII.1683.
75 Cfr. alcune lettere di Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio (1683-1684)in AFAMn, AC, b. 45, nn. 15, 19, 20, 24, 33, 35, 38, 43, 52, 58; inoltre, AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV,n. 74, Francesco Preti al cognato Giuseppe Maria Chieppio, Firenze, 19.VI.1683. Pochi mesi primadell’ingresso di Scipione a Pitti, nel timore di un suo totale sbandamento, il gesuita Luigi Masdoniaveva cercato di riavere il ragazzo con se nel collegio di Parma, «luoco tanto proprio alla sua eta e allasua buona educazione». Tuttavia per ottenere lo scopo, il religioso aveva adottato una strategia ana-loga a quella del suo stesso ‘concorrente’ Magnelli, offrendosi cioe di intercedere presso il duca Ra-nuccio II Farnese «per quello spetta al particolare della cavallerizza» e garantendo che «ne’ studi» ilgiovane «fara quel che puole ed io sempre l’aiutero in essi e [...] godero si faccia un disinvolto ca-valiere negli essercizii di suo genio». Cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 31, Luigi Masdoni aGiuseppe Maria Chieppio, Parma, 9.III.1683.
76 Cfr. G.P. BRIZZI, La formazione, cit., in part. pp. 206-207.77 Cfr. D. FRIGO, Il padre di famiglia, cit., pp. 120-122; STEPHAN KREMER, Herkunft und Werde-
gang geistlicher Fuhrungsschichten in den Reichsbistumern zwischen Westfalischem Frieden und Saku-larisation. Furstbischofe-Weihbischofe-Generalvikare, Freiburg ecc., Herder, 1992, pp. 145-148.
78 BNCF, Ms. Gal. 161, c. 225r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Firenze,8.VI.1660.
Come riferiva lo stesso Bruto al suo maestro e amico Vincenzo Viviani, ilgranduca «mi replico piu volte ‘‘bene bene Vi ho inteso’’, con la solita buonacera».79
La figura dell’aristocratico che palesa la sua intrepida ignoranza era statacondannata dall’umanesimo quattro-cinquecentesco e poi dalle dottrine del-l’onore e dell’economica, nella sicurezza che «la qualita della nascita per sesola non basta per rendersi riguardevole, ma vi vuole la virtu et il sapere».80
La lotta contro l’incultura nobiliare ora veniva imposta anche dall’aggressivaconcorrenza di togati, finanzieri e uomini di sapere che riuscivano a farsi stra-da con il prestigio o la spregiudicatezza delle loro risorse intellettuali.81 I nobilipiu sensibili e accorti provavano in effetti un qualche imbarazzo, e talvolta unsenso di nervosa impotenza di fronte alle carenze formative proprie e di certiloro pari, quali venivano smascherate dalle circostanze della vita. «S’io fossilegale potrei far molte cose da me, ma Ella sa molto bene ch’io ne son del tut-to ciecho, e percio conviene haver presso di me persona da fidarmi», scrivevanel 1697 l’inviato mantovano a Vienna, conte Carlo Maria Vialardi, al marche-se Claudio dei Nobili Gonzaga.82 E un altro conte, Giuseppe Chieppio, invi-tava il volubile fratellino Scipione a riflettere su «quanti cavaglieri sono inMantova che sono resi ridicoli apresso tutti per la loro ignoranza, ne meno[Lei] puol dire di farsi stimare con la robba perche sa come stiamo».83
Ma un autentico gentiluomo non poteva essere semplicemente il prodottodi maceranti studi da tavolino. Solo l’esperienza diretta plasmava un cavalierecosmopolita, fisicamente aitante, bastantemente dotto, gradevole, utile a se, alsuo sovrano e alla sua contrada. Per il conte Carlo Petrozani ({ 1686), gia pag-
79 Ibid.80 ASMo, ASE, CS, Carteggi tra principi estensi, Principi non regnanti, Rinaldo di Alfonso III,
b. 245, n. 1768.LXIII.36, card. Rinaldo d’Este al cugino Cesare Ignazio d’Este, Reggio, 30.IX.1671. Ingenerale sul tema, cfr. D. FRIGO, Il padre di famiglia, cit., pp. 119-122; DOMINIQUE JULIA, L’infanziaagli inizi dell’epoca moderna, in Storia dell’infanzia, I, a cura dello stesso autore e di Egle Becchi,Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 280-281.
81 Cfr. M. BELLABARBA, La giustizia, cit., in part. pp. 141-148. Come rammentava il cardinale eprincipe Rinaldo d’Este seniore, per «il fondamento di qualche letteratura [...] bisogna necessaria-mente passare a chi vuol conseguire il fine desiderato e rendersi habili in qualunque fortuna»: ASMo,ASE, CS, Carteggi tra principi estensi, Principi non regnanti, Foresto di Borso, b. 284, n. 1833.I,[card. Rinaldo d’Este] al cugino Foresto d’Este, 11.IV.1669 (minuta), c. 1r. Cfr. inoltre ASMo,ASE, CS, Carteggi tra principi estensi, Principi non regnanti, Rinaldo di Alfonso III, b. 245, n.1768.LXII.14, card. Rinaldo d’Este al cugino Foresto d’Este, Modena, 4.VIII.1669.
82 Cfr. ASMn, AG, s. E.II.3, b. 504, fasc. [1697. Di Carlo Maria Vialardi], n. 5, da Vienna,27.II.1697 (minuta). Nel suo carteggio diplomatico, Vialardi ritorna piu volte su questo punto: cfr.ivi, n. 19, al duca Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, Vienna, 20.III.1697 (minuta); ivi, n. 43, a Clau-dio dei Nobili Gonzaga, Vienna, 29.V.1697 (minuta); ivi, fasc. 1698. Del conte Carlo Maria Vialardi perla successione di Guastalla, Luzzara e Reggiolo, n. 216, allo stesso, Venezia?, 11.X.1698.
83 AFAMn, AC, b. 45, n. 3, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Mantova,9.VII.1683.
155I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
gio del duca di Mantova e in seguito cavallerizzo maggiore dell’elettore di Ba-viera e del duca di Savoia, «lo stare fuori della patria fa huomini, poiche quegliesercitii cavallereschi che egli [Petrozani] possiede gli ha appresi in alcuni an-ni che e stato altrove».84 E infatti Carlo, ormai inchiodato al letto dal mal digotta, si interessava vivamente agli studi di Scipione Chieppio, forse perche inquesto modo riviveva la propria adolescenza, nondimeno nella convinzioneche il soggiorno a Firenze sarebbe stato di giovamento al conterraneo.85
La corte, considerata quale organismo vitale, nella sua dimensione sociale,nelle sue dinamiche istituzionali, nel suo stile politico, nelle sue iniziative cul-turali e scenografiche avrebbe dovuto costituire una grande scuola per i pag-gi.86 Qui, certo, nei siti deputati, si impartivano e si recepivano lezioni frontali,si attuavano gli esercizi pratici, si celebrava il servizio rivolto al sovrano, ai suoifamiliari e ai suoi ospiti.87 Tuttavia era nella sua qualita di ‘opera totale’ baroc-ca, specchio della cultura e della sociabilita aristocratica e percio teatro delladialettica politica, che la corte avrebbe potuto offrire la sede piu adatta perl’educazione, presuntivamente in positivo, di un cavaliere compito e galante.88
La corte avrebbe assolto maggiormente a questa funzione proprio se il paggiovi fosse giunto dalla lontana patria con il bisogno di emanciparsi dal suo pro-vincialismo.
In effetti, nel sistema «corte» il paggio era perfettamente integrato in virtudella sua «professione», come testimonia altresı la parte coreografica riserva-tagli negli spettacoli eccezionali che celebravano la corte trasfigurandola inun’aura di mitologia assolutista.89 Il corteo, combattimento simulato e balletto
156 ALESSANDRO CONT
84 AFAMn, AC, b. 45, n. 19, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio,Mantova, 17.IX.1683. Per la figura di Petrozani, pronipote del piu celebre ministro e canonico man-tovano Tullio, cfr. altresı ivi, n. 29, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio,Mantova, 29.X.1683; VINCENZO DE CONTI, Notizie storiche della citta di Casale e del Monferrato, VIII,Casale, Casuccio e Bagna, 1841, p. 292; C. D’ARCO, Annotazioni genealogiche, cit., VI, p. 142.
85 Cfr. AFAMn, AC, b. 45, nn. 19, 24, 29, 35, 50, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lo-dovico Chieppio, Mantova, 17.IX.1683, 15.X.1683, 29.X.1683, 26.XI.1683, 25.II.1684.
86 Per quanto concerne invece i futuri sovrani cfr. A. SPAGNOLETTI, Le dinastie italiane nellaprima eta moderna, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 310-314.
87 Cfr. Memoria intorno agli studii, cit.; [Memoria sugli studi dei paggi del re di Sardegna], cit.88 «Le reggie de’ principi lavorate all’uso de’ fini non volgari s’innalzano dissomiglianti dalle
case de’ privati, che si disegnano solo ai comodi dell’ozio e si fabricano solo alle morbidezze d’undelizioso riposo», osservava il poeta veneziano Domenico David in una lettera di dedica a FrancescoII d’Este (cfr. DOMENICO DAVID, Il palagio, overo l’albergo de’ principi d’Este, Venezia, Andrea Po-letti, 1688). E il maggiordomo maggiore Giuseppe Varano di Camerino cantava a un altro duca, cioeal suo sovrano Ferdinando Carlo Gonzaga di Mantova, che «la reggia d’un monarca e a noi palestra, /che suol destar gli addormentati spirti. / Crescon l’edere qui, le palme, e i mirti / premio di dottafronte, e nobil destra» (GIUSEPPE VARANO DI CAMERINO, Divertimenti poetici, Venezia, GiovanniGiacomo Hertz, 1683, In lode della corte, p. 10).
89 Cfr. W. BARBERIS, Le armi del Principe, cit., tavv. 3, 7. Sul significato della festa principescanel sec. XVII, cfr. FRANCA VARALLO, Le feste sabaude nella storia e nella storiografia, in Feste baroc-
a cavallo dal titolo Il mondo festeggiante, che nell’anfiteatro del giardino di Bo-boli fu organizzato per gli sponsali del 1661 tra i principi Cosimo de’ Medici eMargherita Luisa d’Orleans appartiene a questo genere di rappresentazioni.90
Qui, significativamente, «veruno [...] non ebbe luogo, che o per nascita natu-ral vassallo della Toscana, o per elezione attual servitore di questa corte nonfusse».91 Venti paggi ebbero l’onore di accompagnare il «feroce destriero»sfarzosamente bardato su cui lo sposo, novello Ercole, fece la sua solenne en-trata nell’anfiteatro.92 Un altro paggio, Bruto della Molara, guido invece lasquadra dei cavalieri africani, eroe di pelle nera, fiero nell’armatura a liste egirelli di tela bianca adornate d’argento e oro, dalla quale cadevano nappe do-rate al pari dei finimenti del corsiero.93
Con questa opera-torneo a soggetto, Firenze tributo l’estremo, e rutilanteomaggio alla «festa di molte cavalleresche operazioni composta».94 Non solo ilmutare del gusto a livello europeo, ma anche gli orientamenti intellettuali deisovrani, e forse ancora le sopraggiunte ristrettezze economiche, ebbero un’im-portanza determinante nel progressivo declino di tale forma di spettacolo, co-me la ebbero nell’attuazione di riforme dal carattere istituzionale e culturaleall’interno delle altre corti italiane.95 Apporti innovativi di questo genere si fa-
che. Cerimonie e spettacoli alla corte dei Savoia tra Cinque e Settecento, a cura di Clelia Arnaldi diBalme e Franca Varallo, Cinisello Balsamo (MI), Silvana, 2009, pp. 19-20.
90 Cfr. FEDERICO GHISI, ‘‘Il mondo festeggiante’’. Balletto a cavallo in Boboli, in Scritti in onoredi Luigi Ronga, Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, p. 233; FLAVIA e GIOVANNA SPARAPANI, La Forza e laLeggiadria. Dalla fantasmagoria dei balletti a cavallo alla raffinatezza delle danze di sala, in La musica ei suoi strumenti. La Collezione Granducale del Conservatorio Cherubini, a cura di Franca Falletti etalii, Firenze, Giunti, 2001, pp. 58-59; MATTEO CASINI, La corte, i cerimoniali, le feste, in Storia dellacivilta toscana, cit., pp. 471, 482. Fin dal mese di dicembre 1660, in previsione «del parentado che sideve assolutamente concludere a maggio» tra i principi Cosimo e Margherita Luisa, non si discuteva«d’altro che di feste da farsi in tal tempo ed occasione»: BNCF, Ms. Gal. 161, c. 286r, Bruto Anni-baldi della Molara a Vincenzo Viviani, Firenze, 11.XII.1660.
91 GIOVANNI ANDREA MONIGLIA, Il mondo festeggiante..., Firenze, Stamperia di S.A.S., 1661,p. 9.
92 Cfr. ivi, pp. 19-20.93 Cfr. ivi, p. 26.94 Ivi, p. 9.95 Sul torneo a soggetto nelle corti italiane del secondo Seicento cfr. PAOLA BESUTTI, Giostre,
tornei, fuochi e naumachie a Mantova fra Cinque e Seicento, in Musica in torneo, cit., pp. 11-14, 29-
32; A. CHIARELLI, Per un profilo, cit., pp. 59-61; P. BESUTTI, Giostre e tornei a Parma e Piacenza du-rante il ducato dei Farnese, in Musica in torneo, cit., pp. 77-79; SABRINA SACCOMANI, Feste a cavalloalla corte sabauda nella seconda meta del XVII secolo, ivi, pp. 99-102; CHIARA CURCI, Feste, mascheratee armeggiamenti a cavallo nel Ducal Palazzo, in Il Palazzo Ducale, cit., pp. 196-198; SARA MAMONE, Ilsistema dei teatri e le accademie a Firenze sotto la protezione di Giovan Carlo, Mattias e Leopoldo prin-cipi impresari, in Teatro e spettacolo nella Firenze dei Medici. Modelli dei luoghi teatrali, a cura di El-vira Garbero Zorzi e Mario Sperenzi, Firenze, Olschki, 2001, pp. 83-97; GEOFFREY SYMCOX, La reg-genza della seconda madama reale (1675-1684), in Storia di Torino, IV, a cura di Giuseppe Ricuperati,Torino, Einaudi, 2002, pp. 206, 209-210; ID., La trasformazione dello Stato e il riflesso nella capitale,ivi, pp. 837-841; MERCEDES VIALE FERRERO, Itinerario per le Feste Perdute, in Feste barocche, cit., p. 45.
11
157I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
cevano avvertire soprattutto con le successioni al governo dello Stato,96 e, ul-timi ma non ultimi, pure i conflitti militari provocavano ricadute negative che,come nel caso della Guerra della Grande Alleanza (1689-1697), erano destinatia gravare in modo pesante sulle finanze principesche e delle corti.97
3. DUE PROFILI: LORENZO VERZUSO BERETTI LANDI E BRUTO ANNIBALDI DELLA
MOLARA
Quanto forte potesse rivelarsi l’influsso dei costumi sociali e degli orienta-menti culturali delle corti in un determinato momento sulle propensioni e gliinteressi personali di singoli paggi emerge dalla biografia di due personaggiche furono educati nella reggia del sovrano e qui ottennero cariche rilevanti.
Lorenzo Verzuso Beretti Landi (1661-1725), a Mantova dai primi anni Set-tanta, maturo un sincero amore per le belle lettere e gli spettacoli in simbiosicon la effervescente atmosfera della corte gonzaghesca. Palazzo Ducale riful-geva come un centro di altissimo livello per la fruizione di lavori musicali eteatrali.98 Lo stesso Lorenzo, divenuto segretario ducale per le lettere di com-
158 ALESSANDRO CONT
96 Nel 1674, ad esempio, il quattordicenne Francesco II d’Este assunse le redini del potereesautorando di fatto la madre Laura Martinozzi (cfr. LODOVICO ANTONIO MURATORI, Delle anti-chita estensi, II, Modena, Stamperia ducale, 1740, p. 594; LUIGI AMORTH, Modena capitale. Storiadi Modena e dei suoi duchi dal 1598 al 1860 [1961], Milano, Martello, 1967, pp. 134-135). Questa ini-ziativa gli venne rinfacciata, nel gennaio 1685, da una lettera anonima a lui stesso diretta. A provadei danni arrecati dalla presunzione e dalla negligenza del duca, tale accusa indicava la scomparsada Modena di «piu di 7000 milla anime oltra la corte della detta Serenissima e di Madama [Lu-crezia Barberini, nonna del regnante], le quali spesavano tanti poveri, li quali molti si sono ritiratiin altre citta», la decadenza del Collegio San Carlo e la chiusura dell’accademia di belle lettere.Cfr. ASMo, CS, Documenti spettanti a principi estensi, Principi regnanti, Francesco II, b. 347,n. 1974.III.31, p. 4. Per una diversa valutazione della politica culturale di Francesco II cfr.L. AMORTH, Modena capitale, cit., pp. 144-152; PATRIZIA RADICCHI, Francesco II d’Este ed il collezio-nismo artistico e musicale estense, in Musica a Corte e in Collezione. Dagli strumenti musicali di Casad’Este alle collezioni storiche, s.l., s.e., [2002], pp. 13-18; Un cembalo in marmo per Francesco II d’E-ste, a cura di Maria Grazia Bernardini, Modena, Fondazione Cassa di risparmio di Modena, [2005];A. CONT, ‘‘Sono nato principe libero, tale voglio conservarmi’’. Francesco II d’Este (1660-1694), «Me-morie scientifiche, giuridiche, letterarie», Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Mo-dena, s. VIII, XII, 2009, II, pp. 427-430.
97 Cfr. SALVATORE PUGLIESE, Le prime strette dell’Austria in Italia, Milano-Roma, Treves-Trec-cani-Tumminelli, 1932, pp. 145-192; C. STORRS, Imperial Authority and the Levy of Contributions in‘‘Reichsitalien’’ in the Nine Years War (1690-1696), in L’Impero e l’Italia nella prima eta moderna /Das Reich und Italien in der Fruhen Neuzeit, a cura di Matthias Schnettger e Marcello Verga, Bolo-gna, Il Mulino, 2003.
98 Cfr. P. BESUTTI, La corte musicale di Ferdinando Carlo Gonzaga ultimo duca di Mantova. Mu-sici, cantanti e teatro d’opera tra il 1665 e il 1707, Mantova, G. Arcari, 1989; CARLO VITALI, Un cantantelegrenziano e la sua biografia. Francesco de Castris ‘‘musico politico’’, in Giovanni Legrenzi e la Cap-pella Ducale di San Marco, a cura di Francesco Passadore e Franco Rossi, Firenze, Olschki, 1994,pp. 573-574, 578-579; PAOLA CIRANI, Comici, musicisti e artisti di teatro alla corte di Ferdinando CarloGonzaga Nevers, Mantova, Edizioni Postumia, Casa del Mantegna, 2004.
plimento, scrisse i libretti dei due oratori La forza e la pieta e Il Davide libe-rato, musicati rispettivamente da Giovanni Battista Tomasi e da Marc’AntonioZiani e rappresentati a Mantova l’uno nel 1685, l’altro nel 1687.99 L’oratorio,genere musicale d’argomento sacro, era assai apprezzato alla corte di Ferdi-nando Carlo Gonzaga anche perche si sostituiva alla forma profana e dispen-diosa del melodramma nel periodo penitenziale della quaresima.100 In piu, dalpunto di vista degli aristocratici mantovani, l’oratorio presentava un’ulteriore,gradita occasione per incontrarsi e discutere su negozi privati e familiari.101
Lorenzo partecipo ai gusti del suo principe anche nella sua qualita di so-praintendente alle compagnie di comici che operavano al servizio e sotto laprotezione della corte.102 Tale responsabilita era delicata, a causa dell’affezionee delle gelosie che l’assai suscettibile Ferdinando Carlo Gonzaga nutriva per i‘suoi’ cantanti, musici, comici e innanzitutto per le ‘sue’ «virtuose».103 Il pre-stito o il dono di costoro a un principe forestiero, in particolare, assumevanospiccate valenze politico-diplomatiche. Inoltre, il principe era quanto mai con-sapevole che il successo di un melodramma o di una commedia contribuiva adilatare il prestigio del sovrano che, accorto mecenate, l’aveva voluto e finan-ziato o che era proprietario degli interpreti applauditi.104
I frequenti periodi di svago trascorsi da Ferdinando Carlo Gonzaga a Ve-nezia, d’altro canto, procurarono a Lorenzo, che lo accompagnava, la dedicadi due melodrammi. Questi furono allestiti presso i teatri della capitale lagu-nare nel corso degli anni Novanta, quando egli era ormai ultraquarantenne se-
99 Cfr. P. BESUTTI, Oratori in corte a Mantova. Tra Bologna, Modena e Venezia, nel volume cu-rato dalla stessa autrice L’oratorio musicale italiano e i suoi contesti (secc. XVII-XVIII), Firenze,Olschki, 2002, pp. 400, 410, 413; P. CIRANI, Comici, musicisti e artisti di teatro, cit., pp. 191, 193.
100 Cfr. P. BESUTTI, La corte musicale, cit., pp. 31-32; EAD., Oratori in corte, cit., p. 402; P. CI-
RANI, Comici, musicisti e artisti di teatro, cit., pp. 146-149.101 Cfr. AFAMn, AC, b. 38, fasc. LXXIX, n. 92, Carlo Maria Vialardi a Giuseppe Maria Chiep-
pio, Mantova [1688].102 Cfr. ASMn, AG, s. F.II.8, b. 2820, Lorenzo Verzuso Beretti a Ferdinando Carlo Orsatti,
Mantova, 1.II.1692, 15.II.1692, 7.III.1692, 14.III.1692, 21.III.1692, 22.III.1692, 28.III.1692, 29.III.1692,11.IV.1692, 18.IV.1692, 25.IV.1692, Goito, 13.X.1692, Mantova, 16.II.1693, 20.II.1693, 27.II.1693,13.III.1693 (II), 27.III.1693, 10.IV.1693, 13.IV.1693, 19.IV.1693 e all., 2.V.1693, 8.V.1693, 15.V.1693,20.V.1693, 29.V.1693, 5.VI.1693, Goito, 3.VII.1693, Revere, 23.VII.1693, Mantova, 11.XII.1693,24.XII.1693, 24.XII.1695; P. CIRANI, Comici, musicisti e artisti di teatro, cit., pp. 55, nota 92, 77-79.
103 A questo proposito cfr. ASMn, AG, s. F.II.7, b. 2335.104 Cfr. ASMn, AG, s. E.XXX.3, b. 1135, c. 323, Francesco de Castris a [Ferdinando Cavriani],
Firenze, 25.V.1688; ASMn, AG, s. E.XXXII.2, b. 1287, cc. 695r, 816r, 828r, Francesco II d’Este a Fer-dinando Carlo Gonzaga-Nevers, Modena, 11.I.1675, 19.X.1685, 30.III.1686; ASMn, Archivio gentilizioCavriani (ACa), Corrispondenza, b. prov. 10, fasc. Lettere al marchese Massimiliano Cavriani, OttavioCavriani al fratello Massimiliano, Milano, 23.IX.1689; Archivio Storico del Castello di Masino, pressoCaravino (TO), m. 856, fasc. 11406, Angelo Antonio Barozzi a Carlo Francesco Valperga di Masino,Milano, 4.I.1695. Sul circuito teatrale in cui Mantova era inserita cfr. P. BESUTTI, La corte musicale,cit., pp. 7-18; P. CIRANI, Comici, musicisti e artisti di teatro, cit.
159I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
gretario di Stato a Mantova: La Clotilde di Giovanni Battista Neri, con musica
di Giovanni Maria Ruggieri, e La Circe di Aurelio Aureli, musicata da CarloFrancesco Pollarolo.105 Profittando dei suoi soggiorni veneziani, Lorenzo si ac-
costo anche all’accademia letteraria facente capo a Girolamo Albrizzi, il vivaceeditore che per questa sua impresa si avvalse inizialmente della collaborazione
di un autorevole erudito come Apostolo Zeno, e successivamente di un genia-le scienziato come Antonio Vallisneri.106 Dal 1696 tale societa pubblicava La
galleria di Minerva, un periodico illustrato di divulgazione e ricerca letteraria,scientifica e antiquaria che Albrizzi aveva piegato a una sensibilita empirica ed
eclettica tipicamente tardo-secentesca.107
Ma nel caso del marchese Lorenzo Verzuso Beretti Landi il diletto dell’e-
rudizione si sposava alla vocazione per l’impegno politico. Come la sua religio-
sita cattolica, di matrice gesuita, improntava la sua azione nelle missioni diplo-matiche nei paesi «eretici» della Confederazione Elvetica e delle Province
Unite che egli compı per conto della Spagna dal 1703 alla morte (1725),108 cosıanche il suo mecenatismo letterario doveva influire sul ruolo che egli ricoprı
come ministro di Filippo V.109 Non a caso, se negli anni venti incoraggio An-
160 ALESSANDRO CONT
105 Cfr. GIOVANNI BATTISTA NERI, La Clotilde. Drama per musica da recitarsi nel Teatro Tron aSan Cassano, Venezia, Nicolini, 1693; AURELIO AURELI, Circe abbandonata da Ulisse. Drama per mu-sica [...] da rappresentarsi nel famoso teatro Grimano a’ ss. Giovanni Paolo, Venezia, Nicolini, 1697.
106 Cfr. Biblioteca comunale Passerini-Landi di Piacenza, ms. Vitali 27, GIUSEPPE VITALI, Dellapatria e delle azioni del marchese Lorenzo Vergiuso Beretti-Landi. Dissertazioni due, post 1826, Disser-tazione seconda. Anche a Mantova era attiva una societa letteraria, ma con finalita di intrattenimentoaristocratico. Fondata nel 1562, l’Accademia degli Invaghiti continuava a essere luogo d’incontro perquei nobili della corte gonzaghesca che amavano le lettere e la poesia: cfr. M. MAYLENDER, Storiadelle Accademie d’Italia, cit., pp. 363-366.
107 Cfr. DONATA LEVI e LUCIA TONGIORGI TOMASI, Testo e immagine in una rivista veneziana traSei e Settecento. La ‘‘Galleria di Minerva’’, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», classe dilettere e filosofia, s. III, XX (1990), pp. 185-210.
108 In PCPL, ms. Vitali 27, e conservata un’incisione settecentesca che riproduce l’effigie dellostesso Lorenzo Verzuso Beretti Landi. Oltre a un solenne parruccone, «l’eccellenza del signore mar-chese Berretta Landi, ambasciatore cattolico» presso le repubbliche degli Svizzeri e Grigioni portaqui l’«habito in cui intervenne [...] nelle missioni fatte dalli padri della Compagnia di Giesu nell’El-vezia l’anno 1705».
109 Sull’attivita diplomatica di Lorenzo cfr. G. VITALI, Dissertazione seconda, cit.; JOHANNES VON
MULLER, Histoire de la Confederation Suisse, traduzione dal tedesco annotata e continuata da CharlesMonnard e Louis Vulliemin, XIII, Paris, Ballimore, Geneve, Cherbuliez, 1842, pp. 383-384; JOHANN
CASPAR ZELLWEGER, Geschichte der diplomatischen Verhaltnisse der Schweiz mit Frankreich von 1698bis 1784, St. Gallen-Bern, Huber & C., 1848, pp. 332-333; ALFRED BAUDRILLART, Philippe V et la cour deFrance, Paris, F. Didot & C., 1889, pp. 271-272, 284; PIERRE HEINRICH, La Louisiane sous la Compagniedes Indes (1717-1731), Paris, E. Guilmoto, 1908, pp. 70-71, nota 6; GERALD CERNY, Theology, Politicsand Letters at the Crossroads of European Civilization. Jacques Basnage and the Baylean Huguenot Re-fugees in the Dutch Republic, Dordrecht ecc., M. Nijhoff, 1987, pp. 150-152; DIDIER OZANAM, Les di-plomates espagnols du XVIIIe siecle. Introduction et repertoire biographique (1700-1808), Madrid, Casade Velazquez, Bordeaux, Maison des Pays Iberiques, 1998, passim; HARALD KLEINSCHMIDT, The Ne-mesis of Power. A History of International relations theories, London, Reaktion books, 2000, p. 141.
toine-Augustin Bruzen de La Martiniere a pubblicare il suo capolavoro, ilGrand dictionnaire geographique et critique, nello stesso tempo egli fece in mo-do che «ce dictionnaire portat des marques pubbliques de la protection glo-rieuse que Sa Majeste Catholique accorde aux sciences utiles», vale a dire unadedica a Filippo V.110
L’elogio di Lorenzo composto sempre da Bruzen de La Martiniere ed edi-to nel 1720 a esordio del Nouveau recueil des epigrammatistes francois, sorvo-lando sulla complessita di tale dialettica tra dedizione letteraria e impegno po-litico-diplomatico, sintetizzava comunque le qualita dell’uomo ideale che l’expaggio aveva cercato di incarnare: quelle di un «ministre actif, splendide, ef-ficieux», che sapeva essere il «Mecene de nos jours».111
Ancora piu eclatanti, all’epoca, furono gli interessi scientifici e letterari diun altro cavaliere che si formo con la livrea di paggio. In realta l’astro intel-lettuale e politico di Bruto Annibaldi della Molara (1639-1685) coincide conuna precisa fase nella storia della cultura toscana, di cui egli divenne espres-sione e una delle chiavi di comprensione.
Bruto della Molara, divenuto paggio nel 1652,112 si distinse soprattutto inambito scientifico quale seguace dell’inclinazione per lo sperimentalismo gali-leiano nutrita dal granduca Ferdinando II e dal suo fratello piu giovane Leo-poldo de’ Medici.113
Nel 1649, su raccomandazione del maggiordomo maggiore Vincenzo Sal-viati, era stato nominato lettore «delle matematiche» nella paggeria di corteVincenzo Viviani, l’ultimo allievo diretto e il custode premuroso delle memo-rie personali di Galileo.114 Ai nobili giovinetti, Viviani non si limitava a inse-
110 Cfr. G. VITALI, Dissertazione seconda, cit. La monumentale opera di Bruzen de La Marti-niere vide la luce in dieci tomi a La Haye, Amsterdam e Rotterdam tra il 1726 e il 1739.
111 ANTOINE-AUGUSTIN BRUZEN DE LA MARTINIERE, Nouveau recueil des epigrammatistes fran-cois, anciens et modernes, I, Amsterdam, Wetstein, 1720.
112 Cfr. Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo del Principato, fasc. 5544, n. 696, BrutoAnnibaldi della Molara a Leopoldo de’ Medici, Ancona, 20.XII.1670.
113 Un’interessante serie di lettere di Bruto della Molara a Leopoldo de’ Medici e in Archivio diStato di Firenze, Archivio Mediceo del Principato, fasc. 5544, nn. 683-712.
114 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 155, cc. 5r-23r, Vincenzo Viviani al marchese abate Alamanno Salviati,Firenze, 5.IV.1697, pubbl. da ANGELO FABRONI, Lettere inedite di uomini illustri, II, Firenze, France-sco Moucke, 1775, p. 7. Per la figura di Viviani cfr. PAOLO GALLUZZI, Il dibattito scientifico in Toscana(1666-1686), in Niccolo Stenone e la scienza in Toscana alla fine del ’600. Mostra documentaria ed ico-nografica, catalogo a cura di Lionello Negri et alii, con il coordinamento di Angela Dillon Bussi, Fi-renze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, Cassa di risparmio di Firenze, 1986, in part. pp. 114,118-119, 121-122; MICHAEL SEGRE, Nel segno di Galileo. La scuola galileiana tra storia e mito [1991], tra-duzione dall’inglese, Bologna, Il Mulino, 1993, pp. 147-182; P. GALLUZZI, Nel ‘teatro’ dell’Accademia,nel vol. curato dallo stesso autore Scienziati a Corte. L’arte della sperimentazione nell’Accademia Ga-lileiana del Cimento (1657-1667), Livorno, Sillabe, 2001, in part. pp. 19-20, 24; LUCIANO BOSCHIERO,Post-Galileian Thought and Experiment in Seventeenth-Century Italy: The Life and Work of VincenzioViviani, «History of Science», XLIII, 2005, pp. 77-100; ID., Experiment and Natural Philosophy in
161I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
gnare Euclide, la prospettiva e la geometria, ma affrontava anche la gnomoni-ca, la trigonometria, le opere fisico-meccaniche di Archimede e Galileo, l’ar-chitettura militare e civile e la livellazione.115 Che soprattutto nei primi tempiBruto si applicasse a queste materie, e attestato dalle sue stesse lettere all’emi-nente maestro.116 Ancor piu: Viviani riuscı a diventare per lui «il maggior e piucaro amico che io abbia»,117 tanto caro che «mentira chi dice che la lontananzaci deva disunire [...] perche Vi giuro di non voler dare questo gusto a’i mieinemici, o certo poco amorevoli, di far sı ch’io Vi perda, prima di che vorreiperdere la vita».118 Fu ricambiato con vivo entusiasmo, con un sentire inquietoe quasi possessivo: e chi non era «forzato adorare la vera idea di bonta, gen-tilezza, sapienza, prudenza e virtu di tanto cavaliere»?, come si chiedeva, re-toricamente, il medesimo Viviani.119
Notevole per intelligenza, impegnato nello studio piu di tanti suoi coeta-nei ma senza disdegnare divertimenti come il lumagre (un particolare gioco dicarte) o la caccia,120 Bruto possedeva i requisiti per farsi apprezzare anche da-gli scienziati e cavalieri toscani e stranieri che intrattenevano rapporti cordialicon Viviani. Egli suscito ottima impressione nel gentiluomo anglo-irlandeseRobert Southwell, allievo di Viviani e futuro presidente della Royal Society.121
«Un cavaliere di sı rare qualita» lo definı Lorenzo Magalotti, dal 1660 segre-
162 ALESSANDRO CONT
Seventeenth-Century Tuscany. The History of the Accademia del Cimento, Dordrecht, Springer, 2007,in part. pp. 37-58; MARA MINIATI, L’epilogo del collezionismo mediceo, in I Medici e le scienze. Stru-menti e macchine nelle collezioni granducali, a cura della stessa autrice e di Filippo Camerota, Firenze,Giunti, 2008, pp. 362-364; L. BOSCHIERO, Robert Southwell and Vincenzio Viviani: Their friendshipand an attempt at Italian-English scientific collaboration, «Parergon», XXVI, II, 2009, pp. 87-108.
115 Cfr. Vincenzo Viviani all’abate Salviati, cit., p. 17.116 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 161, cc. 291r, 382r; BNCF, Ms. Gal. 162, cc. 43r, 334; BNCF, Ms. Gal.
254, c. 149r; BNCF, Ms. Gal. 254, c. 118r; BNCF, Ms. Gal. 257, cc. 263r, 266r-267r. In parte, il carteg-gio tra Viviani e Molara e disponibile on-line: cfr. http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac/controller.jsp.
117 BNCF, Ms. Gal. 164, c. 296r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Ancona,1.XII.1673.
118 BNCF, Ms. Gal. 162, c. 4r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Pisa, 31.III.1663.Cfr. anche BNCF, Ms. Gal. 163, c. 249r, allo stesso, Pisa, 26.II.1669 [1670].
119 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 157, c. 109r, Vincenzo Viviani a Robert Southwell, 28.XII.1660 (minuta).120 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 161, cc. 343-344, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Pisa,
31.XII.1661; BNCF, Ms. Gal. 162, cc. 138v-139r, allo stesso, Piediluco, 27.X.1663; BNCF, Ms. Gal. 254,c. 206r, allo stesso, Artimino, 9.IX.1661. Sul gioco del lumagre cfr. FEDERICO NOMI, Il catorcio di An-ghiari. Poema eroi-comico in ottava rima, con note di Cesare Testi, Firenze, Daddi, 1830, I, p. 294.
121 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 254, c. 178r, Robert Southwell a Vincenzo Viviani, Firenze, 18.I.1661. Perle relazioni tra Southwell e Viviani cfr. ANNA MARIA CRINO, Accenni a Galileo nel taccuino di Sir Ro-bert Southwell, in Fatti e figure del Seicento anglo-toscano. Documenti inediti sui rapporti letterari, di-plomatici, culturali fra Toscana e Inghilterra, Firenze, Olschki, 1957, pp. 115-117; L. BOSCHIERO, RobertSouthwell, cit.; MORDECHAI FEINGOLD, The Accademia del Cimento and the Royal Society, in The Ac-cademia del Cimento and its European Context, a cura di Marco Beretta et alii, Sagamore Beach,Science history publications, 2009, p. 239.
tario dell’Accademia del Cimento.122 E ancora, il danese Thomas Walgesten,ottico e costruttore di strumenti che a Firenze fece conoscere la lanterna ma-gica, lo considero suo amico e protettore.123
Educato al calcolo secondo i principi tradizionali della matematica e dellageometria, e insieme al nuovo metodo sperimentale quale veniva inteso e propa-gandato dalla casata medicea, Bruto da alunno divenne una sorta di collaborato-re scientifico di Viviani e suo intermediatore privilegiato presso il granduca.124
Pur con qualche difficolta, il paggio Molara cerco di familiarizzarsi conl’atmosfera di quel consesso di studiosi-cortigiani che dal 1657 per un decen-nio formo l’Accademia del Cimento. Partecipo dunque, tra l’altro, alle osser-vazioni sui cerchi generati nell’acqua dalla caduta dei gravi (1662) 125 e ai para-goni tra i cannocchiali di Eustachio Divini e Giuseppe Campani (1665).126 Intutto egli condivise la subordinazione dell’attivita accademica alle necessitadi prestigio e di cautela politica, ma anche alle capricciose curiosita dei prin-cipi patroni Leopoldo e Ferdinando II.127 Si lascio anche coinvolgere nelle me-schine rivalita tra scienziati invidiosi l’uno dell’altro e diversi tra loro perorientamento scientifico e per indole. Cio fu probabilmente inevitabile, peronon rimase senza conseguenze nei tempi lunghi.
122 Lorenzo Magalotti ad Alessandro Segni, Firenze, 11.XII.1665, pubbl. da FERDINANDO MASSAI,Sette lettere inedite di Lorenzo Magalotti al cav. Alessandro Segni (1665-1666), «Rivista delle bibliotechee degli archivi», XXVIII, VIII-XII, agosto-dicembre 1917, p. 129. Per la figura di Magalotti cfr. CE-
SARE PRETI e LUIGI MATT, Magalotti, Lorenzo, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma,Istituto della Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 300-305.
123 Cfr. Thomas Rasmussen Walgesten a Vincenzo Viviani, Venezia, 9.X.1666, in GUSTAV
SCHERZ, Briefe aus der Bartholinerzeit, «Centaurus», VII, 2, 1960, p. 175.124 Per il secondo ruolo cfr. ad es. BNCF, Ms. Gal. 162, cc. 178-179, Bruto Annibaldi della Mo-
lara a Vincenzo Viviani, Pisa, 9.II.1664 [1665].125 Cfr. GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI, Atti e memorie inedite dell’Accademia del Cimento e no-
tizie aneddote dei progressi delle scienze in Toscana..., I, Firenze, Giuseppe Tofani, 1780, p. 163. Per ladata cfr. invece GRAZIANO MAGRINI, Dieci anni di esperienze a Corte, in Scienziati a Corte, cit., p. 144.
126 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 162, cc. 248, 289v, Bruto della Molara a Vincenzo Viviani, Firenze, 7 e23 gennaio 1665; Ms. Gal. 163, cc. 143, 145r, 146v-147, allo stesso, Firenze, 9.VIII.1665, 29.VIII.1665,8.IX.1665; Ms. Gal. 277, cc. 208-209r, Vincenzo Viviani a Leopoldo de’ Medici, Sartiano,29.VII.1665; Leopoldo de’ Medici a Vincenzo Viviani, Firenze, 11.VII.1665, pubbl. da GIOVANNI BAT-
TISTA CLEMENTE NELLI, Saggio di storia letteraria fiorentina del secolo XVII scritta in varie lettere,Lucca, Vincenzo Giuntini, 1759, pp. 111-112. Per la rivalita tra Divini e Campani nella fabbricazionedi occhiali cfr. PAOLO DEL SANTO e GIORGIO STRANO, Il Cimento degli astri, in Scienziati a Corte,cit., pp. 31-34.
127 Per diversi giorni Vincenzo e Bruto rimasero chiusi in casa a risolvere, con calcoli matema-tici, «una curiosita del sig. granduca in materia di giuochi di carte»: Vincenzo Viviani a RobertSouthwell, Firenze, 8.X.1661, in Alcune lettere di celebri scrittori italiani, a cura di Alessandro Mor-tara, Prato, F. Alberghetti & C., 1852, pp. 17-18. Su tal genere di ghiribizzi cfr. P. GALLUZZI, Nel ‘tea-tro’ dell’Accademia, cit., pp. 15-16. Per utili raffronti tra la posizione dei due Medici e quella, poste-riore, di Cristina di Svezia a Roma, cfr. MARIA CONFORTI, The Experimenters’ Anatomy, in TheAccademia del Cimento, cit., p. 43; MARIA PIA DONATO, Late Seventeenth-Century ‘‘Scientific’’ Acade-mies in Rome and the Cimento’s Disputed Legacy, ivi, in part. pp. 160-164.
163I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
Al fine di promuovere la dottrina galileiana e confermare il prestigio scien-tifico della dinastia medicea cercando di evitare ogni contrasto con la Chiesa epolemiche di qualsiasi genere, Leopoldo e Ferdinando II de’ Medici avevanofatto convergere nella loro accademia gli esponenti di vari atteggiamenti intel-lettuali, compreso l’aristotelismo inflessibile.128 Come si apprende dalle sue let-tere a Viviani, il giovane Bruto della Molara si riconobbe nel partito dei gali-leiani moderati che annoverava tra i principali rappresentanti lo stesso Viviani,il meno sistematico Francesco Redi, dal 1666 protomedico granducale, e il giacitato Lorenzo Magalotti.129 Questo gruppo era il piu ossequiente alla strategiaculturale e politica dei principi, in quanto l’osservazione di singoli fenomenifisici, legata soprattutto alla famosa «esperienza» barometrica di Torricelli(1644), e la contestuale rinuncia all’indagine della loro genesi e dunque dellesupreme leggi che reggono il cielo, la terra e l’uomo avrebbero dovuto dimo-strare efficacemente la piena compatibilita tra scienza galileiana e superiorefede romana.130 Nel 1666 aderı a tale posizione, restando tuttavia all’esternodi un’accademia ormai al tramonto, anche Niccolo Stenone, il grande scienzia-to danese al quale Bruto, su ordini del granduca, trasmetteva di volta in voltaanimali marini o mostruosi per le sue brillanti indagini anatomo-fisiologiche.131
Il fatto che Bruto nel corso degli anni Sessanta accumulasse una conside-razione sempre maggiore presso la corte toscana, arrivando a meritare nel 1667
164 ALESSANDRO CONT
128 Cfr. P. GALLUZZI, L’Accademia del Cimento. ‘‘Gusti’’ del Principe, filosofia e ideologia dell’espe-rimento, «Quaderni storici», XLVIII, 1981, pp. 788-844; ID., Nel ‘teatro’ dell’Accademia, cit., pp. 12-25.
129 Per i rapporti di Molara con Magalotti e Redi cfr. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,ms. Redi 220, cc. 1r-12r, Bruto Annibaldi della Molara a Francesco Redi, Firenze, 24.VIII-14.IX.1669;BNCF, Ms. Gal. 161, c. 286r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Firenze, 11.XII.1660;BNCF, Ms. Gal. 162, cc. 154r, 179, 239, allo stesso, Pisa, 19.XII.1663, 9.II.1664 [1665], 1.I.1665 [1666];BNCF, Ms. Gal. 163, cc. 14v, 176, 301r, allo stesso, Pisa, 24.II.1666, 5.II.1668 [1669], Poggio a Caiano,29.IV.1669; BNCF, Ms. 168, c. 118r, Francesco Redi a Vincenzo Viviani, s.d., pubbl. in Opere di Fran-cesco Redi, gentiluomo Aretino e accademico della Crusca, VI, Milano, Societa tipografica de’ ClassiciItaliani, 1811, p. 363; BNCF, Ms. Gal. 283, cc. 164-166, Lorenzo Magalotti a Bruto Annibaldi della Mo-lara, Firenze, 10.XII.1664; Francesco Redi a Piero Girolami, Firenze, 11.X.1667, pubbl. in Opere diFrancesco Redi, cit., VII, Milano, Societa tipografica de’ Classici Italiani, 1811, pp. 208-209.
130 Cfr. P. GALLUZZI, L’Accademia del Cimento, cit., in part. pp. 798-819; ID., Nel ‘teatro’ dell’Ac-cademia, cit., pp. 12-13.
131 Cfr. G. SCHERZ, con la collaborazione di Johann Raeder, Nicolai Stenonis epistolæ et epistolæad eum datæ, quas cum proœmio ac notis germanice scripsit, Hafniae, Nyt Nordisk forlag ArnoldBusck, Friburgi Germaniae, Verlag Herder, 1952, I, pp. 16, 192-193 e II, pp. 924-925; Biografie e lettere.Schede, in Niccolo Stenone, cit., pp. 20, 27; ROBERTO ANGELI, Niels Stensen. Il beato Niccolo Stenone,uno scienziato innamorato del vangelo e dell’Italia, a cura di L. Negri, Cinisello Balsamo (MI), Edi-zioni Paoline, 1996, p. 139. Sulle ricerche compiute da Stenone in Toscana cfr. ora ALAN CUTLER, Laconchiglia del diluvio. Niccolo Stenone e la nascita della scienza della terra [2003], traduzione dall’in-glese di Massimo Gardella, Milano, 2007, dove tuttavia non si accenna a Bruto della Molara. Per ilrapporto del grande danese con la religione cfr. anche AUGUST ZIGGELAAR, L’evoluzione spirituale diNiccolo Stenone giovane, in Niccolo Stenone (1638-1686). Anatomista, geologo, vescovo, a cura di KarenAscani et alii, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2002, pp. 77-84.
la successione nella carica gia ricoperta dal defunto cameriere segreto e cassie-re della camera granducale Ippolito de Vicq,132 potrebbe attestare la sua pra-ticata condivisione di una filosofia naturale rispettosa del cattolicesimo neipresupposti e nei risultati. Significativamente a questo proposito, a lui fu at-tribuito un ruolo decisivo nel provocare le partenze dalla Toscana di duescienziati del Cimento, avvenute entrambe nel 1667. Dei due scienziati unoera il geniale e altero Giovanni Alfonso Borelli, fautore di una interpretazionein chiave corpuscolare e meccanica della natura supportata dal rigoroso calco-lo geometrico, e avversario personale di Viviani.133 Il secondo era il meno do-tato ma irruente Antonio Oliva, un ricercatore noto come libertino ed eclet-tico, dotato di intuizioni vivaci ma inconcludente.134
Se si considerano invece i rapporti di Bruto con la Santa Sede, a giudicaredalle sue lettere a Viviani, si puo constatare che mai questi conobbero parti-colari increspature.135 Ma non bisogna dimenticare come il giovane aristocra-tico, astuto cortigiano oltre che uomo di cultura e cattolico sincero,136 nonignaro di calcoli di politica e strategia familiare, avesse in Riccardo Annibaldidella Molara (1631 ca.-1689) un fratello che doveva essere preservato da qual-
132 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 158, c. 194v, Vincenzo Viviani a Robert Southwell, 18.VII.1667 (minuta);FERRUCCIO FERRUZZI, La Camera del granduca, «Rivista d’arte», XXXVIII, 1986, p. 316, nota 67.
133 Quest’ultimo avrebbe agito «sottomano contro il sig. Borelli per iscreditarlo, e finalmenteper mezzo del conte [!] Molara farlo cadere dalla grazia del serenissimo gran duca Ferdinando II,come gli riuscı, onde il sig. Borelli si licenzio»: Antonio Magliabechi a Geminiano Montanari, s.d.,pubbl. da ANTONGIOVANNI BONICELLI, Bibliotheca pisanorum veneta, annotationibus nonnullis illu-strata, II, Venetiis, Antonio Curti, 1807, p. 312. I termini del contrasto Viviani-Borelli e in parte ilcoinvolgimento di Molara sono noti oggi grazie alle segnalazioni documentarie di LUIGI TENCA,Le relazioni fra Giovanni Alfonso Borelli e Vincenzo Viviani, «Rendiconti» dell’Istituto Lombardodi Scienze e Lettere, XC, 1956, pp. 118-120; e Some unpublished correspondence of Giovanni AlfonsoBorelli, a cura di William Edgar Knowles Middleton, «Annali dell’Istituto e Museo di Storia dellaScienza di Firenze», IX, 1984, p. 103. Invece sulla personalita scientifica di Borelli cfr. UGO BALDINI,Borelli, Giovanni Alfonso, in Dizionario biografico degli italiani, XII, Roma, Istituto della Enciclope-dia Italiana, 1970, pp. 543-551; P. GALLUZZI, Il dibattito scientifico in Toscana, cit., pp. 114-116; ID., Nel‘teatro’ dell’Accademia, cit., pp. 17-19; L. BOSCHIERO, Experiment and Natural Philosophy, cit., in part.pp. 59-92; The Accademia del Cimento, cit., passim.
134 Un pettegolezzo voleva che Bruto, dopo essere stato offeso in un dibattito letterario, avessecommissionato l’assassinio di Oliva: cfr. U. BALDINI, Un libertino accademico del Cimento. AntonioOliva, Firenze, Giunti-Marzocco, 1977, pp. 42-43. In verita, Molara non avrebbe avuto bisogno diricorrere a tali mezzi: cfr. BNCF, Ms. Gal. 163, cc. 146v-147, Bruto Annibaldi della Molara a VincenzoViviani, Firenze, 8.IX.1665.
135 Cfr. BNCF, Mss. Gal. 161, 162, 163, 164, 165, 168, 254, 255 (c. 38rv), 257, 258 (cc. 107r, 109r). Indata ignota, Bruto partecipo a una sottoscrizione, promossa sempre da Viviani, per l’innalzamento diun sepolcro a Galileo. E chiaramente erronea la datazione dell’episodio al 1642 (Bruto aveva allora treanni) e quindi il rapporto di causa con una allarmata reazione papale istituito dalle Note alla Vita diGalileo scritta dal Viviani, in Le opere di Galileo Galilei, XV, Firenze, Societa editrice fiorentina, 1856,pp. 402-404. Cfr. anche ROBERTO LUNARDI e ORETTA SABBATINI, Il rimembrar delle passate cose. Unacasa per la memoria: Galileo e Vincenzo Viviani, Firenze, Polistampa, 2009, pp. 273-274, 289.
136 L’autenticita del sentimento religioso di Bruto e provata da una sua bellissima lettera a Vi-viani: cfr. BNCF, Ms. Gal. 162, cc. 86-87r, da Firenze, 9.IV.1663.
165I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
sivoglia fastidio potesse ostacolare la sua carriera in corso di governatore nellecitta dello Stato della Chiesa.137
E comunque, l’apertura intellettuale anti-aristotelica sviluppata da Bruto acontatto con il magistero di Viviani non era molto ambiziosa: non travalicomai la duplice dimensione di un piacere erudito e, rispetto agli interessi deiprincipi medicei, di un dovere e di un’opportunita connessi allo status dichi «abia da fare il cortegiano, e non altro mestieri per ora».138 Prima di tuttoletteraria fu la viva curiosita del giovane gentiluomo per la Bibbia in lingua ita-liana dell’intransigente calvinista Giovanni Diodati.139 «E un libro da aversi»,sosteneva nel 1670 Antonio Magliabechi, mentre non solo il cattolicissimogran principe Cosimo di Toscana, ma anche gli ebrei e le monache di Firenze«fanno incetta di questi libri, e come sono bibbie volgari non guardano chesieno tradotte o da uno o da un altro».140 Barocca fu inoltre l’infatuazionedi Molara per le raccolte medicee «delle conchiglie, delle medaglie e dei cam-mei», di cui egli figuro tra i pochissimi visitatori autorizzati dal granduca Fer-dinando II.141 Presumibilmente per assecondare queste passioni, lo stesso Fer-dinando assegno al suo paggio di valigia un appartamentino di Pitti contiguoalle due stanze ove il principe Leopoldo custodiva i suoi «instrumenti mate-matici» e parte della sua biblioteca, quest’ultima ottimamente fornita di testistorici, giuridici e scientifici provenienti dai principali centri dell’editoria eu-ropea.142 «Su in libreria», Bruto ebbe in seguito l’occasione di trattare con
166 ALESSANDRO CONT
137 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 161, c. 346r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Pisa,6.I.1662 [1663]. Sul personaggio di Riccardo della Molara cfr. FERDINANDO UGHELLI, Italia sacra, edi-zione corretta e ampliata da Nicola Coleti, I, Venetiis, Sebastiano Coleti, 1717, col. 1400; Legati e go-vernatori dello Stato pontificio (1550-1809), a cura di Christoph Weber, Roma, Ministero per i beni cul-turali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, p. 458; e soprattutto la ricostruzionebiografica di Giovanni Magnante, che sara pubblicata in un volume sulla storia dei vescovi di Veroli,e che ho potuto consultare in versione dattiloscritta grazie alla cortesia dell’autore.
138 BNCF, Ms. Gal. 162, c. 334r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Pisa,23.I.1666.
139 Cfr. Antonio Magliabechi a Lorenzo Panciatichi, Firenze, 26.IV.1670, pubbl. in Raccolta diprose fiorentine, IV, I, Firenze, Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi, 1734, pp. 163-164, e in Lettereserie, erudite e famigliari di diversi uomini scienziati ed illustri, Venezia, Domenico Occhi, 1735, p. 90.
140 Ibid. Per un primo approccio all’opera di Diodati cfr. MICHELE RANCHETTI, Introduzione, inLa sacra Bibbia tradotta in lingua italiana e commentata da Giovanni Diodati, a cura dello stessoautore e di Milka Ventura Avanzinelli, I, Milano, Mondadori, 1999, pp. XI-XXXV.
141 Cfr. Lorenzo Magalotti a Vincenzo Viviani, Parigi, 16.VI.1668, pubbl. in Delle lettere familiaridel conte Lorenzo Magalotti e di altri insigni uomini a lui scritte, Firenze, Stamperia di S.A.R. perGaetano Cambiagi, 1769, II, p. 32.
142 Cfr. S. BERTELLI, Palazzo Pitti, cit., pp. 91-92. Per gli strumenti con cui si eseguivano le os-servazioni del Cimento cfr. M. MINIATI, ‘‘Bocciuoli, palle d’oncia e termometri gelosissimi’’. Vetro escienza nell’Accademia del Cimento, in Scienziati a Corte, cit., pp. 36-42; EAD., La scienza a Corte,in I Medici e le scienze, cit., pp. 331-335. Invece sulle collezioni librarie del principe Leopoldo cfr. AL-
FONSO MIRTO, La biblioteca del cardinal Leopoldo de’ Medici. Catalogo, Firenze, Olschki, 1990, inpart. pp. 40-53; ID., Medici, Leopoldo de’, in Dizionario biografico degli italiani, LXXIII, Roma, Isti-tuto della Enciclopedia Italiana, 2009, p. 110.
«ogni maggior cortesia» quel formidabile conoscitore e consulente in materiaeditoriale che fu Magliabechi, almeno fino a quando, nel luglio del 1670, nonriconobbe in costui un corresponsabile della disgrazia che egli patı presso ilnuovo granduca Cosimo III.143
La figura, a lungo controversa, di Bruto della Molara e specchio ed emble-ma delle tensioni e delle contraddizioni che animarono, e turbarono, la vitaculturale della corte medicea nell’ultima decade del granducato di FerdinandoII. Non stupisce che l’engagement culturale, e prima di tutto scientifico, diBruto si affievolisse dopo il 1670, ossia a seguire la sua sofferta partenza daFirenze per rifugiarsi presso il fratello prelato nella pontificia Foligno.144 Nellanuova temperie del governo di Cosimo III, con il progressivo declinare in attodalla meta degli anni Sessanta nella cultura scientifica toscana, la sua parteci-pazione intellettuale e la sua mediazione politica, ricostruibili oggi soprattuttoattraverso le testimonianze epistolari, non trovavano piu ragione.145 E quindi,col tempo, la personalita di Bruto della Molara, emarginato e ridimensionatonei suoi ruoli, rimase facile preda di distorsioni e di fraintendimenti in sedeletteraria e storiografica.146
4. LA NOBILTA DELLE TRASGRESSIONI
In realta, Lorenzo Verzuso Beretti Landi e Bruto Annibaldi della Molararappresentarono due eccezioni in un panorama globale delle paggerie italianeabbastanza mediocre, se non deprimente. Malgrado l’esattezza e il rigore delledisposizioni sovrane, nonostante la bonta d’intenti professata da principi e go-vernatori, gli istituti per i paggi dei principi della Penisola erano il riflesso del-lo stato di disordine e di conflitto che attraversava le corti dal piu profondodelle cucine palatine sino all’olimpo dei consigli di Stato.147 Ad aggravare la
143 Cfr. Antonio Magliabechi a Lorenzo Panciatichi, [Firenze] 22.VII.1670, pubbl. da CESARE
GUASTI, Scritti vari di Lorenzo Panciatichi, accademico della Crusca, Firenze, Le Monnier, 1856,p. 333. Per un succinto profilo di Magliabechi con estesa bibliografia cfr. MASSIMILIANO ALBANESE,Magliabechi, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, LXVII, Roma, Istituto della EnciclopediaItaliana, 2006, pp. 422-427.
144 Cfr. BNCF, Ms. Gal. 164, c. 123r, Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Foligno,8.VIII.1671. Bruto morı a Novara «sul Milanese» nell’autunno del 1685, a 46 anni di eta: cfr. BNCF,Ms. Gal. 159, c. 202v, Vincenzo Viviani a Niccolo Stenone, 7.XII.1685 (minuta), pubbl. in G. SCHERZ,Nicolai Stenonis epistolæ, cit., II, p. 831.
145 Cfr. P. GALLUZZI, L’Accademia del Cimento, cit., in part. pp. 831-832; ID., Il dibattito scienti-fico in Toscana, cit.; ID., Nel ‘teatro’ dell’Accademia, cit., pp. 24-25.
146 Cfr. a nota 209 della Parte I.147 Sugli abusi che si consumavano presso le cucine del Palazzo Ducale di Modena nel primo
167I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
semi-anarchia nella quale le paggerie versavano irrompeva il temperamentoindocile e aggressivo dei ragazzi stessi. Di fronte all’indole collerica, all’irre-quietezza e ai normali disagi psicologici e affettivi dei nobili adolescenti, faciliprede di «false apparenze», di «velleita erranti» e di «pensieri non condotti afilo», i mezzi di dissuasione dei loro superiori risultavano spesso di scarsa ef-ficacia.148
Una serie di suppliche al serenissimo padrone risalenti al secolo XVII evivida testimonianza delle difficolta oggettive che le persone preposte alla pag-geria ducale di Modena incontravano nell’espletamento quotidiano dei lorocompiti educativi.149 Foriero di conseguenze negative risultava specialmenteil disinteresse del sovrano per le condizioni materiali alle quali costringeva isuoi paggi, diciassette nel 1630, ventiquattro nel 1683.150 Contro la negligenzao poltronaggine dei responsabili della guardaroba ducale, nell’inverno 1656 iragazzi agghiacciati ricorrevano al duca, il grande Francesco I d’Este (1629-
1658), implorando dei tabarri che li proteggessero, «in servitio», dalle «pioggiee venti et altri accidenti».151 Appena l’anno prima, vittime delle intemperie, igiovinetti si erano rivolti al loro sovrano perche «li siano fatti l’impannati allefinestre della paggiaria, non sapendo piu come difendersi e dal freddo e dal-l’humido dentro le loro camere».152
Ma agli insulti del clima si poteva aggiungere di peggio. In un momentoimprecisato, ma databile intorno alla meta del secolo, una petizione del gover-natore padre Domenico Carli aveva informato il Serenissimo che i paggi eranoimpresentabili «perche mostrano la carne da ogni banda per i calzetti rotti, neil sarto vi puol piu provedere». In piu, il giovanissimo Paolo Scaruffi, che sof-friva di scabbia, aveva «cosı ammorbato la paggiaria che non si puol piu abi-tare il camerone dov’egli dorme». Con una cocciutaggine davvero adolescen-ziale, Scaruffi rifiutava di ritirarsi a casa dei genitori per le cure necessarie,costringendo cosı i suoi compagni a un involontario esilio dalla camerata.153
168 ALESSANDRO CONT
Seicento cfr. ASMo, ASE, CS, Corte, b. 446, Ordini del maggiordomo maggiore Augusto Bellinciniper le cucine del principe e dell’infante di Modena, sec. XVII.
148 Per le citazioni cfr. ASMo, ASE, CS, Carteggi tra principi estensi, Principi non regnanti, Ri-naldo di Alfonso III, b. 245, n. 1768.LXIII.33, card. Rinaldo d’Este al cugino Cesare Ignazio, San Mar-tino, 4.VIII.1671.
149 Cfr. ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454.150 Cfr. ivi, fasc. Casa, paggeria. Note di paggi (1630-1777 e s.d.), Lista de’ paggi di S.A.Serenissima.
[Aggiunto di altra mano] 1630 o 1631 circa il principio; ASMo, Archivio camerale (AC), Camera ducaleestense (CDE), Amministrazione della casa, Guardaroba, b. 282, p. 1.
151 ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Suppliche dei paggi (1655-1674).152 Ibid.153 Cfr. ivi, fasc. Casa, paggeria. Capitoli e regolamenti (sec. XVI-1775). Due conti Scaruffi,
«grande» e «picciolo», sono menzionati in Lista de’ paggi, cit.
All’inerzia e alle scarse premure del sovrano si sovrapponevano le insuffi-cienze personali di quanti erano incaricati del governo dei ragazzi. Si trattavadi carenze che derivavano ancora una volta dalla connotazione cortigiana dellapaggeria.
Innanzitutto, la carica di maggiordomo maggiore assommava varie re-sponsabilita a palazzo (governo della casa, presidenza della camera delle finan-ze, partecipazione ai consigli di Stato) che esponevano il titolare al rischio didisperdere la propria attenzione e le proprie energie su troppi fronti contem-poraneamente.154 Ma soprattutto, il maggiordomo maggiore doveva difendereil suo predominio da attacchi e intrighi di emuli e nemici, e per salvaguardarela propria sopravvivenza a corte un puro e semplice espletamento delle fun-zioni istituzionali spesso non era l’unico, ne il piu incisivo dei mezzi. Tuttavia,quando anche il maggiordomo maggiore avesse disposto del tempo richiestoper sovrintendere alla paggeria con «tutta quell’aplicatione che sarebbe neces-saria», restava pur sempre da valutare quale fosse il suo adeguato talento edesperienza in campo pedagogico.155
Al pari del maggiordomo maggiore, anche le figure del governatore e deidiversi maestri erano vincolate a forme clientelari di selezione.156 Questi sog-getti erano penalizzati al solito da un compenso insoddisfacente,157 e non dirado insorgevano gravi contrasti tra loro stessi. Causa, o pretesto, delle crudedispute che li coinvolgevano era la loro diversa opinione circa i metodi disci-plinari ed educativi da applicare nei confronti dei paggi. Ad esempio, nel 1653
Giacomo Beneventi, presumibilmente un maestro, denunzio lo ‘scandaloso’lassismo di un ignoto governatore. Quest’ultimo «tace e non provede» agli«abusi e disolutezze» dei giovinetti, replicando alle osservazioni dello stessoBeneventi che i paggi «sono putti, e che bisogna lasciarli fare». Addirittura,
154 Cfr. ASMo, ASE, CS, Corte, b. 446, [Memoria sulle cariche del maggiordomo maggiore, ma-stro di camera, cavallerizzo maggiore e capitano della guardia], sec. XVII; ivi, [Memoria sulle carichee cerimoniale della corte di Modena], sec. XVIII; ASMo, AC, CDE, Amministrazione dei principi,Francesco II, b. 225, anonimo a Francesco II d’Este, Modena, 21.I.1673.
155 Le parole citate si riferiscono al ruolo del maggiordomo quale «capo» della camera ducale:cfr. ASMo, AC, CDE, Amministrazione dei principi, Francesco II, b. 225, anonimo a Francesco IId’Este, Modena, 21.I.1673.
156 Cfr. ASMo, ASE, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Governo, assistenza (1571-1775), LodovicoBuoncompagni a Francesco I d’Este, Reggio, 31.VII.1651; ibid., memoria per l’assunzione di un gover-natore dei paggi, post 1659. Per un raffronto con Firenze cfr. BNCF, Ms. Gal. 164, c. 5r, Donato Ros-setti a Vincenzo Viviani, Pisa, 21.I.1670. Una tipica lettera di raccomandazione, relativa pero a uncanonicato della basilica di S. Quirino a Correggio, e in ASMo, ASE, Cancelleria, Sezione estero,Carteggi con principi esteri, Germania, Colonia, b. 1604/30, Giuseppe Clemente elettore di Coloniaa Rinaldo d’Este, Liegi 3.XI.1697.
157 Cfr. ASMo, ASE, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Governo, assistenza (1571-1775), [memoriaper il governo dei paggi], sec. XVII; ASMo, ASE, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Istruzione, mae-stri, precettori (1579-1775), Domenico Carli a Francesco I d’Este, 1657.
169I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
egli avrebbe biasimato con durezza lo stesso Beneventi, in presenza dei ragaz-zi, per avere inflitto due staffilate sulle mani di un paggio che nei paraggi delpalazzo ducale di Sassuolo «con una sassata nella publica strada haveva but-tato in terra un povero putto».158
Secondo Beneventi, i paggi, lasciati in balia di se stessi, subivano un pro-cesso di imbarbarimento che li vedeva vittime di un istinto per sua natura pri-mitivo e insieme modernissimo. I ragazzi rimanevano sopraffatti da una irra-zionalita impetuosa che esaltava la superbia e la violenza in nome del piacere edella forza fisica. In tale ambiente, dove soltanto maschi erano attori, complicio avversari, i precetti ecclesiastici e le leggi della cavalleria mantenevano unben scarso valore. Pure l’antichita e la nobilta di una schiatta valevano agli oc-chi del page disgracie 159 nella misura in cui potevano venire usate contro ungovernatore poco accondiscendente o un compagno da umiliare. Con tonidi angosciata crudezza, Beneventi notava che i giovani
stanno la maggior parte del giorno nel cortile giocando al palloncino, anco in compa-gnia d’altri di fuora, tirando sassi e correndosi dietro, alle volte sin sotto la guardia de’todeschi, dal che e cagionata la negligenza ch’usano negl’essercitii della scuola e lapoca attentione et applicatione a cio che se gl’insegna. L’incivilta ch’usano a tavola,gl’improperii e villanie che si dicono l’un l’altro sono tali che sarebbono vituperabi-lissimi nelle persone piu vili della plebe. Dalle risse vengono alle volte alle mani, e co’pugni et ungie si rompono il viso, per il che stanno poi de’ giorni che non vengono a’publici servigii. Il governatore sa e vede il tutto, perche non si guardano di far qua-lunque cosa in di lui presenza.160
Trascorrevano gli anni, e la maledizione di un destino apparentemente in-vincibile continuava ad accanirsi contro i nobili giovinetti. Le medesime ca-renze, gli stessi problemi di conservazione biologica ed estetica dei paggi se-gnalati nella prima meta del secolo motivavano ancora una supplica del 1691
che il governatore padre Pellegrino Righi rivolgeva al maggiordomo maggioredel duca Francesco II. Questa volta era il minuscolo contino Fontana a patiredi scabbia. Gli altri paggi piu giovani, sempre scarmigliati poiche privi di unbarbiere, non potevano nemmeno usufruire delle lezioni di scherma, danza ecalligrafia in quanto mancavano anche i relativi maestri. «Tutto il giorno pri-
170 ALESSANDRO CONT
158 ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Capitoli e regolamenti (sec. XVI-1775),Giacomo Beneventi a Francesco I d’Este, «di paggiaria» 1.XI.1653.
159 Qui ci si riferisce all’autobiografia romanzata di Tristan l’Hermite, risalente al 1643: cfr.D. JULIA, L’infanzia, cit., p. 282.
160 ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Capitoli e regolamenti (sec. XVI-1775),Giacomo Beneventi a Francesco I d’Este, «di paggiaria» 1.XI.1653. Cfr. anche ivi, fasc. Casa, paggeria.Suppliche dei paggi (1655-1674), i paggi di Laura Martinozzi e Lucrezia Barberini a Francesco II d’Este,Modena, 16.X.1674.
gione in paggieria con li signori paggi, che non hanno livrea», padre Righi in-vocava, per mezzo del maggiordomo maggiore, la provvidenza del serenissimopadrone.161
La paggeria di fine secolo scontava gli effetti di una piu generale decaden-za della corte modenese. Certo, le accuse spaventose e raccapriccianti che sa-cerdoti, monache e aristocratici facevano recapitare in forma anonima al ducaFrancesco II tra gli anni Settanta e Novanta sono da accogliere con una certacautela, tanto piu che talune risultano decisamente spropositate se raffrontatecon altre testimonianze del periodo.162 Abbastanza realistico e invece undrammatico scambio di battute tra il cardinale Rinaldo d’Este e il cugino Ce-sare Ignazio, scoccate appena dopo il decesso del trentaquattrenne duca nel1694, quale viene riportato da un cronachista coevo ai fatti:
La prima cosa che doveva farsi era di fare accompagnare a Modena il cadavere deldefonto sovrano dalle guardie del corpo vestite a lutto. A quest’effetto il serenissimoduca cardinale fece chiamare il prencipe Cesare Ignazio [d’Este], come quello ch’ha-veva nelle mani tutti gli affari della casa e corte del duca e gli dommando gl’abiti neriper vestire dette guardie. Gli rispose il principe non trovarsi tanti abiti nella guarda-robba. Replico il duca [tale si reputava ora Rinaldo, in virtu della sua stretta parentelacon l’estinto] maravigliarsi molto come una guardarobba d’un principe grande qualera il duca di Modena fosse cosı mal fornita. Rispose il principe Cesare che poco im-portava, perche per allhora Sua Altezza non faceva figura di duca di Modena, ma solodi cardinale. «Come?», replico il duca, «Io sono il principe regnante, e voglio far figuradi quel che sono, ne Lei mi dica piu simil cosa». Resto mortificato il prencipe Cesare aquesto insolito, ne piu udito parlare, e partitosi dalla sua presenza sgombro la corte,rinunciando il maneggio di tutti gli affari, con mille imbroglii che seguirono.163
161 Cfr. ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454, fasc. Casa, paggeria. Capitoli e regolamenti (sec. XVI-1775),Pellegrino Righi a Francesco II d’Este, «di paggieria» 8.II.1691. Gli esborsi degli anni 1683, 1684 e 1685
concernenti gli abiti nuovi e vecchi dei paggi (livrea, calzette, scarpe, cappello, guanti) sono annotati inun piccolo registro della guardaroba ducale: cfr. ASMo, AC, CDE, Amministrazione della casa, Guar-daroba, b. 282, pp. 1, 5, 7, 8, 11, 17, 21, 24, 26, 30, 33, 35, 39, 42, 49, 52, 53, 58, 60-62, 64, 66, 71, 72. Ilfascicolo ci permette di conoscere meglio l’ambito di attivita della guardaroba estense. Si va dagli ad-dobbi nella foresteria del principe Rinaldo d’Este (8.VII.1683: p. 15) al palco nel Teatro della Spelta aModena (10.III.1685: p. 59), dalle coperte dei volumi «per la libraria di S.A.» (30.VI.1683: p. 14) a duepettini «per le perucche di S.A. Serenissima» (10.III.1685: p. 59), dalle candele per una messa cantatanella cattedrale di Modena (28.IX.1683: p. 18) al lettino da campagna per il Serenissimo (2.XII.1684:p. 52). Va precisato che il maggiordomo maggiore impartiva ordini e comminava punizioni agli ufficialidi corte, ma al guardarobiere e al cavallerizzo maggiore egli era obbligato a comunicare per iscritto«quello le occorre per servizio di S.A.S.»: ASMo, ASE, CS, Corte, b. 446, Relazione data dal computi-sta della casa di S.A.Serenissima in conformita degl’ordini havuti, sec. XVII.
162 Cfr. ASMo, CS, Documenti spettanti a principi estensi, Principi regnanti, Francesco II,b. 347, nn. 1974.III.11, 1974.III.31; ASMo, ASE, CS, Documenti spettanti a principi estensi, Principinon regnanti, Cesare Ignazio di Borso, b. 374, n. 2007.III.63, [Lettera anonima a Francesco II d’E-ste], 1692-1694.
163 Biblioteca Estense Universitaria di Modena, Archivio Muratoriano, filza 39, fasc. 17 b, AN-
TONIO CARANDINI, Memorie pubbliche della citta di Modena, sec. XVIII, pp. 26-27. Nessun accenno
171I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
Ma il governo delle paggerie smascherava disfunzioni pure in quelle corti che i
detrattori del duca Francesco II d’Este citavano invece quali modelli di onesta
magnificenza.164 Infatti, la fragilita politica di una reggente pur volitiva come Ma-
ria Giovanna Battista di Savoia Nemours, l’inettitudine di un duca come Ferdi-
nando Carlo Gonzaga impedivano che l’ampliamento degli organici di corte pro-
mosso da entrambi i principi premiasse in toto, per il potere sovrano, le attese di
una razionalizzazione amministrativa, efficace anche in chiave accentratrice.165
Il conte Giuseppe Chieppio non era il solo a giudicare piuttosto severa-
mente le paggerie dei duchi di Savoia, Mantova e Modena, «piene di gente
che poco applicano al santo timor divino e niente a’ buoni cavalereschi costu-
mi».166 La stessa Madama Reale aveva cercato di correre ai ripari, con l’istitu-
zione dell’Accademia di Torino nel 1678 e i capitoli per i paggi contenuti nelle
Memorie per il regolamento delle fonzioni di corte emanati due anni piu tar-
di.167 Ma, come sembra, l’una e l’altra iniziativa di Maria Giovanna Battista
non avevano sortito l’esito auspicato, e l’intera corte sabauda, lacerata dalle
rivalita e dalle fazioni nobiliari, non era riuscita a evolvere pienamente come
nucleo e manifesto dell’autorita assoluta del suo principe.168
Ma Chieppio non era isolato nell’esprimere stima per la paggeria del gran-
duca di Toscana. «Un congresso di signori sı qualificati», definiva questo isti-
172 ALESSANDRO CONT
a questo episodio presso L.A. MURATORI, Delle antichita estensi, cit., p. 601. I documenti sulla pag-geria estense conservati in ASMo, ASE, CS, Corte, b. 454 non offrono numerosi ragguagli sull’eta delduca Rinaldo (1695-1737). Nel fascicolo Casa, paggeria. Governo, assistenza (1571-1775) e contenuta latestimonianza di un biglietto anonimo che nella notte tra l’8 e il 9 giugno 1709 venne affisso alla portadella paggeria. Il testo recitava: «Quid, Luchesine, paves? Vezzanus, Molza iocantur. Te thomistaprobat, dumfacit scarium. Haud tua, Cincinni tota est iam culpa docentis. Quis numquam viditsub Ganimede sophus?» All’apprendere questa bravata, l’austero e autoritario Serenissimo fu coltoda «molto dispiacere».
164 La citazione e tratta da ASMo, CS, Documenti spettanti a principi estensi, Principi regnanti,Francesco II, b. 347, n. 1974.III.31, p. 3.
165 Sulla debolezza della seconda Madama Reale (1675-1684) e severo G. SYMCOX, Vittorio AmedeoII. L’assolutismo sabaudo (1675-1730) [1983], traduzione dall’inglese, Torino, SEI, 1989, in part. pp. 97-114;cfr. anche M. SCHNETTGER, Zwischen Spanien, Frankreich und dem Kaiser. Italien zur Zeit des Freiedensvon Rijswijk, in Der Friede von Rijswijk 1697, a cura di Heinz Duchhardt, con la collaborazione diM. Schnettger e Martin Vogt, Mainz am Rhein, Philipp von Zabern, 1998, pp. 197-198. Piu cauti, anzi tesia rimarcare gli aspetti positivi di continuita e novita della reggenza rispetto al governo di Carlo Ema-nuele II, sono CLAUDIO ROSSO, Il Seicento, in Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in eta moderna, To-rino, UTET, 1994, pp. 260-263; nonche lo stesso G. SYMCOX, La reggenza, cit., pp. 199-244.
166 AFAMn, AC, b. 45, n. 3, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Mantova,9.VII.1683.
167 Cfr. rispettivamente W. BARBERIS, Le armi del Principe, cit., p. 178; Memorie per il regola-mento, cit., libro III, capp. 7, 17, 18, in Raccolta, cit., pp. 207-208, 212-216.
168 Fallimentari, in rapporto alle finalita di Madama Reale, si dimostrarono in particolare i me-todi educativi adottati nei confronti del figlio duca Vittorio Amedeo II. Cfr. BEATRICE NICCOLINI,Valperga e Savoia, prefazione di Franco Cardini, Firenze, Vallecchi, 1986, pp. 246-248; G. SYMCOX,Vittorio Amedeo II, cit., pp. 81-85.
tuto, sempre nel 1683, il suo compatriota Carlo Petrozani.169 E nello stesso an-no il paggio Francesco Preti, soggiornando nella nativa Mantova, si faceva am-mirare per l’eccellente educazione acquisita presso la corte medicea, un’edu-cazione che, come si affermava, «lo renderebbe sempre piu riguardevolequando continoasse a dimorarvi».170 Invece il marchese Giovanni VincenzoSalviati, maggiordomo maggiore del granduca, manifestava la propria meravi-glia all’apprendere che un altro dei ragazzi soggetti al suo controllo, ScipioneChieppio, aveva premura di abbandonare al piu presto la corte di Pitti. Scon-certava Salviati la straordinaria superficialita del giovane, poiche gli era notoche «la vita de’ signori paggi» di Firenze «passa tra le piu facili, oltre ai con-tinui divertimenti che di tempo in tempo vi sono». Se a qualcosa essa cedevain severita, lo si doveva ai «comodi e liberta della propria casa», ossia del pa-lazzo di famiglia.171 Dunque Salviati richiamava una delle ragioni piu forti cheincoraggiavano gli aristocratici italiani ad affidare uno o piu dei loro figli allecure di una paggeria straniera, e quindi toscana.
Nell’ambito angusto del palazzo di famiglia, infatti, i ragazzi crescevanocircondati da parenti piu anziani o piu giovani di loro e da coetanei di «vile»condizione, venivano adulati e viziati dai servitori, erano coccolati sino all’ec-cesso.172 In un’atmosfera tanto asfittica, l’adolescente non sarebbe mai stato ingrado di maturare il giusto equilibrio interiore, di apprendere le corrette re-gole della socievolezza nobiliare e di «far risplendere le sue virtu».173 Probabil-mente pochi genitori auspicavano che i loro figli partecipassero ai crudelicombattimenti, nei panni di «enfants terribles de la cour» 174 quali sono docu-mentati dalle carte modenesi. Ma numerosi padri condividevano le osservazio-
169 Cfr. AFAMn, AC, b. 45, n. 24, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio,Mantova, 15.X.1683.
170 Ivi, n. 33, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio, Mantova, 19.XI.1683.Per la figura di Francesco Preti cfr. C. D’ARCO, Annotazioni genealogiche, cit., VI, p. 242 A.
171 Cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 92, Giovanni Vincenzo Salviati a Giuseppe MariaChieppio, Val di Marina, 13.VII.1683. Salviati si appoggiava anche su un raffronto con la «paggeriadell’imperatore» a Vienna, in cui dimorava uno dei suoi figli. In realta, il contino veronese GirolamoAntonio d’Emili, paggio alla stessa corte imperiale, confessava al marchese Louis di Canossa che «piubon tempo come ho adeso mai l’havero»: ASMn, AG, s. E.II.3, b. 503, fasc. 1682-1687. Diversi, n. 87,da Vienna, 14.III.1683.
172 Cfr. R. AGO, Giovani nobili, cit., p. 393.173 La citazione e tratta da una lettera di condoglianze per la morte del marchese Corradino Ca-
vriani, primicerio di S. Andrea a Mantova: cfr. ASMn, ACa, Corrispondenza, b. prov. 17, fasc. Lettereal marchese Massimiliano Cavriani (1676, 1687-1689), Antonio Antinori a Massimiliano Cavriani, Fi-renze, 1.IV.1687.
174 Cosı Frederic d’Agay chiama i paggi secenteschi del Louvre e di Versailles: cfr. FREDERIC
D’AGAY, Pages, in Dictionnaire du grand siecle, a cura di Francoise Bluche, nuova edizione rivedutae corretta, Paris, Fayard, 2006, p. 1137.
12
173I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
ni di Gregorio Leti, secondo il quale «un gentil’huomo che non e mai uscitodal suo albergo» e soltanto «un fanciullo che parla e non sa di che, un animaledi gabbia che canta senza intender quello che dice, una bambola pien di ventosenza sostanza & un bifolco malitioso & rozzo».175
La frequentazione di una paggeria e di una corte forestiere poneva il ram-pollo di una nobile schiatta in rapporto diretto e problematico con altri gio-vani provenienti da citta e mondi con costumanze, mentalita e un vissuto assaidifferenti dal proprio, che vantavano un lignaggio magari piu illustre e che siatteggiavano secondo una vasta gamma di indoli. Proiettato in una realta so-ciale ben piu articolata di quella domestica, il paggio poteva aprirsi a uno stiledi vita che, come si sperava, avrebbe temperato il suo orgoglio ed esaltato inlui la modestia, l’equilibrio, la saggezza e la generosita.176
Giuseppe Chieppio, consolando il fratellino abbattuto per le maldicenzedei suoi camerati, ammetteva sı che «nelle corti vi sono sempre delle emula-tioni e molto piu si provano de’ creppacuori quando massime vi sono lingueche giocano a tagliar a pezzi il compagno». Pero con questo egli non perve-niva a una condanna morale della carriera cortigiana. Al contrario, egli sugge-riva una serie di onorevoli mezzi atti a superare le difficolta (in primo luogol’amore, in secondo la dissimulazione, in terzo il ricorso al maggiordomo mag-giore, in quarto l’appello ai serenissimi principi) e mantenersi nella grazia delsovrano.177 Invece il conterraneo marchese Alfonso Dionigio Preti ostentavainsensibilita in faccia alla «malenconia non ordinaria» che aveva colto suo fi-glio Francesco, anch’egli, come si e visto, paggio nella corte di Toscana. A Sci-pione Chieppio, che gli palesava la propria inquietudine per la mestizia del
174 ALESSANDRO CONT
175 GREGORIO LETI, L’Italia regnante, o vero nova descritione dello stato presente di tutti prenci-pati, e republiche d’Italia, I, Geneva, Guglielmo e Pietro de la Pietra, 1675, p. 5.
176 Cfr. AFAMn, AC, b. 45, n. 1, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Man-tova?, 24.VI.1683. Massimiliano Cavriani, dopo il suo ritorno a Mantova dalla corte di Pitti, man-tenne relazioni cordiali con vari esponenti della nobilta e della cultura fiorentine. Tra questi si se-gnalano, oltre ai suoi parenti Antonio Antinori, Margherita Antinori Martini e Maria VittoriaAntinori, anche Donato Acciaioli, Anna Maria Altoviti Acciaioli, Filippo Corsini, Lorenzo Maga-lotti, Filippo Nerli, Francesco Riccardi, Urbano Sacchetti (cardinale) e Luigi Strozzi: cfr. ASMn,ACa, Corrispondenza, b. prov. 10, fasc. Lettere al marchese Massimiliano Cavriani, Lorenzo Maga-lotti (Firenze, 5.VIII.1681); ivi, b. prov. 12; ivi, b. prov. 14, Lettere al marchese Ferdinando Cavriani;ivi, b. 16, fasc. Lettere inviate alla famiglia Cavriani; ivi, fasc. Lettere al marchese Massimiliano Ca-vriani e alla moglie Maddalena Facchini; ivi, b. prov. 17, fasc. Lettere al marchese Massimiliano Ca-vriani; ivi, b. prov. 19, fasc. Lettere al marchese Massimiliano Cavriani; ivi, b. prov. 20, fasc. Lettere almarchese Massimiliano Cavriani. Magalotti in particolare, grato per la «memoria» che di lui conser-vava Massimiliano «anche nel colmo di tanta afflizione» per la morte della moglie Claudia Agnelli,lo consolava per la grave perdita affermando di pregare «la divina clemenza che presto si degni d’ac-correre al conforto del travagliato Suo animo»: ivi, b. prov. 10, fasc. Lettere al marchese Massimi-liano Cavriani, da Firenze, 5.VIII.1681.
177 Cfr. AFAMn, AC, b. 45, nn. 1-3, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico,Mantova, 22.VIII.1683.
cognato nonche amicissimo Francesco, il marchese mantovano rispondevaseccamente: «In quanto poi alla malinconia», stava al ragazzo «il lasciarla ri-trovandosi in camerata di venti e piu cavaglieri giovani e tutti spiritosi».Quanto al desiderio di un viaggio in Inghilterra che veniva accarezzato dallostesso Francesco, egli non intendeva assolutamente incoraggiarlo, anzi avreb-be assunto «quelle misure che saranno opportune per levarli fori di mentequesti suoi pensieri vani», mentre «farebbe ben meglio a continuare questosuo servigio» alla corte medicea.178
Tuttavia gli adolescenti Scipione Chieppio e Francesco Preti non si senti-vano propensi a conquistarsi la stima e la simpatia dei loro compagni. Sin dalsuo ingresso a Pitti nel giugno del 1683, il diciassettenne Chieppio avvertı unintimo disagio: i coetanei invasivamente spigliati e scaltriti provocavano inlui una reazione di distacco e rifiuto a ogni cameratismo.179 Per tutta la duratadel suo soggiorno toscano, egli non riuscı mai a superare questo suo impulsoall’autoemarginazione. Per compensarne gli effetti, Scipione trovo nel cognatoe compatriota Francesco Preti, paggio «molto avenente e compito»,180 le pro-fonde sintonie di un’«amititia intrinseca» adolescenziale che consentı a en-trambi di condividere angustie e sogni.181 Insieme essi intonavano le «ariette»che Chieppio richiedeva senza sosta al curatore dei suoi interessi in patria, dot-tor Giovanni Francesco Tomasini.182 E quando serviva, si consolavano a vicen-da, «ove se un qualcheduno ci vedesse e la piu bella tragedia del mondo».183
Verso i «pretti» della paggeria, ‘colpevoli’ di ostacolare questa amicizia,Scipione Chieppio maturo un odio feroce. L’esclusivita del rapporto tradue paggi confliggeva con le disposizioni granducali per il governo della pag-
178 Cfr. AFAMn, AC, b. 45, n. 9, Alfonso Dionigio Preti a Scipione Lodovico Chieppio, Man-tova, 4.VIII.1683. Francesco Preti era cognato di Scipione Chieppio in quanto la sorella Anna Cate-rina aveva sposato Giuseppe Chieppio, a sua volta fratello di Scipione. Cfr. C. D’ARCO, Annotazionigenealogiche, cit., VI, p. 242 A.
179 AFAMn, AC, b. 45, n. 11, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio,Mantova, 6.VIII.1683; ivi, n. 26, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Mantova,22.X.1683.
180 Ivi, n. 33, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio, Mantova,19.XI.1683.
181 L’espressione citata e dello stesso Scipione: cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 110, Sci-pione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Maria, Firenze, 11.VIII.1683.
182 Cfr. AFAMn, AC, b. 45, n. 24, Mantova, 15.X.1683: «Ricevera altre sei ariette, solo a fine difarLe vedere che non mi scordo di Lei, godendo sommamente che Ella ne partecipi ad altri signorie massime al signor marchese Preti, gia che ho inteso che egli pure se ne diletta». Sulla losca figuradi Tomasini cfr. ivi, n. 49, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Mantova?,15.II.1684.
183 AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 79, Francesco Preti al cognato Giuseppe Maria Chiep-pio, Firenze, 4.VII.1683. Cfr. anche ivi, n. 191, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Ma-ria, [Firenze giugno/luglio 1683].
175I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
geria. Ma e verosimile che Scipione esagerasse un poco i termini dell’ostilitamanifestata verso di lui dai suoi maestri. Egli non intendeva assecondare gliordini dei superiori piegandosi alla minaccia del carcere, e di conseguenza ri-teneva imminente la sua espulsione da Pitti.184 Nella certezza della propria in-nocenza e nell’irriducibile astio che lo perseguitava, Scipione giunse persino ameditare una orgogliosa vendetta, perche «in prigione o che gli voglio andareper qualche cosa o per niente». Cosı, quando il maestro si fosse avvicinato aidue paggi per gettarli in cella, il povero ecclesiastico avrebbe ricevuto «digiorno un scabelo nel capo, se e di sera un candeliere che e piu legiere».185
Per fortuna, eventualita del genere non si verificarono.186 Eppure la tatticaattuata dai due giovanotti doveva essere logorante per i loro maestri, «cosache nesun’altro fa».187 Non appena costoro si accostavano a Scipione e Fran-cesco con lo scopo di castigarli, i due amici univano le loro forze, proclama-vano a squarciagola, «ed i pretti non vorebbero e noi per fargli dispeto ne fac-ciamo [di chiasso] sempre di magiore», sicche quei «pretti non ardiscono divenire a darci».188 Passo meno di un mese, e dalla concessione dell’uso dellacavallerizza Scipione intuı una resa dei suoi nemici.189
Contro il pervicace pessimismo e la repulsione del giovane conte versol’ambiente della paggeria e la corte di Firenze non valsero le parole di incorag-giamento rivoltegli dal fratello maggiore Giuseppe, il quale non appena venneinformato dell’autorizzazione relativa alla cavallerizza, volle interpretare l’e-vento come la conferma che Scipione non era «malvisto in cotesta corte, men-tre viene grattiato cosı subito essendo poco tempo che [...] e al servitio».190
Tuttavia Scipione non era disposto ad adeguarsi alle interpretazioni delfratello maggiore. Dall’arrivo a Firenze, egli aveva riconosciuto in Giuseppeun interlocutore sordo alle sue esigenze e un petulante tutore, o, come lo de-finiva, uno «spropositato, di humore stravagante e [...] un solenissimo caba-lone».191 Il paggio auspicava dal fratello una migliore tutela e una puntualecomprensione, e invece si vedeva corrisposto dalla taccagneria, dalla insensi-
176 ALESSANDRO CONT
184 Cfr. ivi, nn. 110 e 132, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Maria, Firenze,11.VIII.1683, 12.X.1683.
185 Ivi, n. 110.186 Scipione, da incosciente, aveva sostenuto di pregare «Dio che non mi venga l’occasione per-
che se mi vera ho paura che qualcheduno di noi iochera di meno»: ibid.187 AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 132, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe
Maria, Firenze, 12.X.1683.188 Ibid.189 Cfr. ivi, n. 135, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Maria, Firenze, 21.X.1683.190 AFAMn, AC, b. 45, n. 30, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Bologna,
29.X.1683.191 Ivi, n. 6, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodovico, Mantova?, 16.VII.1683.
bilita e da una patriarcale invadenza.192 Supplicava danaro adducendo gli ob-blighi della vita di corte, e quello gli elemosinava monete col contagocce edesortazioni alla sobrieta.193 Partecipava le proprie sofferenze, inviava un dise-gno con preghiera di compatimento «se non e ben fatto perche non e altroche un mese mezo che imparo» 194 e riceveva solenni raccomandazioni conditecon petulanti richieste di migliorare la calligrafia e lo stile grammaticale dellesue lettere.195 Esponeva la diffidenza dei superiori dalla quale era oppresso, eapprendeva che Giuseppe si era rivolto al maestro dipingendolo come unoscioperato e un «mal timorato di Dio», da tenere «un poco in regola». Nonche questo fosse falso, riconosceva Scipione con un pizzico di autocompiaci-mento. Peraltro nessun padre aveva mai scritto del proprio figlio al maestro dipaggeria, e questa insolita sollecitudine del fratello era stata portata a cono-scenza della corte cosicche, osservava Scipione, «tutti mi credevano per unode’ piu sguaiati che ci fosse in tutto il mondo, e per gratia di Dio gli o poi fattovedere in efetto quel che io sono, nonostante le male informationi le quali so-no ite fino alle orechie del gran duca».196
Giuseppe Chieppio era pur tuttavia un uomo maturo, concreto, affaccen-dato nella gestione di un patrimonio economico modesto che egli doveva di-fendere da cause giudiziarie, assalti di creditori paterni, frodi e insolenze diservi e giureconsulti, nonche dalle pretese della sua stessa madre.197 Espostoa piu serie difficolta della vita, non poteva essere piu lontano dal condividere,e di fatti mal sopportava, la stagnante immaturita e l’inguaribile irresponsabi-lita del fratello minore, che ai suoi occhi trascurava scioccamente gli studi pro-ficui e le protezioni potenti per rincorrere effimere fantasticherie.198
192 Cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 79, Francesco Preti al cognato Giuseppe MariaChieppio, Firenze, 4.VII.1683: «Il signor conte Sipione si diporta asai bene ma l’e ben vero che ein collera [...] e pare a me che V.S. li abbi scritto qualche letere che non li piaciono et e in collerae faciamo a consolarci».
193 Cfr. ivi, nn. 70, 89, 191, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Maria, Firenze,19.VI.1683, 12.VII.1683, [giugno/luglio 1683].
194 Ivi, n. 122, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Maria, Firenze, 21.IX.1683.195 Cfr. ivi, n. 89, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Maria, Firenze, 12.VII.1683.
«Ho poi hauta quella lettera piena di avertimenti, mi creda di certo che mi sta a cuore tanto il miohonore quanto alcun altro [...] E ben vero che scrivo malissimo ma e anche vero, conforme Ella in-tende delle altre cose che Gli scrivo che dovrebbe intendere anche questa che mi fa di bisogno diDANARI». Inoltre cfr. AFAMn, AC, b. 45, n. 6, Giuseppe Maria Chieppio al fratello Scipione Lodo-vico, Mantova?, 16.VII.1683.
196 AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 125, Scipione Lodovico Chieppio al fratello GiuseppeMaria, Firenze, 28.IX.1683.
197 Cfr. le sue lettere a Scipione (1683-1684) in AFAMn, AC, b. 45, nn. 2, 3, 6, 8, 12, 17, 21, 26, 30,31, 34, 36, 40, 46, 49, 51, 55, 59.
198 Cfr. ivi, n. 27, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio, Mantova,22.X.1683: «Se Ella sapesse le stretezze e passioni che prova il signor conte Giuseppe nel maneggiodegli affari di casa e delle liti, Vostra Signoria Ill.ma conoscerebbe assai piu la felicita del Suo stato».
177I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
D’altro canto, Scipione ambiva sgravarsi dal peso della vita di palazzo,dove si considerava esule, ingiustamente privato della propria liberta.199 Ne-gli anni in cui il futuro arcade Benedetto Menzini componeva le sue terzinesatireggianti la corte medicea,200 quest’ultima, da miraggio strenuamenteanelato, era diventata agli occhi di Chieppio «il medesimo inferno».201 Ab-bandonandola al piu presto, questa corte, Scipione avrebbe potuto final-mente «andare un poco per il mondo e far voto di non obligarmi piu a ne-suna corte ma pigliarmi spasso e andarmene alla guera ad arischiarmi lavita».202
Anche la pazienza di Giuseppe aveva dei limiti, e soprattutto bisognavaimpedire che l’ostinazione del giovanotto, ben superiore a quella dell’ami-cissimo Francesco Preti,203 danneggiasse il credito proprio e di tutta la suacasata. Con il pretesto di una scorsa in patria, «perche apunto sara un annoo poco meno che son pagio», Scipione era di nuovo a Mantova nell’apriledel 1684.204 Malgrado l’assicurazione prestata di restare a casa non piu di«tre o quatro mesi»,205 egli non fece piu ritorno nell’odiato Palazzo Pitti,alla corte medicea.206 Anzi, nel 1689 riuscı a coronare un desiderio che ave-va manifestato proprio quand’era paggio: si arruolo nell’esercito, e combat-te in Fiandra sotto il vessillo francese.207 Scipione proclamo in questo modola sua indipendenza rispetto alla segregazione che per lui era simboleggiatadalla livrea di paggio. Emozionato, nell’imminenza della sua visita a Man-tova, nell’aprile 1684 egli giurava al fratello, con accenti epici, «che non so-gno altro se non di essere sule montagne», sui selvosi rilievi appenninici traFirenze e Bologna, «con la spada alla mano e di combatere con i venti che
178 ALESSANDRO CONT
199 Cfr. AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 90, Antonio Tarachia a Giuseppe Maria Chieppio,Mantova, 13.VII.1683.
200 Cfr. DAVIDE CONRIERI, La cultura letteraria e teatrale, in Storia della civilta toscana, cit.,pp. 378-380.
201 AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, n. 132, Scipione Lodovico Chieppio al fratello GiuseppeMaria, Firenze, 12.X.1683.
202 Ibid.203 Cfr. AFAMn, AC, b. 45, n. 27, Giovanni Francesco Tomasini a Scipione Lodovico Chieppio,
Mantova, 22.X.1683.204 Cfr. 7 lettere da lui dirette al fratello (1683-1684) in AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXIV, nn. 157,
178 (da cui la citazione); ivi, fasc. LXXV, nn. 12, 35, 39, 40, 42; inoltre AFAMn, AC, b. 45, n. 60, Pas-saporto rilasciato da Cosimo III de’ Medici a Scipione Lodovico Chieppio, Firenze, 11.IV.1684.
205 AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXV, n. 12, Scipione Lodovico Chieppio al fratello GiuseppeMaria, Pisa, 4.II.1684.
206 Cfr. ivi, n. 74, Amadore Magnelli a Giuseppe Maria Chieppio, Firenze, 18.VII.1684; ivi,n. 137, Cosimo III de’ Medici a Giuseppe Maria Chieppio, Firenze, 25.XI.1684.
207 Cfr. AFAMn, AC, b. 38, fasc. LXXX, nn. 4, 5, 6, Scipione Lodovico Chieppio al fratelloGiuseppe Maria, Casale nel Monferrato, 12.IV.1689, 19.IV.1689, Lione, 19.V.1689; C. D’ARCO, Anno-tazioni genealogiche, cit., III, p. 240.
non vorrebero che io venissi dal dispacer che hano di vedermi con buonasalute».208
La biografia di Scipione Chieppio dimostra come i paggi, in ultima istan-za, non costituissero dei meri strumenti passivi e decorativi nelle mani di so-vrani protesi alla ricerca di un prestigio e di un’autorita da perseguire anche osoprattutto con la ostentata magnificenza di un seguito principesco e con ladisponibilita di ricompense cortigiane tali da subordinare «per elettione» o«per debito».209 L’esito della vicenda di Scipione prova altresı come gli stessipaggi non fossero sempre docili e acquiescenti a famiglie d’origine che punta-vano al consolidamento delle loro fortune speculando sull’educazione cavalle-resca dei loro rampolli e sulle strategie di ascesa a palazzo su questi incentra-te.210 Per contro, i ragazzi usufruivano di un margine piu o meno consistentedi liberta personale che derivava specialmente dalle difficolta insite nella ge-stione disciplinare di un istituto dal carattere cortigiano, quale era per l’ap-punto la paggeria.
Duchi e granduchi, e a maggior ragione maggiordomi maggiori, gran scu-dieri, governatori e maestri erano costretti a rispettare la nobilta e l’autoritadelle famiglie dalle quali provenivano i paggi. Per parte loro, tali casate inter-venivano con somma cautela sulla condotta individuale dei figli paggi, non so-lo perche questi erano spesso lontani dalla patria, ma anche e soprattuttoavendone affidato l’istruzione a un sovrano del quale avevano riconosciuto«le riguardevoli qualita».211 E nondimeno, i vantaggi materiali e spiritualiche un servizio in paggeria, vale a dire a corte, continuava a presentare e aconcretizzare, specialmente per la modesta o recente aristocrazia della capitalee del contado (si pensi agli Amigoni, ai Capelli o agli Zanetti nel ducato man-tovano) relegavano volentieri in secondo piano le eventuali perplessita sullecarenze organizzative delle paggerie dei Savoia, degli Estensi, degli stessi Gon-zaga, e, in misura minore, dei Medici.212
Del resto si poteva sperare, e probabilmente l’esperienza lo insegno, che ipaggi sregolati e dissoluti avrebbero assunto un contegno piu confacente al
208 AFAMn, AC, b. 37, fasc. LXXV, n. 42, da Firenze, 18?.IV.1684.209 Le citazioni sono tratte da ASMn, AG, s. E.XXV.3, b. 1051, c. 510r, Gaspare Altieri a Ferdi-
nando Carlo Gonzaga-Nevers, Roma, 13.XII.1680.210 Sulla sensibilita di un paggio ai tornaconti del proprio casato cfr. BNCF, Ms. Gal. 162, c. 4,
Bruto Annibaldi della Molara a Vincenzo Viviani, Pisa, 31.III.1663.211 ASMn, AG, s. E.XIX.2, b. 730, fasc. XVIII, n. 1, Vittorio Amedeo II di Savoia a Ferdinando
III Gonzaga di Castiglione, Torino, 10.III.1684.212 Come richiedeva la convenienza, il patrizio ravennate Ottavio Pietro Rasponi, rivolgendosi
direttamente al duca di Mantova, asseriva che era stata una «fortuna» per lui vedere accolto, circasette anni prima, suo figlio Pietro «al servitio di V. Altezza Serenissima per paggio»: ASMn, AG,s. E.XXV.3, b. 1051, c. 887r, Ottavio Pietro Rasponi a Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers, Ravenna,11.IV.1684.
179I PAGGI NELLE CORTI ITALIANE DEL SEICENTO
loro rango, non appena, placati i bollori dell’adolescenza, avessero riconosciu-to la loro convenienza a mantenere una posizione di forza sul piano sociale epolitico.213 Genitori e parenti, dal canto loro, avrebbero cercato di ricorrere,nei limiti del possibile, a mezzi di persuasione e di pressione onde produrrela resipiscenza degli eventuali sventurati e circoscrivere i danni provocati dasbandamenti e impulsi centrifughi.214 In tal senso, il genere letterario dei pa-reri cavallereschi, che tanta fortuna continuo a godere nell’Italia della secondameta del secolo XVII, svolse un compito efficace quale collante sociale e riso-lutore di deviazioni pericolose per la compattezza e la supremazia del ceto no-biliare. Anche nei confronti dei gentiluomini che erano stati paggi, quellescritture di natura eminentemente pratica, finalizzate a scongiurare o a risol-vere questioni in punto d’onore, potevano rivestire il ruolo di pompose lezionidi recupero.
ALESSANDRO CONT
180 ALESSANDRO CONT
213 E eloquente il fatto che quattro anni dopo il suo abbandono di Palazzo Pitti, Scipione Chiep-pio aspirasse a una sistemazione dipendente dai meccanismi di una corte, cioe dal «medesimo in-ferno». Per questo tento di ingaggiare il fratello, che, in qualita di cameriere ducale a Mantova, aveva«l’orechio del serenissimo padrone» Ferdinando Carlo Gonzaga-Nevers. Cfr. AFAMn, AC, b. 38,fasc. LXXVIII, Scipione Lodovico Chieppio al fratello Giuseppe Maria, Olmo Lungo, 11.X.1688.Per la posizione nel sistema patrimoniale di famiglia assegnata dai genitori a un gentiluomo che fupaggio, ossia al conte reggiano Ernesto Sessi, cfr. invece due documenti dell’Archivio di Stato di Ra-venna, Sezione di Faenza, Archivio Mazzolani-Sessi: Filza H, Testamento della sig. marchese [!] d.Margherita Montecuccoli vedova del sig. marchese Ferdinando Sessi di Rolo, Modena, 21.I.1688; Docu-menti riguardanti la casa Sessi, 1394-1738 (aa), Copia autentica di atti dal 1659 al 1683 relativi all’ereditadi Ferdinando II Sessi di Rolo, [Vienna], 30.I.1773.
214 Cfr. ASMn, AG, s. F.II.8, b. 2820, Lorenzo Verzuso Beretti a Ferdinando Carlo Orsatti,Mantova, 13.III.1693 (I); Archivio di Stato di Ferrara, Archivio Bentivoglio d’Aragona, Lettere,b. 398, cc. 86, 88, 128, 148, 170, 231, Ascanio Gonzaga di Vescovato a Lucrezia Pio di Savoia Bentivo-glio, Mantova, 23.IV.1699 (2), 7.V.1699, 14.V.1699, 21.V.1699, 4.VI.1699.