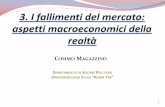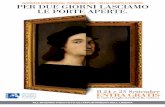TRA "ESTRANEITA'» E CITTADINANZA: MERCATO DEL LAVORO E MIGRAZIONI A GENOVA (SECC. XV-XVI)
Verso il mercato interno dell'energia : le reti energetiche europee
Transcript of Verso il mercato interno dell'energia : le reti energetiche europee
3���� �� ������ ���� �������� ���
LE RETI ENERGETICHE EUROPEE (*)
di Alessandro Candido
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il lento incedere dell’integrazione europea in materiaenergetica. – 3. Il doppio volto dell’energia: merce e servizio di interesse econo-mico generale. – 4. Le reti energetiche transeuropee: le ragioni e gli obiettivi. –5. Gli ulteriori sviluppi in materia di reti energetiche. – 6. Il contesto italiano:cenni. – 7. Spunti conclusivi.
1. Introduzione
Lo sviluppo delle reti transeuropee nelle infrastrutture energetiche(RTE-E) costituisce senza dubbio la chiave di volta della politica comu-nitaria dell’energia e trova il suo fondamento normativo, come accadeper il settore dei trasporti e per quello delle telecomunicazioni, nell’art.170 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (da ora,TFUE).
La norma in questione è stata per la prima volta introdotta con ilTrattato di Maastricht (1) (è l’ex art. 154 TCE) che, con lo scopo difavorire tanto la coesione economica e sociale (2), quanto la creazione diun mercato unico, ha impegnato l’Unione alla costituzione di reti tran-
(*) Ringrazio la Prof.ssa Laura Ammannati per la lettura critica del saggio e peri numerosi spunti di riflessione che mi ha offerto.
(1) Cfr. A. PREDIERI, Le reti transeuropee nei Trattati di Maastricht e diAmsterdam, in Dir. un. eur., 1997, 3, p. 287 ss.
(2) Sul principio di coesione, cfr. ad es. C. BUZZACCHI, Dalla coesione all’ugua-glianza sostanziale. Il percorso comunitario, Milano, 2005; L. MELICA, Fondamenti costi-tuzionali della coesione europea, Napoli, 2006; E. BALBONI, Coesione sociale e livelli essen-ziali delle prestazioni: due paradigmi paralleli della tutela multilivello dei diritti sociali, inLa tutela multilivello dei diritti sociali, in ID. (a cura di), Napoli, 2008, vol. I, p. 3 ss.;M. MASSA, Una politica fondamentale. Profili generali della politica di coesione per il2007-2013, in La tutela multilivello dei diritti sociali, cit., p. 19 ss.; F. PIZZOLATO, Ilsistema di protezione sociale nel processo di integrazione europea, Milano, 2002.
���������� �������
seuropee. Il fine dell’azione, precisato oggi nel § 2 dell’art. 170 TFUE,è quello di realizzare «l’interconnessione e l’interoperabilità delle retinazionali, nonché l’accesso a tali reti», tenendo conto «della necessità dicollegare alle regioni centrali dell’Unione le regioni insulari, prive disbocchi al mare e periferiche».
Chiaramente, si tratta di obiettivi ambiziosi e di lungo periodoche, se da un lato richiedono notevoli investimenti, dall’altro devonomisurarsi con un settore, quello dell’energia, intrinsecamente comples-so, rispetto al quale, peraltro, le politiche comunitarie hanno da semprerisentito dell’assenza di una specifica competenza all’interno dei Trattati(3). Nonostante tale lacuna normativa, si può comunque affermare chenegli anni l’Unione è riuscita ad elaborare una sua strategia energetica,soprattutto adottando numerose direttive in materia, nonché avvalen-dosi di Libri verdi, Libri bianchi e Programmi d’azione (4).
Il quadro è oggi radicalmente mutato con il Trattato di Lisbona che,entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha posto la materia energia all’in-terno delle fonti primarie comunitarie, dedicando alla stessa il Titolo XXIdel Trattato (formato da un unico articolo, il 194) e riconoscendo il carat-tere concorrente della suddetta competenza (art. 4, § 2, lett. i, TFUE)(5).
In particolare, l’art. 194, § 1, TFUE ha individuato i fini dellapolitica energetica europea che, in uno spirito di solidarietà tra gli Statimembri, nonchè «tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliora-re l’ambiente», è volta a:
88
(3) Cfr. B. POZZO, Le politiche comunitarie in campo energetico, in Riv. giur.ambiente, 2009, 6, pp. 841-842.
(4) Sul ruolo degli strumenti di soft law nel diritto comunitario, cfr. A. POGGI,Soft law nell’ordinamento comunitario, Relazione al Convegno dell’Associazione italianadei costituzionalisti “L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionale,Università degli studi di Catania, 14-15 ottobre 2005; ora in Atti del XX Convegnodell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 2007, p. 369 ss.; cfr. anche R.BIN, Soft law, no law, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmo-derne, Torino, 2009, p. 31 ss.; L. SENDEN, Soft Law in European Community Law,Portland, 2004.
(5) Secondo F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, in E.PICOZZA, E. GABRIELLI (a cura di), Trattato di diritto dell’economia, vol. VI, Padova,2008, pp. 39-40, «l’inclusione delle politiche sulle reti transeuropee fra le materie dicompetenza concorrente (voluto dal legislatore del Trattato di Lisbona) aggraverà le dif-ficoltà di coordinamento, posto che la competenza concorrente di per sé – almeno fin-ché non intervengano le istituzioni comunitarie – comporta la divaricazione dei regiminazionali: e ciò è vero sia perché la competenza concorrente può essere esercitata inconcreto in forme diverse, sia perché essa comunque non elimina la procedura di co-decisione e il diritto di veto degli Stati interessati dall’intervento».
!� !������!� �" #�$%�&$!' $(& ) " ' ��!(& ) ""* $ �+�!,
b) garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione;c) promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo
sviluppo di energie nuove e rinnovabili;d) sviluppare l’interconnessione delle reti energetiche.Tali scopi, come meglio si preciserà più avanti, non possono che
essere letti in combinato disposto tra loro, dato che, ad esempio, per rea-lizzare un mercato interno dell’energia sostenibile, sicuro e competitivoè necessario creare dei nuovi e moderni interconnettori, i quali si rivela-no indispensabili sia dal punto di vista della sicurezza energetica, che perlo sviluppo di fonti alternative di energia a prezzi più contenuti.
Tanto premesso, giova sottolineare che l’aver introdotto un’apposi-ta disposizione in materia di energia costituisce non certo (e non anco-ra) un momento di arrivo, bensì soltanto un punto di partenza per ilrealizzarsi del cammino di integrazione europea nel settore energetico,processo che non può prescindere in primo luogo da una regolazioneche sia il più possibile armonizzata all’interno degli Stati membri (6),con la conseguente necessità di rimuovere le numerose asimmetrieinformative che, oltre a incidere sul costo dei prodotti energetici, sonotali da rappresentare una vera e propria barriera all’ingresso di nuovioperatori nel mercato dell’energia.
Tra l’altro, non si può omettere di ricordare che quest’ultimo è unmercato che assiste ai continui scontri tra gli interessi dell’Unione euro-pea e quelli degli Stati membri, senza poi trascurare l’ambito delle rela-zioni internazionali, rispetto al quale l’energia riveste un ruolo strategi-co tanto dal punto di vista della competitività dei vari sistemi economi-ci (essendo l’energia l’elemento propulsore di tutte le attività moder-ne)(7), quanto per il mantenimento della pace (8). Basti pensare, pur
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 89
(6) Così F. SCUTO, La governance del settore energia e gas attraverso la “rete” euro-pea delle autorità indipendenti, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2007, 1, p. 302.
(7) Cfr. N. AICARDI, Energia, in Trattato di diritto amministrativo europeo, inM.P. CHITI, G. GRECO (dir.), Trattato di diritto amministrativo europeo, P.te speciale,Tomo II, 2ª ed., Milano, 2007, p. 1008.
(8) Per sottolineare l’importanza che l’energia riveste nelle relazioni internazio-nali, si ricorda, ad esempio, che tra le cause scatenanti la seconda guerra mondiale siponeva la rivalità tra Francia e Germania in relazione al controllo dei bacini della Ruhre della Saar, area strategica di confine, da sempre oggetto di contesa tra i due Paesi perla localizzazione dei siti di produzione del carbone e dell’acciaio. Allo stesso modo, ènoto che la Germania mirava altresì ad assicurarsi il petrolio della Romania e delCaucaso, così come il Giappone intendeva conquistare quello dell’Indocina, in mododa non dipendere più dagli Stati Uniti.
-./0012456 7124846
senza poter in questa sede approfondire ulteriormente l’argomento, allerecenti vicende che hanno investito numerosi Paesi dell’Africa del Nord,per comprendere quanto le risorse energetiche siano un significativostrumento di pressione sia nei confronti dell’Unione, che dei singoliStati membri i quali, come è accaduto per l’Italia nei confronti dellaLibia, possono trovarsi esposti alla minaccia di un’interruzione delle for-niture di energia (9).
È nell’ambito delle considerazioni sin qui brevemente svolte che vacollocata la questione delle reti energetiche transeuropee, rispetto allaquale non si potrà prescindere dalla disamina della decisione n.1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre2006, «che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settoredell’energia» (10).
L’atto in questione è stato adottato seguendo il procedimento dicui all’art. 172 TFUE (ex art. 156 TCE), ove si dispone che le richiama-te istituzioni dell’Unione (vale a dire, il Parlamento europeo e ilConsiglio) deliberano seguendo la procedura legislativa ordinaria (11),sentiti il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regio-ni e, laddove vengano in rilievo orientamenti e progetti di interessecomune riguardanti il territorio di uno degli Stati membri, previaapprovazione del Paese interessato.
Detta decisione, che sarà analizzata nel corso della presente tratta-zione, delinea i principi cardine dell’azione comunitaria in materia direti energetiche transeuropee, predisponendo «un insieme di orienta-menti concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azionedella Comunità nel settore delle reti transeuropee dell’energia. Tali
90
(9) A quest’ultimo proposito, non può mancare un cenno agli ultimi accadimen-ti che hanno riguardato l’Egitto, la Tunisia, l’Algeria e, soprattutto, la Libia, quantome-no in relazione al problema dell’approvvigionamento energetico italiano. Si ricorda chetanto in Libia (oggi terreno di scontro tra i sostenitori del colonnello MuammarGheddafi, gli insorti e la coalizione ONU), quanto in Egitto, Eni è presente dagli anni’50 ed è il primo produttore internazionale di idrocarburi. Inoltre, oltre il 23% delpetrolio che si consuma in Italia proviene proprio dalla Libia. Cfr. l’articolo di L.VAGLIO, Algeria, Libia, Tunisia: ecco il peso energetico del Nord Africa per l’Italia, in IlSole 24 Ore, 25 febbraio 2011.
(10) Tale atto abroga le precedenti decisioni nn. 96/391/CE e 1229/2003/CE.(11) Com’è noto, la c.d. procedura legislativa ordinaria costituisce il procedi-
mento generale di adozione degli atti legislativi comunitari ed è disciplinata dall’art.294 TFUE. Essa ricalca per buona parte la previgente procedura di codecisione ed èfinalizzata all’adozione dell’atto comunitario (regolamento, direttiva o decisione), daparte del Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, previa proposta dellaCommissione.
9:;<=>?@<=>; ;=A;B;AC?=9 D:9E<>>; A; ;=><:<FF< G9@C=< < D:9E<>>; D:;9H
ritari, compresi quelli d’interesse europeo, nelle reti transeuropee di elet-tricità e gas» (art. 1).
Più in particolare, i principali fini dell’Unione europea in relazio-ne allo sviluppo delle reti energetiche si concentrano sull’interconnessio-ne, l’interoperabilità e l’accesso alle reti, aspetti questi inscindibilmentecorrelati in primo luogo al problema della creazione di un mercatointerno dell’energia. Del resto, non sarebbe possibile immaginare l’inte-grazione dei mercati energetici e l’abolizione delle frontiere nazionali, sesi continuasse a conservare esclusivamente in capo ai singoli Stati mem-bri la gestione e l’organizzazione delle infrastrutture energetiche.
Allo stesso tempo, non meno importante è la necessità di ridurre ildivario in termini di ricchezza energetica tra le diverse regioni europee(12), favorendo una redistribuzione delle risorse verso quelle zone che,per ragioni geografiche o economiche, si trovano oggi in una posizionedi svantaggio. Da questo punto di vista, ancora una volta torna in primopiano l’obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale di cuial richiamato art. 174 TFUE (13), rispetto al quale l’energia rappresen-ta non soltanto una merce, ma soprattutto un diritto sociale fondamen-tale di tutti i cittadini europei (14).
Infine, lo sviluppo delle reti transeuropee dell’energia serve a garanti-re una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti, grazie alla diversifica-zione delle forniture e delle rotte su cui transitano i prodotti energetici.
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 91
(12) L’Italia coordina la regione centro-sud Europa, composta, oltre che dallastessa Italia, da Francia, Germania, Austria, Slovenia e Grecia.
(13) Il Protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale stabilisceespressamente che il Fondo di coesione, previsto dall’art. 177 TFUE «per l’erogazionedi contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel set-tore delle infrastrutture dei trasporti», si rivolgerà a quegli «Stati membri con un PNLpro capite inferiore al 90% della media dell’Unione i quali abbiano un programmavolto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo 126 deltrattato sul funzionamento dell’Unione europea».
(14) Al riguardo, si rinvia a L. AMMANNATI, La regolazione “cooperativa” del mer-cato interno dell’energia e l’organizzazione comune tra i regolatori europei dell’energia elet-trica e del gas, in ID. (a cura di), Monopolio e regolazione proconcorrenziale nella discipli-na dell’energia, Milano, 2005, soprattutto pp. 364-367. L’Autrice afferma la necessitàdi garantire l’energia a tutti i cittadini comunitari, sottolineandone il carattere di dirit-to sociale, in virtù dell’art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,rubricato Accesso ai servizi di interesse economico generale, che così dispone: «Al fine dipromuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispettal’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni eprassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea».
IJKLLMNOPQ RMNOSOQ
Tale premessa è servita sia per tracciare i termini del problema chein questa sede si tenterà di affrontare, che per sottolineare la complessi-tà e la vitalità di un settore, quello dell’energia, che si presenta in peren-ne cambiamento, che trasversalmente si intreccia con la questione deicambiamenti climatici e con la tutela dell’ambiente (15) ma, soprattut-to, che ha costantemente sofferto la mancanza di una disciplina omoge-nea (16). Inoltre, non si può certo pensare di affrontare il tema delle retienergetiche «senza trattare contestualmente i problemi della fornitura dienergia, cioè i problemi di reperimento, estrazione, trasformazione,commercio interno e internazionale dell’energia che viene trasportatasulle reti stesse» (17).
Ecco perchè, ragionando in un’ottica più generale, nonché tenen-do conto dello stratificarsi degli atti comunitari e delle pronunce dellaCorte di Giustizia dell’Unione europea in materia di energia, non ci sipotrà esimere dal tracciare quantomeno un riepilogo delle principalitappe – normative e giurisprudenziali – che hanno contrassegnato ilcammino energetico comunitario (18).
92
(15) Cfr. A. MARZANATI, I principi ambientali tra diritto interno e diritto comu-nitario, in W. CORTESE (a cura di), Conservazione del paesaggio e dell’ambiente, governodel territorio e grandi infrastrutture: realtà o utopia?, Napoli, 2009, p. 177 ss.
(16) A ciò si aggiunga, a ulteriore conferma della complessità, anche nozionisti-ca, del settore in questione, che non è nemmeno semplice fornire una compiuta e uni-voca definizione di energia. In particolare, come osserva C. BUZZACCHI, La materiaenergia nella giurisprudenza costituzionale, in ID. (a cura di), Il prisma energia.Integrazione di interessi e competenze, Milano, 2010, p. 34, «Parlare di energia significaspaziare all’interno di un contesto assolutamente vasto e dai confini poco definiti, capa-ce di comprendere al suo interno valutazioni che concernono una pluralità di altre mate-rie, di cui si può procedere all’ennesimo elenco: ambiente, beni culturali, sicurezza, sani-tà, paesaggio, parchi nazionali, agricoltura e foreste, programmazione urbanistica, asset-to del territorio, uso dell’acqua». Sempre sulla difficoltà di individuare una univoca qua-lificazione del settore in oggetto, come rilevano G.G. GENTILE e P. GONNELLI, Manualedi diritto dell’energia, Milano, 1994, p. 3, «il concetto di energia non è di quelli che i giu-risti abbiano elaborato o concorso ad elaborare, avendo preferito ricavarlo da altre disci-pline o, magari, assumerlo nell’accezione più empirica propria dell’uso comune».
(17) P. RANCI, Le infrastrutture energetiche: l’Italia e il mercato unico europeo, inI nodi delle reti. Infrastrutture, mercato e interesse pubblico, P.M. MANACORDA (a cura di),Firenze-Antella, 2010, p. 157.
(18) Del resto, come affermano L. AMMANNATI e A. CANEPA, Il governodell’«emergenza energetica»: paure, incertezze, regole, in Amministrare, 2010, 2, p. 247,«la ‘politica energetica’ è espressione di sintesi di molteplicità di settori e ambiti, da con-siderare sia sotto il profilo tecnico che giuridico, la cui convergenza e intersezione mettein relazione o in conflitto interessi di diversa natura (dalla garanzia della fornitura dienergia alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla sicurezza degli impianti e tuteladella salute, e alla riduzione dell’inquinamento) […]».
TU Il lento incedere dell’integrazione europea in materia energetica.
Alle origini dell’integrazione europea, l’energia si poneva – almenonelle previsioni iniziali – al centro di due dei tre Trattati istitutivi delleComunità europee. Difatti, sia il Trattato sulla Comunità europea delcarbone e dell’acciaio (c.d. Trattato CECA)(19), sia il Trattato sullaComunità europea per l’energia atomica (c.d. Trattato CEEA o EURA-TOM)(20) intendevano affrontare la questione energetica: il primoinstaurava un mercato comune del carbone di tipo concorrenziale, basa-to sull’abolizione delle barriere doganali tra gli Stati membri, sul divie-to di aiuti di Stato e sul principio di libera circolazione dei prodotti car-bosiderurgici (21); il secondo, invece, poneva le basi per la creazione diun mercato comune delle materie prime e delle infrastrutture necessarieper la produzione dell’energia atomica e, allo stesso tempo, disciplinavala produzione di energia nucleare.
Nonostante l’importante ruolo svolto dalle suddette Comunità inmateria energetica, per molti anni (come già anticipato, bisognerà addi-rittura attendere fino al Trattato di Lisbona) nessuna specifica compe-tenza nel settore de quo veniva prevista nell’unico Trattato a competen-za generale (22), vale a dire quello istitutivo della Comunità economicaeuropea (c.d. Trattato CEE); con la conseguenza che il diritto europeodell’energia rimaneva privo di base giuridica, a causa della refrattarietàdegli Stati membri a subire un’ulteriore erosione di sovranità in favoredelle istituzioni comunitarie in un settore così strategico.
La necessità di agire in modo congiunto verso la creazione di unmercato unico dell’energia emergeva in tutta evidenza soltanto in segui-to alla crisi petrolifera del 1973, causata dalle restrizioni di produzionedecise dai Paesi arabi, cui si accompagnava un vertiginoso aumento del
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 93
(19) Si tenga presente che negli anni ’50 il carbone costituiva la base dei consu-mi energetici europei. In seguito, invece, gli idrocarburi hanno sostituito il carbone,tanto che si è ritenuto di non prorogare il termine cinquantennale di scadenza previstonel Trattato che aveva istituito la CECA, la quale si è estinta il 23 luglio 2002.
(20) Per un’introduzione al Trattato, cfr. N. CATALANO, La Comunità economicaeuropea e l’Euratom, Milano, 1959; R. DUCCI, La Comunità economica europea el’Euratom, Padova, 1957.
(21) Per un quadro generale sulla CECA, si rinvia a T. SCOVAZZI, Carbone eacciaio nel diritto comunitario, in Dig. disc. pubbl., II, Torino, 1987, p. 493 ss.; R.QUADRI, A. TRABUCCHI, a cura di, Commentario al Trattato CECA, Milano, 1970. Conriguardo invece all’estinzione della CECA, cfr. B. UBERTAZZI, La fine della Ceca: i pro-fili giuridici, in Dir. un. eur., 2004, 2, p. 393 ss.
(22) Cfr. L. KRÄMER, Manuale di diritto comunitario dell’ambiente, Milano,2002, p. 52.
VWXYYZ[\]^ _Z[\`\^
prezzo del petrolio e, in una prima fase, l’embargo delle forniture aiPaesi Bassi.
Non a caso, nel 1974 il Consiglio europeo adottava una risolu-zione che, onde evitare ulteriori situazioni di crisi, predisponeva unaprima strategia di politica energetica comunitaria, imponendo agliStati membri di ridurre, nel giro di dieci anni (tra il 1975 e il 1985),la dipendenza della Comunità dall’energia importata e mirante agarantire un approvvigionamento durevole nel tempo (23). In partico-lare, detta risoluzione si articolava in quattro punti: sviluppo accelera-to dell’energia elettronucleare; sviluppo delle risorse energetiche inter-ne alla Comunità; approvvigionamento estero diversificato e sicuro;infine, investimenti in ricerca per la valorizzazione delle energie alter-native (24).
Nonostante i risultati incoraggianti ottenuti nel decennio seguen-te, il problema dell’assenza di un quadro regolatorio coerente e fondatosu fonti vincolanti emergeva in tutta evidenza a seguito della successivarisoluzione del Consiglio europeo (25), che nel 1985 decideva di predi-sporre un nuovo piano energetico decennale (da realizzarsi tra il 1986 eil 1995), volto – tra le altre cose – ad aumentare significativamentel’energia prodotta da fonti rinnovabili, a promuovere ulteriormente losviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, nonché a integrare ilmercato interno dell’energia, così da eliminare gli ostacoli alla liberaliz-zazione del settore.
Gli obiettivi di quest’ultimo atto venivano disattesi e, allo stessotempo, iniziava a farsi strada l’idea della necessità di legiferare in modonon disomogeneo e attraverso atti vincolanti. In particolare, l’esperimen-to della risoluzione falliva proprio perché non in grado di imporre degliobblighi ai Paesi destinatari, così che, «in sostanza, la politica energeticacomunitaria veniva ad essere la somma delle singole politiche energetichenazionali che hanno avuto un limitato grado di convergenza verso gliobiettivi indicati dalla Risoluzione, a causa del mantenimento di un mix
94
(23) Trattasi della risoluzione adottata dal Consiglio Europeo il 17 settembre1974 su Una nuova strategia per la politica energetica della Comunità. In particolare, simirava a ridurre la dipendenza energetica della Comunità dal 61% del 1973 al 50% del1985, obiettivo effettivamente raggiunto, anche grazie allo sviluppo delle centrali elet-tronucleari in Francia e alla scoperta di nuovi giacimenti di idrocarburi nella piattafor-ma continentale del mare del Nord.
(24) Cfr. F. BASTIANELLI, La politica energetica dell’Unione europea e la situazio-ne dell’Italia, in La Comunità internazionale, 2006, 3, p. 448.
(25) È la risoluzione del 16 settembre 1986 (86/C 241/01), che poneva Lineedirettrici per le politiche energetiche degli Stati membri.
abacgetico e di un uso dell’energia molto diverso tra Stato e Stato» (26).Un decisivo passo in avanti nella logica della creazione di un mer-
cato unico dell’energia veniva compiuto in occasione del Consiglio euro-peo di Dublino nel giugno del 1990, quando il primo ministro dei PaesiBassi suggeriva di instaurare una cooperazione nel settore dell’energiacon i Paesi dell’Europa orientale e dell’ex Unione sovietica, così da acce-lerare la loro ripresa economica e migliorare la sicurezza dell’approvvigio-namento della Comunità. Da qui nasceva l’idea, proposta dallaCommissione, di una Carta europea dell’energia, che sarebbe stata sotto-scritta a L’Aia il 17 dicembre 1991 da cinquantuno Paesi firmatari.
Seguivano il Trattato sulla Carta dell’energia (Energy CharterTreaty) e il Protocollo sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambienta-li correlati, atti firmati il 17 dicembre 1994 a Lisbona da tutti i Paesiaderenti alla Carta del 1991, nonché dalla Comunità europea ed entra-ti in vigore il 16 aprile 1998 (27). Tale Trattato regolava i rapporti inter-correnti tra Stati e investitori stranieri in materia energetica, favorendola progressiva armonizzazione delle discipline del settore e la rimozionedelle barriere legislative agli investimenti stranieri e agli scambi di mate-rie prime e prodotti energetici, con il fine di assicurare lo sviluppo di unmercato interno competitivo.
Un ulteriore segnale in questo senso proveniva dal Trattato diMaastricht, che all’art. 3, lett. u), prevedeva la possibilità per l’Unionedi adottare misure in materia di energia; tuttavia, non veniva ancoraindividuata alcuna specifica competenza al riguardo. Inoltre, semprenell’ambito del c.d. Trattato sull’Unione europea, per la prima volta sispecificava all’art. 154 che la Comunità «concorre alla costituzione e allosviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei traspor-ti, delle telecomunicazioni e dell’energia».
Lo scopo delle reti transeuropee era quello di rafforzare la sicurez-za dell’approvvigionamento di gas ed energia elettrica su tutto il territo-rio dell’Unione europea, di ottimizzare l’utilizzo delle risorse energeti-che e, infine, di ridurre le differenze in termini di costi tra i vari Paesimembri (28): era questo il primo vero passo da compiere per creare unmercato energetico integrato e concorrenziale.
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 95
(26) F. BASTIANELLI, La politica energetica dell’Unione europea e la situazionedell’Italia, cit., p. 450.
(27) Il Trattato sulla Carta dell’energia e il Protocollo della Carta dell’energia sul-l’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati erano approvati con decisione98/181/CE, CECA ed EURATOM.
(28) Cfr. B. POZZO, Le politiche comunitarie in campo energetico, cit., p. 845.
defgghijkl mhijnjl
Faceva seguito la decisione del Parlamento europeo e del Consigliodel 5 giugno 1996, che poneva gli orientamenti relativi agli obiettivi,alle priorità e alle linee di azione comunitarie, individuando in partico-lare i campi di applicazione delle reti di elettricità e del gas naturale (29).
Nonostante l’intensa produzione normativa comunitaria in mate-ria energetica, si doveva ulteriormente rinviare l’inserimento nei Trattatidi un apposito Capitolo sull’energia (30), sebbene anche il Comitatoeconomico e sociale avesse presentato un’iniziativa al riguardo, sottoli-neando la necessità che l’Unione si dotasse di una politica energeticacomune (31).
Nell’ambito del quadro storico sin qui sinteticamente tracciato,non si può dimenticare che, a partire dagli anni ’90, il diritto dell’ener-gia veniva attraversato da due fenomeni distinti: da un lato, in tutti gliordinamenti nazionali degli Stati membri si verificavano processi di pri-vatizzazione e liberalizzazione delle attività di impresa in ambito energe-tico (32), riservando ai pubblici poteri un’attività di controllo sul rispet-to, da parte degli operatori economici, delle regole comuni individuatea livello normativo. Dall’altro, diventavano sempre più numerose (edisorganiche) le norme sovranazionali sulla regolamentazione del mer-cato energetico, tornando nuovamente in primo piano la questione dellanecessità di dar vita a un quadro strutturale di riferimento.
Tra le tappe fondamentali che contrassegnavano il progressivo svi-luppo del mercato comunitario dell’energia, si colloca il Libro verde(33) adottato nel 1995 dalla Commissione e intitolato Per una politicaenergetica dell’Unione Europea, che si proponeva lo scopo di realizzare ilmercato interno dell’energia e di garantire la libera circolazione del benein questione. A questo seguiva, nello stesso anno, il Libro bianco dal
96
(29) Si tratta della decisione n. 1254/96/CE.(30) Per la verità, come si è già anticipato, sia con il Trattato di Maastricht, che
con il Trattato di Amsterdam, si era tentato di introdurre un apposito Capitolo sul-l’energia, ma in entrambi casi il progetto era stato ritirato per mancanza del necessarioconsenso politico.
(31) Si tratta del parere adottodato dal Comitato economico e sociale il 14 set-tembre 1994, con il quale si avanzava la proposta di un Capitolo sull’energia fondatosu quattro articoli e facendo leva sugli aspetti legati alla sicurezza degli approvvigiona-menti, alla politica ambientale, al mercato interno dell’energia, nonché allo sviluppo diuna politica estera energetica comune.
(32) Con riferimento al contesto italiano, si rinvia, ex multis, a D. SORACE, Il ser-vizio di interesse economico generale dell’energia elettrica in Italia tra concorrenza ed altriinteressi pubblici, in Dir. pubbl., 2004, 3, p. 1010 ss.
(33) COM (1994) 659 def. dell’11 gennaio 1995.
opoqrq Una politica energetica per l’Unione Europea (34), che conteneva lelinee guida dell’azione comunitaria in materia energetica e si prefiggevai seguenti fini: raggiungere una rapida integrazione del mercato internodell’energia, gestire le situazioni di dipendenza energetica, garantire lasicurezza degli approvvigionamenti, promuovere lo sviluppo sostenibilee, infine, predisporre una strategia di tutela ambientale.
Nuovi impulsi alla creazione di un mercato unico dell’energia pro-venivano da una serie di direttive degli anni ’90, vale a dire il periododella prima fase di liberalizzazioni (35). In particolare, tali atti normati-vi avevano ad oggetto la liberalizzazione del mercato dell’elettricità (36),la liberalizzazione della ricerca e la produzione di petrolio e gas in con-dizioni di parità di accesso tra le imprese (37), la liberalizzazione delmercato del gas naturale (38), senza poi dimenticare la direttiva sullatrasparenza dei prezzi del gas e dell’energia elettrica e quella concernen-te il transito dell’energia (39).
La seconda stagione delle liberalizzazioni (40) prendeva avvio condue ulteriori direttive del 2003 (cui vanno aggiunti i regolamenti nn.1228/2003 e 1775/2005 in materia di scambi transfrontalieri)(41) che,abrogando le direttive del 1996 e del 1998, miravano al completamen-to della liberalizzazione del mercato interno dell’elettricità (42) e del gas
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 97
(34) COM (1995) 682 def. del 13 dicembre 1995.(35) Al riguardo, si rinvia a S. CASSESE, La disciplina del mercato dell’elettricità,
in Rass. giur. ener. el., 1997, 4, p. 753 ss.(36) Direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996. (37) Direttiva 94/22/CE del 30 maggio 1994.(38) Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998.(39) Si tratta, rispettivamente, delle direttive 90/377/CEE del 29 giugno 1990
e 90/547/CEE del 29 ottobre 1990.(40) Cfr. M. ROMANO, La liberalizzazione del settore elettrico, in Rass. giur. ener.
el., 2005, p. 709 ss. La riforma, tra le altre cose, delineava i requisiti minimi di indi-pendenza delle varie Autorità di regolazione nazionali. Com’è noto, in Italia la l. n. 481del 1995 aveva istituito con largo anticipo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
(41) Tali regolamenti, concernenti gli scambi transfrontalieri di elettricità e l’accessoalle reti di trasporto del gas, costituivano la formalizzazione delle decisioni che negli anniprecedenti erano state assunte dai Fora di Firenze (nel 1998) e di Madrid (nel 1999), vale adire incontri informali sorti tra le varie Autorità di regolazione nazionali, la Commissione,i rappresentanti dei produttori, i fornitori, i gestori di mercato e i consumatori, finalizzati auno scambio periodico di informazioni con lo scopo di pervenire all’individuazione di prin-cipi e regole comuni. Al riguardo, cfr. F. DI PORTO, Il coordinamento tra autorità di regola-zione nella governance dell’energia e delle comunicazioni elettroniche a livello comunitario:spunti da una comparazione, in L. AMMANNATI e P. BILANCIA (a cura di), Governance dell’eco-nomia e integrazione europea, vol. II, Milano 2008, pp. 246-249.
(42) Direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003.
stuvvwxyz{ |wxy}y{
naturale (43), in modo da consentire agli utenti – entro il termine del1° luglio 2007 per i clienti finali – la libera scelta del proprio fornitoredi energia: in pratica, si introduceva un modello di liberalizzazione tota-le, all’ingrosso e al dettaglio. Oltre a quest’ultimo aspetto di novità, leinnovazioni più significative risiedevano: nella tutela del diritto di acces-so alla rete, nella libertà di produzione e di offerta dei servizi energetici,nonché nella garanzia della parità di trattamento dei terzi, obiettivo cheavrebbe dovuto essere perseguito attraverso il principio di separazionedelle reti (c.d. unbundling)(44). Nella seconda stagione delle liberalizza-zioni si imponeva dunque una separazione non più soltanto contabile,ma altresì legale, con la costituzione di apposite società.
Nonostante i numerosi interventi dell’Unione in materia di ener-gia, le c.d. direttive di seconda generazione raggiungevano solo in parte– e con risultati non del tutto soddisfacenti – lo scopo di velocizzare ilprocesso di liberalizzazione dei mercati energetici, tanto che si rendevanecessario elaborare un terzo pacchetto di direttive (45) (formulato nel2007, ma faticosamente approvato solo il 21 aprile 2009)(46), conl’obiettivo di rafforzare l’integrazione del mercato interno dell’energia edi migliorarne il funzionamento, anche grazie a un collegamento piùstringente tra le Autorità chiamate a controllare le varie fasi della filieraenergetica. A tal fine, è stata prevista – e poi istituita – un’Agenzia per la
98
(43) Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003.(44) Per un’analisi dei principi enunciati, compreso quello di separazione, si
rimanda al commento di N. AICARDI, Energia, cit., soprattutto p. 1038 ss.(45) Il terzo pacchetto energia si compone di cinque misure normative: regola-
mento n. 713/2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazio-nali dell’energia; direttiva 2009/72/CE, in materia di energia elettrica; direttiva2009/73/CE, in materia di gas naturale; regolamenti n. 714/2009 e n. 715/2009 inmateria di accesso alla infrastrutture di trasmissione e trasporto. Il termine per il rece-pimento delle direttive è scaduto il 3 marzo 2011 (ma, con riferimento all’unbundling,il termine ultimo è fissato al 3 marzo 2012). Per un’analisi del terzo pacchetto, si rin-via a M. BECCARELLO e F. PIRON, La regolazione del mercato del gas naturale, SoveriaMannelli, 2008, p. 35-41. Cfr. anche E. CABAU et al., EU Energy Law. The internalEnergy market. The third liberalisation package, Leuven, 2010; L. HANCHER e A. DE
HAUTECLOCQUE, Manifacturing the EU Energy markets: the current dynamics of regula-tory practice, in Tilburg University, TILEC discussion paper, January 2010(http://ssrn.com/abstract=1539901).
(46) Il pacchetto integrato di misure istitutive della politica energetica europeaè stato introdotto con la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e alParlamento europeo del 10 gennaio 2007, dal titolo Una politica energetica per l’Europa.Sul tema, cfr. A. CANEPA, La costruzione del mercato europeo dell’energia e il difficile per-corso del ‘terzo pacchetto’ legislativo, in Amministrare, 2009, 2, p. 217 ss.
~����������� ��� � ���������� ������������ (ACER)(47), il cui compito èesprimere pareri su tutte le questioni relative ai regolatori dell’energia,partecipare allo sviluppo di codici di rete nel settore dell’energia elettri-ca e del gas, decidere in merito alle infrastrutture transfrontaliere, risol-vere le controversie tra regolatori nazionali, nonché monitorare i prezzial dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale. Detta Agenzia sosti-tuirà progressivamente l’ERGEG (European Regulators Group forElectricity and Gas), organismo istituito nel 2003 dalla Commissioneeuropea e dal CEER (Council of European Energy Regulators), che fin dal2000 riunisce tutti i Regolatori dei Paesi UE (48).
Non riuscito risulta invece il tentativo di introdurre la regola dellac.d. ownership unbundling, vale a dire la separazione tra la proprietà dellarete, da lasciare all’impresa energetica e la gestione della stessa, da affi-dare invece a una società non controllata dalla medesima impresa. Taleproposta della Commissione, che ha visto la ferma opposizione di moltiStati membri (su tutti, la Francia) e, ovviamente, degli operatori diret-tamente interessati, è stata inserita nel terzo pacchetto, ma solo comeopzione possibile e non invece, come più incisivamente si sarebbe potu-to verificare, quale forma obbligatoria (49).
Certo è, ad oggi, che il settore dell’elettricità appare ancora sintroppo frammentato e, come si vedrà più avanti, tra le ragioni della
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 99
(47) Si rinvia al regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i rego-latori nazionali dell’energia. Tale Agenzia, con sede a Lubiana, è attualmente diretta daAlberto Pototschnig. Su questo tema, si rinvia a L. AMMANNATI, Il ruolo dell’Agenzia perla Cooperazione dei Regolatori dell’Energia (ACER) nella governance e nella regolazionedel settore energetico, 23 marzo 2011, in Amministrazione in cammino.
(48) L’ERGEG è stato istituito con decisione n. 2003/796 dell’11 novembre2003 (recentemente abrogata dalla Commissione con decisione 2011/280/UE del 16maggio 2011), con l’obiettivo di promuovere l’uniformazione delle regole e delle tarif-fe per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e gas. In questi anni l’ERGEG hatentato soprattutto di favorire l’armonizzazione dei codici di rete nazionali. Sul ruolodell’ERGEG, cfr. L. AMMANNATI, Tutela della concorrenza e accesso al mercato dei servi-zi pubblici locali dell’energia: il caso del gas, in ID. (a cura di), Monopolio e regolazioneproconcorrenziale, cit., p. 311 ss.
(49) Cfr. P. RANCI, Le infrastrutture energetiche: l’Italia e il mercato unico europeo,cit., 165. Recentemente, cfr. A. CANEPA, Reti europee in cammino. Regolazione dell’eco-nomia, informazione e tutela dei privati, Napoli, 2010, p. 49 ss. Occorre osservare chele direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE hanno individuato tre distinti modelli di sepa-razione delle attività di trasmissione/trasporto dalle attività di generazione/produzionee fornitura: la separazione proprietaria (OU), l’istituzione di un gestore del sistema diproduzione/trasporto indipendente (ITO), l’istituzione di un gestore di sistemi indi-pendente (ISO).
���������� �������
mancata integrazione dei vari mercati un ruolo di primo piano è assun-to dallo scarso sviluppo delle infrastrutture energetiche e degli scambitransfrontalieri (50).
3. Il doppio volto dell’energia: merce e servizio di interesse economicogenerale.
Si è sottolineato che il tema dello sviluppo delle reti energetichecorre in parallelo (anzi, si antepone, come fosse una condicio sine quanon) con quello della creazione di un mercato energetico libero e con-correnziale.
Uno degli ostacoli più rilevanti al perseguimento di quest’ultimoobiettivo è dato dal fatto che gli Stati membri continuano a conservareimportanti prerogative nel settore dell’energia. Il punto è stato più volteevidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha tenta-to di far fronte all’assenza di un quadro di riferimento strutturale suldiritto europeo dell’energia, non mancando tuttavia di rimarcare a piùriprese l’impossibilità di sindacare le scelte compiute dagli Stati membri,se connesse all’adempimento di obblighi di servizio pubblico (51).
Allo stesso tempo, proprio grazie ai giudici comunitari si è svi-luppato quell’orientamento fondato sull’applicazione ai prodottienergetici della disciplina sulla libera circolazione delle merci. Il lea-ding case è costituito dalla nota sentenza Costa c. Enel, con la qualela Corte per la prima volta ha statuito che l’energia deve essere con-siderata una merce (52), potendo dunque essa formare oggetto di
100
(50) Si rinvia alla comunicazione della Commissione al Consiglio e alParlamento europeo dell’11 marzo 2009, dal titolo Relazione sui progressi nell’istituzionedi un mercato interno del gas e dell’elettricità, COM (2009) 115 def.
(51) È quanto emerge dalle seguenti sentenze: 27 aprile 1994, causa C-393/92,Comune di Almelo, in Racc., p. I- 1477; 23 ottobre 1997, causa C-158/94, Commissionec. Italia, in Racc. p. I-5789; 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra AG c.Schleswag AG, consultabile sul sito web www.curia.europa.eu/it/content/juris/juris.htm; 14 aprile 2005, C-128 e c-129/03, AEM e a. c. Autorità per l’energia elettri-ca e il gas e a., ibid.; 7 giugno 2005, C-17/03, Vereninging voor Energie, Milieu en Water,Amsterdam Power Exchange Spotmarket, Eneco c. Directour van de Dienst uitvoering entoezicht energie e a., ibid. In dottrina, cfr. F. MUNARI, Il nuovo diritto dell’energia: il con-testo comunitario e il ruolo degli organi europei, in Dir. un. eur., 2006, 4, p. 877 ss.
(52) Corte di Giustizia, sentenza 15 luglio 1964, causa C-6/64, Costa c. Enel, inRacc. 1964, p. I-1127; sulla stessa linea, cfr. sentenza 27 aprile 1994, causa C-393/92,Comune di Almelo cit. Al riguardo, cfr. V. SOTTILI, Il mercato dell’energia elettrica nellagiurisprudenza della Corte di giustizia, in Dir. un. eur., 1998, 4, p. 927 ss. In ulteriori
��������� �� ¡¢
In tal senso, come meglio più recentemente è stato precisato dal-l’art. 3, lett. a), della direttiva 2006/32/CE, per energia si intende «qual-siasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità,gas naturale (compreso il gas naturale liquefatto) ed il gas di petrolioliquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento(compresi il teleriscaldamento ed il teleraffreddamento), carbone elignite, torba, carburante per autotrazione […] e la biomassa quale defi-nita nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettri-ca prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno del-l’elettricità».
Oltre a essere una merce, l’energia è anche un bene di particolareimportanza per l’esistenza stessa di uno Stato (54), nonché «per il fun-zionamento non solo dell’economia, ma soprattutto delle istituzioni edei servizi pubblici essenziali, e perfino la sopravvivenza della popolazio-ne» (55). Ecco allora la ragione per cui l’Unione ha ammesso che a livel-lo nazionale gli Stati membri possano adottare disposizioni di deroga alprincipio della libera circolazione dei prodotti energetici, in particolarmodo ove vengano in rilievo particolari motivi di «pubblica sicurezza»(art. 36 TFUE).
Si è appena detto che l’energia è una merce e, dunque, un bene; maessa è anche un indispensabile servizio (basti pensare alle attività di for-nitura, trasporto e distribuzione di energia) e, in quanto tale, è assogget-
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 101
occasioni la Corte di Giustizia aveva qualificato l’energia come merce. Ad es., si rinviaa: Corte di Giustizia, sentenza 19 marzo 1991, causa C-202/88, Francia c.Commissione, in Racc., p. I-1223; sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner c.Macrotron, in Racc. p. I-1979; sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, inRacc. p. I-2951; sentenza 10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci concenzionali Portodi Genova, in Racc. p. I-5889; sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, RTT, inRacc. p. I-5973; sentenza 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commissione c. Paesi Bassi,in Racc. p. I-5699; sentenza 23 ottobre 1997, causa C-158/94, Commissione c. Italiacit.; 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione c. Francia, in Racc. p. I-2925.
(53) Guardando al sistema italiano, è il caso di ricordare l’art. 624, co. 2, cod.pen., in base al quale «Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anchel’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico». Allo stessomodo, l’art. 814 cod. civ. statuisce che «Si considerano beni mobili le energie naturaliche hanno valore economico».
(54) Cfr. M. DE BELLIS, Energia elettrica (voce), in S. CASSESE (dir.), Dizionariodir. pubbl., vol. II, Milano, 2006, p. 2189.
(55) Corte di Giustizia, sentenza 10 luglio 1984, causa C-72/83, Campus Oil,punto 34, in Racc. p. I-2727.
£¤¥¦¦§¨©ª« ¬§¨©©«
tata alla disciplina dell’art. 57 TFUE, che considera come servizi «le pre-stazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non sianoregolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, deicapitali e delle persone».
Più in particolare, viene qui in rilievo la categoria dei servizi diinteresse economico generale (56) che, in quanto tali, devono sottosta-re «alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di talinorme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della spe-cifica missione loro affidata […]» (art. 106, § 2, TFUE).
Com’è noto, quando si affronta il tema dei servizi pubblici, si pren-de in considerazione una delle figure dai confini più discussi e incertinel panorama del diritto pubblico italiano ed europeo. Questi ultimi,infatti, in passato concepiti fuori dal mercato, ne sono oramai divenutiuna parte importante, anche in virtù dell’affermarsi dei principi comu-nitari di concorrenza e di libera circolazione dei servizi, tanto che da unlato le varie discipline di settore – come, appunto, il mercato dell’ener-gia elettrica e quello del gas – sono state assoggettate a radicali interven-ti di riforma, dall’altro i regimi nazionali (come quello di cui all’art. 43della Costituzione italiana) possono oramai dirsi di gran lunga superati.
Proprio il diritto comunitario, infatti, ha radicalmente trasformatoi caratteri del regime giuridico entro il quale si erano formate le tradi-zionali concezioni del servizio pubblico, ragion per cui, volendo sgom-brare il campo da ogni equivoco, qualsivoglia tentativo di rilettura eattualizzazione delle nozioni soggettiva (57) e oggettiva (58) di pubbli-co servizio sarebbe oggi inevitabilmente destinato a fallire (59).
102
(56) Recentemente, cfr. F. MERUSI, Lo schema della regolazione dei servizi di inte-resse economico generale (Relazione a Convegno su “La regolazione dei servizi di interesseeconomico generale”, Firenze, 6 novembre 2009), in Dir. amm., 2010, 2, p. 313 ss.
(57) Secondo la concezione soggettiva, è pubblico servizio ogni attività svolta dalla pub-blica amministrazione, la cui qualificazione giuridica in termini di pubblicità non può chederivare dallo Stato. Cfr. S. ROMANO, Principii di diritto amministrativo italiano, Milano,1912, p. 357; A. DEVALLES, I servizi pubblici, in Tratt. Orlando, VI, Milano, 1923, p. 377 ss.
(58) In base alla nozione oggettiva, un servizio ben può assurgere alla qualificadi pubblico tanto se gestito da soggetti pubblici, quanto da soggetti privati, purché visia una destinazione unitaria dell’attività esercitata. Su tutti, cfr. U. POTOTSCHNIG, Ipubblici servizi, Padova, 1964, p. 46 ss. L’Autore muove dall’analisi del combinatodisposto degli artt. 41, co. 3 e 43 della Costituzione, per sostenere che il servizio pub-blico oggettivo rappresenta l’attività economica indifferentemente svolta da soggettipubblici o privati, assoggettata dalla legge a programmi e controlli e volta al persegui-mento di fini sociali ordinariamente estranei alla stessa attività. Ibid., p. 154.
(59) Così G. NAPOLITANO, Servizi pubblici, in S. CASSESE (dir.), Dizionario dir.pubbl., cit., vol. VI, p. 5523.
®¯ °±±°²²³´ µ ¶³·°¶¶¸ ¹¸·ºµ¯µ»³¸¯µ¶° ¼ ¸ºµ½µ³ ³¯·µ¶¹µ ¶µ ¾ºµ¹¹³ ¿¸¯¹³À
stente nell’individuare per il servizio pubblico una definizione quantopiù sistematica possibile, nonché del tutto avulsa dal contesto storico-politico di riferimento, diversamente da quanto invece accade tuttoranei singoli ordinamenti nazionali; così che, tra le nozioni più ricorrenti,si rinvengono quelle di: servizi di interesse generale, concernenti le attivi-tà di servizio che sono ritenute di interesse generale dalle pubblicheautorità e, pertanto, sono sottoposte ad obblighi specifici di serviziopubblico; servizi di interesse economico generale, vale a dire le attività diservizio che, come l’energia, sono prestate dietro retribuzione e sonorivolte a realizzare obiettivi di interesse generale (e, a tal fine, sono sot-toposte dagli Stati membri a precise obbligazioni di servizio pubblico);servizi pubblici, espressione che individua tanto l’organismo che realizzail servizio, quanto la missione di interesse generale che deve essere per-seguita; servizi universali, che definiscono un insieme di esigenze di inte-resse generale da rispettare nell’esecuzione di attività miranti a fornireagli utenti l’accesso alle prestazioni definite essenziali.
Nell’ingarbugliato panorama nozionistico sopra delineato, né laCommissione europea, né la Corte di Giustizia sono riuscite a elabora-re una concezione univoca di servizio pubblico, il che è principalmentedovuto al fatto che si tratta di un concetto in continua evoluzione e,inoltre, al fatto che gli Stati membri conservano rilevanti spazi di sovra-nità rispetto alla determinazione dell’interesse generale da perseguire.
Posto che, come anticipato, l’energia rappresenta un esempio diservizio di interesse economico generale, va ricordato che essa costitui-sce altresì un classico modello di servizio a rete (come i trasporti ferro-viari e le telecomunicazioni), caratterizzato dalla presenza di un cicloproduttivo articolato in cinque diverse fasi (la generazione, il dispaccia-mento, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura di energia)(60),ove l’esecuzione della prestazione avviene in contemporanea su tutto il
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 103
(60) Tra le varie fasi della filiera elettrica, la generazione riguarda la produzionedi energia attraverso le centrali; il dispacciamento, invece, consente al gestore della retedi trasmettere i flussi di energia prodotti dagli impianti di generazione e smistarli nellarete ad altissima tensione; con la trasmissione, l’energia elettrica viene trasportata sulsistema interconnesso ad altissima ed alta tensione ai fini della consegna agli utentifinali o ai distributori, ma senza ricomprendere la distribuzione; la distribuzione è lafase in cui in cui l’energia elettrica viene trasportata su sistemi di distribuzioni a mediae bassa tensione per la consegna ai clienti finali, ma senza comprendere la fornitura; daultimo, la fornitura attiene alla vendita o alla consegna dell’energia elettrica ai medesi-mi clienti finali. Per una disamina delle varie fasi dell’attività, si rinvia a M. DE BELLIS,Energia elettrica, cit., pp. 2194-2196.
ÁÂÃÄÄÅÆÇÈÉ ÊÅÆÇËÇÉ
territorio nazionale e per mezzo di un sistema connesso di linee ad alta,media e bassa tensione.
Ciò premesso, l’attività di regolazione in ambito energetico diven-ta allora uno strumento imprescindibile (61): in primo luogo, per disci-plinare quella parte di servizio che si trova sostanzialmente in regime dimonopolio, cioè le reti; in secondo luogo, per garantire il rispetto dideterminati standards qualitativi, assicurare il servizio e la continuitàdello stesso, ridurre le asimmetrie informative esistenti tra imprese econsumatori, nonché infine tutelare quei soggetti che versano in condi-zioni maggiormente disagiate.
4. Le reti energetiche transeuropee: le ragioni e gli obiettivi.
Si è detto che l’energia elettrica costituisce un servizio a rete (62).Esso, in quanto tale, richiede per ovvie ragioni dei costi di installazionee di gestione infrastrutturale alquanto elevati che, nonostante l’aperturadel servizio al mercato, sono tali da costituire una pesante barriera all’in-gresso di nuovi concorrenti.
Se da un lato viene in rilievo un problema di costi, dall’altro il temadelle infrastrutture deve essere inserito nell’ambito del programma ener-getico comunitario, che impone agli Stati membri di conseguire gliambiziosi obiettivi stabiliti nel c.d. Pacchetto energia e clima del 23 gen-naio 2008, altresì denominato 20-20-20 (63), vale a dire: la riduzionedei gas ad effetto serra almeno del 20%; la riduzione dei consumi ener-getici del 20% attraverso misure di aumento dell’efficienza energetica; ilsoddisfacimento del 20% del fabbisogno energetico comunitario attra-verso l’impiego di energie rinnovabili (64).
104
(61) Come sostiene L. AMMANNATI, Governance e regolazione attraverso reti, inL. AMMANNATI e P. BILANCIA (a cura di), Governance dell’economia e integrazione euro-pea, cit., p. 185, «la regolazione è una forma particolare di governance in quanto con laregolazione si esercita una attività specifica che ha come fine principale quello di indur-re un mutamento nel comportamento dei soggetti cui è diretta».
(62) Si rinvia all’opera curata da E. FERRARI, I servizi a rete in Europa: concorrenzatra gli operatori e garanzia dei cittadini, Milano, 2000, p. 325 ss. In particolare, nel casodell’energia viene in rilievo un sistema a rete di tipo materiale e unidirezionale, poiché larete effettua un collegamento diretto tra il centro di produzione e il consumatore.
(63) Il Pacchetto, adottato il 17 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo comprendesei proposte legislative, consultabili sul sito del Parlamento europeo, www.europarl.europa.eu.
(64) Con riguardo al problema della sicurezza dell’approvvigionamento energe-tico e alla necessità di ridurre i gas serra e le altre sostanze inquinanti, si segnala la recen-
ÌÍÎÏÍÐÎ ÑÒÎÓÔÕÖÎ Ö× Ø×ÙÔ ÚÒ×ÖÍÎÛ Ü ÏÎÝÝÐÞÐÙÔ ßÎÑÏÍÔÕÖÔÍÔ ÙàÐÑá
portanza di realizzare adeguate reti energetiche, posto che, come si dice-va all’inizio, i predetti obiettivi potranno essere perseguiti solo se e nellamisura in cui la politica dell’Unione europea sulle reti si armonizzeràcon quella in materia di energia.
Per chiarezza, giova sottolineare che, quando si parla di reti elettri-che o di reti del gas (ma lo stesso dicasi per i trasporti e le telecomuni-cazioni), occorre pensare a delle vere e proprie reti fisiche, che si carat-terizzano per la presenza di infrastrutture che materialmente consento-no la fornitura dell’elettricità o del gas (65); in particolare, la rete è quel-la complessa struttura di interconnessione che pone in relazione tra loroi fornitori e gli utilizzatori del servizio e si compone di: un’infrastruttu-ra materiale (come i tubi del gasdotto, o le linee di trasporto dell’elettri-cità); un flusso che scorre lungo il tracciato, formato da materiali (comel’energia e il gas) o conoscenze codificate (es. gli impulsi elettrici); infi-ne, una centrale operativa che organizza l’infrastruttura e la circolazionedel flusso (66).
Ciò posto, volendo (in via di prima approssimazione) tentare difornire una compiuta definizione di rete transeuropea, può affermarsiche essa comprende l’insieme delle infrastrutture diffuse in modo capil-lare nei vari territori, che dovranno essere collegate per superare le bar-riere e i mercati nazionali. Il fine è creare un unico grande mercato glo-bale interconnesso (cioè, per l’appunto, collegato tra le varie reti) e inte-roperabile (vale a dire, in grado di rendere possibile la comunicazionetra i diversi sistemi), che da un lato sia in grado di consentire lo svilup-po della concorrenza nei mercati locali, dall’altro sia idoneo a tutelare ilservizio universale e gli interessi dei consumatori (67).
Come si sosteneva in premessa, la decisione n. 1364/2006/CE delParlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 ha stabilito«orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia», abrogan-do le precedenti decisioni nn. 96/391/CE e 1229/2003/CE.
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 105
te comunicazione della Commissione europea adottata l’8 marzo 2011, Piano efficien-za energetica 2011, COM (2011) 109/4.
(65) F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, cit., p. 9, distin-gue le reti fisiche da quelle virtuali (che sono le reti generate dal convergere di compu-ter, mass media e telecomunicazioni) e istituzionali (che mettono in collegamento uninsieme di persone e mezzi per il raggiungimento di obiettivi condivisi, come ad esem-pio accade nei fora).
(66) Ibid., p. 110.(67) Sul tema, cfr. E. CARDI, Mercati e istituzioni in Italia. Diritto pubblico del-
l’economia, Torino, 2009, p. 196.
âãäååæçèéê ëæçèìèê
Uno dei fini dell’atto in esame è consentire che, in linea con lenorme comunitarie in tema di completamento del mercato interno nelsettore energetico, anche la costruzione e la manutenzione delle infra-strutture energetiche possa essere aperta alla libera concorrenza tra glioperatori di mercato, pur ammettendo, in casi eccezionali (e ove vi sianodelle sufficienti motivazioni), l’intervento del contributo finanziariodell’Unione per la realizzazione e la conservazione delle infrastrutture dequibus. Queste ultime, infatti, devono essere costruite e mantenute «inmodo tale da consentire il buon funzionamento del mercato internodell’energia, rispettando le procedure di consultazione delle popolazio-ni interessate, tenendo conto al contempo di considerazioni strategicheed, eventualmente, di servizio universale nonché di obblighi di serviziopubblico» (68).
Un’altra ragione che si pone a sostegno dell’opportunità di crearedelle reti transeuropee nel settore dell’energia deriva dalla necessità didiversificare le forniture energetiche dell’Unione, incorporando le retidei nuovi Stati membri e dei Paesi in fase di adesione, così da assicura-re un funzionamento coordinato delle medesime. Tutto ciò, tra l’altro,risponde al principio solidaristico (69) di cui all’art. 194 TFUE, criteriogenerale del diritto dell’Unione europea e, allo stesso tempo, principio– per così dire – supremo in materia energetica, dato che impone agliStati membri una leale cooperazione per il raggiungimento dell’obietti-vo della sicurezza energetica, prevedendo altresì in capo agli stessi l’ob-bligo di coadiuvare quei Paesi che abbiano subito una grave interruzio-ne dell’approvvigionamento energetico (70).
Poc’anzi si parlava del carattere di eccezionalità che riveste l’inter-vento finanziario dell’Unione. Occorre al riguardo osservare che il bilan-cio assegnato alle RTE-E (71) viene di regola destinato a studi di fatti-bilità, anche se vi sono ulteriori strumenti comunitari (come i fondistrutturali, o i programmi e gli strumenti finanziari dell’Unione) chepossono intervenire per cofinanziare gli investimenti. Detto sostegnofinanziario, tuttavia, non deve provocare alterazioni nella concorrenza,
106
(68) Decisione 1364/2006/CE, cit., n. 5 Premessa.(69) Sul principio di solidarietà nelle politiche europee, cfr. G. P. MANZELLA, Le
prospettive della politica di coesione europea: tra approfondimento e globalizzazione, in Riv.giur. Mezzogiorno, 2010, 1, p. 43 ss.
(70) La direttiva 2004/67/CE stabilisce agli artt. 2 e 8 che l’Unione è chiamataa intervenire quando si verifichi un’interruzione che influisca su oltre il 20% delle for-niture, oppure nei casi in cui vi siano situazioni di portata tale da non poter essere ade-guatamente gestite per mezzo di interventi di carattere nazionale.
(71) Si tratta, annualmente, di circa 20 milioni di euro.
íîïð ñòó ôõ ö÷ôøñôöôð ùðøíîúóøïîõó ÷ôúîøó ûüóõõð ýóñðøíð ñüô ïîøïð õî
costruzione, quanto la manutenzione delle infrastrutture energetichedevono essere sottoposte alle leggi del mercato (72).
I casi eccezionali in cui l’Unione può fornire il proprio contributoriguardano, in particolare, tre diverse categorie di progetti infrastruttu-rali:
Progetti di interesse comune (73): trattasi di progetti caratterizzati dauna prospettiva di redditività economica, per valutare la quale è neces-sario procedere a un’analisi del rapporto tra costi e benefici rispetto allatutela dell’ambiente, alla sicurezza degli approvvigionamenti e, ovvia-mente, alla coesione territoriale, che è uno degli obiettivi cardine del-l’azione comunitaria. L’elenco di tali progetti è riportato negli allegati IIe III della decisione.
Progetti prioritari (74): costituiscono una parte dei progetti di inte-resse comune e sono particolarmente importanti per il funzionamentoconcorrenziale del mercato interno dell’energia, per la sicurezza degliapprovvigionamenti e per la valorizzazione delle energie rinnovabili.Questi ultimi, riportati nell’allegato I della decisione, sono privilegiatiin sede di assegnazione del sostegno finanziario dell’Unione.
Progetti di interesse europeo (75): tra i progetti prioritari, quellidichiarati di interesse europeo assumono la maggiore rilevanza. In par-ticolare, sono i progetti di natura transfrontaliera, ovvero quelli chehanno un impatto significativo sulla capacità di trasmissione transfron-taliera. Anch’essi sono contenuti nell’allegato I del richiamato atto.
Per meglio comprendere la portata dell’azione dell’Unione, pareopportuno, a tal proposito, svolgere alcuni esempi concreti, proprio apartire dal richiamato allegato I della decisione n. 1364/2006/CE, checontiene un elenco degli assi dei progetti prioritari, compresi quelli diinteresse europeo. Tra questi, per ciò che concerne le reti di elettricità,può ad esempio ricordarsi il progetto che riguarda l’aumento della capa-
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 107
(72) I principi generali per la concessione di un contributo finanziariodell’Unione nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia sono stabilitidal regolamento n. 680/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno2007.
(73) Come si dispone all’art. 6, § 3 della richiamata decisione, «Solo i progettielencati nell’allegato III che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e nell’allegato IIsono ammissibili al contributo finanziario della Comunità di cui al regolamento (CE)n. 2236/95».
(74) Così, ancora, l’art. 6, § 3 e 4.(75) Si rinvia all’art. 8, decisione cit.(76) A questo proposito, sono ad esempio considerati progetti di interesse euro-
þÿ�������� �������
cità di interconnessione elettrica da effettuarsi sulle frontiere che sepa-rano l’Italia dalla Francia, dall’Austria, dalla Slovenia e dalla Svizzera(76); il potenziamento delle reti elettriche necessarie per risolvere la con-gestione del flusso di elettricità negli Stati del Benelux; l’aumento dellecapacità di interconnessione elettrica tra Francia, Spagna e Portogallo,nonché lo sviluppo della rete nelle regioni insulari; la costruzione del-l’infrastruttura elettrica necessaria per collegare la Grecia al sistemaeuropeo e per consentire la realizzazione di un mercato dell’elettricitànell’Europa sud-orientale. Ancora, pare opportuno segnalare i progetticoncernenti l’incremento delle capacità di interconnessione elettrica: traRegno Unito ed Europa centro-settentrionale; tra Regno Unito eIrlanda; tra Danimarca, Germania e il circuito dei Baltico (77); traGermania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria eSlovenia; tra gli Stati membri mediterranei e il circuito elettrico delMediterraneo (cioè, i Paesi nord-africani e la Turchia)(78).
Per quanto invece concerne le reti del gas, vengono in rilievo: i pro-getti rivolti alla creazione di gasdotti, al fine di collegare alcune delleprincipali fonti di fornitura di gas naturale in Europa e migliorare l’in-teroperabilità delle reti e la sicurezza dell’approvvigionamento (compre-si i gasdotti che collegano per via marittima e per via terrestre la Russiaall’Unione), nonché aumentare la capacità della rete in Germania,Danimarca e Svezia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria;quelli miranti alla costruzione di nuovi gasdotti per il trasporto di gasnaturale dall’Africa settentrionale ai Paesi mediterranei (79), con l’au-mento della capacità delle reti degli stessi Stati membri citati; ancora, iprogetti finalizzati alla costruzione di nuove reti di gasdotti che colleghi-no l’Unione europea a nuove fonti, attraverso i Balcani occidentali.
A tale proposito, non si può fare a meno di ricordare il progettoPoseidon, cioè il gasdotto di collegamento tra la Grecia e l’Italia, il quale,a partire dal 2015, consentirà di importare – dall’area del Mar Caspio edal Medio Oriente – oltre 8 miliardi di metri cubi di gas naturale all’an-no, così contribuendo alla diversificazione dell’approvvigionamentoenergetico europeo. Inoltre, vale la pena di segnalare il progetto
108
peo quelli che riguardano la Linea Venezia Nord – Cordignano, o l’interconnessione darealizzarsi tra Austria e Italia attraverso il tunnel ferroviario del Brennero.
(77) Il c.d. circuito del Baltico comprende Norvegia, Svezia, Finlandia,Danimarca, Germania, Polonia, Stati baltici e Russia.
(78) Per quel che riguarda l’Italia, si segnala il progetto per la connessione elet-trica con la Tunisia.
(79) Si pensi ad esempio al gasdotto di collegamento tra Libia e Italia.
1����, rivolto alla realizzazione di un nuovo canale di importazionedel gas naturale proveniente dal Caucaso, dal Mar Caspio e, potenzial-mente, anche dal Medio Oriente. Il gasdotto, per il quale sono statistanziati circa 200 milioni di euro, collegherà la Turchia all’Austria.
Ciò premesso, la decisione del 2006 non si limita a porre un elen-co dei progetti prioritari in materia di reti, ma sviluppa altresì nel det-taglio una serie di criteri supplementari per l’identificazione dei proget-ti di interesse comune di cui all’art. 6, § 2, del citato atto comunitario.Così, l’allegato II si preoccupa di salvaguardare quei Paesi che si trova-no, per posizione geografica, in una situazione di svantaggio, promuo-vendo lo sviluppo delle reti elettriche «nelle regioni insulari, isolate,periferiche e ultraperiferiche», attraverso la diversificazione delle fonti dienergia e il maggiore ricorso all’energia rinnovabile; inoltre, si ponel’obiettivo di sviluppare le connessioni elettriche tra gli Stati membri pergarantire l’affidabilità e la sicurezza delle reti energetiche, nonchè la con-nessione delle fonti energetiche rinnovabili e lo sviluppo delle connes-sioni elettriche con i Paesi terzi, in modo da migliorare l’approvvigiona-mento di elettricità nell’Unione europea.
Analoghi obiettivi vengono posti in evidenza con riferimento al gasnaturale, per il quale il problema principale riguarda lo sviluppo dellecapacità recettive del gas naturale liquefatto (Gnl)(80) e la diversificazio-ne delle fonti e dei percorsi di approvigionamento.
Sulla base dei criteri indicati nell’allegato II, il successivo allegatoIII contiene un ulteriore elenco di progetti di interesse comune. Per quelche riguarda l’Italia, giova menzionare i progetti più significativi: i Cavisottomarini Sardegna – Italia continentale (81), Corsica – Italia e Africasettentrionale – Italia; una nuova interconnessione con la Francia,l’Austria e la Slovenia; la connessione elettrica sottomarina e un gasdot-
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 109
(80) Il gas naturale liquefatto (Gnl) è una miscela di idrocarburi composta prin-cipalmente da metano (all’80-90%). La sua filiera si articola in quattro fasi: esplorazio-ne e produzione; liquefazione; trasporto; rigassificazione. A differenza del gas naturale,che può raggiungere il mercato di destinazione sfruttando il sistema dei gasdotti, il Gnlviene trasportato in navi metaniere e il Paese importatore deve essere dotato di sistemidi rigassificazione (che consentono al gas liquefatto di riassumere la forma gassosa). Ilproblema del Gnl è dato dagli elevati costi di trasporto, che si ripercuotono sul prezzofinale del prodotto. Al riguardo, un’ampia analisi sul Gnl è svolta da C. STAGNARO (acura di), Il mercato del gas naturale. L’Europa tra sicurezza e liberalizzazioni, SoveriaMannelli, 2009, soprattutto pp. 75-112.
(81) L’interconnessione di collegamento tra Sardegna e Penisola italiana entreràa regime nel 2012. Così segnala l’Autorità per l’energia elettrica e il gas nel Piano stra-tegico triennale 2011-2013, consultabile sul sito dell’Authority, www.autorita.energia.it.
��������� �������
to tra Malta e la Sicilia; un nuovo gasdotto di interconnessione Italia –Grecia; il rafforzamento delle capacità di trasporto del gas tra Francia eItalia; lo sviluppo del gas naturale liquefatto sulle coste adriatica, ionica,tirrenica e ligure; diversi gasdotti per il passaggio in Italia delle risorselibiche, di quelle russe e del mar Caspio.
I progetti sopra elencati mirano da un lato a favorire «l’intercon-nessione, l’interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee del-l’energia, nonché l’accesso a queste reti» (82); dall’altro, a raggiungere iseguenti scopi, individuati dall’art. 3 della decisione in questione:
a) favorire la realizzazione e lo sviluppo del mercato interno ingenerale e, in particolare, del mercato interno dell’energia, incoraggian-do la produzione, il trasporto, la distribuzione e l’uso razionale dellerisorse energetiche, nonché lo sviluppo e la connessione delle risorseenergetiche rinnovabili, al fine di ridurre i costi dell’energia per i consu-matori e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;
b) facilitare lo sviluppo delle regioni meno favorite e insularidell’Unione, contrastandone l’isolamento e contribuendo così al raffor-zamento della coesione economica e sociale;
c) aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico,attraverso l’approfondimento delle relazioni con i Paesi terzi in materiadi energia, in particolare nel quadro del Trattato sulla Carta dell’energiae degli accordi di cooperazione conclusi dall’Unione;
d) contribuire allo sviluppo sostenibile e alla protezione ambienta-le, facendo ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e riducendo i rischiambientali associati al trasporto e alla trasmissione di energia.
Premesso tale quadro, la decisione in esame ribadisce l’importanzadi accelerare e agevolare la realizzazione dei suddetti progetti, in parti-colare quelli di interesse europeo (vale a dire, i progetti transfrontalie-ri)(83). A tal fine, gli Stati membri devono adottare i provvedimentinecessari per evitare ogni ritardo (in particolare, dal punto di vista delleprocedure di autorizzazione) e sempre nell’osservanza della normativaambientale. Anche gli Stati terzi possono favorire la realizzazione deiprogetti che interessano il loro territorio, purchè vengano osservate ledisposizioni del Trattato sulla Carta dell’energia.
Un ulteriore aspetto degno di nota è dato dalla figura del coordi-natore europeo, che interviene quando un progetto di interesse europeosubisca ritardi significativi o incontri particolari difficoltà di realizzazio-
110
(82) Si rinvia all’art. 3 della decisione cit. (83) Così si dispone all’art. 7, § 3, decisione cit.
�� ����� � !"#$%&'("#�) $"(� '#*"�' &'+,�%$"#%' -" %( &'+!%$' .% +'�%/
torare il progetto e di facilitare il coordinamento tra i vari soggetti chepartecipano alla realizzazione della tratta transfrontaliera della rete (85).Esso può inoltre intervenire su altri progetti di RTE-E, previa richiestadegli Stati membri interessati. Infine, il coordinatore europeo rivestenotevole importanza in relazione alla possibilità di favorire il raggiungi-mento di soluzioni di compromesso tra le parti coinvolte, tenendoconto delle richieste delle popolazioni locali, nonché nel rispetto degliobiettivi della sicurezza dell’approvvigionamento e degli standards ditutela ambientale.
5. Gli ulteriori sviluppi in materia di reti energetiche.
Un significativo input alla definizione di una strategia comune inmateria di reti energetiche transeuropee è provenuto dalla comunicazio-ne della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 gen-naio 2007, dal titolo Piano di interconnessione prioritario (PIP).
Com’è noto, presupposto imprescindibile per il buon funziona-mento della concorrenza e per la costruzione di un mercato interno del-l’energia è che si vengano a creare le condizioni per il trasporto di elet-tricità e gas tra mercati che generalmente sono organizzati su base nazio-nale. Ciò è possibile soltanto attraverso la predisposizione di intercon-nettori di rete e, dunque, mediante delle infrastrutture energetichenuove, in grado di perseguire gli obiettivi della sostenibilità (attraversol’energia elettrica prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili), dellacompetitività (un adeguato rendimento delle infrastrutture energeticheè in grado di prevenire il crearsi di posizioni dominanti) e della sicurez-za dell’approvvigionamento (86).
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 111
(84) Per fare alcuni esempi, nel settembre 2007 sono stati nominati quattrocoordinatori europei per la realizzazione di taluni progetti di particolare complessità: ilprof. Monti per l’interconnettore Spagna-Francia; il prof. Mielczarski per la connessio-ne elettrica polacco-lituana; il Sig. Adamowitsch per la rete di turbine eoliche offshorenel Mare del Nord e nel Mar Baltico; il Sig. Van Aartsen per il corridoio meridionaleper il transito del gas.
È possibile consultare le relazioni dei richiamati coordinatori europei al seguen-te indirizzo web: http://ec.europa.eu/ten/energy/coordinators/index_en.htm.
(85) Art. 10 decisione cit.(86) Il problema della sicurezza energetica è sorto all’indomani della seconda
guerra mondiale, con il passaggio dallo sfruttamento del carbone al petrolio, che hareso indispensabile importare l’approvvigionamento da Paesi terzi. Prima di allora,
0234456789 :567;79
Su quest’ultimo versante, occorre osservare che la sicurezza dellerete elettrica è tanto più garantita, quanto più sono sviluppate le capa-cità di interconnessione tra le infrastrutture energetiche poste al confi-ne tra i vari Stati membri (87). Inoltre, volendo fare un esempio concre-to di misure adottate dall’Unione europea a tutela delle reti, è interes-sante constatare che nel 2008 è stata approvata, sulla base dell’art. 308TCE (oggi art. 352 TFUE), la direttiva 2008/114/CE per la protezionedelle infrastrutture critiche in caso di attacchi terroristici (88).
Proprio con riferimento al settore energetico, quest’ultimo attoidentifica le infrastrutture critiche europee (89) maggiormente esposteal rischio di attentati terroristici, in relazione alle quali è necessario pre-disporre degli appositi piani di sicurezza, vale a dire: le infrastrutture egli impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica perla fornitura di elettricità; la produzione, la raffinazione, il trattamento,lo stoccaggio e il trasporto di petrolio e di gas attraverso oleodotti; i ter-minali Gnl (90).
Ciò posto, si è detto che l’Unione europea ha elaborato una seriedi politiche – tuttora in progress – finalizzate allo sviluppo di infrastrut-ture energetiche efficaci. Si fa riferimento: alle direttive 2005/89/CE e2004/67/CE, rivolte a individuare delle regole specifiche, al fine digarantire un livello adeguato di interconnessione elettrica e di approv-viggionamento di gas tra gli Stati membri; alla più volte richiamata deci-
112
invece, l’Europa era produttrice di risorse energetiche, basando la propria produzioneindustriale sulle riserve di carbone. Per approfondire, cfr. S. HAGHIGHI, Energy securi-ty. The external legal relations of the European Union with major oil and gas supplyingcountries, Oxford-Portland, 2007, soprattutto p. 38 ss.
(87) Al riguardo, si rinvia alla comunicazione della Commissione al Parlamentoe al Consiglio del 10 dicembre 2003, Infrastruttura energetica e sicurezza dell’approvvi-gionamento, COM (2003) 743 def.
(88) Si tratta della direttiva 2008/114/CE del Consiglio dell’8 dicembre 2008,relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e allavalutazione della necessità di migliorarne la protezione.
(89) L’art. 2, lett. a), della citata direttiva qualifica infrastruttura critica «un ele-mento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per ilmantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benes-sere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzioneavrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell’impossibilità dimantenere tali funzioni». L’infrastruttura critica europea (o ECI) è «un’infrastruttura cri-tica ubicata negli Stati membri il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe unsignificativo impatto su almeno due Stati membri. La rilevanza dell’impatto è valutatain termini intersettoriali. Sono compresi gli effetti derivanti da dipendenze intersetto-riali in relazione ad altri tipi di infrastrutture».
(90) Si rinvia all’allegato I della citata direttiva.
<=>?@ A@B CDDEF GH@ HI =?A=J=AKIL> MNO PQ>R@LL= A= =?L@Q@<<@ G>SK?@
(alcuni dei quali sono stati menzionati nel paragrafo precedente); infi-ne, alla necessità, sottolineata a più riprese dal Consiglio europeo, direalizzare un mercato interno dell’energia interconnesso, trasparente enon discriminatorio, con norme armonizzate, nonché di sviluppare lacooperazione per affrontare le emergenze, in particolare nel caso diinterruzione dell’approvvigionamento.
Il principale problema è che a tutt’oggi la creazione delle reti tran-seuropee risulta insufficiente e ciò è dovuto da un lato alla mancata valo-rizzazione delle reti private, dall’altro all’assenza dei necessari investi-menti, con la conseguenza che gli operatori sono disincentivati a svilup-pare interconnessioni con altre reti e, così, a esporsi alla concorrenza dinuovi soggetti produttori o fornitori. Il risultato è che le reti attualmen-te disponibili vengono utilizzate ben oltre i limiti consentiti (tanto daessere sature), il prezzo dell’energia continua ad aumentare e cresce altre-sì il rischio che vi siano interruzioni temporanee dell’approvvigiona-mento (91).
Il richiamato Piano di interconnessione prioritario (PIP) illustra lostato di avanzamento dei quarantadue progetti dichiarati di interesseeuropeo negli orientamenti sulle reti transeuropee dell’energia. A causadei ritardi accumulati, non emergono risultati ancora soddisfacenti,principalmente per via della complessità dei progetti de quibus (i quali,ovviamente, devono rispettare diversi vincoli in materia ambientale oltrea tutta una serie di limiti posti a tutela della salute pubblica)(92), alledifficoltà di finanziamento (93) e all’assenza di procedure armonizzate.
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 113
(91) Si ricorda, peraltro, che ancora oggi diverse regioni continuano a essere delle“isole energetiche” (ad esempio, gli Stati baltici), in quanto poco interconnesse con ilresto del mercato interno. Sotto il profilo del rischio di interruzioni nell’approvvigiona-mento energetico, si pensi al blackout del 4 novembre 2006, verificatosi a causa di un gua-sto sulla rete tedesca ad alta tensione, che ha coinvolto ben otto Paesi comunitari; o, anco-ra, a quello occorso in Italia nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2003, che per molte oreha paralizzato l’intero sistema elettrico nazionale. Un’analisi del c.d. decreto anti-blackout(d. l. 29 agosto 2003, n. 239, recante Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delsistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) è contenuta nel-l’opera di F. DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, cit., pp. 182-186.
(92) Un’analisi del rapporto tra politiche energetiche e diritto alla tutela dellasalute è svolta da M. CAMPAGNA, Energia, salute e ambiente: dove opera la contiguità, inC. BUZZACCHI (a cura di), Il prisma energia, cit., p. 129 ss.
(93) Per far fronte alle esigenze stabilite negli orientamenti RTE-E, nella richiama-ta comunicazione del 2007 si afferma che entro il 2013 l’Unione dovrà investire almeno30 miliardi di euro per interventi infrastrutturali (6 miliardi per il trasporto di elettricità,19 miliardi per i gasdotti e 5 miliardi per i terminali di gas naturale liquefatto).
TUVWWXYZ[\ ]XYZ^Z\
Per tali ragioni, con il PIP la Commissione ha messo a punto cin-que azioni prioritarie per la creazione di un ambiente favorevole agliinvestimenti:
a) l’individuazione dei progetti ritenuti fondamentali per il com-pletamento del mercato interno, l’integrazione nel mercato delle fontienergetiche rinnovabili e il miglioramento della sicurezza dell’approvvi-gionamento (94);
b) la nomina dei coordinatori europei per la realizzazione di deter-minati progetti prioritari;
c) la pianificazione delle reti in funzione delle esigenze dei consu-matori, grazie a un approccio di tipo regionale;
d) la semplificazione delle procedure di autorizzazione, che ostaco-lano considerevolmente lo sviluppo delle infrastrutture. In particolare,si è pensato di imporre agli Stati membri, nel rispetto del principio disussidiarietà, di istituire procedimenti nazionali in virtù dei quali la pia-nificazione e l’approvazione dei progetti di interesse europeo venganodefiniti entro un termine massimo di cinque anni;
e) infine, l’istituzione di un quadro di riferimento chiaro per gliinvestimenti, valutando l’opportunità di incrementare il finanziamentodelle reti RTE-E.
Qualora il Piano di interconnessione prioritario dovesse trovarepiena attuazione, allora verrebbero a sussistere tutte le condizioni per lacreazione di un effettivo mercato unico dell’energia, in grado di assicu-rare tanto l’approvvigionamento esterno, quanto gli scambi interni,prevenendo i rischi di interruzione delle forniture, tutelando le regionipiù isolate e garantendo prezzi accettabili per tutte le categorie di con-sumatori.
In caso contrario, invece, come afferma la Commissione, l’Unioneeuropea «non sarà in grado di istituire un vero e proprio mercato unico.Non potrà neanche integrare la necessaria produzione aggiuntiva di elettri-cità proveniente da fonti rinnovabili. Continuerà a pagare prezzi più eleva-ti dovuti alla congestione e a mantenere delle capacità non adeguate in cia-scuna delle aree energetiche non sufficientemente interconnesse» (95).
Un ulteriore passo in avanti nel tentativo di accelerare la realizza-zione delle reti di distribuzione dell’energia (che, lo si ribadisce, rappre-sentano il vero momento di snodo della politica energetica comunitaria)
114
(94) Uno di questi è il progetto riguardante le linee di collegamento tra Slovenia eItalia, che oggi sono ritenute eccessivamente sovraccariche (e, dunque, a rischio blackout).
(95) Si rinvia alle conclusioni della citata comunicazione COM (2006) 846 def.del 10 gennaio 2007.
_ `abac dcefghac dci gj kglmc nompo giagacjbac Verso una rete energeticaeuropea sicura, sostenibile e competitiva (96).
Attraverso tale atto, la Commissione ha fatto il punto sul quadrodei principi da seguire per un adeguato sviluppo delle reti di distribu-zione dell’energia in Europa, tenendo conto dei richiamati obiettivi cli-matici ed energetici fissati nel 2008 e meglio conosciuti come Progetto20-20-20 (97).
Il primo obiettivo consiste nel riuscire a collegare adeguatamentetutti gli Stati membri dell’Unione europea, in modo che gli stessi possa-no beneficiare pienamente del mercato interno dell’energia; ma, allostesso tempo, attraverso la creazione di un numero maggiore di collega-menti regionali, è essenziale assicurare che tutto il territorio comunita-rio sia in grado di beneficiare delle nuove fonti energetiche, come l’ener-gia eolica offshore (98), o l’energia solare fotovoltaica; inoltre, non menoimpellente appare la necessità di modernizzare la rete energetica, anchein virtù del fatto che alcune delle principali condutture risultano sovrau-tilizzate, con la connessa questione della sicurezza nelle importazioni.
Lo stretto nesso tra la realizzazione del mercato interno dell’ener-gia e il sistema delle infrastrutture energetiche risulta ancor più eviden-te se si sottolinea che, una volta attuato il terzo pacchetto sull’energia,sarà possibile individuare compiutamente le interconnessioni indispen-sabili. Nel frattempo, la Commissione ha inteso modificare gli orienta-menti per le TEN-E secondo i seguenti principi (99):
a) gli obiettivi delle reti transeuropee devono essere in linea con lapolitica energetica europea, alla luce degli obiettivi 20-20-20, nonchédei fini della sicurezza dell’approvvigionamento, della solidarietà, dellasostenibilità e della concorrenza;
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 115
(96) COM (2008) 782 def.(97) Rispetto allo stato di avanzamento del progetto in questione, con comuni-
cazione del 31.01.2011, COM (2011) 31 fin., dal titolo Renewable Energy: Progressingtowards the 2020 target, la Commissione ha chiesto agli Stati membri un maggiore dia-logo allo scopo di accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili. A tal fine, essa haindicato la necessità di implementare i singoli piani d’azione nazionali, con l’elabora-zione di forme di finanziamento il più possibile convenienti e chiare per gli investito-ri, nonché con l’obiettivo di raddoppiare gli investimenti.
(98) In tema di energia eolica offshore, si rinvia alla comunicazione dellaCommissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e socialeeuropeo e al Comitato delle regioni, del 13 novembre 2008, intitolata Energia eolica off-shore: interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi della politica energetica per il2020 e oltre, COM (2008) 768 def.
(99) Si fa sempre riferimento al richiamato Libro verde del 13.11.2008.
qrsttuvwxy zuvw{wy
b) il campo di applicazione delle TEN-E deve riguardare l’interarete di trasporto dell’energia;
c) la pianificazione delle reti dovrebbe provenire dal mercato,demandando all’Unione un ruolo attivo di mediazione;
d) occorre contenere il numero dei progetti prioritari in linea con ilcitato Piano di interconnessione prioritario, attribuendo la precedenza aiprogetti transfrontalieri, a quelli destinati a collegare gli Stati membriisolati alla rete europea, o a quelli che interessano più Paesi membri;
e) bisogna elaborare delle misure di accompagnamento per la diffu-sione di best practices e per la rimozione delle asimmetrie informativeriguardanti detti progetti (100);
f ) in casi eccezionali, è opportuno nominare dei coordinatori europei;g) infine, bisogna stanziare un numero maggiore di risorse, aumen-
tando il bilancio TEN-E.Il quadro delineato mostra chiaramente che, in assenza di reti
nuove e potenziate, l’Unione europea difficilmente raggiungerà gliobiettivi fissati per il clima e l’energia. Per questa ragione, la stessaCommissione ha proposto di sostituire l’attuale strumento TEN-E conun nuovo mezzo che possa meglio garantire la sicurezza degli approvvi-gionamenti e lo sviluppo delle infrastrutture energetiche, allo scopo dicompletare il mercato interno dell’energia, osservare il perseguimentodegli obiettivi comunitari in materia di rinnovabili e, infine, assicurarela continuità e la sicurezza delle forniture energetiche, grazie alla realiz-zazione di taluni progetti infrastrutturali ritenuti cruciali per il futuroenergetico dell’Unione (101).
116
(100) A proposito dell’opportunità di creare delle strategie finalizzate alla rimozio-ne delle asimmetrie informative tra soggetti regolatori e regolati, tra soggetti pubblici,nonché tra questi ultimi e i soggetti privati, pare interessante lo studio realizzato da R.H.THALER e C.R. SUNSTEIN, Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness”,New Haven, 2008 (trad. it. di A. OLIVERI, Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia permigliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, Milano, 2009). Gli Autori definisco-no figurativamente nudge l’insieme di strategie, basate prevalentemente sull’informazio-ne, che i pubblici poteri possono mettere in pratica per promuovere determinati compor-tamenti ritenuti desiderabili: tra queste, lo sviluppo di campagne informative in materiaenergetica può certamente contribuire alla creazione di un insieme di strumenti rivoltialla gestione della sostenibilità e alla diffusione di pratiche socialmente responsabili. Sipensi, ad esempio, alle campagne informative che erano state previste dall’art. 32 del d.lgs. n. 31 del 2010 in materia di produzione di energia elettronucleare. A quest’ultimoproposito, cfr. L. AMMANNATI e M. DE FOCATIIS, Un nuovo diritto per il nucleare. Unaprima lettura del d. lgs. 31/2010, in www.astrid-online.it, 2010.
(101) Si segnalano i progetti individuati nel Libro verde come indispensabili: unpiano baltico di interconnessione, al fine di collegare i mercati energetici europei rima-
|} ~������ ����} ����}�}�� ���� ������ }� ���� ��� �}���~��������
dei richiamati obiettivi di competitività, sostenibilità e sicurezza degliapprovvigionamenti, la stessa Commissione, con comunicazione del 17novembre 2010, dal titolo Energy Infrastructure priorities for 2020 andbeyond – A blueprint for an integrated European network, ha ulteriormen-te declinato le priorità per operare nuovi investimenti nelle infrastruttu-re energetiche, definendo un numero limitato di “corridoi europei”(102) che occorre sviluppare per rafforzare le interconnessioni tran-sfrontaliere e integrando le energie rinnovabili nella rete.
6. Il contesto italiano: cenni.
Com’è noto, in attuazione dell’art. 43 della Costituzione, la l. 6dicembre 1962, n. 1643 ha disposto la riserva originaria della produzio-ne, del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica, istituendol’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Enel)(103). A quest’ultimo eraaffidato il compito di pervenire «all’utilizzazione coordinata e al poten-ziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi digestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità eprezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del paese»
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 117
sti ancora isolati; un nuovo corridoio meridionale per il gas; lo sviluppo del GNL; unamaggiore connessione tra Mediterraneo e Africa; dei piani di interconnessioni di gas edelettricità lungo l’asse nord-sud dell’Europa centrale e sudorientale; una guida orienta-tiva per la costruzione di una rete offshore nel mare del Nord.
(102) Nel settore dell’energia elettrica sono stati individuati quattro corridoieuropei prioritari: una griglia offshore nei mari del Nord e un collegamento all’Europasettentrionale e centrale; interconnessioni nell’Europa sudoccidentale per trasportarel’energia prodotta da impianti eolici, solari e idroelettrici verso il resto del continente;collegamenti nell’Europa centrale, orientale e meridionale a rafforzamento della reteregionale; integrazione del mercato baltico dell’energia con il mercato europeo. Nel set-tore del gas sono stati individuati tre corridoi europei prioritari: il corridoio meridio-nale per il trasporto di gas dal mar Caspio all’Europa per diversificare le fonti; l’inte-grazione del mercato baltico dell’energia e il collegamento con l’Europa centrale e sud-orientale; un corridoio nord-sud nell’Europa occidentale, per consentire di sfruttare almeglio eventuali forniture esterne.
(103) Per un approfondimento sul processo di nazionalizzazione elettrica, si rin-via ai numerosi scritti menzionati nel Repertorio di dottrina sull’Enel, a cura di V. ROSSI,in Rass. giur. Enel, 1983, p. 63; allo stesso modo, cfr. l’analogo repertorio a cura di T.LA MONACA, in Rass. giur. en. elettr., 1989, p. 901. Sul quadro normativo in materia dienergia elettrica prima della nazionalizzazione, si rinvia a G. GUARINO, Unità ed auto-nomia del diritto dell’energia, in ID., Scritti di diritto pubblico dell’economia, prima serie,Milano, 1962, p. 221 ss.
���������� �������
(104). Nonostante il processo di nazionalizzazione elettrica, venivanomantenute in vita le imprese di piccola dimensione e quelle degli auto-produttori (cioè, «le imprese che producano energia destinata ai proprifabbisogni, in relazione ad un diverso ciclo industriale»)(105), mentrealle imprese appartenenti agli enti locali (che esercitavano attività elet-triche attraverso aziende speciali) veniva concesso di continuare ad ope-rare, sia pure come concessionarie dell’Enel (106).
Soprattutto con la crisi petrolifera del 1973, ma ancor più in segui-to all’abbandono del nucleare (nel 1987), l’originario rigore impostodalla citata legge del 1962 si andava via via attenuando, così ridimensio-nando la posizione di assoluta supremazia dell’Enel (107) e riducendoquell’atteggiamento di chiusura nei confronti degli altri soggetti cheaveva caratterizzato gli anni ’60. Così, dopo che già la l. 29 maggio1982, n. 308 aveva aperto all’ingresso nel mercato energetico di nuoveimprese, con le l. 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10 avveniva una sostanzialeliberalizzazione della produzione energetica da fonti rinnovabili (108).Con l. 8 agosto 1992, n. 359, seguiva la trasformazione di Enel in socie-tà per azioni. La progressiva privatizzazione dell’Ente Nazionale perl’Energia Elettrica veniva accompagnata dalla liberalizzazione del setto-re, avviata con d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. Decreto Bersani), poipiù volte modificato, soprattutto con l. 23 agosto 2004, n. 239, per viadella spinta comunitaria verso la costruzione del mercato interno del-l’energia elettrica (109). Il mercato al dettaglio è libero dal luglio 2007.
Da ultimo, la l. 4 giugno 2010, n. 96, recante Disposizioni perl’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alleComunità europee (110), ha dato avvio al processo di recepimento, nel-l’ordinamento interno, di talune importanti direttive relative ai settorienergetici. In particolare, si tratta di alcuni dei citati provvedimenti rela-
118
(104) Art. 1, co. 3, l. n. 1643 del 1962.(105) G. GENTILE e P. GONNELLI, Manuale di diritto dell’energia, cit., p. 107.(106) Per un quadro generale, cfr. S. CASSESE, La nuova costituzione economica,
Roma-Bari, 2007, pp. 143-150. (107) Al riguardo, si rinvia al testo di V. CAIA, Stato ed autonomie locali nella
gestione dell’energia, Milano, 1984.(108) Sulla cit. l. n. 9 del 1991, cfr. F. ROVERSI MONACO e V. CAIA (a cura di),
Commentario alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, in Nuove leggi civ. comm., 1993, 2-3, p.277 ss.
(109) In tema di liberalizzazione dell’energia elettrica, ex multis cfr. E. BRUTI
LIBERATI, La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pubblici a rete. Il caso dell’energiaelettrica e del gas naturale, Milano, 2006.
(110) Si tratta della Legge comunitaria 2009.
���� �� ¡¢¡ �£¤¥¦ §� ¨£��¦ £©£¤ª��« ���£ � ¢�¤£¬ �� ¢�¤£����� ®®¯°±°²³
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e le due diret-tive 2009/72/CE e 2009/73/CE, che pongono norme comuni per imercati interni rispettivamente dell’energia elettrica e del gas naturale.
In base agli orientamenti dell’Unione europea in materia energeti-ca (111), ciascun Paese membro avrebbe dovuto realizzare la progressi-va apertura alla concorrenza nelle attività di produzione, importazione,esportazione, acquisto e vendita dell’energia. Inoltre, il gestore della retenazionale (la società Terna) avrebbe avuto l’obbligo di connettere allarete di trasmissione nazionale tutti i soggetti richiedenti, sulla base dellecondizioni stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas(AEEG)(112).
Quest’ultima, con la recente relazione del 3 febbraio 2011 hasegnalato i progressi realizzati in tema di liberalizzazione del settore elet-trico, dove «il peso dell’operatore maggiore, l’Enel, si è ridotto al 30%del totale della produzione nazionale nel 2010 rispetto al 38% del tota-le della produzione nazionale nel 2005» (113). Tuttavia, l’Autorità nonha mancato di ricordare che in specifiche zone geografiche del Paese eper taluni servizi di dispacciamento, il livello di competizione sul mer-cato è ancora lontano da quello proprio di mercati che possano definir-si compiutamente concorrenziali.
In particolare – e qui torna in rilievo il tema delle reti, a ulterioreconferma del fatto che non può svilupparsi un mercato concorrenzialein assenza di un adeguato sviluppo delle necessarie infrastrutture – indeterminate zone geografiche italiane si riscontra un basso livello diconcorrenza, dovuto principalmente a insufficienze di tipo infrastruttu-rale: basti pensare alla situazione critica che si registra soprattutto inSicilia e in Sardegna, a causa dell’inadeguatezza delle interconnessionitra il sistema elettrico delle Isole e quello dell’Italia peninsulare (114).
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 119
(111) Si rinvia al par. 2.(112) Per un quadro generale sull’AEEG, cfr. G. SOLA, Le amministrazioni indi-
pendenti, Napoli, 2007, p. 274 ss.(113) Si tratta della relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo
stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed inte-grazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Detta relazione è stata redattaai sensi dell’art. 28, co. 2, l. 23 luglio 2009, n. 99, recante Disposizioni per lo sviluppoe l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed è consultabile sulsito dell’Autorità, www.autorita.energia.it. In particolare, ved. relazione cit., p. 10.
(114) In base alle stime del 2010, l’Autorità osserva che i prezzi dell’energia inSicilia e Sardegna sono superiori rispetto a quelli praticati nelle altre zone dell’Italia,rispettivamente del 43% e del 22%. Ibid.
´µ¶··¸¹º»¼ ½¸¹º¾º¼
Tuttavia, continua l’Authority, «la situazione è comunque destinata amigliorare fra il 2011 e il 2014 in virtù del progressivo incremento dellacapacità di interconnessione fra le Isole e il Continente nonché delpieno dispiegarsi degli effetti positivi della riforma del mercato elettrico[…]» (115).
È questo un ulteriore esempio dell’importanza di realizzare deinuovi interconnettori, anche al fine di garantire l’accesso al mercato del-l’energia a prezzi più contenuti: in pratica, maggiore sarà il grado diinterconnessione tra le Isole e il Continente, minori saranno i livelli dicriticità (e, dunque, i costi) nelle stesse Isole (116).
Sempre nella relazione del febbraio 2011, l’Autorità per l’energiaelettrica e il gas ha elencato altresì gli interventi da operare per ridurrele criticità nel mercato energetico e per rafforzare la concorrenza: traquesti, un ruolo di primo piano non può che essere assunto dalla neces-sità di realizzare delle infrastrutture di rete, non solo fra il Continente ele Isole, ma altresì all’interno del Continente medesimo, tra la zona Sude la zona Centro-Sud. In tal modo, sarà possibile incrementare signifi-cativamente il livello di concorrenza e di adeguatezza in molte zone delmercato elettrico, riducendo in misura sostanziale gli oneri di dispaccia-mento per la risoluzione delle congestioni intrazonali.
Completamente diversa è la situazione concernente il settore delgas naturale, che ha conosciuto una progressiva apertura per via dellenorme comunitarie, ma rispetto al quale la liberalizzazione «è ancorainsoddisfacente e sconta oggettive criticità anche per le caratteristichestesse di questo mercato, contraddistinto dalla presenza di contratti dilungo e lunghissimo termine, dai vincoli infrastrutturali e da monopoliverticalmente integrati» (117); senza poi dimenticare, tra l’altro, chel’estrazione e il trasporto del gas su lunghe distanze richiede investimen-ti rilevanti e molto rischiosi (118).
Com’è noto, una serie di leggi (l. 11 gennaio 1957, n. 6; l. 21luglio 1967, n. 613; l. 26 aprile 1974, n. 170) hanno attribuito all’EnteNazionale Idrocarburi (ENI), istituito con l. 10 febbraio 1953, n. 136,
120
(115) Ibid.(116) Con riguardo al complesso iter da seguire per la costruzione di infrastrut-
ture in ambito energetico, si rinvia a C. BUZZACCHI e L. SALOMONI, Il nodo dei proce-dimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche: prospettive di modifica, in Amm. inCammino, n. 9/2010.
(117) C. STAGNARO (a cura di), Il mercato del gas naturale cit., pp. 8-9.(118) Cfr. P. RANCI, Le infrastrutture energetiche: l’Italia e il mercato unico euro-
peo cit., p. 176.
¿ÀÁ ÂÃÂÄÁÀÅÆÁÇÈ ÉÃÂÆÅÆÃÀÈ ÊÆ ËÃÀÃÉÃÇÆÃ ÀÈÇÇÈ ÌÁÂÆ ÊÆ ÆËÉÃÍÄÁÅÆÃÀÈÎ ÉÍÃÏ
duzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione del gas. In seguito, si èrealizzata una progressiva apertura delle attività di prospezione, ricerca ecoltivazione degli idrocarburi (119), sino a dichiarare libere – con d. lgs.23 maggio 2000, n. 164 (c.d. decreto Letta), poi con l. 3 agosto 2007,n. 125 (cui hanno fatto seguito una serie di Delibere regolatricidell’AEEG) e, infine, con d. lgs. 13 agosto 2010, n. 130 – le attività diimportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita delgas naturale (120). In particolare, nel settore del gas, la completa libera-lizzazione del mercato e la connessa possibilità per i clienti finali dome-stici di scegliere un venditore sul mercato libero è avvenuta a partire dal1° gennaio 2003.
Anche in questo caso, però, la dottrina ha notato come «i risultatisin qui ottenuti siano stati sicuramente al di sotto delle originarie aspet-tative» (121). Una delle ragioni risiede ancora una volta nel mancato svi-luppo di un sistema adeguato di infrastrutture, nonostante già nel 2004il legislatore italiano avesse previsto al riguardo diversi meccanismi diincentivazione. In particolare, l’art. 1, co. 17 della l. 23 agosto 2004, n.239 (c.d. Legge Marzano) stabiliva numerosi incentivi per coloro i qualiavessero inteso investire: nella realizzazione di nuove infrastrutture diinterconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati mem-bri dell’Unione Europea e la rete di trasporto italiana; nel potenziamen-to delle capacità delle infrastrutture già esistenti, al fine di favorire lo svi-luppo di un mercato concorrenziale; nella realizzazione in Italia di ter-minali di rigassificazione del Gnl; nella possibilità per le imprese inve-
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 121
(119) Si ricorda il d. lgs. 25 novembre 1996, n. 625, che ha recepito la diretti-va 94/22/CE, del 30 maggio 1994. Il citato d. lgs. 164 del 2000 è stato invece emana-to in recepimento della direttiva 98/30/CE, del 22 giugno 1998, recante Norme comu-ni per il mercato interno del gas naturale, che imponeva agli Stati membri di: eliminarele situazioni monopolistiche nei settori della produzione, del trasporto e della distribu-zione del gas; garantire il diritto di accesso dei terzi alle infrastrutture a rete e ai serviziaccessori in condizioni di parità; introdurre l’obbligo di trasparenza in capo alle impre-se verticalmente integrate nella gestione delle diverse attività della filiera. Ulteriore attoda segnalare è la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, recepita dalla l. 3 agosto2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il d. l. 18 giugno 2007, n. 73,recante Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberaliz-zazione dei mercati dell’energia.
(120) Sul carattere innovativo del d. lgs. n. 164 del 2000, cfr. G. CAIA e S.COLOMBARI, Regolazione amministrativa e mercato interno del gas naturale, in Rass. giur.en. elettr., 2000, p. 342.
(121) Così M. BECCARELLO e F. PIRON, La regolazione del mercato del gas natu-rale cit., p. 11.
ÐÑÒÓÓÔÕÖ×Ø ÙÔÕÖÚÖØ
stitrici di ottenere, per un congruo numero di anni, un’esenzione dalladisciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
Ulteriori meccanismi premiali sono stati individuati dal citato d.lgs. n. 130 del 2010, al fine di creare nuove infrastrutture di stoccaggiodel gas naturale e per potenziare quelle già esistenti, così da rendere pos-sibile la realizzazione di un volume pari a quattro miliardi di metri cubidi gas (122).
Ad oggi, come risulta dalla richiamata relazione dell’Autorità perl’energia elettrica e il gas, l’apertura del mercato del gas non può dirsicompletata, a causa della posizione dominante che Eni continua a con-servare nel mercato (basti pensare che nel 2009 Eni deteneva una quotapari all’84,5% della produzione nazionale di gas)(123). Anche la strut-tura proprietaria delle principali infrastrutture di produzione, approvvi-gionamento dall’estero, trasporto e stoccaggio di gas naturale si conno-ta per il controllo esercitato dall’operatore dominante, tanto che la stes-sa Autorità ha sottolineato in più occasioni la necessità di realizzare laseparazione proprietaria delle attività di trasporto.
In particolare, afferma l’AEEG, «con riferimento alle infrastruttu-re oggetto di regolazione, risulta impossibile o rischia, quantomeno, dirivelarsi inefficace ed eccessivamente costoso per i consumatori, struttu-rare un sistema di incentivi che allinei gli interessi dei soggetti che ero-gano il servizio agli interessi del sistema» (124).
Probabilmente, molte delle responsabilità sono da ascriversi allapolitica comunitaria, che ha rivolto la propria azione a tutelare in viaprioritaria l’accesso al mercato del gas naturale, piuttosto che sviluppa-re fisicamente il mercato medesimo, attraverso la costruzione di infra-strutture adeguate (125). Come nel caso dell’elettricità, un sistemainfrastrutturale più ampio e rinnovato consentirebbe infatti di raggiun-
122
(122) Sul tema dello stoccaggio del gas naturale, occorre segnalare le dueIndagini conoscitive svolte congiuntamente dall’AEEG e AGCM: la prima conclusasicon provvedimento AGCM n. 13267 del 17 giugno 2004 e deliberazione AEEG n.90/04, adottata in pari data; la seconda, più recente, conclusasi con provvedimentoAGCM n. 19925 del 28 maggio 2009 e, nello stesso giorno, con deliberazione AEEGn. 51/09. Tali documenti sono consultabili sui siti delle richiamate autorità:www.agcm.it e www.autorita.energia.it.
(123) Come afferma C. STAGNARO (Il mercato del gas naturale cit., p. 205), «Eniè titolare di numerosi contratti a lungo termine che possono coprire, nel loro insieme,l’intera domanda italiana».
(124) Relazione cit., p. 24.(125) Cfr. M. BECCARELLO e F. PIRON, La regolazione del mercato del gas natura-
le cit., pp. 341-342.
ÛÜÝÜ ÞßÛàßáßâãäßåß ÝßÞæçäãäß Þßã èãç éæàäê èß åßÞäã èÜççã ÞßâæÝÜëëã èÜÛçß
approvvigionamenti (obiettivo perseguibile solo attraverso un adeguatolivello di diversificazione delle fonti di energia), che sotto il profilo dellariduzione dei prezzi di mercato (126). A tutto questo si aggiunga, perquel che riguarda l’Italia (ma ciò accade anche in tanti altri Paesi euro-pei), che esiste un operatore nazionale – l’Eni – il quale è presente inmodo preponderante in tutte le fasi della filiera, limitando così forte-mente il perseguimento di una compiuta liberalizzazione del mercato.
7. Spunti conclusivi.
Dall’analisi sinora svolta, emerge un quadro complesso e articola-to, dal quale si evince che l’Europa, di per sé non autosufficiente dalpunto di vista delle risorse energetiche (127), si trova dinanzi alla neces-sità di attivare in tempi non troppo lunghi una gestione unitaria dellereti e delle infrastrutture nel settore dell’energia, così da riuscire final-mente a parlare con una sola voce. Tale obiettivo, considerando – perl’appunto – il fatto che l’Unione europea per gran parte del proprio fab-bisogno energetico dipende dall’estero, rappresenta un passo fondamen-tale da compiere se si vuole perseguire il rafforzamento della medesimasulla scena internazionale e, soprattutto, nei confronti dei Paesi dell’areadel Mediterraneo (128).
Guardando poi al contesto italiano, si riscontra che la situazionepeggiora ulteriormente, data l’elevata dipendenza dell’Italia dalle impor-tazioni di energia, pari a circa l’85%, senza poi dimenticare da un latole numerose inefficienze della nostra rete elettrica (che contribuisconoad aumentare il costo dell’elettricità), dall’altro le carenze strutturali
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 123
(126) Ad esempio, rispetto alle vendite che avvengono prima della frontiera, Enisi trova nella situazione di vendere gas alle stesse imprese con cui entrerà poi in com-petizione nelle fasi successive della filiera. Ciò conferma ulteriormente l’odierna assen-za di una vera e propria competizione nell’approvvigionamento del gas naturale. C.STAGNARO (Il mercato del gas naturale cit., p. 205) ritiene possibile sviluppare una mag-giore competizione negli approvvigionamenti, investendo di più nel gas naturale lique-fatto.
(127) Basti ad esempio pensare al fatto che l’Europa, che consuma il 20% delgas mondiale, detiene solo il 2% delle riserve. Invece, la Russia, l’Iran e il Qatar possie-dono da soli oltre il 60% delle riserve mondiali.
(128) Cfr. l’intervento di A. MARZANO nell’ambito del Convegno: La politicaeuropea dell’energia: il problema delle reti, 19 novembre 2008, p. 11. Il documento èconsultabile sul sito del CNEL, www.portalecnel.it.
ìíîïïðñòóô õðñòöòô
concernenti le reti di trasporto del gas, che necessiterebbero di esserepotenziate, dotate di adeguate capacità di stoccaggio, nonché connessea nuovi rigassificatori e alle reti estere. Tra l’altro, proprio l’Italia dovreb-be mirare a diventare, in virtù della propria posizione geografica, il Paeseapprovvigionatore di gas dal Nord Africa e dalla regione del mar Caspio,fungendo da snodo fondamentale per il mercato del gas mediterraneo:ma ciò potrà avvenire soltanto una volta che sarà realizzato un mercatointerno dell’energia funzionante.
Vi è poi un ulteriore problema, cui già si è accennato: vale a dire,la necessità di diversificare le fonti di energia. A tal proposito, si era ria-perta la strada per la realizzazione di impianti nucleari (con legge dele-ga n. 99 del 2009)(129). Tuttavia, a causa del disastro nucleare dellacentrale giapponese di Fukushima Daiichi (in seguito al devastante ter-remoto e al successivo tsunami dello scorso 11 marzo 2011), con l’art.5 del d. l. n. 34 del 31 marzo 2011, il Governo aveva approvato unamoratoria sul nucleare per dodici mesi, che aveva – solo provvisoria-mente – bloccato la reintroduzione dell’energia nucleare in Italia (130).Tale norma non ha comunque potuto evitare, come invece era nelleintenzioni dell’esecutivo, che il corpo elettorale si pronunciasse sulnucleare attraverso il recente referendum abrogativo del 12 e del 13 giu-gno 2011, che si è concluso con l’abrogazione dell’art. 5, co. 1 e 8, deld. l. 31 marzo 2011, n. 34 (convertito con modificazioni con l. 26 mag-gio 2011, n. 75), che avrebbe consentito la produzione nel territorionazionale di energia elettrica nucleare.
Su quest’ultimo tema, si segnala la recente proposta di risoluzionedel Parlamento europeo del 6 aprile 2011, con la quale si afferma lanecessità da parte dell’Unione europea di «riconsiderare globalmente ilproprio approccio alla sicurezza nucleare, tenendo presente che l’energianucleare continuerà a far parte del mix energetico di diversi Stati mem-
124
(129) Si rinvia ancora una volta a L. AMMANNATI e M. DE FOCATIIS, Un nuovodiritto per il nucleare cit. Cfr. anche P.M. PUTTI, La prospettiva del riavvio dell’industriaelettronucleare in Italia, in Resp. civ. e prev., 2010, p. 2402 ss. Per una comparazione traalcuni sistemi di regolazione del nucleare, cfr. L. AMMANNATI e A. SPINA, Il “ritorno” alnucleare. Il contesto regolatorio e l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, in Amministrare,2009, 2, p. 231 ss.
(130) La norma in questione dispone che «Allo scopo di acquisire ulteriori evi-denze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazio-ne alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti diproduzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore delpresente decreto resta sospesa l’efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30,comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31».
÷øù úûø üýþÿù +��ù + �û�ùøû û ��û �ý�ý úøû�ù�ÿù ý �ù� ù� �ý�ÿø��ùý�û ��ý�ù
reattori» (131). Tuttavia, la stessa risoluzione è stata bocciata e, con essa,l’accordo rivolto a sospendere la costruzione di nuove centrali nucleari.
In tale contesto, almeno nell’immediato, un ruolo decisivo saràpertanto svolto soprattutto dalla promozione delle fonti di energia rin-novabili (132), il cui sviluppo dovrà comunque rispondere a criteri dieconomicità ed efficienza, sulla base di una razionalizzazione degli oneria carico del sistema e dei consumatori.
Tanto posto, dall’analisi svolta emerge chiaramente che l’Europanon ha ancora superato la situazione di debolezza strutturale in cui versanel settore dell’energia, posto che ad oggi non è ancora stata in grado diincidere in modo decisivo sulla creazione di una politica energeticasostenibile per tutte le fasce sociali, né tantomeno sono stati raggiuntirisultati troppo soddisfacenti sul fronte dell’eliminazione delle disparitàdi trattamento nell’accesso ai servizi offerti delle imprese erogatrici dienergia, o su quello del mantenimento di prezzi sostenibili per i consu-matori finali. Il punto è che per raggiungere questi obiettivi occorrereb-be prima che gli Stati membri fossero disposti a cedere una fetta impor-tante della propria sovranità in materia di politiche energetiche, così dariuscire a costruire finalmente un mercato che possa dirsi a tutti gli effet-ti unico e armonizzato; in secondo luogo, bisognerebbe rafforzare le retitranseuropee di trasmissione dell’elettricità e del gas.
Sotto tale profilo, giova tra l’altro considerare che, per risolvere laquestione degli scarsi investimenti nella costruzione di infrastruttureenergetiche, occorrerà in via preliminare eliminare le asimmetrie infor-
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 125
(131) Si tratta del punto 5 della risoluzione del 6 aprile 2011 del Parlamentoeuropeo “sugli insegnamenti da trarre dall’incidente nucleare in Giappone per la sicurezzanucleare in Europa”, consultabile sul sito del Parlamento europeo, www.europarl.euro-pa.eu.
(132) L’art. 2 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (rubricato Attuazione delladirettiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti ener-getiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) qualifica come rinnovabile l’ener-gia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da biomasse,da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas. Sono poiconsiderate fonti assimilate a quelle rinnovabili la cogenerazione, il calore recuperabilenei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali(art. 17). Sulle energie rinnovabili, cfr. G. PIZZANELLI, Gli impianti alimentati da fontienergetiche rinnovabili: organizzazione e procedimenti alla luce del principio di integrazio-ne, in C. BUZZACCHI (a cura di), Il prisma energia, cit., p. 86 ss. Per uno sguardo al con-testo italiano, con riguardo alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia dirinnovabili, cfr. N. RANGONE, Fonti rinnovabili di energia: stato della regolazione e pro-spettive di riforma, in Giur. cost., 2010, 2, p. 1490 ss.
���� ��� �� ����
mative che caratterizzano il mercato elettrico e quello del gas, le quali sipongono quali ostacoli all’ingresso dei nuovi investitori. Il problema,come ha segnalato l’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella citatarelazione del febbraio 2011, è che «le informazioni nel mercato elettri-co sono incomplete e distribuite in modo asimmetrico fra gli attori delsistema elettrico. In assenza di interventi regolatori, quindi, il mercatoelettrico si rivela uno strumento inefficiente ed inefficace di coordina-mento delle scelte di investimento degli operatori» (133).
Un buon esempio di strategia rivolta alla corretta informazione èfornito dal regolamento n. 617 del 24 giugno 2010, con il quale ilConsiglio, tenuto conto dell’importanza di diffondere i dati relativi aiprevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto, nella capacità distoccaggio, nonché i progetti di investimento nelle infrastrutture ener-getiche, ha istituito «un quadro comune per la comunicazione allaCommissione di dati e informazioni sui progetti di investimento ininfrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell’energia elet-trica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, e dei biocarbu-ranti, nonché sui progetti di investimento connessi alla cattura e allostoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori» (art. 1). Inparticolare, si tratta di indicare, in relazione ai singoli progetti di inve-stimento, il tipo e le caratteristiche principali dell’infrastruttura, le capa-cità programmate o in costruzione, l’anno probabile di attivazione, iltipo di fonti di energia utilizzate, nonché gli impianti in grado dirispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture (art. 5).
È evidente, dunque, che per un corretto funzionamento del mer-cato energetico dovrà imporsi prima di tutto la regola della trasparenza,affinché le imprese concorrenti possano essere messe nelle condizioni diaccedere in uguali condizioni tanto alle reti, quanto ai clienti (134).
Inoltre, si potrebbe ad esempio pensare a delle modalità di raffor-zamento dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali del-l’energia, la quale «esprime il tentativo di rafforzare e rendere più effica-ce la regolazione a livello europeo attraverso una nuova forma di coope-razione tra regolatori nazionali» (135).
Alla luce del complessivo contesto delineato, risulta palese che, per
126
(133) Relazione cit., p. 21.(134) Così ha affermato il Comitato economico e sociale con il recente parere
sul tema La nuova politica energetica europea: applicazione, efficacia e solidarietà per i cit-tadini (2011/C 48/15), pubblicato sulla G.U. dell’UE il 15.02.2011.
(135) Così L. AMMANNATI, Il ruolo dell’Agenzia per la Cooperazione tra iRegolatori dell’Energia, cit., pp. 3-4.
#��������� �� #�#���� �����#���������� � �!���" � ��� ���#�!���� �$"%���&
tivo di un mercato unico dell’energia, l’Unione europea sarà destinata asvolgere il ruolo più delicato, essendo chiamata a mediare tra gli interes-si degli Stati membri e quelli dell’Unione stessa, tra le esigenze delleimprese e quelle degli utenti. Ma dovrà trattarsi di un’azione sempre piùincisiva tanto sulle politiche degli Stati membri, quanto sugli investi-menti da effettuare (gran parte dei quali dovranno essere rivolti allacreazione di adeguate infrastrutture), nella consapevolezza che la politi-ca energetica costituisce il cuore della politica estera, industriale, di sicu-rezza e di sviluppo dell’intera Europa.
Bibliografia
AICARDI N., Energia, in CHITI M. P., GRECO G. (dir.), Trattato didiritto amministrativo europeo, P.te speciale, Tomo II, 2ª ed., Milano,2007
AMMANNATI L. (a cura di), Monopolio e regolazione proconcorrenzia-le nella disciplina dell’energia, Milano, 2005
AMMANNATI L., BILANCIA P., a cura di, Governance dell’economia eintegrazione europea, Milano 2008
AMMANNATI L. e SPINA A., Il “ritorno” al nucleare. Il contesto rego-latorio e l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare, in Amministrare, 2009, 2
AMMANNATI L. e CANEPA A., Il governo dell’«emergenza energetica»:paure, incertezze, regole, in Amministrare, 2010, 2
AMMANNATI L., DE FOCATIIS M., Un nuovo diritto per il nucleare.Una prima lettura del d. lgs. 31/2010, in www.astrid-online.it, 2010
AMMANNATI L., Il ruolo dell’Agenzia per la Cooperazione deiRegolatori dell’Energia (ACER) nella governance e nella regolazione delsettore energetico, in Amministrazione in cammino, 2011
BALBONI E. (a cura di), La tutela multilivello dei diritti sociali,Napoli, 2008
BASTIANELLI F., La politica energetica dell’Unione europea e la situa-zione dell’Italia, in La Comunità internazionale, 2006, 3
BECCARELLO M., PIRON F., La regolazione del mercato del gas natu-rale, Soveria Mannelli, 2008
BIN R., Soft law, no law, in SOMMA A. (a cura di), Soft law e hardlaw nelle società postmoderne, Torino, 2009
BRUTI LIBERATI E., La regolazione pro-concorrenziale dei servizi pub-blici a rete. Il caso dell’energia elettrica e del gas naturale, Milano, 2006
BUZZACCHI C., Dalla coesione all’uguaglianza sostanziale. Il percor-
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 127
'()**,-./0 1,-.2.0
so comunitario, Milano, 2005BUZZACCHI C., SALOMONI L., Il nodo dei procedimenti autorizzati-
vi delle infrastrutture energetiche: prospettive di modifica, inAmministrazione in cammino, 2010, 9
BUZZACCHI C. (a cura di), Il prisma energia. Integrazione di interes-si e competenze, Milano, 2010
CABAU E. et al., EU Energy Law. The internal Energy market. Thethird liberalisation package, Leuven, 2010
CAIA G., COLOMBARI S., Regolazione amministrativa e mercatointerno del gas naturale, in Rassegna giuridica dell’energia elettrica, 2000
CAIA V., Stato ed autonomie locali nella gestione dell’energia, Milano,1984
CANEPA A., La costruzione del mercato europeo dell’energia e il diffi-cile percorso del ‘terzo pacchetto’ legislativo, in Amministrare, 2009, 2
CANEPA A., Reti europee in cammino. Regolazione dell’economia,informazione e tutela dei privati, Napoli, 2010
CARDI E., Mercati e istituzioni in Italia. Diritto pubblico dell’econo-mia, Torino, 2009
CASSESE S., La disciplina del mercato dell’elettricità, in Rassegna giu-ridica dell’energia elettrica, 1997, 4
CASSESE S., La nuova costituzione economica, Roma-Bari, 2007CATALANO N., La Comunità economica europea e l’Euratom,
Milano, 1959DE BELLIS M., Energia elettrica (voce), in S. CASSESE (dir.).,
Dizionario di diritto pubblico, vol. II, Milano, 2006DE VALLES A., I servizi pubblici, in Tratt. Orlando, VI, Milano,
1923DI PORTO F., La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, in
PICOZZA E., GABRIELLI E. (dir.), Trattato di diritto dell’economia,Padova, 2008
DUCCI R., La Comunità economica europea e l’Euratom, Padova,1957
FERRARI E., I servizi a rete in Europa: concorrenza tra gli operatori egaranzia dei cittadini, Milano, 2000
GENTILE G.G., GONNELLI P., Manuale di diritto dell’energia,Milano, 1994
GUARINO G., Unità ed autonomia del diritto dell’energia, in ID.,Scritti di diritto pubblico dell’economia, prima serie, Milano, 1962
HAGHIGHI S., Energy security. The external legal relations of theEuropean Union with major oil and gas supplying countries, Oxford-Portland, 2007
128
8ANCHER L., DE HAUTECLOCQUE A., Manifacturing the EU Energymarkets: the current dynamics of regulatory practice, in Tilburg University,TILEC discussion paper, January 2010 (http://ssrn.com/abstract=1539901)
KRÄMER L., Manuale di diritto comunitario dell’ambiente, Milano,2002
MANZELLA G.P., Le prospettive della politica di coesione europea: traapprofondimento e globalizzazione, in Rivista giuridica del Mezzogiorno,2010, 1
MARZANATI A., I principi ambientali tra diritto interno e dirittocomunitario, in CORTESE W. (a cura di), Conservazione del paesaggio edell’ambiente, governo del territorio e grandi infrastrutture: realtà o uto-pia?, Napoli, 2009
MARZANO A., La politica europea dell’energia: il problema delle reti,19 novembre 2008, in www.portalecnel.it
MELICA L., Fondamenti costituzionali della coesione europea, Napoli,2006
MERUSI F., Lo schema della regolazione dei servizi di interesse econo-mico generale (Relazione a Convegno su “La regolazione dei servizi diinteresse economico generale”, Firenze, 6 novembre 2009), in Dirittoamministrativo, 2010, 2
MUNARI F., Il nuovo diritto dell’energia: il contesto comunitario e ilruolo degli organi europei, in Diritto dell’Unione Europea, 2006, 4
NAPOLITANO G., Servizi pubblici, in S. CASSESE (dir.)., Dizionariodi diritto pubblico, vol. VI, Milano, 2006
PIZZOLATO F., Il sistema di protezione sociale nel processo di integra-zione europea, Milano, 2002
POGGI A., Soft law nell’ordinamento comunitario, Relazione alConvegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti “L’integrazionedei sistemi costituzionali europeo e nazionale, Università degli studi diCatania, 14-15 ottobre 2005; ora in Atti del XX Convegnodell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova, 2007
POTOTSCHNIG U., I pubblici servizi, Padova, 1964POZZO B., Le politiche comunitarie in campo energetico, in Rivista
giuridica dell’ambiente, 2009, 6PREDIERI A., Le reti transeuropee nei Trattati di Maastricht e di
Amsterdam, in Diritto dell’Unione Europea, 1997, 3PUTTI P.M., La prospettiva del riavvio dell’industria elettronucleare
in Italia, in Responsabilità civile e previdenza, 2010QUADRI R., TRABUCCHI A. (a cura di), Commentario al Trattato
CECA, Milano, 1970RANCI P., Le infrastrutture energetiche: l’Italia e il mercato unico
Verso il mercato interno dell’energia: le reti energetiche europee 129
3456679:;< =79:>:<
europeo, in MANACORDA P. M. (a cura di), I nodi delle reti. Infrastrutture,mercato e interesse pubblico, Firenze-Antella, 2010
RANGONE N., Fonti rinnovabili di energia: stato della regolazione eprospettive di riforma, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 2
ROMANO M., La liberalizzazione del settore elettrico, in Rassegnagiuridica dell’energia elettrica, 2005
ROMANO S., Principii di diritto amministrativo italiano, Milano,1912
ROSSI V. (a cura di), Repertorio di dottrina sull’Enel, in Rassegna giu-ridica dell’Enel, 1983
ROVERSI MONACO F., CAIA V., a cura di, Commentario alla legge 9gennaio 1991, n. 9, in Nuove leggi civili commentate, 1993, 2-3
SCOVAZZI T., Carbone e acciaio nel diritto comunitario, in Digestodiscipline pubblicistiche, II, Torino, 1987
SCUTO F., La governance del settore energia e gas attraverso la “rete”europea delle autorità indipendenti, in Rivista italiana di diritto pubblicocomunitario, 2007, 1
SENDEN L., Soft Law in European Community Law, Portland, 2004SOLA G., Le amministrazioni indipendenti, Napoli, 2007SORACE D., Il servizio di interesse economico generale dell’energia
elettrica in Italia tra concorrenza ed altri interessi pubblici, in Diritto pub-blico, 2004, 3
SOTTILI V., Il mercato dell’energia elettrica nella giurisprudenza dellaCorte di giustizia, in Diritto dell’Unione Europea, 1998, 4
STAGNARO C. (a cura di), Il mercato del gas naturale. L’Europa trasicurezza e liberalizzazioni, Soveria Mannelli, 2009
THALER R.H. e SUNSTEIN C.R., Nudge. Improving decisions abouthealth, wealth and happiness”, New Haven, 2008, trad. it. di OLIVERI A.,Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre deci-sioni su denaro, salute, felicità, Milano, 2009
UBERTAZZI B., La fine della ceca: i profili giuridici, in Dirittodell’Unione Europea, 2004, 2
VAGLIO L., Algeria, Libia, Tunisia: ecco il peso energetico del NordAfrica per l’Italia, in Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2011
130