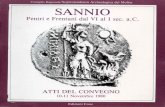Gli ordini inutili? Lo Stato, il mercato e il tramonto delle gilde moderne
Politica Economica_MAGAZZINO-3.I fallimenti del mercato, aspetti macoreconomici della realtà
Transcript of Politica Economica_MAGAZZINO-3.I fallimenti del mercato, aspetti macoreconomici della realtà
Le critiche mosse al primo t.f. dell’E.B. ne impediscono l’utilizzo a difesadei mercati reali, per 3 ragioni:
a) l’elevata astrazione e le ipotesi molto restrittive comportano che imercati cui fa riferimento il primo t.f. siano distanti da quelli reali, il chenon consente di conseguire l’ottimo paretiano;
b) l’individualismo metodologico, alla base del primo t.f., rappresenta unvincolo troppo stringente rispetto ai bisogni giudicati degni di esseresoddisfatti;
c) il criterio di ottimalità paretiana non sempre conduce a stati del mondoauspicabili.
2
Si definiscono macroeconomici quei fallimenti connessi con l’instabilitàdelle economie di mercato.
In quanto fallimenti, essi denotano la presenza di inefficienze e/oiniquità.
In quanto propri del Mercato, sono strettamente inerenti alfunzionamento concreto dei mercati.
In quanto macroeconomici, la teoria più adatta a spiegarli è una teorianon già di natura micro, bensì macroeconomica.
I fallimenti macro del Mercato sono 4:
1. Disoccupazione
2. Inflazione
3. Squilibri della Bilancia dei Pagamenti (BP)
4. Sottosviluppo.
3
La disoccupazione involontaria (che si ha quando vi sono dei lavoratoripotenzialmente disposti ad occuparsi al saggio di salario reale vigente, mala domanda di lavoro è insufficiente per occuparli, e pertanto l’offerta dilavoro risulta razionata) è causa di fallimento macro del Mercato.
L’esistenza di disoccupazione involontaria genera 2 tipi di perdite:
a) perdita di efficienza statica: impossibilità di migliorare la posizione dialcuni individui (i disoccupati) senza peggiorare quella di altri.
b) perdita di efficienza dinamica: si realizza uno spreco di risorse umane,con loro deperimento (LUNGHINI).
Inoltre, la disoccupazione, oltre a rappresentare una possibile fonte diinstabilità sociale (costi non economici: frustrazione, emarginazione,aumento dell’economia parallela), accresce l’ineguaglianza nelladistribuzione del reddito.
Lo Stato può intervenire tramite la redistribuzione, per via di pagamentidi indennità di disoccupazione (basic income system), integrazione deiguadagni, garanzia di salari minimi.
Questi sistemi facilitano i licenziamenti o le sospensioni dal lavoro,riducendone i costi sia per i lavoratori che per le imprese. Tuttavia, sonouna distorsione del mercato del lavoro, disincentivando l’offerta.
4
La disoccupazione volontaria si verifica quando, pur in presenza diuna situazione di equilibrio sul mercato del lavoro, esiste una parte dilavoratori disposta a lavorare solo per un salario superiore a quello che sidetermina dall’incontro tra domanda e offerta.
Tasso di disoccupazione: quota dei disoccupati sul totale delle forzedi lavoro:
u = U / FL
La disoccupazione frizionale è un tipo particolaredi disoccupazione costantemente presente all'interno del mercato dellavoro. Essa è dovuta al fatto che ci sono sempre persone alla ricerca diun lavoro. Ciò avviene anche in situazioni di piena occupazione. Si ritienecosì che il tasso di disoccupazione non riesca a raggiungere mai lo zero,in quanto anche in condizioni economiche particolarmente favorevoli visarà sempre qualcuno che per un periodo, magari breve, cercherà lavoro.Pur ritenendo che il tasso di disoccupazione frizionale si attesti attorno al3-4% esistono aree in cui vengono misurati tassi anche inferiori al 2%.
In presenza di disoccupazione frizionale alcuni individui – per motivieconomici o su base volontaria – transitano da un’occupazione all’altra. 5
La disoccupazione stagionale è connessa a dinamiche proprie del sistemaproduttivo, che tende a sperimentare l’alternarsi di periodi di espansione e diperiodi di ristagno.
La disoccupazione ciclica è anch’essa legata alle dinamiche del sistemaproduttivo, ma i suoi effetti sono destabilizzanti: infatti nelle fasi espansive non siriesce a produrre un reddito sufficiente al sostentamento delle fasi di ristagno.
La disoccupazione strutturale è la forma più grave del fenomeno. Denota unsistema produttivo squilibrato, in cui non è possibile raggiungere il pienoimpiego, a causa di croniche deficienze o circoli viziosi del sistema stesso. Siassocia al sottosviluppo.
La disoccupazione tecnologica è dovuta agli effetti dell’innovazione e delprogresso tecnico, che favoriscono produzioni labour-saving.
Con il termine piena occupazione si intende l’impegno di eliminare ladisoccupazione involontaria al di sopra di quella frizionale. In p.o.: u = NAIRU
Le posizioni di piena occupazione (o pieno impiego) assumono la natura di“precipizio”, non rappresentando un equilibrio stabile (ROBINSON).
Ciò perché:
- gli effetti della pressione della domanda di beni si fanno sentire sull’offerta, dalmomento che quest’ultima in p.o. è anelastica (non potendo aumentare);
- viene meno la disciplina esercitata dalla u sulle richieste salariali. 6
La disoccupazione volontaria (o di ricerca) è finalizzata alla ricerca di unposto di lavoro, e si registra tutte le volte in cui un soggetto rinunzia aun’occupazione qualsiasi sperando di trovarne una migliore.
Il salario di riserva è quel salario minimo a fronte del quale l’occupazioneviene preferita al sussidio.
Sul NAIRU (tasso di disoccupazione al quale l’inflazione non accelera)incidono:
- l’organizzazione del mercato del lavoro;
- la composizione demografica delle FL;
- la presenza dei sussidi di disoccupazione.
Sacrifice Ratio = Punti annuali di eccesso di u / Riduzione di p
Replacement Ratio = Sussidio netto / Reddito netto
Quando il RR è elevato, ossia quando non sussiste una rimarchevole differenzatra l’essere occupati e l’essere disoccupati, si verifica:
- un allungamento del tempo di ricerca del lavoro;
- molti individui, che di norma non rientrerebbero nelle FL in quanto noncercano attivamente un’occupazione, dichiarano di essere alla ricerca, solo perottenere il sussidio;
- l’occupazione diviene meno stabile. 7
Per inflazione si intende l’aumento sostenuto e costante del livellogenerale dei prezzi, con la perdita di valore della moneta.
p = (Pt – Pt-1) / Pt-1
Distinguiamo, dal punto di vista delle cause immediate:
- inflazione da domanda: deriva dalla pressione della domanda aggregata(AD), che tende ad espandersi al di là dell’offerta aggregata disponibile(AS), all’approssimarsi della p.o.
- inflazione finanziaria: deriva dalla crescita della spesa pubblica (G)finanziata in deficit (Dis>0)
- inflazione creditizia: deriva dalla eccessiva creazione di credito da partedel sistema bancario
- inflazione da offerta: deriva dagli shocks che portano a ridurre l’offerta
- inflazione da costi: deriva dal trasferimento sui prezzi dell’aumento deicosti variabili di produzione delle imprese
- inflazione da profitti: deriva dall’aumento del mark-up (μ) delle imprese
- inflazione importata: deriva da un prolungato aumento delleesportazioni (X) del paese considerato, stimolate da un eccesso didomanda del Resto del Mondo (RdM). 8
Distinguiamo, dal punto di vista del ritmo di aumento dei prezzi:
- inflazione strisciante: se p = 2-3%
- inflazione moderata: se 3% < p < 10%
- inflazione galoppante: se 10% < p < 300%
- iperinflazione: se p > 300%
La misurazione dell’inflazione avviene tramite gli indici di prezzo(deflatore del PIL, deflatore dei consumi, deflatore degli investimenti,prezzi all’ingrosso, prezzi alla produzione, prezzi al consumo).
Una pressione inflazionistica sorge quando i percettori dei vari redditimonetari (salari, profitti, rendite) cercano di accrescere la propria quotanella distribuzione del reddito reale prodotto, a scapito degli altriconsociati. L’inflazione è dunque il sintomo di una lotta sociale.
L’inflazione comporta anche una redistribuzione della ricchezza: il valoredi un’obbligazione fissa in termini nominali, se p , si riduce in terminireali. Pertanto l’inflazione avvantaggia i debitori (imprese, Stato) esvantaggia i creditori (famiglie).
La svalutazione della moneta a causa dell’inflazione è definita impostada inflazione. 9
Per stagflazione s’intende la situazione nella quale sonocontemporaneamente presenti - su un determinato mercato - sia unaumento generale dei prezzi (inflazione) che una mancanza di crescitadell’economia in termini reali (stagnazione economica).
Lo Stato può intervenire mediante meccanismi di indicizzazione, chelegano i redditi alle variazioni del livello generale dei prezzi (“scalamobile”).
Alcuni studiosi hanno argomentato a favore di un moderato tasso positivodi inflazione, quale stimolo agli investimenti; infatti, le imprese vedrebberoridursi in termini reali i costi del capitale, mentre l’aumento dei prezzi glipermetterebbe di aumentare i ricavi totali.
L’inflazione provoca altri 2 fenomeni:
- facendo sorgere oneri specifici per l’adeguamento dei listini (menucosts) o dei macchinari per i pagamenti (slot-machine costs);
- essendo connessa con i, l’inflazione aumentando il costo-opportunitàdella detenzione del circolante, ne genera la riduzione, facendo aumentarei prelievi bancari (shoe-leather costs).
Il valore della moneta (cioè il suo potere d’acquisto) è pari a 1/P.10
La Bilancia dei Pagamenti (BP) è il documento contabile dove siregistrano le transazioni economiche che hanno luogo in un determinatoperiodo di tempo fra i residenti e i non residenti di un dato Paese, e dallequali scaturiscono esborsi o introiti di valute estere.
Viene registrata a debito ogni transazione che comporti esborso divalute (importazioni, trasferimenti all’estero, deflussi di capitale); mentreviene registrata a credito ogni transazione che comporti afflusso di valute(esportazioni, trasferimenti dall’estero, afflussi di capitale).
La BP si compone di 3 conti:
1.Conto corrente: comprende le esportazioni (X) e le importazioni (M) dibeni (merci, servizi, redditi da L, redditi da K), i trasferimenti unilateralicorrenti. All’interno del CCor, le transazioni di sole merci danno luogo allabilancia commerciale: BilCom = X – M
2. Conto capitale: comprende le operazioni commerciali, i trasferimentirelativi ad attività d’investimento e le attività intangibili (brevetti)
3. Conto finanziario: comprende i movimenti di capitale a breve, medio elungo termine (investimenti diretti, investimenti di portafoglio, derivati,prestiti pubblici, crediti commerciali, capitali bancari; variazione delleriserve ufficiali).
11
In un’economia florida il saldo di conto corrente è positivo.
Il saldo dei movimenti dei beni è dato dalla somma algebrica tra ilsaldo di conto corrente e il saldo del conto capitale.
Se il saldo del conto finanziario è positivo significa che nel Paese vi è unastabilità dei mercati finanziari.
Le Riserve Ufficiali (RU) comprendono l’oro monetario e le attività invaluta verso i non residenti.
La somma dei 3 conti dovrebbe essere teoricamente nulla. Tuttavia, pereffetto sia di errori contabili che dell’evasione fiscale, viene rilevata unadiscrepanza, nella voce “Errori ed omissioni”.
Contabilmente, la BP ha un saldo globale pari a 0. Infatti, ogni volta che siverificano squilibri tra movimenti dei beni e conto finanziario (oltre aerrori ed omissioni), ha luogo una variazione delle RU di pari ammontare.
Nelle fasi iniziali di sviluppo di un Paese si verificano squilibri consistentie duraturi della BP. Man mano che l’economia inizia a divenire matura, laBilCom>0, mentre il saldo del conto capitale <0. Giunti a un sufficientelivello di sviluppo, i saldi attivi di parte corrente si fanno sempre piùcospicui e si registrano afflussi di capitali dagli investitori esteri.
12
La crescita è un concetto prettamente economico, e pertiene all’aumentodel reddito. Lo sviluppo è un concetto più generale, che coinvolge anchealtri aspetti della vita di un Paese (di carattere sociale, civile, democratico).
Indicatori dello sviluppo:
- PIL
- PIL pro-capite = PIL/Popolazione
- PIL verde
- ISU (o HDI), che si fonda su 3 parametri: longevità, grado di cultura estandard di vita
- Indice di malessere = u + p
- Tasso di crescita reale pro-capite medio annuo
Le determinanti dello sviluppo di un Paese sono:
a) il tasso di investimento, la propensione marginale al risparmio (s) e iltasso di produttività (π)
b) il capitale umano, che comprende l’abilità e il talento naturali,l’istruzione, la qualificazione professionale
c) la crescita demografica
d) la garanzia di diritti e libertà fondamentali. 13
Sia
Y = π N
dove Y: reddito aggregato, π: prodotto medio per occupato (o produttivitàmedia del lavoro), N: numero di occupati.
Il prodotto Y è esprimibile anche come
Y = π (N/FL) (FL/Pop) Pop
dove N/FL: tasso di occupazione, FL: forze di lavoro, Pop: popolazione,FL/Pop: tasso di partecipazione o di attività.
Le autorità di PE dovrebbero far aumentare il reddito e il tasso diattività nella stessa misura della popolazione e del prodotto unitario peroccupato, favorendo così una diminuzione della disoccupazione nellungo periodo. Un’elevata crescita di Y è associata a una riduzione di u.
dove ut: tasso di disoccupazione effettiva (in t), ut-1: tasso didisoccupazione al tempo t-1, gyt: tasso di crescita della produzione, gy:tasso normale di crescita della produzione.
Una crescita della produzione superiore al tasso normale (gyt > gy) porta auna riduzione del tasso di disoccupazione (ut < ut-1). 14
1 ( )t t yt yu u g g
Si definisce «gap della crescita» la differenza tra quanto il sistemaeconomico potrebbe produrre se lasciato all’iniziativa privata e l’economiaritenuta pienamente produttiva nel caso intervenga l’operatore pubblico. Èun concetto di matrice keynesiana.
15
I considerato quale componente della AD, ma anche della AS. Sia:
ng = s/v
dove ng: saggio di crescita garantito (ossia quel tasso di incremento degliI che mantiene l’equilibrio sulla IS); s: propensione al risparmio; v:rapporto capitale/prodotto. Se ne = ng, aspettative realizzate. Se ne > ng,ΔAD>0 (AD>AS). Se ne < ng, ΔAD<0 (AD<AS): instabilità harrodiana.
- Implausibilità che un’economia di mercato assicuri condizionidinamicamente stabili (AD=AS);
- inesistenza in un’economia di mercato di meccanismi capaci diassicurare l’uguaglianza del tasso di crescita garantito al tasso di crescitanaturale (ng = Y*).
Per le teorie post-keynesiane, la convergenza tra ng e Y* è data dallapossibilità di mutamenti di s, determinati a loro volta da cambiamentinella distribuzione del reddito.
16
SOLOW rimuove l’ipotesi harrodiana di un coefficiente fisso di capitale,per cui ng tende verso Y*.
Le decisioni di I si basano sulla disponibilità relativa di K e di L, e nonsulle aspettative degli imprenditori circa il futuro: il mercato dei beni saràsempre in equilibrio (impossibilità di squilibri sui mercati reali).
Il sistema economico del modello neoclassico prevede l’esistenza di unostato stazionario: l’idea è che se Kpro-capite =cost. anche Ypro-capite=cost. Inassenza di progresso tecnico, ciò è possibile se la crescita del K segue lastessa velocità della crescita della Pop: ΔY/Y = ΔL/L = ΔK/K = n
Nello stato stazionario, l’ammontare del S è esattamente pariall’ammontare necessario per rimpiazzare il K usurato(ammortamento) e per consentire una crescita netta del K tale dapermettere il mantenimento della quota di Kpro-capite quando la Popaumenta a un tasso costante n. Nello stato stazionario Ypro-capite=cost.mentre Y aggregato cresce della stessa percentuale della popolazione(n) e non è influenzato dal tasso di risparmio.
17
Ruolo essenziale svolto dal progresso tecnico come frutto diapprendimento connesso con la produzione (learning by doing).
Secondo ROMER il processo di apprendimento comporta rendimenticrescenti di scala, incompatibili con l’assunto di perfetta concorrenza. Ilprogresso tecnico è reso endogeno (interno) al sistema economico,collegandolo ad elementi quali la spesa in R&S.
G può rafforzare il progresso tecnico e l’aumento della π derivanti daIprivati. Ciò costituisce una giustificazione dell’intervento pubbliconell’economia: l’impossibilità per gli investitori privati di appropriarsi ditutti i vantaggi derivanti dall’accumulazione implica in un’economia dimercato un tasso di crescita più limitato di quello socialmente efficiente.
In presenza di rendimenti costanti dei fattori, il tasso di crescita dellostato stazionario dipende dal tasso di accumulazione dei fattori. Inoltre, iltasso di risparmio influenza il tasso di crescita.
18
La domanda dipende soltanto dai prezzi relativi: D = f(pA/pB).
Se in un sistema economico di N mercati vi è equilibrio su N-1mercati, allora vi sarà equilibrio anche sul mercato rimanente.
Se si realizzano queste uguaglianze e sono rispettate le pre-condizioni diperfetta concorrenza, l’equilibrio risulta anche un ottimo paretiano, in virtùdel primo t.f. dell’E.B.
Regola del lato corto
Quando sul mercato non c’è equilibrio fra D e S, la quantitàeffettivamente scambiata coincide con la minore fra quella domandata (qD)e quella offerta (qS).
Il soggetto che non riesce a realizzare i suoi piani ottimali si dicerazionato.
19
(I) Eccesso di S sia sul mercato del L che sul mercato dei B. I lavoratorisaranno razionati (non tutta la SL troverà la corrispondente DL, e quindinon potrà essere scambiata); le imprese saranno razionate sul mercato deiB (non tutti i beni prodotti, SB, troveranno la corrispondente DB).
Disequilibrio: regime di disoccupazione keynesiana: anni Trenta.
(II) Eccesso di S sul mercato del L, eccesso di D sul mercato dei B. Ilavoratori saranno razionati sia sul mercato del L (esprimendovi una SL
eccessiva), sia sul mercato dei B (dove esprimono una DB eccessiva, chenon riesce a incontrare la corrispondente SB).
Disequilibrio: regime di disoccupazione classica. Paesi dell’Europadell’Ovest negli anni Settanta. 20
(III) Eccesso di D sia sul mercato del L che sul mercato dei B. Le famigliesaranno razionate sul mercato dei B (non trovando una sufficiente SB persoddisfare la loro DB); le imprese saranno razionate sul mercato del L (nontrovano una SL in grado di soddisfare la loro DL).
Disequilibrio: regime di inflazione repressa. Paesi del Blocco sovietico.
(IV) Eccesso di S sul mercato dei B, eccesso di D sul mercato del L. Leimprese saranno razionate sia sul mercato del L (esprimendovi una DL
eccessiva), sia sul mercato dei B (dove esprimono una SB eccessiva, che nonriesce a incontrare la corrispondente DB).
Disequilibrio: quarto regime. Curiosum teorico.21
In un sistema bimetallico, la moneta cattiva scaccia quella buona.
In un sistema monetario nel quale il valore nominale delle monete erapari al loro contenuto in oro o in metalli preziosi, era piuttosto comuneche le monete in circolazione perdessero parte del metallo prezioso di cuierano composte per effetto dell'uso o per la pratica illegale consistentenella “tosatura” (grattare, raschiare, tagliuzzare i bordi delle monete, percui nacque l’uso della zigrinatura del bordo). Accadeva così che alcunemonete, solitamente quelle in circolazione da più tempo, avesseroun valore intrinseco decisamente inferiore al valore nominale. In altritermini tali monete, considerate “cattive”, continuavano ad avereufficialmente un valore determinato dal tipo di moneta (oggi diremmo ilvalore su di esse stampato), mentre il loro valore intrinseco, determinatodal contenuto in oro, argento o altri metalli preziosi, era decisamenteinferiore.
22
In un sistema bimetallico, la moneta cattiva scaccia quella buona.
Poiché le monete, passando da uno stato a un altro, venivano fusee riconiate, le monete cattive potevano dare vita, in virtù della minorequantità di metallo prezioso contenutovi, a nuove monete di valorenominale (e intrinseco) inferiore al valore delle monete dalla cui fusionederivavano. Pertanto, nessuno era disposto ad accettare in pagamentola moneta cattiva, preferendo quella buona, vale a dire monete nuove dizecca, con un contenuto di metallo prezioso pari al valore della moneta.
23
La tesi generale della t.q.p. della M è che il livello generale dei prezzi (P),e quindi il valore della moneta che è espresso dal suo reciproco, dipendonodalla quantità di moneta (M):
M V = P Q (Eq. degli scambi di I. FISHER)
dove M: quantità di moneta esistente, V: velocità di circolazione dellamoneta, P: livello dei prezzi, Q: quantità dei beni.
M V: valore monetario delle vendite di beni
P Q: volume degli esborsi monetari (o delle transazioni)
Nella stessa misura in cui aumenta (o diminuisce) il valore delle merciche si vendono sul mercato, deve anche aumentare (o diminuire) l’esborsomonetario che si effettua per acquistarli.
Per i quantitativisti ortodossi, la moneta è sempre neutrale e ha soloeffetti nominali (o monetari), ma non reali. Infatti, per ipotesi V = cost. eQ = cost. Dunque, variazioni di M si scaricano necessariamente solo su P.
V = cost. perché dipende dalle consuetudini e dall’organizzazionedell’economia circa le modalità di pagamento delle transazioni.
Q = cost. perché per ipotesi il sistema economico è in grado diraggiungere spontaneamente la p.o. e Y*. 24
La “Scuola di Cambridge” introduce la distinzione tra quantità di Mdomandata (MD) e quantità di M offerta (MS), dove la MS dipende dalledecisioni delle autorità monetarie, mentre la MD dipende dalle decisionidel pubblico:
MD = k P Q (Eq. quantitativa della “Scuola di Cambridge”)
k = 1 /V
dove MD: quantità di moneta domandata, k: costante di Cambridge, P:livello dei prezzi, Q: quantità dei beni. Per ipotesi: V = cost. e Q = cost.
La MD dipende secondo una proporzione costante dal volume delletransazioni: MD = f(Q). Esiste uno sfasamento temporale fra debiti ecrediti.
Squilibrio monetario: MD e MS non coincidono necessariamente.
Domanda di moneta esercitata per 2 finalità:
- transattiva
- precauzionale (o cautelativo).
25
Legge di SAY
In un’economia di baratto, l’offerta crea la propria domanda.
Chi risparmia compie necessariamente un atto di investimento (S=I),assicurando così l’equilibrio sul mercato dei beni (IS). Non possono essercibeni invenduti: S = I
Mano invisibile
Principio descritto da A. SMITH, secondo il quale esisterebbe sui mercatiun meccanismo invisibile di regolazione, che permetterebbe diarmonizzare e di coordinare i vari interessi individuali. Solo il Mercatosarebbe in grado di procurare un benessere risultante da un ordinespontaneo, non voluto da alcuno ma realizzato da tutti. L’autoregolazionedel Mercato è invisibile nel senso che non è promossa espressamente danessuna volontà o autorità particolari. Andando anche a scapito distrategie meramente individuali, le transazioni globali (domanda eofferta) vengono rese reciprocamente compatibili.
26
I classici non attribuirono un vero ruolo alla M, giudicandola un velo,che porta a distinguere 2 mercati: quello reale e quello monetario(modello dicotomico, prevedendo una separazione fra aspetti reali easpetti monetari dell’economia).
Sul mercato reale avverrebbero le note dinamiche di riequilibrio sullabase della modifica dei prezzi relativi.
Sul mercato monetario si stabilirebbe unicamente il livello generale deiprezzi, a sua volta determinato dall’offerta esogena di M.
27
KEYNES propone:
- una diversa concezione della domanda di moneta (MD)
- una diversa concezione dei meccanismi attraverso i quali gli squilibrimonetari si trasmettono all’economia
- una diversa concezione del funzionamento del mercato del L.
Il sistema keynesiano prevede la non neutralità della moneta,sia nel b.p.che nel l.p. Infatti, per KEYNES la M e le sue variazioni non si riflettono sulvolume e sull’andamento della spesa complessiva in beni (MV).
KEYNES ritiene che V ≠ cost., perché la ritiene «un concetto che nonspiega nulla». Inoltre, egli rifiuta l’ipotesi di p.o., a causa dell’incapacità peri salari nominali (W) di diminuire quando u.
28
Per risolvere gli squilibri della disoccupazione classica (volontaria)sarebbe sufficiente p e W→ Teoria classica
Se i P sono perfettamente flessibili, condurranno i mercati in equilibrio;le situazioni di perdurante disequilibrio possono essere dunque attribuiteal mancato funzionamento della flessibilità dei P.
Per risolvere gli squilibri della disoccupazione keynesiana(involontaria) W sarebbe dannosa: se Yfamiglie allora DB, aggravandolo squilibrio presente sul mercato del L, già afflitto da eccesso di SL.
Problema: crisi degli anni ’30
Ricetta dei classici: W, stante un eccesso di DB
Ricetta keynesiana: G , stante un eccesso di SB
29
Disoccupazione keynesiana: regime in cui si ha contestualmente uneccesso di SL e di SB.
KEYNES parlò di equilibrio stabile di sottoccupazione cui giungerebbespontaneamente il Mercato, anziché di eccesso di SB.
La situazione è di disequilibrio rispetto ai piani ottimali walrasiani chenon riescono a essere realizzati, e pertanto i soggetti si trovano a essererazionati, ossia in una condizione nella quale non riescono a mettere inpratica le loro decisioni. Però, una volta che gli scambi si realizzino(secondo la “Regola del lato corto”) può accadere che gli agenti ritenganoche le decisioni prese siano ottimali, e quindi non vi sia motivo percambiarle. Dunque, essi si trovano in equilibrio. Se non interviene unamodifica esterna, ciascuno ritiene di aver operato la scelta migliore, inpresenza del vincolo comportamentale altrui. La situazione di equilibrio disottoccupazione keynesiana richiama la situazione di equilibrio di NASH,PARETO-efficiente, che si viene a stabilire in situazioni tipo “gioco deldilemma del prigioniero”. Infatti, le scelte operate da ciascun agente sonoottimali, dati i vincoli rappresentati dall’attuazione dell’altruicomportamento; ma se tutti si coordinassero per cambiare i propricomportamenti, si potrebbe pervenire a un miglioramento paretiano. 30
La situazione di equilibrio di sottoccupazione keynesiana rappresenta uncaso in cui tutti gli agenti sono soddisfatti del proprio comportamento(dato il livello di Y, il C è quello ottimale: C=C*, mentre dato il livello dellaDB, Y=Y*), ma se famiglie e imprese potessero coordinarsi in modocredibile, potrebbero scegliere assieme una situazione nella quale ciascunodi essi raggiunge il proprio equilibrio walrasiano.
L’intuizione di KEYNES fu quella di suggerire che i soggetti, presisingolarmente, non avevano la possibilità di arrivare a un accordo di questotipo, pertanto era necessario un intervento esterno e, nella fattispecie, unincremento della domanda generato dal policy-maker.
L’innovazione più rilevante di KEYNES rispetto alla teoria economicaclassica consiste nel riconoscimento della possibilità, in un sistemacapitalistico, di crisi produttive e disoccupazione, a causa dell’insufficienzadella domanda effettiva di beni (AD).
31
La teoria keynesiana della moneta
KEYNES muove dal presupposto che la M non può prodursi facilmente,avendo un’elasticità di produzione nulla: MS è un dato, deciso dalle autoritàmonetarie (ipotesi di rigidità della MS).
Per KEYNES la MD esprime la preferenza per la liquidità del pubblico(detenzione di mezzi liquidi vs. acquisto di beni reali o di titoli).
Domanda di moneta esercitata per 3 finalità:
- transattiva
- precauzionale (o cautelativa)
- speculativa.
Speculazione: acquisto di un’attività reale o finanziaria effettuato dalpubblico quando il suo P di mercato è basso, con lo scopo di rivenderlaquando P, in modo da lucrare sulla differenza.
Sussiste una relazione inversa fra PTit e iTit: iTit = (100 - PTit) / PTit
Quanto più è elevato il prezzo del titolo (PTit) tanto minore sarà il tassod’interesse pagato dal titolo stesso (iTit).
Se DTit e DTit > STit allora PTit mentre iTit
Se STit e DTit < STit allora PTit mentre iTit32
La teoria keynesiana della moneta
Se in un dato istante gli speculatori dovessero valutare PTit relativamentebassi, allora avrebbero convenienza ad acquistare titoli (DTit, PTit, i):pertanto essi MD
speculativa, cedendo M per acquistare Tit.
La MDspeculativa varia in ragione inversa rispetto a i: MD
speculativa = f(i)
La MDtransattiva+precauzionale varia in ragione diretta rispetto a Y:
MDtransattiva+precauzionale = f(PQ)
i è determinato dall’uguaglianza tra MD e MS.
Variando MS le autorità monetarie possono influenzare i.
Il tasso d’interesse d’equilibrio (i*), che è unico, è quello al quale non siverificano squilibri monetari: MD = MS.
i ha natura monetaria: esso scaturisce dall’incontro tra domanda eofferta di moneta (MD e MS).
I→ Y→ S33
Squilibrio monetario per la “Scuola di Cambridge”
Se MD = MS, ma il p.m. decide di MS, allora MS > MD: squilibriomonetario dato da eccesso di offerta di M. Il pubblico tende a liberarsi deimezzi monetari eccedenti (MD
transattiva+precauzionale = f(PQ)) aumentando lapropria spesa in beni ( C). Ma ciò conduce a PQ. E ciò porta a MD:equilibrio ristabilito, MS = MD. Inoltre, essendo per ipotesi in condizioni dip.o., l’offerta dei beni non può aumentare (mentre ne sta aumentando ladomanda): P. Lo squilibrio trova soluzione sul mercato (reale) dei beni.
I prezzi P costituiscono il meccanismo riequilibratore fra MD e MS.
Squilibrio monetario per KEYNES
Se MD = MS, ma il p.m. decide di MS, allora MS > MD: squilibriomonetario dato da eccesso di offerta di M. Il pubblico tende a liberarsi deimezzi monetari eccedenti aumentando la domanda di titoli ( DTit); ciòconduce a PTit e iTit. Lo squilibrio trova soluzione sul mercato(finanziario) dei titoli.
Il tasso d’interesse i costituisce il meccanismo riequilibratore fra MD eMS.
34
Per KEYNES gli investimenti privati (Ipr) sono determinati dal movente delprofitto: affinché vengano realizzati, è necessario che gli imprenditoriprevedano di ottenere da essi un rendimento almeno pari al costo delcapitale investito. Tale rendimento atteso dall’investitore deve esserealmeno pari all’interesse gravante sul prestito (qualora le somme investitesiano state mutuate), o al mancato interesse percepito (qualora l’impresaimpieghi fondi propri: autofinanziamento). Via via che nel sistemaeconomico si realizza un maggior volume di I, il saggio di rendimentoatteso (re) tende a diminuire.
35
Gli imprenditori effettueranno comunque tutti gli investimenti per i qualii tassi di rendimento attesi siano superiori, o al limite pari, al tasso diinteresse di mercato (r≥i). Se si fermassero prima di tale limite,rinuncerebbero ad attuare progetti che promettono comunque un margine,benché minore, di profitto. E ciò contrasterebbe con l’ipotesi dicomportamento razionale.
MS e MDspec determinano i*(=Oie). Gli imprenditori ne prendono atto,
effettuando investimenti pari a Oie, il volume di investimenti di equilibrio.
36
Condizione necessaria affinché venga effettuato un determinato progettodi investimento è l’esistenza di un tasso di rendimento atteso (efficienzamarginale del capitale) non inferiore al tasso di interesse sul mercato:
emgke >= i
- All’aumentare del volume degli I realizzati nel sistema economico, ilsaggio di rendimento atteso dagli investimenti addizionali tende adiminuire, essendo gli investimenti ulteriori meno promettenti.
- Verranno effettuati tutti gli I per i quali emgke >= i.
Ad alternativi volumi degli I corrispondono diversi livelli di emgk.
I* è determinato da emgk = i.
Per i classici: W è, innanzitutto, il costo dell’input lavoro (L).
Per i keynesiani: W è, innanzitutto, il reddito dei lavoratori (Y).
37
Y = C + I
c = ΔC/ΔY
Y = cY + I
Y = I * 1/(1-c) = I * 1/s
ΔY = ΔI * 1/(1-c) = ΔI * 1/s
con ΔY > ΔI e dove 1/(1-c): moltiplicatore degli investimenti.
ΔY = ΔI + c ΔI + c (c ΔI) + c [c (c ΔI)]+… = c0 ΔI + c1 ΔI + c2 ΔI + … + cn ΔI
0 < c < 1; 0 < s < 1; c + s = 1; 1/(1-c) > 1
- Le variazioni del reddito (ΔY) dipendono dalle variazioni degliinvestimenti (ΔI)
- supponendo c = cost. nel b.p., 1/(1-c) = cost.
- il moltiplicatore degli I agisce in modo da tradurre ogni data variazionedegli I in una variazione maggiore del Y.
Se c, (1-c), 1/(1-c), Y.
Se I, Y, N, u, W, C, Y,…: gli aumenti della spesa globale e delreddito sono maggiori rispetto all’incremento degli investimenti iniziali.
Un aumento iniziale della AD si traduce in una successione di aumentiindotti del Y.
38
Per KEYNES sussistendo una situazione di disoccupazione involontariadel L, variazioni del Y non suscitano variazioni dei prezzi (P). Se AD,allora le imprese potrebbero N e u, portando a S, ossia ( Y). Soloquando ci si trovi in p.o. aumenti del reddito (Y) provocano aumenti deiprezzi (P).
S = Y - C
S = Y – cY = Y (1-c)
Y = S * 1/(1-c) = S * 1/s
ΔY = ΔS * 1/(1-c) = ΔS * 1/s
Il reddito di equilibrio (Y*) è quello al quale corrispondono investimenti(I) pari ai risparmi (S): flusso circolare del reddito.
Una parte del reddito viene spesa dalle famiglie per l’acquisto dei beni diconsumo (C=cY), tornando alle imprese grazie alla vendita di questi beni.La parte residua del reddito viene risparmiata (S). Anche di questa leimprese vengono reintegrate, se gli ordinativi di beni di investimento (I)uguagliano i risparmi (S). In particolare, se I < S, la spesa globale dellacollettività (Y=PQ) sarebbe insufficiente a reintegrare le imprese dei costisostenuti nel processo di produzione.
39
Per i keynesiani «la moneta conta indirettamente», giacché M influenzai, ma sono le variazioni degli investimenti (I) a determinare l’andamentodel reddito (Y). E gli I dipendono soprattutto dalla produzione attesa (Ye)
M i I Y
La manovra di P.E. più efficace per i keynesiani è dunque quella dibilancio.
Per i quantitativisti «la moneta conta direttamente»: le variazioni dellaquantità di moneta (M) provocano quelle del reddito nominale (Y).L’andamento dell’economia, in quanto espresso principalmente dalcomportamento del reddito monetario (Y), è suscettibile di esserecontrollato attraverso la manovra dell’offerta di moneta (MS). Unandamento recessivo del reddito ( Y) che crei output gap (Y<Ye) puòessere contrastato con una politica monetaria (P.M.) espansiva. Alcontrario, un’espansione eccessiva del reddito ( Y), che rechi pressioni alrialzo dei prezzi ( P), essendo Y>Y*, può essere contenuta con una P.M.restrittiva.
40
Trappola della liquidità
Se si è in presenza di un’elasticità infinita della MDspeculativa, allora le
variazioni di MS non provocano variazioni di i, né degli I, e in definitivaneanche del reddito Y (che, secondo l’equazione del moltiplicatore degli I,dipende proprio dagli I).
La trappola della liquidità si manifesta quando gli operatori finanziaripreferiscono non investire in titoli poiché essi si aspettano che il loro valore(PTit) debba diminuire. Se ciò avviene essi detengono moneta, sterilizzandola manovra espansiva ( MS), in attesa del futuro aumento degli interessi.
Se si è in presenza di una perfetta rigidità degli I rispetto a i, allora levariazioni di MS possono provocare variazioni di i, ma non degli I, enemmeno del reddito Y.
La manovra monetaria incide sul livello del Y, nel migliore dei casi,attraverso ΔI. Ma tale interazione può risultare indebolita, o al limiteinterrotta, da alcune condizioni ostative.
Eutanasia dei rentiers: per KEYNES l’esistenza dei rentiers e i lororedditi, lungi dall’aver alcun effetto positivo nell’economia capitalista, neostacolano il funzionamento, sottraendo risorse e disincentivandol’accumulazione.
41
La visione della macroeconomia “classica” è molto simile a quella sottesaal concetto di “mano invisibile”: in un sistema capitalistico operano forzemosse essenzialmente dall’interesse individuale, capaci di assicurare dasole un equilibrio avente carattere di ottimalità. I fenomeni economiciappaiono allora alla stregua di manifestazioni di leggi naturali e non comeil prodotto, almeno in parte, del contesto istituzionale esistente, ridotto,invece, dai “classici” al puro operare di un’economia di baratto.
Il Mercato è pressoché l’unica istituzione considerata dai “classici”. Essinon ignorano l’esistenza della moneta, ma pensano che l’essenza delfunzionamento del sistema economico dal punto di vista reale possaessere ben rappresentata prescindendo dalla considerazione dellamoneta stessa. Ora, in un’economia di baratto vale certamente la “Legge diSAY”, ma in un’economia monetaria essa non è più vera. In una taleeconomia si potrebbe continuare ad assumere l’uguaglianza dei piani dirisparmio e di investimento, se si pensa che esiste un meccanismo capacedi riequilibrarli, ossia di coordinare le relative decisioni; si potrebbecioè ipotizzare l’esistenza di un prezzo del risparmio S (il tasso di interesse,i), i cui movimenti potrebbero consentire di uguagliare risparmio einvestimento I ex ante. 42
L’oggetto dell’analisi keynesiana è costituito dai movimentidell’occupazione prodotti da variazioni della domanda globale e/o deiparametri di comportamento.
KEYNES individua i due connotati essenziali del sistema capitalisticonell’esistenza di:
a) un’economia monetaria, che è largamente il prodotto di convenzioni oregole formatesi nel tempo;
b) classi sociali (lavoratori, capitalisti/imprenditori, rentiers), le cuiposizioni sono diversamente influenzate dai movimenti dei prezzi chereagiscono in modo differente a variazioni effettive o attese dei salari W, deltasso di interesse i e di altri prezzi.
L’analisi keynesiana contenuta nella “Teoria Generale” è fondata su alcuneipotesi semplificatrici, fra le quali conviene ricordare:
a) l’esistenza di un sistema economico chiuso, ovvero di una situazionenella quale esportazioni (X) e importazioni (M) sono nulle (X=M=0);questa ipotesi è stata successivamente rimossa da altri autori;
b) la considerazione di una situazione di breve periodo, il che comportache siano date la capacità produttiva e la tecnologia, le preferenze e leabitudini dei consumatori, il grado di concorrenza.
43
La vischiosità dei prezzi (in particolare la loro rigidità verso ilbasso) scaturisce dal contrasto in materia distributiva fra i varipercettori di reddito: ognuno di essi tenderà almeno a non fardiminuire il prezzo del bene che offre, temendo che i prezzi dei beni cheegli acquista rimangano invariati o aumentino.
Si consideri la rigidità del salario monetario (W).
Secondo i “classici” la flessibilità del salario reale (W/P), ottenutaattraverso una riduzione del salario monetario e una riduzione (meno cheproporzionale) dei prezzi (P), consentirebbe il raggiungimento di unreddito di piena occupazione (p.o.): se W e P, allora W/P.
Secondo KEYNES, invece, una riduzione del salario monetario e reale puòfar crescere l’occupazione ( N) soltanto a condizione che non ne restinegativamente influenzatala la domanda globale (AD), ciò che va legatoall’effetto della riduzione del salario sulle variabili dalle quali in ultimaanalisi la domanda stessa dipende: propensione al consumo (c), efficienzamarginale del capitale (emgk), tasso di interesse (i).
44
1. La caduta del salario reale ( W/P) induce una redistribuzione delreddito a danno dei lavoratori e a favore delle altre classi, fra le quali irentiers, che hanno una più bassa propensione al consumo (c).
2. La riduzione del salario di un paese migliora la competitività dellemerci del paese stesso, nell’ipotesi che i salari restino invariati all’estero.
3. La riduzione dei prezzi connessa con la caduta del salario monetarioprovoca un aumento del valore reale dei debiti, con possibilità difallimenti di impresa o, comunque, con una riduzione della propensionea investire. Si generano, poi, anche tensioni sui conti pubblici ( B).
4. La riduzione attuale del salario reale può indurre aspettative diulteriori riduzioni o, al contrario, di suoi aumenti nei periodi successivi,generando incertezza all’interno del sistema economico.
5. La riduzione del salario monetario accompagnata da una qualchediminuzione dei prezzi fa diminuire la domanda di moneta per transazioniper il pagamento dei salari stessi.
45
In generale, la molteplicità degli effetti prodotti dalle variazioni delsalario reale (W/P) induce a dubitare della capacità che esse possanoassicurare l’equilibrio del mercato del lavoro.
In un’economia monetaria le decisioni di risparmio sono separate daquelle di investimento (non vale la «legge di SAY»). In essa esiste ancheun’intrinseca instabilità del valore patrimoniale della ricchezza finanziariae del rendimento del nuovo capitale.
Essa introduce un’ulteriore fonte di incertezza, che può indurre gliindividui a rifuggire dall’impiegare la ricchezza in forme che nongarantiscano la conservazione del valore stesso, ossia a mantenersi liquidi.
In questo ambito, sottolinea KEYNES, il tasso di interesse (i) è laricompensa all’abbandono della liquidità per un certo periodo di tempo,ed è quindi il prezzo che equilibra domanda e offerta di moneta.
Il tasso di interesse è il compenso che spetta a colui che rinuncia adetenere la sua ricchezza in forma liquida; esso sarà tanto più alto quantipiù individui ci sono i quali pensano che in futuro il tasso di interesse saràalto; e, d’altra parte, qualsiasi livello di interesse che sia accettato consufficiente convinzione come probabilmente durevole, sarà durevole.
46
Per tutte queste ragioni, in un sistema capitalistico la domanda globale el’occupazione sono instabili e possono assestarsi su livelli lontani dalla p.o.
Nel pensiero di KEYNES l’intervento pubblico sotto forma di politicamonetaria e, soprattutto, di politica fiscale, è l’unica forza capace diriportare il sistema alla piena occupazione.
In situazioni belliche vi è la tendenza a una crescita eccessiva della AD,soprattutto a causa delle spese militari ( G) che, aggiungendosi alladomanda normale per consumi e investimenti privati, tipicamente provocaeccessi di domanda e inflazione (AD, p).
Nel corso della “Grande Guerra” la spesa pubblica fu dapprima finanziatain deficit (Dis>0, B). In seguito i governi cercarono di finanziare la spesacon la base monetaria ( BM), diminuendo il tasso d’interesse reale (r=i-p). Il risultato fu p.
La ricetta suggerita da KEYNES in occasione della S.G.M. fu, invece,quella di razionare i consumi privati ( C), proibire alcune forme diimpiego del risparmio, (quali l’acquisto di beni durevoli o preziosi) eincanalare il risparmio stesso verso i depositi bancari, utilizzati persottoscrivere titoli del debito pubblico, emessi a basso tasso di interesseper ridurre il costo del finanziamento. 47
L’analisi keynesiana supera sia la dicotomia del modello classico sia laneutralità della moneta (per KEYNES la moneta non è neutrale né nel b.p.né nel l.p.).
I limiti principali del sistema keynesiano sono essenzialmente 2:
- il ragionamento viene svolto in un sistema economico chiuso (senza X eM, ossia X=M=0), ovvero in un sistema dove la BilCom è in perpetuoequilibrio
- manca la dimensione intertemporale.
Per KEYNES «nel lungo periodo siamo tutti morti».
48
Nell’analisi kaleckiana, la retta DD’ indica la produttività marginale dellavoro (PML) al variare del numero dei lavoratori occupati (N).
Se il numero dei lavoratori in un certo periodo fosse L, pari a quello dip.o., e il salario reale corrente fosse w/p=OW, il valore del prodottoottenuto, ODEL, sarebbe distribuito fra lavoratori (in misura pari a OWEL)e capitalisti (la parte residua del prodotto WED). Si supponga che ilavoratori consumino tutto il loro reddito e, invece, che i capitalisti nonconsumino affatto, ma investano.
49
Se gli imprenditori non hanno aspettative ottimistiche sui rendimentifuturi degli I, essi non investiranno i profitti realizzati, e AD.
Se I=π, ossia pari a WED, il valore della domanda sarebbe proprio ugualea quello della produzione al livello di pieno impiego. Ma se non fosse cosìuna caduta dei salari monetari alla quale non si accompagni unaproporzionale riduzione dei prezzi potrebbe anche contribuire a ridurreulteriormente la domanda effettiva.
Secondo KALECKI, la dinamica dei sistemi capitalistici dipendeprincipalmente dalle decisioni di investimento delle imprese, collegatestrettamente ai profitti realizzati, che costituiscono un indicatore anche deiprofitti futuri.
Gli investimenti generano un incremento della capacità produttivasuperiore all’incremento di domanda, e la differenza fra questi due effetticresce all’aumentare del grado di monopolio e della quota dei profitti sulreddito.
Come KEYNES, anche KALECKI ritiene che il motore della produzionecapitalistica siano gli I e non i S: la spesa in I sa creare da sé le risorsenecessarie al proprio finanziamento.
50
PIGOU fa notare che esiste la possibilità astratta che il sistemaeconomico ritorni sempre a un livello di piena occupazione in presenza diperfetta flessibilità del livello assoluto dei prezzi.
Ipotesi: C = f(Y-T, M/P); shock esogeno che conduce a AD.
Ciò implica una caduta del livello generale dei prezzi ( P), suppostiflessibili, e un incremento del valore reale dei saldi monetari detenuti(M/P), che sale al di sopra del valore precedente, per ipotesi pari aquello desiderato.
Ne consegue la tendenza a spendere in beni di consumo l’eccedenza delvalore reale effettivo di detti saldi rispetto a quello desiderato ( C). Unsimile processo alimenta la domanda globale fino a riportare il sistemaalla piena occupazione ( AD): “effetto PIGOU”.
In termini diversi, vi è sempre la possibilità che il livello generale deiprezzi cada di tanto da far crescere il valore reale delle scorte monetarie aldi sopra di quello desiderato, nella misura necessaria a suscitarequell’aumento dei consumi capace di assicurare la piena occupazione.
51
PATINKIN si prefigge di dimostrare che, in presenza di p.o.,l’introduzione e la generalizzazione dell’“effetto PIGOU” superano ladicotomia classica ma, al tempo stesso, consentono di riaffermare laneutralità della moneta asserita dagli economisti pre-keynesiani.
Questa riaffermazione parte dalla constatazione che l’“effetto PIGOU” è(teoricamente) capace di riportare sempre il sistema in pienaoccupazione.
Se, in un tale sistema, varia l’offerta di moneta ( MS), si ha un aumentodel valore reale delle scorte monetarie ( M/P) (real balance effect):tale aumento è prodotto dalla quantità nominale di moneta ( M).
L’eccedenza che così si ottiene del valore reale delle scorte monetarierispetto alla quantità desiderata provoca un aumento della domanda diconsumi ( C, AD); ma, poiché il sistema è in posizione di p.o.,l’eccesso di domanda di beni (AD > AS) provoca un incremento dei prezzi( P) che continua fino a quando il valore reale delle scorte monetarienon ritorna al livello desiderato ( M/P): p = MS : “effetto PATINKIN”.
52
nd = e + v; ns = FL
dove nd: domanda di L; e: posti di lavoro “programmati” (ossiaeffettivamente occupati); v: posti di lavoro disponibili.
nd = ns non implica necessariamente che v ed u siano entrambi nulli,ma solo che le persone in cerca di occupazione sono esattamente pari alnumero dei posti vacanti. Anche in equilibrio (nd = ns, non vi è pressionesu w) esiste una quota di u “da ricerca”: ad ogni salario corrisponde unlivello di occupazione (e) pari al minimo tra nd e ns. I valori di e associatiad ogni livello di w costituiscono la “frontiera dell’occupazione”.
53
Nel singolo micromercato, la velocità di aggiustamento dei salari (Δw)sia proporzionale all’entità di eccesso di domanda (x), e x sia unafunzione inversa e non lineare del tasso di disoccupazione (u).
pe
54
L’esistenza di una funzione non lineare tra x ed u implica che a parità di tasso generale di disoccupazione si osservino valori di Δw tanto più elevati quanto maggiore è la dispersione di u tra i micromercati del L.
Si può cercare di contenere priducendo la dispersione della utra i mercati, favorendo una più rapida riallocazione del fattore La seguito di variazioni della nd o della tecnologia.
In base alla convenzione di CASAROSA:
- Relazione di PHILLIPS: lega il tasso di variazione del salario monetario(Δw) al tasso di disoccupazione (u) (curva di PHILLIPS originaria)
- Curva di PHILLIPS: lega il tasso d’inflazione (p) al tasso didisoccupazione (u) (curva di PHILLIPS trasformata).
PHILLIPS mostra che nei periodi in cui u, allora Δw. Il contrarioaccade quando u. Esiste una relazione inversa e non lineare tra Δw edu. La stabilità della curva di PHILLIPS permette al p.m. di scegliere lacombinazione ottimale tra p ed u lungo la curva di PHILLIPS del sistema.
55
PHELPS: hp: i posti di lavoro e i lavoratori sono eterogenei;l’informazione è incompleta (le imprese conoscono solo parzialmente lecaratteristiche dei lavoratori); la raccolta di informazioni è costosa.
In presenza di posti vacanti, la generica impresa offre un w > w*, se vuolattirare nuovi lavoratori. Tale differenziale salariale dipende dallecondizioni del mercato del L. Se u è elevato, il reclutamento è più facile.
In equilibrio: Δw = Δwe. Al di fuori dell’equilibrio le aspettative non sirealizzano e u < un se Δw > Δwe.
56
Il sistema ha la possibilità di attestarsi in corrispondenza di un tasso didisoccupazione u1 diverso da quello di equilibrio un, purché l’effettivainflazione salariale differisca da quella anticipata, per cui:
Δw = a ≠ Δwe = 0
Ciò è plausibile qualora si verifichi una mancanza di coordinamento trale imprese o sussistano delle asimmetrie informative.
In un simile contesto, una manovra di P.E. che riesca a u, con u < un,verrebbe convalidata se vi fosse l’effettiva possibilità di Δw.
Al contrario, qualora il sistema fosse sempre in grado di anticiparecorrettamente le oggettive condizioni del mercato del L, per cui Δw =Δwe, non ci si allontanerebbe da un.
57
Per i monetaristi il movente prevalente per la MD è quello delletransazioni. MD dipende dalla ricchezza totale (o reddito permanente,R.P.) di cui dispone la collettività: MD=f(Yl.p.). Si ipotizza uncomportamento di consumo tale da lasciare inalterato il tenore di vitanell’arco dell’intera esistenza. Il Yl.p. è molto più stabile del reddito di b.p.,perché è meno influenzato dalle fluttuazioni cicliche. Pertanto, anche laMD può essere considerata stabile nel l.p.
Ridimensionando la portata del movente speculativo, i monetaristiattenuano il legame tra MD e r, recuperando la t.q. della S. di Cambridge.
Se MS è nota, l’equilibrio monetario si ha solo in MD = MS. Ma se MD
dipende secondo una relazione stabile dal Yl.p., vi è un solo livello diequilibrio del reddito (Y*): cioè, un solo valore di Y* tale che MD = MS.Dunque, il reddito d’equilibrio è univocamente determinato.
Ciò comporta che nel modello IS-LM la LM tenda a verticalizzarsi,rendendo inefficace la P.F. Se G, allora Y. Ma gli individui sarannodisposti a C solo se ritengono che Y sia durevole. Inoltre, se lo Statocontinuasse a G, finanziandola in deficit con l’emissione di titolipubblici, provocherebbe lo spiazzamento degli I privati e ( PTit, r). 58
La variazione della G può rivelarsi inefficace già nel b.p., se essa vienepercepita come transitoria. Infatti, in tal caso essa non intacca il redditopermanente (Yl.p.) e non influisce, pertanto, sul consumo.
Comunque, anche se essa fosse efficace nel breve periodo, non losarebbe nel lungo, in quanto un aumento della G finanziato in deficitsenza emissione di moneta provocherebbe lo spiazzamento finanziariodella spesa privata sensibile al tasso di interesse, ossia di I.
59
L’aumento della G, spostando la IS (da IS0 a IS’) farebbe inizialmenteaumentare Y al di là del valore corrispondente al tasso naturale diproduzione (Yn) ma determinerebbe: un aumento del tasso di interesse( r) (punto B); un aumento del livello dei prezzi o del tasso di inflazione( p), che ridurrebbe la quantità di moneta in termini reali (M/P) eprovocherebbe uno spostamento a sinistra della LM, determinando cosìun ulteriore aumento del tasso di interesse, sino a che la domanda non siriporta al livello corrispondente a un (punto C).
60
Se MS > MD, l’eccesso di offerta di M si scarica sull’intera gamma dimercati sui quali si possa cedere M. I sostituti possibili della M sonomolteplici. Quanto più si allarga la gamma degli acquisti attivati cedendomezzi monetari, tanto più si riduce l’impatto dello squilibrio monetariosul solo mercato dei Tit: si allenta il legame tra MD e r.
Se MS, MS > MD e AD, per cui p.
Dunque p dipende da M: si ristabilisce la validità dell’equazionequantitativa della moneta.
Per FRIEDMAN la moneta non è neutrale nel b.p., mentre lo è nel l.p.
61
FRIEDMAN e i monetaristi concepiscono il sistema economico di mercatocome intrinsecamente stabile, a differenza dei keynesiani.
FRIEDMAN sostiene che la P.M. a meno di non causare crescenteinflazione ( P) non possa garantire né r < r*, né u < un.
Il tasso di interesse naturale (r*) è sostanzialmente il prezzo diequilibrio fra domanda di capitale (KD) e offerta di capitale (KS).
Il tasso naturale di disoccupazione (un) è quello in corrispondenza delquale il numero dei posti di lavoro disponibili è in una certa relazione diequilibrio con il numero dei lavoratori disoccupati; essendovi sostanzialeequilibrio fra domanda e offerta di lavoro, il salario tende a rimanerecostante.
Hp: r = r*; u < un.
Se M, attraverso l’aumento del valore reale delle scorte monetarie(M/P) porta inizialmente a una riduzione del tasso di interesse ( r) eun aumento della domanda di beni ( AD), in particolare di beni diinvestimento ( I), al quale si accompagna un aumento della produzione( Y). Al tempo stesso si ha N, reso possibile da un contemporaneoaccrescimento della domanda ( LD) e dell’offerta di lavoro ( LS). 62
Ciò costituisce un’apparente contraddizione: l’aumento della domandadi lavoro può avvenire soltanto se si suppone una riduzione del salarioreale ( W/P); d’altro canto, un aumento dell’offerta di lavoro ha luogosoltanto se si ipotizza un aumento del salario reale ( W/P).
L’incoerenza viene superata se si suppone che:
a) le aspettative degli individui siano adattive;
b) i vari operatori abbiano diversa informazione e diversi tempi direazione alle informazioni scaturenti dalla realtà: in particolare, leimprese sono più informate dei lavoratori dell’aumento dei prezzi passatio in corso; esse si attendono una flessione del salario reale e aumentano ilvolume degli investimenti e la loro domanda di lavoro; i lavoratori, alcontrario, notando un aumento dei salari nominali e non dei prezzi siattendono un aumento del salario reale e accrescono l’offerta di lavoro.
La curva di PHILLIPS originaria è la relazione inversa fra tasso divariazione dei salari nominali e tasso di disoccupazione: w = φ(u).
63
Non si potrà parlare di una sola curva di PHILLIPS, ma di un fascio dicurve di PHILLIPS di b.p., caratterizzate ognuna da un diverso valoredell’inflazione attesa (pe).
Se il tasso di inflazione attesa per il periodo t, pt, è pari al tasso diinflazione effettiva nel periodo precedente, pt-1, si avrà: wt = φ(ut) + pt-1
Si supponga che nel periodo zero il sistema sia da tempo indefinitonella posizione un: allora il tasso di variazione dei salari nel periodocorrente sarà w0 = 0.
64
Secondo la visione di FRIEDMAN, la P.M. può innescare un processoinflazionistico che tende ad autoalimentarsi.
Da questa analisi si possono trarre le implicazioni che seguono:
1. La P.M., secondo i neo-quantitativisti, è efficace soltanto nel b.p.; ossiariesce a garantire u < un soltanto per breve tempo; la possibilità di farloper un tempo più lungo implica che venga aumentata ulteriormente laquantità di moneta ( M), il che genera inflazione ( P). Pertanto,soltanto una crescente inflazione può garantire un tasso didisoccupazione minore di quello naturale.
2. Nel l.p. la curva di PHILLIPS, sempre secondo i monetaristi, è verticale;ossia per qualunque tasso di inflazione, vale u = un; non vi è pertanto untrade-off fra disoccupazione e inflazione, se non nel b.p.
L’azione monetaria deve svolgere il ruolo di “lubrificante”dell’economia: la variazione della quantità di moneta deve essere pari allavariazione media della sua domanda, che, se non cambia la velocità dicircolazione, corrisponde alla variazione del reddito reale, in un ambitodi stabilità dei prezzi: ΔM = ΔMD = ΔY (se V = cost.). 65
La duplice idea di fondo dei monetaristi è dunque che:
a) il sistema economico privato è sostanzialmente stabile, obbedendo aforze capaci di riportarlo su un sentiero di piena occupazione (il tassonaturale di disoccupazione), anche se turbato da shock esogeni;
b) l’azione pubblica è inefficace, se non nel breve periodo, e non incidesulle caratteristiche strutturali del sistema economico; ad esempio,l’abbassamento del tasso di disoccupazione effettivo non riesce a ridurreil tasso di disoccupazione naturale (NAIRU).
Per i monetaristi il tasso d’interesse ha natura reale: r = i – p, mentreMD
transattiva+precauzionale = f(PQ).
Per i keynesiani il tasso d’interesse ha natura nominale, mentreMD
speculativa = f(i).
66
Regola “semplice” (o automatica) della P.M.: consiste di interventidecisi di volta in volta dalle autorità monetarie; in situazioni di bassolivello della domanda si compirebbero azioni monetarie espansive e,viceversa, in caso di eccesso di domanda. In sostanza, se V = cost., ΔMS =ΔY, per evitare p.
La superiorità della regola automatica rispetto agli interventidiscrezionali non deriva soltanto dalla temporaneità degli effettisull’occupazione prodotti da quegli interventi e dal loro costo in terminidi inflazione, ma anche dalla possibilità che ne scaturiscano addiritturaeffetti perversi, a causa della lunghezza e variabilità del ritardo neglieffetti della politica monetaria: le conseguenze della politica monetariapotrebbero manifestarsi in un periodo nel quale la situazione economicaè del tutto mutata rispetto a quella che aveva consigliato l’interventomonetario. L’effetto sarebbe di aggravare, anziché temperare leoscillazioni cicliche (3 ritardi della P.E.).
67
Dal momento che i consumi di un individuo in genere si adeguano conun certo ritardo a brusche variazioni del reddito, il consumo dipendesecondo alcuni studiosi anche dal reddito precedente.
Supponiamo che un individuo da un anno all’altro abbia un forteaumento del suo reddito. Difficilmente egli accrescerà immediatamente isuoi consumi, ma li eleverà gradualmente, man mano che si abitua ainuovi standard di consumo. Il fenomeno per cui il reddito di un datoanno influenza non solo il consumo dello stesso anno ma anche quellodegli anni successivi è stato chiamato “effetto d’eco”.
MODIGLIANI, rilevando che il reddito di un individuo di solito è bassonel periodo iniziale e finale della vita, mentre è più elevato nel periodocentrale (quando è in età lavorativa), ha sostenuto che il consumo di unindividuo non dipende dal suo reddito corrente bensì dal redditopercepito durante tutto l’arco della vita: in vecchiaia, in età dipensionamento, l’individuo consumerà parte di ciò che ha risparmiatonel periodo centrale della sua vita (“teoria del ciclo vitale delconsumo”). 68
La N.M.C. rafforza il punto di vista dei monetaristi di primagenerazione, partendo da ipotesi ancor più ottimistiche sulle capacitàriequilibratici intrinseche al sistema economico privato, e giungendo aconclusioni ancor più negative sull’efficacia dell’intervento pubblico.
Due sono le ipotesi essenziali:
a) gli operatori formano le proprie aspettative in modo razionale,sfruttando tutte le informazioni disponibili, che non necessariamentesono complete. Una previsione razionale risulterà corretta in media;potranno esservi degli errori, ma questi avranno natura casuale e nonsistematica. L’introduzione di aspettative razionali (AR) equivaleall’ipotesi secondo la quale gli operatori si comportano come seconoscessero la teoria sottostante il modello. L’introduzione di AR in unmodello economico è un potente mezzo per far convergere le previsionidegli operatori sui risultati che scaturiscono dal modello stesso.
69
b) i mercati vengono continuamente riportati in equilibrio dalmovimento dei prezzi, che sono perfettamente flessibili; in particolare,il mercato del lavoro è sempre in equilibrio di piena occupazione. Ladisoccupazione esistente è sempre volontaria. Essa può ridursi, se vi èun aumento imprevisto del livello generale dei prezzi avvertito dalle soleimprese e non dai lavoratori.
Se, partendo dalla p.o., AD, p, W/P, N, LD, AS, W, (W/P)e, LS, u.
70
Sia A il punto di equilibrio di l.p. Hp: shock positivo: MS. Allora,AD0 → AD1 con equilibrio da A a A’, dove p (da p0 a p1), e Y (da Y0 aY1): effetto sorpresa. Se MS è transitorio, Y (in Yn) e p (in un).Infatti, p = pe. La AS non si sposta, e AD1 → AD0 (poiché MS ritorna alsuo livello iniziale).
P.M. espansiva: nel b.p. p.
71
Sia A il punto di equilibrio di l.p. Hp: shock positivo: MS. Allora,AD0 → AD1 con equilibrio da A a A’, dove p (da p0 a p1), e Y (da Y0 aY1): effetto sorpresa. Se MS è permanente, p (perché pe). La AS0 →
AS1, con equilibrio da A’ a A’’, dove p (da p1 a p2), e Y (da Y1 a Y0).Ciascun operatore, prevedendo un aumento generale dei p delle altremerci e del L in conseguenza dell’aumentata domanda, sarà disposto aoffrire una q minore. P.M. espansiva: nel l.p. p.
72
Gli effetti della P.M. possono essere esaminati considerando chel’aumento dell’offerta di moneta provoca un incremento della domandaaggregata e, pertanto, uno spostamento verso destra della curva AD.Pertanto, ogni aumento previsto dell’offerta di moneta avrà l’unico effettodi far aumentare i prezzi ( MS , p).
Se la manovra fiscale è prevista, essa lascia inalterato l’equilibriogenerale del sistema, scaricandosi immediatamente ed esclusivamentesui p. La curva di PHILLIPS è verticale anche nel b.p. La P.F. è, quindi, deltutto inutile e, anzi, produce addirittura risultati negativi, per l’inflazioneche ne scaturisce ( p).
Soltanto una P.F. imprevista e, si badi bene, imprevedibile sulla basedelle informazioni di cui si dispone, può avere efficacia; ma questa èassolutamente episodica.
I risultati della N.M.C. per la politica economica sono particolarmentedrastici e pessimisti: è esclusa ogni possibilità sistematica che le misure dipolitica economica modifichino permanentemente il livello dellaproduzione e dell’occupazione d’equilibrio (policy invariance). 73
Critiche mosse alle ipotesi di base della N.M.C.:
a) la tendenza a un continuo riequilibrio dei mercati;
b) il tipo di informazione disponibile;
c) il semplicismo con il quale vengono affrontati e risolti i numerosiproblemi derivanti nella realtà dalla scarsità delle informazionidisponibili, dai limiti nelle capacità di calcolo e di ottimizzazione, dallacomplessità dei processi di apprendimento dei parametri del modello.
74
Secondo LUCAS (1976), nel momento stesso in cui un’azione di P.E. vieneattuata, muta il quadro nel quale gli individui si muovono, e quindipossono mutare i criteri comportamentali degli individui, e i parametri dicomportamento considerati nelle equazioni comportamentali. Semutano i parametri, l’effetto della P.E. sulle variabili obiettivo èimprevedibile. Se il p.m. prendesse le proprie decisioni sulla base deivalori stimati dei parametri comportamentali, compirebbe un errorelogico, dato che i valori effettivi dei parametri cambieranno, proprio aseguito dell’azione di P.E.
Pertanto, in base alla critica di LUCAS, la P.E. ha sì effetto sulle variabilieconomiche, ma in un modo che non può essere previsto sulla base deicomportamenti osservati nel passato. Di conseguenza, LUCAS ritiene chesia meglio, per le autorità di P.E., astenersi da interventi attivi proprioperché l’esito del loro intervento è sempre imprevedibile.
Gli agenti privati e le autorità di P.E. sono legati da interdipendenzastrategica: il comportamento ottimale degli uni dipende dalcomportamento delle altre. In particolare, il meccanismo di formazionedelle aspettative si modifica in seguito a nuove misure di P.E.
75
Ripresa della “Legge di SAY”. Caso concreto: Reaganomics.
Se G e T, allora Ydisp, C, S, I, N, u, Y, T.
L’iniziale riduzione del gettito fiscale dovrebbe, alla fine del processo,essere più che compensata dall’aumento della ricchezza del Paese. Su taleragionamento si basa la “curva di LAFFER”.
76
“Curva di ARMEY”: l’idea alla base del lavoro di ARMEY è che con livellidi spesa pubblica molto bassi, lo Stato non riuscirebbe a garantire ilrispetto dei contratti e la protezione dei diritti di proprietà, e quindi untasso di crescita positivo. Al contrario, con quote molto elevate di spesapubblica, i cittadini avrebbero scarsi incentivi ad investire e produrre,giacché i livelli di prelievo sarebbero esorbitanti, ed anche in questo casola crescita ne soffrirebbe.
77
L’anarco-capitalismo è uno degli orientamenti della filosofiapolitica liberale e anarco-individualista (di area libertarian), dellafilosofia giuridica giusnaturalista contemporanea, ed è presenteprincipalmente nel mondo anglosassone.
Il principale riferimento intellettuale per l’anarco-capitalismo è l’operadell’economista e filosofo della politica ROTHBARD. Apparsa sulla scenaamericana nel corso degli anni Sessanta, questa teoria politica proponel’instaurazione di una società basata esclusivamente sul libero mercato enella quale sia eliminato ogni ricorso alla coercizione attraverso ilsuperamento dello Stato, intrinsecamente autoritario secondo gli anarco-capitalisti. A dispetto della denominazione, l’anarco-capitalismo non èanarchico nel senso tradizionale e socialista del termine, in quantoappare slegato e spesso anche contrapposto alle tematiche classichedell’anarchismo storico (quali il mutualismo, il socialismo,l’egualitarismo, l’anti-autoritarismo, l’anti-sessismo), mentre affonda leradici nella classica tradizione liberale e liberista, definendosi l’unicapossibilità di dare un contenuto realistico e coerente alla proposta diabolire lo Stato e la violenza che è insita in esso. Si propone di sostituire ilW.S. con le libere associazioni, le comunità volontarie e il filantropismo. 78