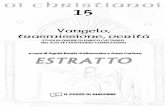Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda
RDE
Rivista di Diritto EllenicoReview of Hellenic Law
I I/ 2012
Edizioni dell’Orso
Frontespizi RDE II 1 feb 13.indd 3 19/05/2013 10.36.49
Rivista di Diritto Ellenico / Review of Hellenic Law
Pubblicazione periodica annualeRegistrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2 / 13 (31 maggio 2013)Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio
© Edizioni dell’Orso S.r.l.Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67E-mail: [email protected] – http: // www.ediorso.com
Stampata da Digital Print S.r.l. in Segrate (MI)per conto delle Edizioni dell’Orso
È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, com-presa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L’illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell’art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941
No part of this volume may be reproduced, or trasmitted, in any form or by any means, eletro-nic, mechanical, photocopying, or otherwyse. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171
ISSN 2239-6675ISBN 978-88-6274-459-1
Frontespizi RDE II 1 feb 13.indd 4 31/05/2013 13.34.14
Arduino Maiuri
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda*
1. Presentazione della vicenda.
Il secondo mimiambo di Eroda presenta un gustoso discorso giudiziario pronunciato da un tale Battaro, pornoboskÒj di professione1. La vicenda è
* Si tratta del testo inedito di un approfondimento seminariale che condussi nel 1997, al-l’interno delle attività previste nel Corso di Dottorato di Ricerca in Filologia Greca e Latina da me frequentato presso l’Università «La Sapienza» di Roma. Tra le uscite successive segnalo anzitutto l’interessante contributo di HENGSTL, 2004 che, sia pure con diverso profilo critico, può reputarsi integrativo rispetto al presente lavoro (il cui impianto lascio, comunque, delibera-tamente inalterato, tranne minimi aggiustamenti bibliografici, affinché le rispettive acquisizioni restino indipendenti e possano essere proficuamente armonizzate nei futuri studi in materia), e la recentissima edizione oxoniense di Eroda di ZANKER, 2009, dotata di introduzione, traduzione e commento in inglese.
1 B£ttaroj (v. 5) è un ¤pax legÒmenon. Secondo i moduli tipici dell’onomastica scenica si può accostare come nome parlante al verbo battar…zein («balbettare»), attestato anche come sinonimo di battologe‹n («parlare a vanvera»), in un certo senso l’accezione che qui sembra prevalente. Al v. 74, tuttavia, il lenone si dichiara un cinedo (k…naidÒj e„mi kaˆ oÙk ¢par-neàmai), per cui è possibile anche un’allusione oscena al sostantivo b£ttaloj (o b£taloj), «dissoluto»: infatti, data la sua origine straniera (v. 8), egli avrà avuto un nome diverso, esotico (come Talete: 'Art…mmhj, v. 38) e la scelta di un nome di battaglia allusivo al suo ‘mestiere’ non sarà stata certo casuale. Risulta interessante, infine, anche la lezione b£tracoj, tràdita dal De audiendis poetis di Plutarco (18 c) e verosimilmente dovuta al ‘gracidio forense’ del lenone. Nella letteratura latina il nome Battarus si trova nelle Dirae dell’Appendix Vergiliana (p. 73 s. Baehrens). Il tipo del lenone, originario della Sicilia e della Magna Graecia, è attestato sia nella Palai£ (cfr. Aristoph., Pax 848; Myrtil., fr. 5 Kassel, Austin) che nella Mšsh (Anassilao scrive una commedia intitolata `U£kinqoj pornoboskÒj), per poi conoscere un’ampia diffusione nella Nša (cfr. Philem., fr. 3 Kassel, Austin; Diphil., fr. 87 Kassel, Austin; Menand., Col. 71 Sandbach e il PornoboskÒj di Posidippo). Polluce (4.145) lo descrive così: Ð d� pornoboskÕj … t¦ d� ce…lh Øposšshre kaˆ sun£gei t¦j Ñfràj, kaˆ ¢nafalant…aj ™stˆn À falakrÒj (cfr. RO-BERT, 1911, p. 2, 15 s. e 54, nonché, più di recente, BERNABÓ BREA, 2001, p. 180-183). In Eroda compaiono tutti i tratti tipici del suo stampo, come l’impertinenza, l’avidità, la sguaiatezza e la grossolanità. È un tÒpoj anche quello delle percosse subite, quasi una ‘necessità naturale’ secondo Luc., Abdic. 21: pÒte ¢pÒkoitoj ™genÒmhn; t…naj pÒtouj ¢ka…rouj, t…naj kèmouj ™gkale‹j; t…j ¢swt…a; t…j pornoboskÕj Ûbristai; Anche nel mondo latino i lenoni sono spergiuri e infedeli, soprattutto quelli plautini (Ballione nello Pseudolus, Labrace nella Rudens, Dordalo nel Persa, Lico nel Poenulus, Cappadoce nel Curculio), che giocano un ruolo fonda-mentale nell’intreccio, mentre tinte più sbiadite presentano, come è naturale, quelli di Terenzio (Sannione negli Adelphoe e Dorione nel Phormio): cfr. STOTZ, 1920.
www.rivistadirittoellenico.it (1)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 107 19/05/2013 10.39.03
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
108 Arduino Maiuri
ambientata in un tribunale dell’isola di Cos2; oltre al lenone, il testo suggerisce la presenza di altre figure costitutive del processo, come Talete, il convenu-to3, Menne e Aristofonte, i due patroni4, Mirtale5, la fanciulla, il cancelliere (grammateÚj)6, l’addetto alla clessidra (Ð ™f' Ûdwr)7, nonché, naturalmente, i giudici (¥ndrej dikasta…)8.
Il mimiambo, pertanto, si rivela un articolato e movimentatissimo mono-logo del mezzano, con la sola eccezione del breve intervento del cancelliere, intorno alla metà della ·Ásij9.
2 Cfr. il v. 95. La datazione va probabilmente fissata intorno al 270 a.C., come si ricava dal riferi-mento ad ”Akh (v. 16), oggi S. Giovanni d’Acri, nella Galilea Occidentale. Proprio in quel periodo, infatti, la città, antico porto fenicio, mutò nome in Ptolema…j, dal Filadelfo. La genericità del riferi-mento cronologico non contrasta con le indicazioni desumibili da altri passi di Eroda (e.g. 1.30).
3 Battaro a più riprese si rivolge contro di lui, sia direttamente che indirettamente. Al v. 74, per esempio, ne sottolinea l’atteggiamento irridente (gel´j;) e non perde occasione per deni-grarlo. Talete è nome di chiara origine ionica.
4 Cfr. i v. 10-12: prost£thn nšmei MennÁn, / ™gë d' 'Aristofînta: pÝx nen…khken / Men-nÁj, 'Aristofîn d� k½ti nàn ¥gcei. Cito Eroda secondo l’ultima edizione teubneriana di CUN-NINGHAM, 2004, la quale tendenzialmente conserva la lettura del papiro data da KENYON, 1891. Le integrazioni in ordine ai versi mutili sono normalmente quelle proposte da TERZAGHI, 1925 = 1944. Un Mšnnhj è citato da Nicol. Dam., FGrHist 353 fr. 51; il nome, caratteristico dei pugili, è cor-radicale di Mšnaicmoj o MeneptÒlemoj. Battaro, però, tiene bene botta alle intenzioni intimida-torie di Talete, opponendogli un campione assolutamente all’altezza, Aristofonte – nome di atleta olimpionico in Paus., 6.13.11 –, il quale k½ti nàn ¥gcei (concordo sull’interpretazione letterale e non metaforica di queste parole, come allusive in senso proprio alle doti pugilistiche dell’uomo: cfr. DI GREGORIO, 1997, p. 129, che richiama il contrasto con pÝx nen…khken).
5 Deàro, Murt£lh, kaˆ sÚ: / de‹xon sewut¾n p©si: mhdšn' a„scÚneu: / nÒmize ktl. (v. 65-68). Anche in questo caso, come nel continuo rivolgersi di Battaro a Talete, il quale a sua volta sembra quasi «ringhiare», ammiccando al lenone, si hanno forti elementi di sceni-cità della rappresentazione del mimo di Eroda. Secondo MASTROMARCO, 1979, p. 70, «anche il mimo secondo che, per il suo carattere monologico, sembrerebbe maggiormente avallare l’ipotesi che i mimi di Eronda fossero recitati da un solo attore, era in realtà destinato alla rap-presentazione a cura di più attori». Murt£lh è nome di etera anche in 1.89: deriva certamente dal màrtoj, pianta odorosa propria della flora mediterranea, secondo il costume tipicamente comico di connettere i nomi delle etere con la qualità del loro profumo: si pensi ad 'AbrÒtonon negli 'Epitršpontej di Menandro. Anche il nonno e il padre di Battaro vantano nomi floreali (Sisumbr©j e Sisumbr…skoj, v. 76), che indicano effeminatezza e rappresentano uno striscian-te indizio della loro turpe professione (kºpornobÒskeun p£ntej, v. 77).
6 Ka…toi labèn moi, grammateà, tÁj a„ke…hj / tÕn nÒmon ¥neipe (v. 41-42).7 Kaˆ sÝ t¾n Ñp¾n bàson / tÁj kleyÚdrhj, bšltiste (v. 42-43).8 Richiamati in più punti del discorso, secondo una prassi tipica dell’eloquenza attica.9 Cfr. i v. 46-48. Nel processo attico la citazione del testo di legge era espressamente prevista
come uno dei mezzi di prova (si veda infra, p. 114 nt. 35), e così si spiega la richiesta di Battaro. Il principio allora vigente, iura non novit curia, comportava che il giudice fosse obbligato a giudicare secondo la legge, ma non per questo era tenuto a conoscerla, e quindi poteva anche non tenerne conto, se essa non fosse stata debitamente richiamata dalla parte interessata. Si noti come l’intera orazione rifletta la prassi giudiziaria ateniese, mentre non è possibile risalire ad
(2) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 108 19/05/2013 10.39.04
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 109
Sarà opportuno accennare brevemente ai motivi della contesa, prima di pro-cedere all’individuazione e all’analisi degli elementi parodici presenti nel testo, con particolare riferimento alle procedure e alla prassi giudiziaria attica10.
Battaro espone l’accaduto con parole sdegnate e colme di risentimento: il ricco11 ma prepotente Talete è penetrato nella sua abitazione, nottetempo e senza il suo consenso, per molestare Mirtale, una delle ragazze. Il lenone ha cercato di opporsi, ma invano, perché a sua volta è stato costretto a subire l’ira del giovinastro, che si è manifestata con percosse e danni alla casa12, configu-rando così un delitto di vis privata (a„k…a)13.
Il senso del monologo è dunque questo: i fatti chiaramente mostrano che Talete ha commesso gli illeciti di violazione di domicilio e violenza privata, per cui è opportuno che i giudici emettano la sentenza non già in base alle ca-ratteristiche personali delle due parti14, bensì secondo criteri di pura giustizia
eventuali riferimenti al diritto coo, per la penuria di informazioni in nostro possesso. La struttu-ra complessiva del mimiambo e le analogie con lo stile oratorio lasciano supporre, in ogni caso, un chiaro intento burlesco nei confronti della prassi giudiziaria attica.
10 Per le quali resta sempre valida l’ottima monografia di LAVENCY, 1965. Frequenti i riferi-menti al secondo mimiambo anche in GERNET, 1955.
11 QalÁj m�n oâtoj ¢x…hn t¾n nhàn / œcei tal£ntwn pšnt(e) (v. 3-4); ™x ”Akhj ™l»louqa / puroÝj ¥gwn k½sthsa t¾n kak¾n limÒn (v. 16-17); ple‹ t¾n q£lassan À cla‹nan / œcei triîn mnšwn 'Attikîn (v. 21-22).
12 Si veda la studiata gradualità del resoconto di Battaro relativo al trattamento oltraggioso subito da parte di Talete.
13 L’a„k…a (lesioni personali), la p»rwsij (lesione o privazione di un organo), l’omicidio (q£natoj), la rapina (¢rpag»), il plagio (desmÒj), la kakhgor…a (ingiuria verbale) e il prophlaki-smÒj (oltraggio) sono annoverati da Aristotele (Eth. Nic. 1132 a, 19-20) tra le ‘obbligazioni involonta-rie’ (sunall£gmata ¢koÚsia), in una prima categoria di atti illeciti commessi con la forza (b…aia); vi è, poi, il gruppo di rapporti obbligatori derivanti da atti illeciti commessi di nascosto (laqra‹a), come il furto (klop»), l’adulterio (moice…a), la falsa testimonianza (yeudomartur…a), il veneficio (farmake…a) e il lenocinio (proagwg…a). Da questa rapida rassegna si può notare subito come risulti estremamente comico il fatto che Battaro, reo anch’egli di un’illecito, peraltro proclamato, come l’esercizio del lenocinio, citi in giudizio Talete per un illecito diverso dal suo ma appartenente alla stessa categoria sinallagmatica. Si aggiunga che tra i sunall£gmata ¢koÚsia erano inclusi anche l’incendio (purkai£) e sotto certi aspetti il danno ingiusto (bl£bh), ma Battaro fa esplicita richiesta della sola legge sull’a„k…a, per incentrare, evidentemente, l’azione giudiziaria sul fattore umano, più rilevante agli occhi dei giudici. La d…kh a„k…aj si differenziava dalla graf¾ Ûbrewj perché perse-guiva un illecito privato e non un crimine, configurando la Ûbrij un comportamento violento perse-guibile da qualsivoglia membro della comunità: valutata un tempo dalla dottrina giusgrecistica come un illecito essenzialmente religioso (DEL GRANDE, 1947), oggi si tende a reputarla piuttosto un reato di tipo sociale, in quanto lesivo dell’altrui tim» (MAC DOWELL, 1976; CANTARELLA, 1983).
14 La discriminante non riguarda, infatti, lo status giuridico dei due contendenti, che è iden-tico, ma i diversi mezzi economici a loro disposizione. Si è detto della ricchezza di Talete: Battaro, ogni volta che la richiama, le contrappone la sua povertà. Così, se Talete ha una nave da cinque talenti, lui invece «neppure il pane» (mhd' ¥rtouj, v. 4); se il rivale è giunto recando fru-mento da Ace, egli ha portato pÒrnaj ™k TÚrou (v. 18); al mantello da tre mine attiche, invece,
www.rivistadirittoellenico.it (3)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 109 19/05/2013 10.39.04
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
110 Arduino Maiuri
e obiettiva valutazione dell’accaduto15.Tutto il discorso del pornoboskÒj può essere considerato l’imitazione di
un’orazione giudiziaria attica. La prima parte (v. 1-83) contiene, infatti, la pun-tualizzazione della posizione delle parti di fronte alla pÒlij, con la menzione dei rispettivi patroni (v. 8 ss.), l’esposizione della vicenda e le conseguenti accuse a carico di Talete (sapientemente tratteggiato sotto il profilo caratteria-le)16, la lettura del testo di legge e il richiamo ad ulteriori provvedimenti legi-slativi collaterali in materia (v. 46 ss.), la plateale esibizione delle piaghe di Mirtale, atta ad accrescere il p£qoj e ingenerare sdegno nei giudici (v. 65-71). Nella seconda parte (v. 84-102) si trovano, invece, secondo lo schema classico, perorazione e conclusione: Battaro, abbandonando la polemica con Talete, si rivolge direttamente ai giudici (v. 84-86), elevando il tono del suo discorso, sia dal punto di vista giuridico, dal momento che invita la giustizia di Cos ad operare con imparzialità, sia per i solenni richiami epico-mitologici, poiché chiama in causa le divinità tutelari dell’isola come garanti del corretto svolgi-mento del processo17. È proprio qui, del resto, che l’apologo raggiunge l’apice della sua vena umoristica e caricaturale, se si tiene conto della sordida natura dell’oratore e delle vili ragioni per cui egli osa attingere la sfera divina.
2. Status personale delle parti e capi d’accusa.
È sicuramente importante raccordare i fatti alla personalità giuridica dei due contendenti: Battaro, infatti, dichiara espressamente di essere un
fanno riscontro il mantelluccio (tr…bwna) e le ciabatte sdrucite (¢skšraj sapr£j) del v. 23. Si noti, infine, come i diversi mezzi a disposizione dei due contendenti siano pungentemente evidenziati dal lenone tramite la specificazione del loro rispettivo ambito operativo (q£lassan per Talete, al v. 21; gÍ per Battaro, due versi dopo).
15 La preoccupazione di Battaro è talmente forte da essere espressa a due riprese, ai v. 86 (gnèmV dika…V t¾n kr…sin diait©te) e 99-100 (p£nta t¾n d…khn ÑrqÍ / gnèmV kubern©te).
16 Dopo essersi scagliato veementemente contro l’avversario, di cui evidenzia a fosche tinte la protervia, mostrandogli un odio implacabile (lšont' ¥gcoim' ¥n, e„ QalÁj e‡h, v. 78), Bat-taro sposta il tiro soltanto ai v. 84 s., appena prima della peroratio, quasi rimanesse una sola, ultima, raccomandazione da fare ai giudici (Ÿn d' œstin, ¥ndrej – taàta m�n g¦r e‡rhtai / prÕj toàton – Ùme‹j ktl.).
17 Cfr. i v. 95-98: nàn de…xet' º Kîj kç Mšroy kÒson dra…nei, / kç QessalÕj t…n' e�ce kºraklÁj dÒxan, / kçsklhpiÕj kîj Ãlqen ™nq£d' ™k Tr…kkhj, / k½tikte Lhtoàn ðde teà c£rin Fo…bh. Cos era una ninfa, figlia di Merope, e l’isola era chiamata anche Merop…j (Steph. Byz., sv. Kîj). Tessalo era figlio di Eracle (Schol. Hom., Il. 14.255) e di Calciope, figlia di Eripilo, re di Cos, mentre iscrizioni locali attestano il culto ufficiale riservato allo stesso Eracle. Asclepio aveva un celebre santuario nell’isola (cfr. il IV mimiambo). Esiodo (Theog. 404 s.) riferisce che Febe generò Leto con Coio; la probabile confusione tra le voci Ko…oj e Kùoj può aver causato la successiva ambientazione della leggenda a Cos (Tac., Ann. 12.61: Coeum Latonae parentem).
(4) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 110 19/05/2013 10.39.04
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 111
meteco, come Talete18.La posizione dei meteci, tuttavia, non era uniforme19: ed è in questo senso
che va interpretato il timore incessante di Battaro di subire un trattamento ingiusto, come emerge dall’intera orazione20.
Considerando la capacità processuale e la legittimazione attiva dei meteci, va da sé che il magistrato cui si è rivolto Battaro per avere giustizia sia stato l’arconte polemarco, deputato dall’ordinamento della pÒlij a dirimere le loro specifiche controversie21.
Regolarmente, inoltre, il motivo della querela di Battaro è costituito dalla tutela di un suo interesse particolare, dal momento che i meteci avevano facol-tà di esperire solo azioni private (d…kai), ma non pubbliche (grafa…)22.
18 Oâtoj mštoikÒj ™sti tÁj pÒlioj kºgè (v. 8). Riferendosi alla realtà attica, non era infrequente che Atene, città dedita al commercio, accogliesse nel suo territorio cittadini pro-venienti da altre pÒleij (mštoikoi), che avevano uno status intermedio tra quello dei pol‹tai e degli xšnoi. Il meteco che si stabiliva in Atene aveva l’obbligo di porsi sotto la protezione di un prost£thj, per poter prendere parte alla vita civile della pÒlij. È nota, almeno nominal-mente, una graf¾ ¢prostas…ou che poteva essere intentata da chiunque contro un meteco che, anzitutto, risultasse privo di prost£thj. Funzioni del patrono nel V secolo a.C. erano quella di sostenere la richiesta di iscrizione del meteco nelle liste tenute dai demi e di garantire il versamento del meto…kion, una tassa che, al pari dello xenikÒn e dell’™pinÒmion, rivestiva un valore simbolico di riconoscimento da parte della pÒlij. Cfr. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF, 1887; PAOLI, 1957; LIPSIUS, 1905-1915 = 1966, p. 369-373. In questo mimiambo la figura del prost£thj (v. 10) sottende un’ulteriore funzione di assistenza a livello processuale da parte del patrono, sia pure con un forte accento caricaturale: cfr. Isocr., De pac. VIII.53 (toÝj m�n meto…kouj toioÚtouj e�nai nom…zomen o†ouj per ¨n toÝj prost£taj nšmwsin). Non sem-bra rivestire, invece, questa valenza tecnica il prost£thn (™pist£thn TERZAGHI, 1925 = 1944, p. 38) del v. 40, sia per la sua collocazione tra i termini generici nÒmon e ¥rconta che per la frequente attestazione nelle epigrafi di Cos di un collegio di prost£tai, assimilabili per fun-zioni ai prut£neij attici, secondo quanto fu già osservato da REINACH, 1891.
19 Solo alcuni privilegiati tra loro godevano dell’œgkthsij (il diritto di possedere immobili), dell’™pigam…a (il diritto di sposare una ¢st»: in realtà non ve ne sono attestazioni, perché di norma era concessa la cittadinanza al meteco reputato degno di contrarre giuste nozze con una ‘cittadina’) e della prÒsodoj (il diritto di comparire di fronte a Boul» ed 'Ekklhs…a per otte-nere favori a titolo personale). In particolare, quest’ultima prerogativa rispecchia la precarietà della condizione dei meteci per quanto riguardava la loro partecipazione alla vita politica: essi, infatti, erano esclusi dalle assemblee cittadine, pur prestando servizio nell’esercito (ma non tra i cavalieri) e nella marina, in virtù della loro iscrizione in liste speciali di demi e della conseguen-te inclusione negli elenchi delle tribù. Cfr. CASINI, 1964; MAFFI, 1972; WHITEHEAD, 1977.
20 Si veda infra, p. 119 nt. 49.21 Nell’ordinamento attico, lo stesso diritto era configurato diversamente in base al soggetto
destinato a farlo valere, per cui l’azione relativa doveva essere esperita di fronte a diversi fori (ad esempio, i meteci adivano il Polemarco, mentre un cittadino promuoveva l’azione presso i Quaranta e un commerciante, libero o schiavo, presso i Tesmoteti). Anche in ps. Demosth., In Steph. II, XLVI.14 un meteco promuove e sostiene personalmente l’accusa.
22 Le azioni ordinarie del diritto attico si distinguevano in azioni pubbliche, grafa…, e pri-vate, d…kai, a seconda della natura dell’interesse tutelato (si veda supra, p. 109 nt. 13). Allo
www.rivistadirittoellenico.it (5)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 111 19/05/2013 10.39.05
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
112 Arduino Maiuri
Buona parte della comicità della scenetta ideata da Eroda si fonda, dunque, sulla scelta di una lite fra due personaggi di rango non eccelso23, già di per sé tali da risultare ridicoli24; si aggiunga, poi, che tra i due discorsi è presentato proprio quello del lenone, più enfatico, provenendo dalla parte lesa, ma certa-mente anche più buffo, vista la professione del relatore25.
Battaro, secondo la prassi, sostiene personalmente la propria tesi, senza alcun patrocinio legale, ma recitando lui stesso la sua orazione dal bÁma, una sorta di pedana separata da quella dell’avversario, al quale spettava il diritto di replica26.
stesso modo, in diritto romano esisteva una netta linea di demarcazione tra gli illeciti pubblici (crimina) e privati (delicta). Va, tuttavia, notato come fosse proprio il clima sociale della cit-tà di Atene ad influenzare questa distinzione; ad esempio, il principio dell’inviolabilità della proprietà privata e quello della parallela inviolabilità della compagine familiare erano ritenuti interessi fondamentali per la pÒlij; di qui la loro trasposizione sul piano del diritto pubblico, e la conseguente repressione mediante graf» di reati come il furto e l’adulterio. Al contrario, l’azione diretta a perseguire l’omicida era rimessa alla sfera privata: infatti, mentre alla luce dei nostri principii giuridici l’omicidio non può non risultare un’offesa all’intera collettività, bisogna invece riconoscere che in questo caso l’ordinamento pluralistico ateniese ne mantenne, con la d…kh fÒnou, la primigenia modalità repressiva. Essa, infatti, era nettamente preesistente alla costituzione della pÒlij, in quanto attuata nella forma della vendetta da parte della famiglia dell’ucciso, e l’ordinamento statale si limitò semplicemente a disciplinarla, proibendo cioè la vendetta, ma conservando ai familiari la facoltà di perseguire privatamente l’omicida.
23 Per Talete, cfr. i v. 28-30: ×n crÁn ™autÕn Ôstij ™stˆ k¢k po…ou / phloà pefÚrht' e„dÒt' æj ™gë zèein / tîn dhmotšwn fr…ssonta kaˆ tÕn ½kiston; inoltre, la nota di profon-do disprezzo relativa alle sue origini frigie (sottintese anche dal riferimento proverbiale dei v. 100-101): ¢ll' Ñ FrÝx oâtoj, / Ñ nàn QalÁj ™èn, prÒsqe d', ¥ndrej, 'Art…mmhj (v. 37-38); e ancora, il riferimento alla condizione di perdurante e inguaribile barbarie del naÚklhroj (v. 55-56: ð Q£lhj, sÝ d' oÙk o�sqaj / oÜte pÒlin oÜte pîj pÒlij dioike‹tai) o della pre-carietà della sua residenza (v. 57-59: o„ke‹j d� s»meron m�n ™n Brikind»roij / ™cq�j d' ™n 'Abd»roisin, aÜrion d' ½n soi / naàlon dido‹ tij, ™j Fashl…da plèsV). Quanto a Battaro, a parte la generale grossolanità delle sue parole e delle sue argomentazioni, talora persino paradossali, è egli stesso a sottolineare la sua modesta estrazione sociale, ora quasi con un cenno di rimpianto (v. 9-10: zîmen oÙk æj boulÒmesq' ¢ll' æj ¹mšaj / Ñ kairÕj œlkei), ora con surreale vanagloria (v. 74: k…naidÒj e„mi kaˆ oÙk ¢parneàmai; segue l’indicazione dell’ereditarietà della sua turpitudine, con la ricostruzione dei precedenti pornobosko… della sua famiglia, in comica antitesi rispetto alla moda delle genealogie illustri).
24 Non è qui il caso di affrontare la complicata questione di una presunta rappresentazione scenica dei mimiambi di Eroda. In favore di tale ipotesi reca numerosi argomenti MASTROMAR-CO, 1979, passim. Già LEGRAND, 1902, p. 10 nt. 3, sosteneva che in questo mimiambo la parte dei giudici potesse essere agevolmente svolta dagli spettatori.
25 Sulla ¢maq…a di Battaro si sofferma in dettaglio USSHER, 1985, p. 52 s.26 Sarà utile fornire qualche indicazione procedurale sulle modalità di istruzione dei pro-
cessi, per poter correttamente inquadrare e ricostruire la vicenda dal punto di vista giuridico. L’atto iniziale dell’azione ordinaria (pubblica o privata) era la prÒsklhsij, citazione orale, fatta dall’attore al convenuto, alla presenza di uno o due testimoni (klhtÁrej). Dalla citazio-ne alla comparizione doveva trascorrere un intervallo non inferiore a cinque giorni, durante i
(6) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 112 19/05/2013 10.39.05
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 113
È interessante notare come il lenone dissemini le sue accuse contro Talete in più punti dell’orazione, riportando ogni volta sotto una diversa angolazione i mi-sfatti del convenuto, in modo da convincere i giudici che non vi siano dubbi sulla gravità dei danni che ha subito e sulla necessità di una loro adeguata condanna.
Per cominciare, il primo riferimento27 mette in evidenza fondamental-mente tre concetti: l’uso della violenza (b…V); il mancato rilascio del per-messo (œm' oÙ pe…saj), l’aggravante costituita dal fattore notturno (kaˆ taàta nuktÒj)28. Si tratta, in realtà, solo di un accenno, rispetto all’espo-sizione che sarà fatta più compiutamente in seguito, ma l’individuazione dei principali motivi di lamentela da parte del lenone è mirata e consape-
quali era cura dell’attore presentare al foro del magistrato un esposto riassuntivo dei motivi dell’accusa e delle sue pretese, precisandone il fondamento giuridico. L’istruttoria (¢n£krisij) aveva lo scopo di raccogliere tutti gli elementi necessari per il giudizio: al magistrato spettava il compito di conservare i mezzi di prova prodotti dalle parti per trasmetterli al tribunale elia-stico (Aristot., Ath. pol. 49.1), ossia uno dei dieci dikast»ria in cui erano distribuiti i seimila membri dell’Eliea (cittadini iscritti nelle apposite liste e soggetti a kl»rwsij: unici requisiti per essere eliasti erano il compimento del trentesimo anno di età e la sanità mentale). Raccolti i mezzi di prova, fissato il giorno del dibattito e costituito il collegio giudicante, la contesa passava dal magistrato istruttore al presidente del tribunale appositamente creato, la cui composizione numerica variava a seconda del tipo di processo (ad esempio, occorrevano 501 giudici per le cause pubbliche, 401 per le private di di valore superiore alle 1000 dracme e 201 se di valore inferiore, almeno nel V secolo a.C.). Il presidente nominava immediatamente dieci giudici, uno in rappre-sentanza di ciascuna tribù, con compiti speciali: uno controllava il tempo concesso ad ogni oratore per la sua arringa, misurandolo con la clessidra (si tratta dell’Ð ™f' Ûdwr: cfr. i v. 42-43; il tempo a disposizione variava a seconda della causa, tuttavia la sua unità di misura era sempre l’¢mforeÚj, diviso in dodici coa…); altri quattro fungevano da scrutatori, mentre i rimanenti cinque sorveglia-vano l’operato dei precedenti. Quindi l’araldo chiamava la causa e il cancelliere (grammateÚj, v. 41) dava lettura dell’istanza e della controistanza delle parti, le quali venivano allora invitate a parlare. È a questo punto che si colloca il discorso di Battaro, certamente il primo a prendere la parola, per sostenere l’accusa. Va sottolineato come siffatte orazioni fossero di regola composte da logografi professionisti, abilissimi nell’intesserne le trame: di qui l’accentuata comicità delle espressioni triviali di Battaro, assolutamente improponibili in un vero discorso giudiziario, di cui, come si vedrà, la ·Ásij del lenone è parodia buffonesca e caricaturale.
27 B…V tin' ¥xei tîn ™mîn œm' oÙ pe…saj, / kaˆ taàta nuktÒj (v. 24-25). Lo sdegno è sapientemente accresciuto dal poliptoto.
28 L’elemento notturno ha avuto sempre un ruolo determinante nella configurazione giuridi-ca dei delitti. A Roma, per esempio, in caso di furto flagrante (furtum manifestum), il derubato di notte poteva uccidere il ladro, se lo coglieva sul fatto (fur nocturnus), invece di giorno solo se era a mano armata (fur diurnus qui telo se defendit) e previa endoploratio (invocazione del soc-corso dei vicini, a testimonianza dell’aggressione subita); negli altri casi di flagranza, invece, il libero esercizio della vendetta non era consentito e il ladro veniva semplicemente fustigato e addictus al derubato (Cic., Tull. 20; Macr., Sat. 1.4.19 = XII Tab. 8.12-13). L’aggiunta di Battaro, pertanto, non è insignificante, e la congiunzione ka… qui sembra caricarsi di un marcato valore intensivo («e per di più»).
www.rivistadirittoellenico.it (7)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 113 19/05/2013 10.39.05
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
114 Arduino Maiuri
vole, e il contesto prescelto solenne ed enfatico29.Qualche verso più avanti, invece, i misfatti di Talete sono presentati in for-
ma negativa, secondo un interessante procedimento e contrario30: essi risulta-no, infatti, tanto più gravi laddove si consideri che mai li avrebbero perpetrati non solo i tÁj pÒlioj kaluptÁrej, che sopravanzano di gran lunga per digni-tà il meteco Talete31, ma neppure i semplici cittadini (oÙdeˆj pol…thj).
In questo caso, pur essendovi qualche consonanza rispetto al primo ac-cenno32, i fatti sono riportati con maggiore dovizia di particolari, aggiun-gendosi gli elementi delle percosse subite dallo stesso Battaro (ºlÒhsen), della violazione di domicilio (Ãlqen / prÕj t¦j qÚraj meu) e dei danni materialmente arrecati alla struttura (œcwn d´daj / t¾n o„k…hn ÙfÁyen), mentre anche la violenza arrecata a Mirtale, già menzionata in precedenza, riceve ulteriori specificazioni33.
Una completa descrizione dell’accaduto si colloca, invece, finalmente, dopo il breve intervento del cancelliere, espressamente richiesto da Battaro34 e previsto dalla prassi giudiziaria attica come uno dei mezzi di prova35.
29 Vi compare, infatti, un primo accenno alla portata generale dell’episodio, che attenta al-l’aÙtonom…h dell’intera pÒlij (v. 27), preoccupazione che torna insistentemente nel mimiambo: koÙk ™pVdšsqh / oÜte nÒmon oÜte prost£thn oÜt' ¥rconta (v. 39-40); sÝ d' oÙk o�sqaj / oÜte pÒlin oÜte pîj pÒlij dioike‹tai (v. 55-56). Per di più, il medesimo procedimento di universalizzazione della vicenda porta Battaro a estendere il discorso non solo a coloro che fanno parte della pÒlij, che sono i primi responsabili e interessati al corretto funzionamento dei meccanismi giudiziari (cfr. i v. 31-33: nàn d' o„ m�n ™Òntej tÁj pÒlioj kaluptÁrej / kaˆ tÍ genÍ fusîntej oÙk ‡son toÚtJ / prÕj toÝj nÒmouj blšpousi), ma a tutti gli stranieri residenti in città, ognuno dei quali si sarebbe potuto trovare in quelle condizioni (cfr. i v. 92-94: tÕ loipÒn, ¥ndrej, m¾ doke‹te t¾n yÁfon / tù pornoboskù Batt£rJ fšrein, ¢ll£ / ¥pasi to‹j o„keàsi t¾n pÒlin xe…noij). Si tratta in realtà, come si vedrà meglio in seguito, di uno dei numerosi procedimenti retorici impiegati a bella posta da Eroda.
30 Kºm� tÕn xe‹non / oÙdeˆj pol…thj ºlÒhsen oÙd' Ãlqen / prÕj t¦j qÚraj meu nuktÕj oÙd' œcwn d´daj / t¾n o„k…hn ÙfÁyen oÙd� tîn pornšwn / b…V labën o‡cwken (v. 33-37).
31 Kaˆ tÍ genÍ fusîntej oÙk ‡son toÚtJ (v. 32).32 NuktÒj (v. 35) e b…V (v. 37).33 Il generico tin' ¥xei tîn ™mîn (v. 24) è sostituito dal concreto tîn pornšwn … labën
o‡cwken, in cui ricevono una specificazione sia l’elemento personale (pornšwn), che quello dell’azione verbale (labën o‡cwken: cfr. il v. 71, e�lken aÙt¾n k¢bi£zeto).
34 Ka…toi labèn moi, grammateà, tÁj a„ke…hj / tÕn nÒmon ¥neipe (v. 41-42). Compare qui esplicitamente per la prima volta il nome dell’accusa intentata dal lenone.
35 Dagli argomenti recati dall’oratore per provare il proprio assunto (p…steij œntecnoi) si distinguevano le prove raccolte durante il periodo istruttorio (¥tecnoi), che Aristot., Rhet. 1375 a classifica in nÒmoi, m£rturej, sunqÁkai, b£sanoj e Órkoj. La retorica romana traduce le due espressioni con probationes artificiales e inartificiales. Sul nÒmoj come mezzo di prova nel processo attico si veda MAFFI, 1976; sui mezzi di prova in ge-nerale SOUBIE, 1973. Un’attenta analisi della testimonianza aristotelica si ha in HARRISON,
(8) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 114 19/05/2013 10.39.06
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 115
Il testo di legge citato dal grammateÚj è stato certamente adattato all’epi-sodio concreto: ™p¾n d' ™leÚqerÒj tij a„k…sV doÚlhn / À ˜kën ™p…spV, tÁj d…khj tÕ t…mhma / diploàn tele…tw (v. 46-48). Una spia in tal senso è rappresentata dal femminile doÚlhn, dovuto al riferimento a Mirtale, in luogo del maschile atteso. Si sarà trattato, con ogni probabilità, di una disposizione legislativa che non rimetteva alla stima delle parti e alla decisione del giudice la determinazione della pena pecuniaria, ma la fissava essa stessa36, raddop-piandola37 in caso di premeditazione (˜kèn)38.
1971, p. 133-154, e MARTIN, 1974, p. 97-101. Nel secondo mimiambo mancano i testimoni (¢martÚrwn eÜntwn, v. 85, riferito ai giudici): non sfugge, tuttavia, l’ingente valore pro-batorio, quantunque non giuridicamente configurabile come martur…a, del patetico ingres-so di Mirtale dei v. 65-71. Inoltre il ricorso alla b£sanoj è sollecitato con fare spavaldo dallo stesso Battaro (kºj b£sanon a„tÍ, prosd…dwmi k¢mautÒn, v. 88), né manca una sottile allusione alla solennità dell’Órkoj, considerato l’insistito riferimento alla sfera di-vina presente nei v. 95-98.
36 L’¢gèn attico era, infatti, per lo più timhtÒj, ossia diretto alla stima del pregiudizio sof-ferto dall’attore ad opera del convenuto. In questo tipo di procedimento giudiziario, i giudici dovevano stabilire Ó ti cr¾ paqe‹n À ¢pote‹sai, cioè la pena afflittiva o pecuniaria del reo. Pertanto si effettuavano due votazioni: nella prima si stabiliva la colpevolezza o meno dell’ac-cusato; nella seconda si decideva fra la pena proposta dall’attore e quella autostimata dal con-venuto (celebre il caso di Socrate, il quale, al termine del suo processo, descritto da Plato, Apol. 36-38, si riconobbe meritevole di ottenere il mantenimento vitalizio nel Pritaneo per il suo ser-vizio civico, mentre l’accusa chiedeva la pena di morte). Un caso di d…kh (bl£bhj) ¢t…mhtoj che può essere, invece, avvicinato alla fattispecie in questione, è rappresentato dall’orazione demostenica Contro Callicle (LV); l’azione relativa, esperita da Callicle per danni causati da un vicino a un suo fondo (perˆ cwr…ou) prevedeva un’ammenda (t…mhma) predeterminata dal legislatore nell’ammontare di 1000 dracme.
37 Non era infrequente, nel diritto antico, che in presenza di particolari circostanze la puni-zione del reo venisse raddoppiata. Nel processo romano, ad esempio, esisteva una particolare categoria di azioni, definite miste, con le quali si perseguiva sia la res che la poena (Gai. 4.9). Si trattava, cioè, di cause in duplum (= diploàn), nel senso che esse erano volte ad ottenere con un simplum il risarcimento del danno (la res), e con l’altro la poena, ossia la punizione vera e propria del convenuto.
38 Cfr. i v. 47-48, in cui il cancelliere dà lettura del testo di legge, specificando che, ove l’illecito venga commesso volontariamente, il valore della lite si raddoppia. La lezione ˜kën, a onor del vero, è stata messa in discussione dal Rutherford, il quale ha proposto di sostituirla con œ‹l›kwn, ipotesi di per sé paleograficamente plausibile, ma che presenta lo svantaggio di depri-vare il contesto del suo senso specifico. Tra gli editori moderni l’unico ad accogliere l’emen-dazione è Cunningham, mentre gli altri mantengono il testo tràdito da P. La teoria dell’atto volontario è stata esposta da Aristotele nell’Etica Nicomachea (1111 b - 1112 a; 1135 a-b): per-ché un’azione possa essere ritenuta tale, è necessario che sia compiuta con la consapevolezza delle cose che dipendono dall’agente, senza ignoranza né della persona, né del mezzo, né del fine a cui è diretta. Aristotele, inoltre, distingue la volontarietà in presenza di premeditazione (™k prono…aj) da quella non premeditata (m¾ ™k prono…aj), per cui i danni (bl£bai) possono essere di tre tipi: causati per ignoranza (¢mart»mata); verificatisi paralÒgwj (contro ogni
www.rivistadirittoellenico.it (9)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 115 26/05/2013 9.52.50
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
116 Arduino Maiuri
In seguito alla lettura della legge39, Battaro avverte l’esigenza di porre in migliore sintonia le sue accuse con il dettato normativo, e così il suo resocon-to assume una veste più puntuale e giuridicamente fondata40. Subito dopo, sollecitato l’intervento del cancelliere e addirittura citate a mente tutte le altre disposizioni legislative che potevano adattarsi al suo caso, con i relativi risvol-ti pecuniari, il lenone ripete per l’ultima volta gli illeciti commessi da Talete nei suoi confronti, con un’evidenza ormai decisiva (v. 63-65): pÝx ™pl»ghn, º qÚrh kat»raktai / tÁj o„k…hj meu, tÁj telšw tr…thn misqÒn, / t¦ Ùpšrqur' Ñpt£. È notevole il senso di impersonalità che Battaro riesce ormai a conferire agli effetti dell’azione deleteria di Talete, del quale non c’è più bi-sogno neppure di fare il nome: parlano da soli, infatti, i risultati tangibili della sua irruzione. L’unica concessione personalistica che si concede il lenone è l’espressione parentetica tÁj telšw tr…thn misqÒn, la cui interpretazione, peraltro, ha creato non pochi problemi agli studiosi41.
L’oratore passa, a questo punto, al pezzo forte delle sue argomentazioni: dimostrato a parole il comportamento violento e irriguardoso del suo avver-sario nei confronti di sé e dei propri beni, riserva ai giudici uno spettacolo particolarmente idoneo ad esecrare in iure la ferocia di Talete. Chiama, difatti, accanto a sé Mirtale e la invita a denudarsi in pubblico, per mostrare ai presen-
ragionevole previsione: si tratta degli inconvenienti della sorte, gli ¢tuc»mata); provocati e„dîj (consapevolmente). Solo a questi ultimi tocca la qualifica di ¢dik»mata, cioè di atti ingiusti commessi volontariamente (˜kën). Qualora essi siano addirittura premeditati (™k proairšsewj), sono indice di malvagità da parte dell’autore: si tratta del caso in questione, che Battaro vuole dimostrare appartenente alla categoria più riprovevole degli atti illeciti, e indegno, pertanto, di qualsiasi attenuante o giustificazione. Sul significato della tripartizione aristotelica si distendono FECHNER, 1885 =1964, p. 49 s., e BRETONE, 1975; sulla bl£bh, invece, MUMMENTHEY, 1971.
39 O, meglio, del particolare caso rilevante ai fini della fattispecie in questione: poiché i casi della legge dovevano essere diversi, qui è prescelto quello delle violenze fatte da un libero a uno schiavo.
40 —Hn qÚrhn dš tij kÒyV, / mnÁn tinštw, fhs': Àn d� pÝx ¢loi»sV, / ¥llhn p£li mnÁn: Àn d� t¦ o„k…' ™mpr»sV / À Ôrouj ÙperbÍ, cil…aj tÕ t…mhma / œneime, kÀn bl£yV ti, diplÒon t…nein (v. 50-54). La concitazione di Battaro aumenta, dal momento che si stanno toccando i termini del risarcimento, che per lui sono di vitale importanza, come dimostrano i v. 79-80, di inaudito cinismo: ™r´j sÝ m�n ‡swj Murt£lhj; oÙd�n deinÒn: / ™gë d� puršwn: taàta doÝj ™ke‹n' œxeij. Battaro praticamente scompone i singoli atti di a„k…a di Talete e vi affianca la corrispondente ammenda pecuniaria, al fine di ricavare il massimo vantaggio dalla futura stima dei giudici.
41 Secondo KNOX, HEADLAM, 1922 = 1966, p. 92, per la pigione di Battaro occorrerebbe un ter-zo (tr…thn, scil. mo‹ran, lezione originaria di P, poi sostituita dal copista con misqÒn) dei proventi della sua attività; RUTHERFORD, 1891, p. 38, pensa invece che Battaro abiti in sunoik…a con due coinquilini, con cui spartirebbe le spese del fitto; TERZAGHI, 1925 = 1944, p. 43, ipotizza che il lenone gestisca la casa per appuntamenti con altri due soci; particolarmente originale NAIRN, 1904, p. 24, il quale, sulla base di Hesych., e 1718 Latte (›kth, tr…th, tet£rth: nom…smata ¢rgur…ou kaˆ calkoà), propone l’identificazione del numerale con «un terzo di statere» (al mese: quattro stateri l’anno), con misqÒn in funzione appositiva. Infine CUNNINGHAM, 1971, p. 95, ritiene che tr…thn indichi il terzo del valore dello stabile affittato dal lenone e motiva questa cifra
(10) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 116 19/05/2013 10.39.06
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 117
ti gli effetti devastanti della violenza subita42.Non sembra ozioso ricordare come un siffatto espediente abbia un insigne
precedente nell’oratoria giudiziaria attica: Iperide, infatti, fece vincere a Frine la lite esibendone le bellezze senza veli43.
Non c’è dubbio, poi, tenendo conto della dichiarata ambiguità morale di Battaro44, che una simile forma di captatio benevolentiae dovesse risultare un accorgimento malizioso ed opportunistico non esente dall’intenzione di pro-vocare gli appetiti e condizionare le valutazioni dei giudici45.
Il riferimento implicito ma evidente a un grande oratore come Iperide può essere assunto come una prova significativa che il secondo mimiambo di Ero-da sia una sottile imitazione in chiave parodica di un’orazione giudiziaria46.
così elevata sia con i danni che i frequentatori potevano arrecare alla casa, sia con la tendenza all’esagerazione propria di Battaro (cfr. i v. 21-22, in cui dichiara che il mantello di Talete vale tre mine attiche, mentre questo è il costo di uno schiavo, e Aristoph., Pl. 928, che fissa il prezzo di un ƒm£tion in appena venti dracme). Concludendo, l’unico dato certo nell’interpretazione dell’espres-sione adoperata dal mezzano nel v. 64 è che doveva trattarsi di un misqÒj davvero considerevole.
42 'OrÁt' ¥ndrej, / t¦ t…lmat' aÙtÁj kaˆ k£twqen k¥nwqen / çj le‹a taàt' œtillen çnag¾j oâtoj, / Ôt' e�lken aÙt¾n k¢bi£zet(o) (v. 68-71). Secondo HOUSMAN, 1922, p. 109, Battaro intende far passare la depilazione di Mirtale (le‹a), caratteristica di tutte le donne, e non delle sole etere (KILMER, 1982), come il risultato delle percosse di Talete: in ogni caso, sem-bra di poter individuare in questa scena un elemento in favore dell’effettiva rappresentazione dei mimiambi, se si considera che la comicità poteva essere notevolmente accresciuta congiun-gendo al tono appassionato e crudo del mezzano la reale verifica autoptica del corpo liscio della giovane da parte dei qeata….
43 L’episodio viene narrato da Ateneo nei Deipnosofisti (590 e): i giudici, ammirando la bellezza sovrumana della cortigiana, definita «sacerdotessa di Afrodite», non la condannarono benché accusata di ¢sšbeia. La deformazione in chiave parodica effettuata da Eroda declas-serebbe la celebre etera al rango di prostituta di infima condizione, mentre Iperide verrebbe a essere sostituito da un volgare lenone. Si noti, comunque, la forte valenza aneddotica della vicenda iperidea, a dire il vero piuttosto sospetta: cfr. BARTOLINI, 1977, p. 118 s. La fonte origi-naria sarebbe il Perˆ dhmagogîn di Idomeneo di Lampsaco (IV-III secolo a.C.).
44 L’impudenza e la falsità caratterizzano un po’ tutta l’arringa del lenone e sembrano motivi topici del personaggio (Plaut., Curc. 58: pudor si quoiquam lenoni siet; Capt. 57: periurus leno).
45 E tanto più comica e di dubbio gusto appare, in quest’ottica, l’aggiunta di Battaro che invita Mirtale a mostrarsi senza provare vergogna: i giudici dovrebbero guardare il corpo della fanciulla con la stessa purezza di cuore che se fosse loro figlia o sorella! Qui l’ipocrisia del mezzano raggiunge livelli di inaudita sfrontatezza: questa fittizia e simulata dolcezza paterna, infatti, suona grottesca in un individuo così ambiguo, che cerca addirittura di ammantare le sue parole di un tono solenne: si pensi al tribrachi iniziale del v. 68 (patšraj), che conferisce tono tragico, o all’asindeto bimembre patšraj ¢delfoÚj, che ripete un tratto stilistico tipico della tragedia (e.g. pa…dwn gunaikîn, Aeschyl., Eum. 1027; ¢ndrîn gunaikîn, Soph., Ant. 1079; nšwn gerÒntwn, Eur., Suppl. 722).
46 Questa fu una convinzione radicata fin dai primi commentatori del mimiambo, come risulta già evidente in HENSE, 1900, p. 230. Il rapporto tra mimo ed eloquenza dové essere avvertito, peral-tro, fin dagli albori di tale genere letterario (·htoreÚwn Boul…aj, Sophr., fr. 104 Kassel, Austin).
www.rivistadirittoellenico.it (11)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 117 19/05/2013 10.39.07
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
118 Arduino Maiuri
A sostegno di questa interpretazione, pertanto, nel prossimo paragrafo si se-gnaleranno ulteriori consonanze formali tra l’arringa di Battaro e alcuni loci notevoli tratti dall’opera dei logografi attici47.
3. La parodia giudiziaria.
Una classificazione generale dei riferimenti burleschi presenti nel mimiam-bo consente di catalogarli in due macrocategorie: l’una, più tecnica, contenen-te analogie con procedure e istituzioni processuali attiche, soprattutto grazie al richiamo a vezzi e abitudini tipiche degli oratori giudiziari; l’altra, invece, comprendente spunti comico-realistici ed ironici lato sensu, atti a mettere in ridicolo e deformare in chiave grottesca le figure dei personaggi, sì da renderle vere e proprie caricature48.
47 Sul punto le opinioni dei commentatori sono alquanto divergenti. Per esempio, secondo CUN-NINGHAM, 1971, p. 81, «it is generally said that the piece is a parody of Attic court speeches, but this is to give the wrong emphasis. It is of course true that Hds. uses material from that source but his primary intention is not to parody them, but to depict a pornoboskÒj making such a speech. As usual, he portrays a character». Lo studioso non accetta neppure lo schema strutturale supposto nell’orazione, ma preferisce puntare sul disordine e la ripetitività del discorso del lenone, che si di-stanzierebbe dai moduli delle orazioni giudiziarie, non rispettando né il filo logico dell’esposizione dei fatti né dei capi di accusa. È evidente che una perfetta consequenzialità oratoria sia inadatta alla goffa figura del lenone, né sortirebbe gli stessi effetti parodici; tuttavia, come si è visto, nel discorso sono agevolmente identificabili l’esordio, l’esposizione dei fatti, la lettura della legge, il tentativo di ricorrere a una sorta di prova testimoniale e la perorazione finale.
48 Secondo MASSA POSITANO, 1971, p. 5, «l’invenzione comica di base consiste … nella degra-dazione satirica di Battaro». Il fatto che l’interesse di Eroda sia completamente incentrato sulla figura del mezzano spiega anche l’assoluta convenzionalità dei tratti del suo antagonista Talete, kwfÕn prÒswpon, appena un’ombra che riceve supinamente ogni sferzata di Battaro e sembra acquistare vita autonoma solo nella risata del v. 74. Naturalmente il carattere comico-realistico del mimiambo è prevalente e il pornoboskÒj è magistralmente caratterizzato con un’incessan-te fantasmagoria di trovate colorite e motti salaci. A tal proposito, tuttavia, bisogna notare che la matrice del personaggio non va cercata nella vita quotidiana coeva (cosí ritiene, ad esempio, GIGANTE, 1971, p. 88), ma in modelli di carattere prettamente letterario e in particolare nella com-media. Si può, pertanto, condividere la posizione di Domenico Bo, che, al termine di una lunga rassegna sulla lingua dell’autore, evidenzia la raffinata letterarietà dei mimiambi: «Battaro usa un miscuglio di dialetti, ionizza parole non ioniche, intercala termini attici e tutto questo con evidenti effetti comici della sua singolare arringa. Sono mimi per raffinati dal palato delicato, che sanno scoprire tutto il travaglio di creazione del poeta, che ne sanno apprezzare l’abilità tecnica, capire l’accortezza nel collocare a bello studio una paroletta per creare una parodia, un proverbio, o una frase sentenziosa di carattere moraleggiante per provocare un paradosso … Eroda … vissuto nella cerchia degli alessandrini, ne rivela le stesse caratteristiche di gusto, di dottrina, la stessa padro-nanza di tecnica» (BO, 1962, p. 132). Si chiariscono, in questa linea interpretativa, sia l’osserva-zione di Plinio il Giovane (Ep. 4.3.3), che accosta Eroda a Callimaco per esaltare l’humanitas, la venustas, la dulcedo, l’antiquitas, l’argutia e la rectitudo degli epigrammi e dei mimiambi del suo amico Antonino Arrio (Callimachum me vel Heroden vel, si quid melius, tenere credebam), sia i
(12) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 118 19/05/2013 10.39.07
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 119
Per quanto concerne la prima categoria, la quale, ovviamente, è oggetto di precipuo interesse per la presente indagine, si può notare che già l’introduzio-ne di Battaro, con l’insistita preoccupazione che la sentenza possa risultare iniqua in virtù delle differenze economiche esistenti tra le due parti in causa49, ricorda una tipica movenza di Isocrate50.
Inoltre, come per una sorta di dotta e sottile Ringkomposition, un altro motivo isocrateo riaffiora proprio in chiosa di mimiambo (v. 100-101), quando Battaro afferma che un’equa punizione renderà migliore il reo51.
L’accenno alle benemerenze delle parti in causa nei confronti dello stato (v. 16 ss.) è, invece, un espediente tipico di Lisia52, come anche il tentati-
continui riferimenti di carattere letterario presenti nel secondo mimiambo, permeato di allusioni più o meno esplicite ad espressioni correntemente utilizzate dagli oratori attici.
49 L’ansia di Battaro nasce da quanto esposto nei v. 3-4: oâtoj ¢x…hn t¾n nhàn / œcei tal£ntwn pšnt', ™gë d� mhd' ¥rtouj. Cfr. anche i v. 16-18: ™re‹ tac' âmin: «™x ”Akhj ™l»louqa / puroÝj ¥gwn k½sthsa t¾n kak¾n limÒn», / ™gë d� pÒrnaj ™k TÚrou; 21-23: e„ d' oÜneken ple‹ t¾n q£lassan À cla‹nan / œcei triîn mnšwn 'Attikîn, ™gë d' o„kšw / ™n gÍ tr…bwna kaˆ ¢skšraj sapr¦j œlkwn. La preoccupazione di una sentenza iniqua viene chiaramente espressa alla fine dell’orazione (v. 84-86: Ÿn d' œstin, ¥ndrej – taàta m�n g¦r e‡rhtai / prÕj toàton – Ùme‹j d' çj ¢martÚrwn eÜntwn / gnèmV dika…V t¾n kr…sin diait©te, e si noti il timore che l’assenza di testimoni ingenera in Battaro, il quale, oltre alle sue doti dialettiche deve dar fondo ad ogni stratagemma suggeritogli dal suo ingegno, financo la paradossale proposta di sottoporre se stesso a b£sanoj, la tortura regolarmente inflitta solo agli schiavi: cfr. THÜR, 1977, p. 26); e ancora i v. 99-100: taàta skopeàntej p£nta t¾n d…khn ÑrqÍ / gnèmV kubern©t(e). Efficace la variatio dell’aggettivazione del termine gnèmV, accompagnato prima da dika…V e quindi da ÑrqÍ, forse in connessione con la scelta di d…khn in luogo di kr…sin e la conseguente volontà di eliminare la figura etimologica. La giuntura ricorre spesso in Demostene: cfr. XX.118 (gnèmV tÍ dikaiot£tV krine‹n); XXIII.96; XXXIX.40 (ove l’infinito è dik£sein).
50 Kaˆ mhdeˆj Ømîn, e„j toàt' ¢poblšyaj Óti pšnhj e„mˆ kaˆ toà pl»qouj eŒj, ¢xioÚtw toà tim»matoj ¢faire‹n. OÙ g¦r d…kaion ™l£ttouj poie‹sqai t¦j timwr…aj Øp�r tîn ¢dÒxwn À tîn diwnomasmšnwn, oÙd� ce…rouj ¹ge‹sqai toÝj penomšnouj À toÝj poll¦ kekthmšnouj (Isocr., XX.19). L’analogia è, in questo caso, essenzialmente contenutistica: dal punto di vista formale, invece, l’andamento è simile a ps. Demosth., XLIII.61: œstin d' Ð nàn ¢gën kaˆ ¹ diadikas…a oÙk e‡ tij ›teroj ˜tšrou prÒteroj À Ûsteroj teteleÚthken, ¢ll' e„ m¾ pros»kei ™xelaqÁnai ™k toà o‡kou toà `Agn…ou toÝj o„ke…ouj toÝj `Agn…ou.
51 ‘Wn ›neka de‹ perˆ ple…stou poie‹sqai taÚtaj tîn dikîn, kaˆ perˆ m�n tîn ¥llwn sumbola…wn tosoÚtou tim©n Óson pros»kei tù dièkonti kom…sasqai, perˆ d� tÁj Ûbrewj Óson ¢pote…saj Ð feÚgwn paÚsesqai mšllei tÁj paroÚshj ¢selge…aj (Isocr., XX.16). Si confrontino anche il v. 26 con Isocr., VIII.49-50, per l’orgoglio provato dai cittadini nei confronti della propria forma di governo; i v. 24-27 nel loro complesso con Isocr., XX.9-11 (ove i giudici consentano la violenza verrà meno la stessa libertà del paese); i v. 92-94 sempre con Isocr., XX.18 (la causa trascende gli interessi personali per investire l’intera città).
52 'Egë g¦r t¦ ™moˆ prostetagmšna ¤panta proqumÒteron pepo…hka, À æj ØpÕ tÁj pÒlewj ºnagkazÒmhn, kaˆ trihrarcîn kaˆ e„sfor¦j e„sfšrwn kaˆ corhgîn kaˆ t«lla lVtourgîn oÙdenÕj Âtton polutelîj tîn politîn (Lys., VII.31). Cfr. anche Lys., XIX.62; XXVI.3; Demosth., XX.33; XXXIV.38; Andoc., II.11, 20-21.
www.rivistadirittoellenico.it (13)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 119 19/05/2013 10.39.07
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
120 Arduino Maiuri
vo di blandire i giudici con un’ostentata povertà e lo squallore degli abiti (v. 22-23)53, o l’accenno dell’oratore ai propri antenati (v. 75-76)54. Per di più, la descrizione dell’ingresso indesiderato di Talete nel postribolo è molto si-mile a quella di Simone in Lys., III.6: puqÒmenoj g¦r Óti tÕ meir£kion Ãn par' ™mo…, ™lqën ™pˆ t¾n o„k…an t¾n ™m¾n nÚktwr meqÚwn, ™kkÒyaj t¦j qÚraj (cfr. il v. 63) e„sÁlqen e„j t¾n gunaikwn‹tin55. A ciò si aggiunga che in Andocide e Iperide compaiono delle espressioni che potrebbero aver fornito a Eroda lo spunto per due delle sue trovate più divertenti e sarcastiche56.
L’oratore con il quale è dato riscontrare un numero maggiore di consonan-ze è, tuttavia, senza alcun dubbio, Demostene57. Una prima analogia di ordine espositivo e strutturale salta immediatamente agli occhi in relazione a un parti-colare comune nell’impostazione della tecnica accusatoria: al termine di uno dei più aggressivi resoconti sulla cattiva condotta di Talete (v. 31-40), infatti, è col-locata la climax koÙk ™pVdšsqh / oÜte nÒmon oÜte prost£thn oÜt' ¥rconta, secondo uno schema ricorrente sia nell’orazione demostenica contro Midia58
53 'En tribwn…oij, ¢nupod»touj (Lys., XXXII.16); inoltre Isae., V.11: ™gkale‹ aÙtù Óti ™mb£daj kaˆ tr…bwna fore‹.
54 Mentre in Lys., XXIV.6 e Andoc., I.141 il richiamo è serio e mira ad ottenere la solida-rietà dei giudici, lo stesso intento dissacratore di Eroda è tipicamente comico. Si vedano, per esempio, il contegno insolente del sicofante di Aristoph., Av. 1451-1452 (tÕ gšnoj oÙ katai-scunî, / pappùoj Ð b…oj sukofante‹n ™st… moi) e del parassita Saturione in Plaut., Pers. 57-58: pater, avos, proavos, abavos, atavos, tritavos / quasi mures semper edere alienum cibum (inoltre ibid., v. 474-475, analogamente a quanto si predica nel v. 30 di Eroda, Dordalo si offre come campione di virtù civica: sumne probus, sum lepidus civis, qui Atticam hodie civitatem / maxumam maiorem feci atque auxi civi femina).
55 Il passo può essere utilmente accostato a Ter., Ad. 88-91: foris ecfregit atque in aedis inruit/ alienas: ipsum dominum atque omnem familiam/ mulcavit usque ad mortem: eripuit mulierem/ quam amabat; più avanti, al v. 198, lo sconsolato Sannione dichiarerà: me invito (= œm' oÙ pe…saj) abduxit meam.
56Andoc., I.149 (Øme‹j to…nun kaˆ ¢ntˆ patrÕj ™moˆ kaˆ ¢ntˆ ¢delfîn kaˆ ¢ntˆ pa…dwn gšnesqe) può aver ispirato l’ironico v. 68, contenente l’invito di Battaro a Mirtale a mostrarsi come se i giudici fossero suoi padri o fratelli (ma cfr. anche Soph., El. 1361); Hyper., In Demosth. fr. I.1 Jensen (œgrayen d� aÙt¦ oÙdeˆj tîn ™cqrîn tîn Dhmosqšnouj, ¢ll' aÙtÕj oátoj) si può utilmente confrontare con i v. 48-49 (taàt' œgraye Cairèndhj, / … kaˆ oÙcˆ B£ttaroj).
57 Va ricordato che il lenone forse deve il suo nome al difetto della balbuzie e che al v. 74 si de-finisce un cinedo. D’altra parte, Demostene in gioventù era bleso e veniva chiamato B£t(t)aloj (ossia prwktÒj: Demosth., XVIII.180; Aeschin., I.126, 131; II.99), forse perché la sua trau-lÒthj lo portava a pronunciare il r come fosse un l.
58 Cfr. Demosth., XXI.61: Meid…an d' „dièthn Ônta, mhd�n ¢nhlwkÒta, Óti tJ prosškrousen kaˆ ™cqrÕj ØpÁrcen, toàton ¢nal…skonta, corhgoànta, ™p…timon Ônta prophlak…zein kaˆ tÚptein, kaˆ m»te tÁj ˜ortÁj m»te tîn nÒmwn m»te tˆ Øme‹j ™re‹te m»te toà qeoà front…zein (qui l’elenco, tuttavia, è più variegato, arrivando ad includere, in ultima istanza, persino l’elemento divino).
(14) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 120 26/05/2013 9.42.05
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 121
che in quella contro Aristogitone59.Grosse affinità legano, inoltre, l’espressione proverbiale dei v. 9-10 (zîmen
oÙk çj boulÒmesq' ¢ll' çj ºmšaj / Ñ kairÕj œlkei) con almeno due passi di Demostene60, mentre le riprese dei versi 13 (cçj d» ™st' ¢lhqša taàta) e 79 (™r´j sÝ m�n ‡swj Murt£lhj;) trovano un preciso riscontro in altret-tanti luoghi demostenici61; il fatto stesso che la legge sull’a„k…a preveda una pena al doppio in caso di intenzionalità trova una interessante conferma in un passo dell’orazione contro Midia62; infine, Minosse come modello di giustizia (taàta trut£nV M…nwj / oÙk ¨n dik£zwn bšltion diÇthse, v. 90-91) è già in Dem., XVIII.127 (e„ g¦r A„akÕj À `Rad£manquj À M…nwj Ãn Ð kath-gorîn). Addirittura, spostando il discorso sul piano squisitamente lessicale, nel celebre oratore ateniese ricorrono precisamente le stesse coppie verbali con cui Eroda descrive la violenza di Talete (lamb£nein in connessione con o‡cesqai al v. 37; ›lkein e bi£zesqai al v. 71)63.
59 Demosth., XXV.90: taàta to…nun 'Aristoge…twn t¦ kalîj oÛtw pephgÒta tÍ fÚsei kaˆ to‹j ½qesi to‹j Ømetšroij kine‹n kaˆ ¢naire‹ kaˆ metarr…ptei, kaˆ § tîn ¥llwn tîn ºtuchkÒtwn ›kastoj ¢yofhteˆ poie‹, taàq' oátoj mÒnon oÙ kèdwnaj ™xay£menoj diapr£ttetai. OÙ prut£neij, oÙ kÁrux, oÙk ™pist£thj, oÙc ¹ proedreÚousa ful¾ toÚtou krate‹n dÚnatai. Qui l’analogia è ancora più scoperta: taàq' oátoj … diapr£ttetai equivale perfettamente a ¥panta taàt' œprhxe di Eroda (v. 39), mentre la stessa cli-max conclusiva è incentrata esclusivamente su elementi di ordine istituzionale della pÒlij, come nel v. 40 di Eroda. In tal senso, infine, sembra pertinente riportare anche quanto detto a proposito di Alcibiade in ps. Andoc., IV.14: p©sin ™d»lwse kaˆ tîn ¢rcÒntwn kaˆ tîn nÒmwn kaˆ tîn ¥llwn politîn katafronîn.
60 I passi in questione sono Demosth., LVII.31 (tain…aj pwle‹n kaˆ zÁn oÙc Óntina trÒpon boulÒmeqa) e XVIII.239 (oÙc Ós' ™boulÒmeqa, ¢ll' Ósa do…h t¦ pr£gmat' œdei dšcesqai). Il concetto che non si possa vivere a proprio piacimento è diffuso nella letteratura greca (cfr. Plato, Hipp. mai. 301 c: toiaàta, ð `Ipp…a, t¦ ¹mšter£ ™stin, oÙc oŒa boÚleta… tij, fasˆn ¥nqrwpoi ˜k£stote paroimiazÒmenoi, ¢ll' oŒa dÚnatai). Da Menandro (273 Jaekel): zîmen g¦r oÙc æj qšlomen, ¢ll' æj dun£meqa) deve essersi esteso al teatro latino, perché ricorre in Caecil., fr. 173 Guardì (vivas ut possis, quando non quis ut velis) e Ter., Andr. 805 (sic ut quimus, aiunt, quando ut volumus non licet).
61 Cfr. Demosth., XX.115: Óti to…nun ¢lhqÁ lšgw; XXI.220: mise‹ Meid…aj †swj ™mš, sempre a formulare un’ipotesi possibile.
62 Demosth., XXI.43: prîton m�n to…nun oƒ perˆ tÁj bl£bhj oátoi nÒmoi p£ntej … ¨n m�n ˜kën bl£yV, diploàn, ¨n d' ¥kwn, ¡ploàn tÕ bl£boj keleÚousin ™kt…nein.
63 Si confronti il v. 37 (labën o‡cwken) con ps. Demosth., XLIII.82 (õketo labèn) e XLIV.9 (õkonto labÒntej). L’espressione è, comunque, molto risalente: cfr. Hymn. Hom., In Cer. 72: labën o‡cetai. Quanto all’endiadi e�lken … k¢bi£zet(o) del v. 71, l’idea del «trascinare a forza e con violenza» è presente anche in Demosth., XXI.150: tÕ tÁj fÚsewj æj ¢lhqîj b£rbaron kaˆ qeo‹j ™cqrÕn ›lkei kaˆ bi£zetai (cfr. inoltre Dio Chrys., Or. LXXVII-LXXVIII.10: ̃ lkontej kaˆ biazÒmenoi). Si noti, infine, che pÒlij dioike‹tai (v. 56) è analogo al dioike‹tai (nÒmoij kaˆ yhf…smasi) di Demosth., XXIV.152.
www.rivistadirittoellenico.it (15)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 121 26/05/2013 9.53.35
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
122 Arduino Maiuri
Restando sul piano del lessico, è naturale che il mimiambo abbondi di tecnicismi giuridici, come richiesto, d’altronde, dal contesto64. Tuttavia, alcuni impieghi superano di gran lunga le necessità espressive di ordine procedu-rale, attingendo volutamente ad un repertorio di preferenze e vezzi stilistici proprio degli oratori, con intento canzonatorio. Ne sono testimonianza parole come d»kouqen (attico d»pouqen, v. 2), abbondantemente usata nell’oratoria ateniese nel senso del latino videlicet 65, o makrhgore‹n (v. 60), «annoiare parlando troppo», talmente frequente nei discorsi tribunalizi da far dire, forse, a Battaro che il suo uso è divenuto proverbiale66; lo stesso n¾ D…(a) del v. 81 è un atticismo, per nulla ignoto allo stile oratorio.
Anche alcuni procedimenti scelti da Battaro fanno parte dei moduli tipici della retorica: così la prokat£lhyij (anticipatio) del v. 16 (™re‹ t£c' âmin), allorché Battaro previene una possibile obiezione di Talete, che potrebbe vantarsi di essere un benefattore della pÒlij, in quanto vi ha fatto cessare la carestia, e quella del v. 74 (k…naidÒj e„mi kaˆ oÙk ¢parneàmai)67, decisa ammissione di immoralità con cui il lenone intende stornare una potenziale allusione del suo avversario (a meno che un simile commento non abbia effettivamente accompagnato la risatina di scherno postulata nel medesimo verso)68; ovvero la vituperatio, il contegno ingiu-
64 Cfr. prost£thn (v. 10); tÁj a„ke…hj / tÕn nÒmon (v. 41-42); kleyÚdrhj (v. 43: si tratta dell’orologio ad acqua, strumento indispensabile nelle procedure giudiziarie, come attesta Aristoph., Vesp. 93); l’intero dettato legislativo dei v. 46-48; metelqe‹n («perseguire in giudizio», v. 50: cfr. Eur., Cycl. 280); tinštw (in variatio con tele…tw, v. 51); t…mhma (v. 53); diplÒon t…nein (v. 54); naàlon (corrispondente anche formalmente al nostro ‘nolo’, v. 59: cfr. Aristoph., Ran. 270); tr…thn misqÒn (v. 64); dik£zontaj (v. 67); gnèmV dika…V t¾n kr…sin diait©te (v. 86); doàla sèmata (v. 87: l’espressione contrassegna la posizione giuridica degli schiavi, visti non già come soggetti di diritto, ma come semplici corpi animati: cfr. gli instrumenta vocalia di Varr., Rust. 1.17.1); b£sanon (v. 88); tim» (la somma da lasciare in deposito in caso di soccombenza nella prova della tortura, v. 89); trut£nV (la bilancia, simbolo di equità, v. 90); dik£zwn … diÇthse (v. 91); yÁfon (il sassolino per il voto dei giudici, v. 92); e infine, ancora in variatio, la giuntura p£nta t¾n d…khn ÑrqÍ / gnèmV kubern©t(e) (v. 99-100). Un richiamo implicito alla forza persuasiva dell’oratoria, anzi dell’eristica, può, a mio avviso, rinvenirsi anche nel v. 24 (œm' oÙ pe…saj): non si dimentichi il forte influsso eserci-tato dalla sofistica sulle studiate ·»seij dei personaggi euripidei (e a una presunta parodia dei mono-loghi di Euripide, in riferimento al discorso del lenone Battaro, accenna VENERONI, 1971, p. 232).
65 Cfr. Lucian., Lexiph. 21 e Rhet. praec. 18, in cui sottolinea l’utilità dell’impiego di termi-ni come ¤tta e d»pouqen, anche senza effettiva necessità, per conferire tono al discorso. Eroda utilizza anche il sinonimo d»kou (3, 90; 5, 24).
66 Ma si veda infra, p. 125 nt. 85, per l’incertezza dell’attribuzione di tÍ paroim…V trÚcw (v. 61). In realtà, si tratta della variante makrologšw, amata, oltre che dagli oratori attici, anche da Platone (Resp. 403 c), come formula di passaggio ad altro argomento. Demosth., XIV.41 realizza con la tmesi una duplice allitterazione: m¾ makr¦ l…an lšgwn ™noclî.
67 Cfr. Ter., Ad. 188: leno sum, pernicies communis, fateor, adulescentium.68 Una anticipatio molto simile a quella del v. 74 si trova in Aeschin. III.17: teicopoiÒj
e„mi: Ðmologî: ¢ll(£) ktl. Altre attestazioni notevoli del procedimento si hanno in Demosth., XXI.160; XXXVIII.25; ps. Lys., VI.43; Lys., XIII.70.
(16) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 122 19/05/2013 10.39.09
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 123
rioso che il lenone riserva all’accusato, demolendone la persona69; la deductio ad absurdum, in cui l’ironia si fa provocatoria e aggressiva70; la refutatio, che consiste nel menzionare ciò che l’avversario avrebbe dovuto considerare per non cadere in torto, eppure non lo ha fatto71; e infine, soprattutto, l’amplificatio, con l’estensione della vicenda personale di Battaro a tutti gli stranieri che vivono nella pÒlij (v. 92-94)72 e il successivo richiamo ai mitici ecisti di Cos (v. 95-98), trucco tipico degli oratori giudiziari, e qui estremamente comico73.
La collocazione stessa dell’excursus, in sede di peroratio, rivela che il suo obiettivo è la mozione degli affetti (p£qh) dei giudici, che Battaro intende tocca-re nelle corde più delicate, quelle relative agli antenati fondatori della città. Ri-salire alle origini mitiche vuole significare un innalzamento di tono, e appellarsi alle divinità tutelari equivale a far leva sull’amor proprio e sul campanilismo dei giudicanti, per un’equa sentenza. Dal piano giuridico si passa a quello della coscienza, non solo individuale, ma anche storica. Lo schema, naturalmente, assume in questo contesto una valenza parodica particolarmente esilarante.
69 Cfr. i v. 37-40 sulla tracotanza e la spudoratezza di Talete; i v. 55-56 sulla sua ignoranza delle leggi e conseguente inciviltà; nonché, naturalmente, il cocente disprezzo che serpeggia dalle parole di Battaro ogni volta che si trovi a rievocare le malefatte del giovane.
70 E„ d' oÜneken ple‹ t¾n q£lassan À cla‹nan / œcei triîn mnšwn 'Attikîn … b…V tin' ¥xei tîn ™mîn … o‡cet' Ãmin º ¢lewr» / tÁj pÒlioj, ¥ndrej, k¢p' ÔtJ semnÚnesqe, / t¾n aÙtonom…hn Ùmšwn QalÁj lÚsei (v. 21-27). È chiaro come tale estensione sia improponibile dal punto di vista pratico e valida solo in linea di principio, come in Lys., XXX.30 (kaˆ Ön œdei ØpÕ toà d»mou kr…nesqai, oátoj tÕn dÁmon sugkatalÚsaj fa…netai). Cfr. anche Lys., IV.20-21; XII.36; XXII.19; XXVII.7.
71 —On crÁn ™autÕn Ôstij ™stˆ k¢k po…ou / phloà pefÚrht' e„dÒt' çj ™gë zèein / tîn dhmotšwn fr…ssonta kaˆ tÕn ½kiston (v. 28-30). Questa tecnica oratoria è marcata dall’uso del verbo crÁn (Lys., III.22; VII.19, 20, 37; XII.32, 48, 50), di solito in alternanza con ™xÒn (I.46; IV.10; VII. 42-43). Si noti al v. 28 l’esito labiale di po…ou in luogo dell’attesa forma dorica ko…ou, probabilmente per favorire l’effetto allitterante con phloà (come è presumibile anche nella sequenza pîj pÒlij, v. 56).
72 Si tratta anche in questo caso della parodia di una tipica movenza oratoria, mirante ad estendere sul piano pubblico un interesse di natura personale: cfr. per es. Lys., I.47: ™gë m�n oân, ð ¥ndrej, oÙk „d…an Øp�r ™mautoà nom…zw taÚthn genšsqai t¾n timwr…an, ¢ll' Øp�r tÁj pÒlewj ¡p£shj; XXVIII.10: ™nqume‹sqe g£r, ð ¥ndrej 'Aqhna‹oi, Óti oÙk 'ErgoklÁj mÒnoj kr…netai, ¢ll¦ kaˆ ¹ pÒlij Ólh; ps. Demosth., LVI.48: m…an d…khn dik£zontej nomoqete‹te Øp�r Ólou toà ™mpor…ou; Andoc., I.105: Ð m�n ¢gën ™n tù sèmati tù ™mù kaqšsthken, ¹ d� yÁfoj ¹ Ømetšra dhmos…v krine‹. In ambito comico, infine, un procedi-mento simile si riscontra in Aristoph., Eccl. 1055-1056: ¢ll' oÙk ™gè, / ¢ll' Ð nÒmoj ›lkei se (accostabile ancor meglio ai v. 48-50 del nostro mimiambo: taàt' œgraye Cairèndhj, / ¥ndrej dikasta…, kaˆ oÙcˆ B£ttaroj crÇzwn / QalÁn metelqe‹n).
73 È frequente nell’eloquenza attica conferire un risalto spropositato a ciò che è insignifi-cante: cfr. Plato, Phaedr. 267 a (su Tisia e Corace, i quali t¦ smikr¦ meg£la poioàsin di¦ t¾n ·èmhn lÒgou).
www.rivistadirittoellenico.it (17)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 123 26/05/2013 9.54.10
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
124 Arduino Maiuri
La continua oscillazione di Battaro tra il piano più strettamente giuridico e quello, per così dire, umano, è testimoniata anche dal suo modo di rivolgersi ai giudici. Soltanto in tre occasioni74, infatti, egli li chiama ¥ndrej dikasta…, usando la definizione completa, tecnica e solenne, e richiamando, pertanto, la loro funzione di decisori della controversia. In tutti gli altri casi, peraltro numerosi75, Battaro punta sull’umanità del collegio giudicante, ricorrendo al semplice ¥ndrej, come aveva già fatto Lisia, per esempio, fin dall’esordio dell’orazione Per l’uccisione di Eratostene76.
L’espediente mira a toccare la sensibilità dei giudici al di là del mero det-tato legislativo, che pure il lenone tiene a dimostrare a sé favorevole77: la sua azione, pertanto, è duplice, mirando alla compenetrazione tra il profilo umano e quello giuridico, in modo da non lasciare scampo al rivale.
Il calore con cui Battaro propugna le sue ragioni si nota anche dal fatto che, oltre che con il vocativo ¥ndrej (dikasta…), egli si rivolge direttamente ai giudici in più punti dell’orazione78, e non solo a loro, ma anche al restante udito-rio, in modo da renderlo parte viva e integrante del suo monologo; così fa con il cancelliere (v. 41-42), con l’addetto alla clessidra (v. 42-43)79, con Talete80 e con
74 Al v. 1, proprio in apertura, dove il vocativo è subito rafforzato da krita… (v. 2); ai v. 49 (ancora in contesto tecnico e solenne: segue la lettura del testo di legge) e 61, in cui l’innalza-mento di tono è giustificato dall’intenzione di esporre l’elenco dei reati in maniera formalmente ineccepibile: essendo l’orazione l’unico strumento offerto alle parti per palesare i fatti e pro-muovere le proprie istanze, era necessario rivolgersi ai giudici secondo le formule convenzio-nali, ove le necessità procedurali lo richiedessero.
75 Cfr. i v. 14, 27, 38, 68, 84, 92.76 Perˆ polloà ¨n poihsa…mhn, ð ¥ndrej, tÕ toioÚtouj Øm©j ™moˆ dikast¦j perˆ toÚtou
toà pr£gmatoj genšsqai, oŒo…per ¨n Øm‹n aÙto‹j e‡hte toiaàta peponqÒtej (Lys., I.1). Il pas-so è particolarmente vicino allo spirito che anima il discorso di Battaro, nel senso che sia il lenone sia Eufileto intendono instaurare con i giudici un rapporto privilegiato, di profonda comprensione e solidarietà. Per questo entrambi, sia pure a parti inverse (Battaro accusa, Eufileto si difende), non trascurano alcun particolare per accentuare a regola d’arte la gravità delle offese patite.
77 Si vedano i brani delle disposizioni legislative di Caronda, citati convulsamente dal lenone ai v. 50-54. La menzione del grande legislatore del VI secolo, cui sono attribuite le leggi di Catania ed altre colonie calcidiche d’Italia, è qui inserita da Battaro come ulteriore prova della necessità di punire Talete, nel senso che i giudici, nell’emettere la loro sentenza, dovranno mostrare rispetto per la legislazione di Caronda (esaminata da CASTELLO, 1988 = 2002). La stessa idea è presente in Demosth., XXI.30: Ótan to…nun tîn parabainÒntwn tin¦ toÝj nÒmouj kol£zhte, oÙ to‹j ka-thgÒroij toàton ™kd…dote, ¢ll¦ toÝj nÒmouj Øm‹n aÙto‹j bebaioàte.
78 'Umšaj (v. 6 e 60); âmin (v. 16); Ùmšwn (v. 27); Ùme‹j (v. 85).79 La familiarità con cui Battaro si rivolge al funzionario non stupisce, tenuto conto del per-
sonaggio. Il lenone cerca qui una sorta di complicità con l’addetto alla clessidra, cui è affidata la misurazione del tempo concesso per l’orazione; in questa chiave può essere interpretato, infatti, anche Âmin del verso successivo.
80 Cfr. la nt. 83 per i continui riferimenti di Battaro al naÚklhroj per mezzo del deittico; si aggiungano l’efficacissimo gel´j; (v. 74) e il provocatorio labèn, QalÁ, stršblou me (v. 89, l’ultima allusione al giovane prima della peroratio).
(18) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 124 19/05/2013 10.39.10
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 125
Mirtale81, allestendo un vero impianto scenico intorno al suo discorso, che ne risulta più movimentato e imaginifico82. L’insistenza sul deittico83, come anche sui pronomi personali di prima e seconda persona84, spesso in contrapposizione tra loro, rappresenta un ulteriore accorgimento finalizzato al medesimo scopo.
Non necessariamente legata a fini di parodia giudiziaria risulta, invece, la seconda categoria di spunti burleschi individuabili nel mimiambo, e per que-sto se ne fa qui una rapida menzione, senza approfondirne la portata o chiarir-ne i termini, per non snaturare l’obiettivo della ricerca85.
4. Alcune conclusioni d’insieme.
Eroda, presentando il discorso di un ridicolo bwmolÒcoj come Battaro, mette efficacemente a nudo le curiose ingenuità della giustizia ateniese, forie-re di una sostanziale iniquità sociale: un accusatore si rivolge a una giuria di
81 Si noti lo stridente attrito tra la bruschezza degli imperativi (il primo addirittura in ellissi, tanto sbrigativo è il tono) usati da Battaro nel rivolgersi a Mirtale (deàro, Murt£lh, kaˆ sÚ· / de‹xon sewut¾n p©si: mhdšn' a„scÚneu: / nÒmize ktl.) e lo specioso paternalismo della sua bizzarra argomentazione suasoria (si veda supra, p. 117 nt. 45).
82 Sembra assurgere a dignità di personaggio la stessa vecchiaia (GÁraj, v. 71), chiamata in causa mediante un’ipotiposi che affonda le sue radici in Hom., Od. 23.24: s� d� toàtÒ ge gÁraj Ñn»sei.
83 Oâtoj, riferito a Talete, non senza un alone di disprezzo, compare nei v. 3, 8, 19, 32 (toÚtJ), 37, 70, 85 (toàton); si aggiungano toÚtouj (v. 67, riferito ai giudici); aÙtÁj (v. 69, a Mirtale); taàta (v. 70, alle ferite); e infine gli avverbi deàro (v. 65), ™nq£de (v. 97) e ðde (v. 98).
84 Frequentissimo ™gè, spesso usato per marcare il contrasto con Talete, come nei v. 4, 8, 11, 18, 20, 22, 33 (kºmš), 60, 80. Nei casi obliqui, invece, non sembra usato in funzione dialettica: cfr. i v. 29, 35 (meu), 41, 75 e 76 (moi). Anche sÚ è frequente: cfr. i v. 42, 55, 65, 72 (soi), 79, 81 (seu).
85 Basti citare di scorcio i v. 10-15, sui patroni Menne ed Aristofonte, e in particolare la fiducia incondizionata riposta da Battaro in quest’ultimo; l’eloquente toponomastica (Tiro contrapposta ad Ace, v. 16 e 18; Bricindera, Abdera e Faselide, v. 57-59; il dispregiativo FrÚx, v. 37 e 100); lo zeugma del v. 20 (¢l»qein, «macinare», ben si adatta a puroÚj, mentre riferito a Mirtale è osceno); la precisazione del v. 25 (kaˆ taàta nuktÒj), come se Battaro di notte dormisse e non esercitasse il suo sordido mestiere; l’allusione implicita al mito di Prometeo (v. 28-30) per le umili origini di Talete e l’impiego stesso del termine kaluptÁrej (v. 31: le tegole hanno la stessa composizione fisica del fango di cui è impastato Talete, ma ben altra disposizione gerarchica); la deformazione satirica del nome del celebre legislatore Caronda in Cairèndhj (v. 48); la scelta di Ñpt£ (v. 65), più comico rispetto a kaut£ o simili; il goffo invito di Battaro a Mirtale a mostrarsi nuda senza timori (v. 65-68); la personificazione della Vecchiaia (v. 71-72); l’elogio della propria genealogia da parte di Battaro (v. 74-77) e gli stessi nomi di suo padre e suo nonno; la glossa oscena rappresentata dai v. 81-83 rispetto a ™r´j del v. 79; il diminutivo Battar…J (v. 82), evidentemente voluto (complica la sequenza metrica del-lo scazonte, rendendo necessario postulare un anapesto in quinta sede); l’autodenigrazione di Battaro che offre addirittura sé stesso per la tortura, pur non essendo schiavo (v. 88); la bizzarra
www.rivistadirittoellenico.it (19)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 125 19/05/2013 10.39.10
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
126 Arduino Maiuri
semplici e privati cittadini; il giudice non è competente della materia, ma, sor-teggiato come giurato, riceve dalla città una potestà decisionale praticamente inappellabile. La composizione del tribunale, pur essendo avanzata espressio-ne di sovranità democratica, comporta che il pol…thj-dikast»j apprenda i termini della contesa solo attraverso il dibattimento giudiziario, dal momento che non prende parte all’istruzione della causa. Il suo compito, quindi, è emi-nentemente ‘arbitrale’, limitato al ruolo passivo dell’attenzione da prestare prima all’accusa e poi alla difesa. La sua valutazione dipende in gran parte dall’impressione che ricava dalle arringhe, non potendo egli contare sui dati del ‘fascicolo’, e quindi sulle acquisizioni di una precedente analisi. Un si-stema così strutturato presenta alcune peculiarità: il giudice non ha libertà di ricerca o scelta delle prove, ma è vincolato all’esame esclusivo di quanto allegato dalle parti nei loro discorsi; non esiste procedura ex officio; il potere accusatorio spetta unicamente alla parte lesa, il che comporta l’assoluta im-possibilità per l’organo statale di intervenire nelle azioni private.
Il tribunale, pertanto, si configura come mero risolutore di una contro-versia: emerge, quindi, chiaramente, l’importanza vitale dei discorsi come strumento fondamentale concesso alle parti per sostenere la validità delle proprie ragioni. All’orazione vengono rimesse, infatti, da un lato l’oggettiva esposizione dei fatti e la correttezza delle istanze, dall’altro l’impressione soggettiva da suscitare nei giudici in merito alla causa; inoltre, in un dibatti-mento, essa rappresenta l’unico terreno concesso per il confronto e lo scon-tro. Con una simile posta in palio, è ovvio che l’arringa costituisca il nerbo del
parentesi mitologica (v. 95-98). In questo quadro rientrano a buon diritto anche le espressioni paremiache, disseminate in più punti del mimiambo: cfr. i v. 44-45 (m¾ †prÒj† te kàsoj fÍ kç t£phj Ãmin, / tÕ toà lÒgou d¾ toàto, lh…hj kÚrsV: la metafora indecente è richiamata dal t¾n Ñp¾n bàson di v. 42; scurrile anche il riferimento dei v. 81-83, in cui torna l’imperativo, ma di un composto: œmbuson, v. 82); 62-63 (pšponqa prÕj Q£lhtoj Ôssa kºn p…ssV / màj: resto convinto del fatto che l’espressione tÍ paroim…V trÚcw vada riferita alla splendida immagine del «topo nella pece», mentre molti commentatori preferiscono associarla a makrhgoršwn, assimilabile per senso a makrologšw, verbo assai diffuso negli oratori attici: si veda supra, p. 122 nt. 66); 72-73 (tÕ a�m' ¨n ™xefÚshsen / êsper F…listoj ™n S£mJ kot' Ñ Bršgkoj: è incerto qui se sia Filisto o Filippo di Samo e di che episodio si tratti); 78 (lšont' ¥gcoim' ¥n e„ QalÁj e‡h: l’iperbole dello strangolamento di un leone copre sicuramente un modo di dire po-polare, ma in questo contesto assume anche un colorito epico-eroico, considerato il riferimento a Eracle, uno dei numi tutelari di Cos richiamati nell’excursus mitologico finale); 100-102 (çj Ñ FrÝx t¦ nàn âmin / plhgeˆj ¢me…nwn œsset', e‡ ti m¾ yeàdoj / ™k tîn palaiîn º paroim…h b£zei: già al v. 37 era evidente il disprezzo riservato all’origine frigia; qui viene del tutto esplicitato per mezzo della citazione integrale dell’espressione proverbiale, che suona a un dipresso «il Frigio migliora solo con le botte»). È notevole anche il fatto stesso che il mimiambo termini con una sentenza (come anche 4.94-95; 5.95; 7.128). L’interesse paremiaco, del resto, è caratteristico del mimo, come dimostra l’elevata frequenza di massime riscontrabile in Sofrone (cfr. i fr. 33, 41, 62, 63, 67, 73, 103, 122, 157, 169, Kassel, Austin).
(20) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 126 19/05/2013 10.39.10
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 127
processo: se l’occasione di colpire la parte avversa è unica e determinante, è necessario che essa preveda eventuali repliche e attacchi, anticipi potenziali battute e prevenga ogni obiezione con rigore di logica. Senza dubbio l’esito della lite dipende tutto dalla completezza e dalla linearità dell’orazione.
Consapevole di ciò, Eroda distorce e deforma, grazie ai potenti mezzi del-la sua parodia, l’elemento portante della struttura giudiziaria, dell’ordinamento giuridico e, in definitiva, della stessa realtà istituzionale della pÒlij, proseguen-do sul percorso già tracciato dalla satira aristofanea nelle Vespe, anzi riuscendo a tratti addirittura a superarla: se il commediografo, infatti, aveva preso di mira la mania tribunalizia dei suoi contemporanei come sintomatica della degenerazio-ne ormai irreversibile della moralità e dei costumi, l’autore alessandrino arriva ad individuarne con sagacia il cardine sostanziale nell’orazione, sa efficacemen-te circoscriverla nei limiti di un mimiambo e dà vita, per di più, a un ‘tipo’ indi-menticabile come il lenone Battaro. Il logografo, in questo caso, è Eroda stesso, che, seguendo l’esempio di Lisia, Demostene e Isocrate, riesce a immedesimarsi nel suo ‘cliente’, facendo ricorso a tutti gli espedienti usuali, con uso scaltrito della tecnica logografica e grande capacità etopoietica. Egli, infatti, non si limita alla descrizione estetica del suo personaggio, ma ne elabora anche le sfumature interiori, presentandolo come un essere umano amaramente consapevole del suo squallore di mezzano e meteco, doppiamente reietto dalla società.
Nonostante l’inevitabile tributo pagato al verismo del maestro Ipponatte, particolarmente evidente in talune descrizioni crudamente realistiche e in alcune battute apertamente oscene, non manca, quindi, nel secondo mimiambo di Eroda, l’azione di un più approfondito scandaglio psicologico: Battaro, infatti, in fin dei conti non risulta una figura sgradevole, perché rivela una sensibilità tutta sua, vagamente malinconica e portata a meste e penose considerazioni sulla sua condizione di uomo esposto alle angherie altrui e a un incerto domani. Allo stesso tempo, tuttavia, non rinuncia a battersi utilizzando tutte le armi a sua disposizione, attingendo a piene mani ai moduli e al repertorio dei grandi logografi e trasponendo la questione contingente su vari livelli, da quello più tecnicamente giuridico a quello umano, politico e sociale, fino a toccare addirittura la sfera divina.
Questa figura, indubbiamente sordida e di cattivo gusto nel suo complesso, resta, tuttavia, simpatica al lettore moderno perché riflette e sintetizza in sé un campionario di varia umanità: amplifica spudoratamente i vizi propri della sua ca-tegoria, e comunque non esita a reclamare dal funzionario il rispetto del legittimo spazio di clessidra86, con l’ansia di chi non vuole subire prevaricazioni e desidera ardentemente esternare all’auditorio la totalità delle sue argomentazioni.
86 Kaˆ sÝ t¾n Ñp¾n bàson / tÁj kleyÚdrhj, bšltiste, mšcrij eâ ‹'n›e…pV (scil. Ð gram-mateÚj, v. 42-43).
www.rivistadirittoellenico.it (21)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 127 19/05/2013 10.39.10
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
128 Arduino Maiuri
Abbreviazioni
FGrHist: F. JACOBY, Die Fragmente der griechischen Historiker, I-III, Berlin - Leiden, 1923-1958.
«NNDI»: «Novissimo Digesto Italiano», Torino, 1957-1975; «Appendice», Torino, 1980-1987.
Bibliografia
BARTOLINI, 1977: G. BARTOLINI, Iperide, Padova, 1977.
BERNABÓ BREA, 2001: L. BERNABÓ BREA, Maschere e personaggi del teatro greco nelle terracotte liparesi, Roma, 2001.
BO, 1962: D. BO, La lingua di Eroda, Torino, 1962.
BRETONE, 1975: M. BRETONE, Ricerche labeoniane. Iniuria e Ûbrij, in «Rivista di filo-logia e di istruzione classica», CIII, 1975, p. 413-429.
CANTARELLA, 1983: E. CANTARELLA, Spunti di riflessione critica su Ûbrij e tim» in Omero, in «Symposion 1979. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Re-chtsgeschichte», cur. P. Dimakis, Köln - Wien, 1983, p. 83-96.
CASINI, 1964: N. CASINI, Meteci, in «NNDI», X, 1964, p. 598-600.
CASTELLO, 1988 = 2002: C. CASTELLO, Sulla legislazione attribuita a Caronda nel secondo Mimiambo di Eroda, in «Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. G. Nenci, G. Thür, Köln - Wien, 1990, p. 361-368 = Scritti scelti di diritto romano, Genova, 2002, p. 509-516.
CUNNINGHAM, 1971: Herodas. Mimiambi, cur. I.C. Cunningham, Oxford, 1971.
CUNNINGHAM, 2004: Herodas. Mimiambi, cur. I.C. Cunningham, Monachii - Lipsiae, 2004.
DEL GRANDE, 1947: C. DEL GRANDE, Hybris, Napoli, 1947.
DI GREGORIO, 1997: Eronda. Mimiambi (I-IV), cur. L. Di Gregorio, Milano, 1997.
FECHNER, 1885 = 1964: H.A. FECHNER, Über den Gerechtigkeitsbegriff des Aristoteles, Leipzig, 1885 = rist. Aalen, 1964.
GERNET, 1955: L. GERNET, Droit et société dans la Grèce ancienne, Paris, 1955.
GIGANTE, 1971: M. GIGANTE, L’edera di Leonida, Napoli, 1971.
HARRISON, 1971: A.R.W. HARRISON, The Law of Athens, II, Procedure, Oxford, 1971.
HENGSTL, 2004: J. HENGSTL, Zum Quellenwert von Hero(n)das, Mimiambos 2, in «Ad fontes! Festschrift für Gerhard Dobesch zum fünfundsechzigsten Geburtstag», Wien, 2004, p. 169-177.
(22) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 128 19/05/2013 10.39.11
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 129
HENSE, 1900: O. HENSE, Zum zweiten Mimiamb des Herodas, in «Rheinisches Mu-seum», LV, 1900, p. 222-231.
HOUSMAN, 1922: A.E. HOUSMAN, Herodas II 65-71, in «Classical Review», XXXVI, 1922, p. 109-110.
KENYON, 1891: F.G. KENYON, Classical Texts from Papyri in the British Museum, In-cluding the Newly Discovered Poems of Herodas, London, 1891.
KILMER, 1982: M. KILMER, Genital Phobia and Depilation, in «Journal of Hellenic Studies», CII, 1982, p. 104-112.
KNOX, HEADLAM, 1922 = 1966: Herodas. The Mimes and Fragments, cur. A.D. Knox, W. Headlam, Cambridge, 1922 = rist. 1966.
LATTE: K. LATTE, Hesychii Alexandrini Lexicon, I-II (A-O), Copenhagen, 1966.
LAVENCY, 1965: M. LAVENCY, Aspects de la logographie judiciaire attique, Lou-vain, 1965.
LEGRAND, 1902: P.E. LEGRAND, A quelle espèce de publicité Hérondas destinait-il ses mimes?, in «Revue des Études Anciennes», IV, 1902, p. 5-35.
LIPSIUS, 1905-1915 = 1966: J.H. LIPSIUS, Das Attische Recht und Rechtsverfahren, I-III, Leipzig, 1905-1915 = rist. Hildesheim, 1966.
MAC DOWELL, 1976: D.M. MAC DOWELL, Hybris in Athens, in «Greece and Rome», XXIII, 1976, p. 14-31.
MAFFI, 1972: A. MAFFI, La capacità di diritto privato dei meteci nel mondo greco clas-sico, in «Studi in onore di Gaetano Scherillo», I, Milano, 1972, p. 177-200.
MAFFI, 1976: A. MAFFI, Nomos e mezzi di prova nella teoria aristotelica e nella pras-si giudiziaria attica, in «Atti del I Seminario Romanistico Gardesano», Milano, 1976, p. 115-126.
MARTIN, 1974: J. MARTIN, Antike Rhetorik. Technik und Methode, München, 1974.
MASSA POSITANO, 1971: L. MASSA POSITANO, Eroda. Mimiambo II, Napoli, 1971.
MASTROMARCO, 1979: G. MASTROMARCO, Il pubblico di Eronda, Padova, 1979.
MUMMENTHEY, 1971: H. MUMMENTHEY, Zur Geschichte des Begriffs bl£bh im atti-schen Recht, Diss., Freiburg, 1971.
NAIRN, 1904: The Mimes of Herodas, cur. J.A. Nairn, Oxford, 1904.
PAOLI, 1957: U.E. PAOLI, Aprostasia, in «NNDI», I, 1957, p. 816.
REINACH, 1891: T. REINACH, Inscription de l’île de Cos, in «Revue des études grecques», IV, 1891, p. 357-376.
ROBERT, 1911: C. ROBERT, Die Masken der neueren attischen Komödie, Halle, 1911.
RUTHERFORD, 1891: W.G. RUTHERFORD, Herondas. A First Recension, London, 1891.
www.rivistadirittoellenico.it (23)
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 129 26/05/2013 10.24.52
II/2012
R EDREVIEW OF HELLENIC LAW
ARTICLES
130 Arduino Maiuri
SOUBIE, 1973: E. SOUBIE, Les preuves dans les plaidoyers des orateurs attiques, in «Revue internationale des droits de l’antiquité», XX, 1973, p. 171-253.
STOTZ, 1920: O. STOTZ, De lenonis in comoedia figura, Darmstadt, 1920.
TERZAGHI, 1925: Eroda. I mimiambi, cur. N. Terzaghi, Torino, 1925 (rist. 1944).
THÜR, 1977: G. THÜR, Beweisführung vor den Schwurgerichtshöfen Athens. Die Prokle-sis zur Basanos, Wien, 1977.
USSHER, 1985: R.G. USSHER, The Mimic Tradition of ‘Character’ in Herodas, in «Quad-erni urbinati di cultura classica», XXI, 1985, p. 45-68.
VENERONI, 1971: B. VENERONI, Ricerche su due mimiambi di Eroda, in «Rendiconti del-l’Istituto Lombardo. Classe di Lettere, Filosofia e Morali», CV, 1971, p. 223-242.
WHITEHEAD, 1977: D. WHITEHEAD, The Ideology of the Athenian Metic, Cambridge, 1977.
VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF, 1887: U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORF, Demotika der attischen Metöken, in «Hermes», XXII, 1887, p. 107-128, 211-259.
ZANKER, 2009: Herodas. Mimiambs, cur. G. Zanker, Oxford, 2009.
(24) www.rivistadirittoellenico.it
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 130 19/05/2013 10.39.12
II/2012
R EDRIVISTA DI DIRITTO ELLENICO
ARTICOLI
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda 131
www.rivistadirittoellenico.it (25)
Features of judicial parody in Herodas’ second mime
Abstract
In his second mime Herodas brutally reveals the contradictions of the Attic judicial system, in which the judge does not take part in the inquiry of the case, nor is he allowed to investigate or choose evidence, but is forced to base his decisions only on what the sides attach to their speeches. This reduces the judge to a mere role of arbitrator and increases the importance of the harangue, because it combines signifi-cant objective and subjective elements, such as the report of facts, the correct submission of claims and the positive effect to be produced before the court. Moreover, in that kind of trial, it is the only ground for comparison between the sides. Being aware of this, Herodas makes a vivid caricature of such an im-portant judicial instrument, so that his mime is dominated by the comic-re-alistic figure of the pimp. Ungraceful, but also extremely human, Baktaros strongly claims respectful treatment, which society denies him because of his immoral job: hence the strong sa-tirical aptitude of this mime.
Keywords: parody, oratory, pimp, metoikos, private violence, damage.
Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda
Abstract
Nel secondo mimiambo Eroda mette im-pietosamente a nudo le aporie dell’or-dinamento giudiziario attico, in cui il dikast»j non prende parte all’istruzio-ne della causa, né ha libertà di ricerca o scelta delle prove, ma è vincolato esclu-sivamente a quanto le parti scelgono di allegare ai loro discorsi. Tutto ciò relega il giudice a un mero ruolo arbitrale e ac-cresce l’importanza dell’orazione, che assomma in sé fondamentali elementi oggettivi e soggettivi, come l’esposizio-ne dei fatti, la corretta presentazione delle istanze e l’effetto positivo da su-scitare nei giudici. Inoltre, in un simile dibattimento, essa costituisce l’unico reale terreno di confronto tra le parti. Consapevole di ciò, Eroda caricatureg-gia questo essenziale strumento giudi-ziario, circoscrivendolo efficacemente nei limiti di un mimiambo, interamente permeato dalla figura comico-realistica del lenone Battaro. Costui, infatti, sgra-ziato ma anche tanto umano nelle sue accorate rivendicazioni, reclama a viva voce quel trattamento dignitoso che la società non gli riconosce in virtù del suo sordido ufficio: di qui la dirompente vena parodica del mimiambo.
Parole chiave: parodia, oratoria, lenone, meteco, violenza privata, danno.
Arduino Maiuri
RDE 2-2012 15 ott 12.indd 131 19/05/2013 10.39.12
COMITATO SCIENTIFICO / EDITORIAL BOARD
Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),
Silvio Cataldi (Torino), Feliciantonio Costabile (Reggio Calabria),
Giovanna Daverio Rocchi (Milano), Luigi Gallo (Napoli),
Edmond Lévy (Strasbourg), Remo Martini (Siena),
Gianfranco Purpura (Palermo), Nicolas Richer (Lyon), Guido Schepens (Louvain),
Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)
DIREZIONE / EDITED BY
Pietro Cobetto Ghiggia (Isernia)Ferdinando Zuccotti (Torino)
REDAZIONE / EDITORIAL STAFF
Gianluca Cuniberti (Torino)Barbara Maduli (Torino)Carlo Pelloso (Verona)
Federica Pennacchio (Isernia)Marcello Valente (Torino)
Rivista di Diritto Ellenico / Review of Hellenic Law
V. Mazzini 8 V. Porta Palatina 1 (int. 16)86170 Isernia (Italia) 10122 Torino (Italia)
e-mail: [email protected]
Prezzi e condizioni di abbonamento / Annual Subscription € 60.00(spese postali escluse) (except postal charges)
In copertina e frontespizio: Athena Areia
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)
Frontespizi RDE II 1 feb 13.indd 2 19/05/2013 10.36.47