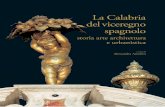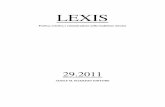Modalità compositive e processi di trasmissione nelle scritture narrative del Medioevo francese
La trasmissione dei sistemi religiosi complessi nel secondo ellenismo. Qualche esemplificazione...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of La trasmissione dei sistemi religiosi complessi nel secondo ellenismo. Qualche esemplificazione...
MEDITERRANEAquaderni annuali dell’ i st itutodi studi sulle c iv iltà ital iche
e del mediterraneo anticodel cons igl io nazionale delle r icerche
già
«quaderni d i archeologia etrusco- ital ica»
iv · 20 07
p i s a · r o m a
fabriz io serra editoremmvi i iiv
· 2
007
ME
DIT
ER
RA
NE
A
issn
182
7-05
06
RELIGIONI IN CONTATTO
NEL MEDITERRANEO ANTICOM O DA L I TÀ D I D I F F U S I O N E
E P RO C E S S I D I I N T E R F E R E N Z A
atti del 3° colloquio su« le religioni orientali nel mondo greco e romano »
loveno di menaggio (como)26-28 maggio 2006
a cura di
corinne bonnet · sergio ribichinidirk steuernagel
Rivista annualediretta da
Francesco Roncalli
*
Comitato scientifi co
Maria Giulia Amadasi · María Eugenia AubetSandro Filippo Bondì · Dominique Briquel
Giovanni Colonna · Carlo de SimoneMohammed Hassine Fantar · Michel Gras
Dieter Mertens · Annette RathjeDavid Ridgway · Vincenzo Tusa
Redazione
Sergio Ribichinicon la collaborazione di
Laura Attisani e Bianca Lea Zambrano
*
Istituto di Studi sulle Civiltà Italichee del Mediterraneo Antico · CNR
MEDITERRANEAquaderni annuali dell’ i st itutodi studi sulle c iv iltà ital iche
e del mediterraneo anticodel cons igl io nazionale delle r icerche
già
«quaderni d i archeologia etrusco- ital ica»
iv · 20 07
p i s a · r o m a
fabriz io serra · editoremmvi i i
Amministrazione e abbonamentiAccademia editoriale®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, i 56123 PisaTel. +39 050 542332 · Fax +39 050 574888
Abbonamenti (2007) :Italia : € 525,00 (privati) · € 745,00 (enti, con edizione Online)
Abroad : € 725,00 (Individuals) · € 845,00 (Institutions, with Online Edition)Prezzo del fascicolo singolo € 1.155,00
I pagamenti possono essere eff ettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
La Casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonatie la possibilità di richiederne la rettifi ca o la cancellazione previa comunicazione alla medesima.
Le informazioni custodite dalla Casa editrice verranno utilizzate al solo scopodi inviare agli abbonati nuove proposte (Dlgs. 196/2003).
*
Autorizzazione del Tribunale: in attesa di registrazione.
*
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti,per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo eff ettuati, compresi la copia fotostatica, il microfi lm,
la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,
un marchio della Accademia editoriale ®, Pisa · Roma.Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2008 by
Fabrizio Serra · Editore®, Pisa · Roma,un marchio della Accademia editoriale ®, Pisa · Roma
*
La Accademia editoriale ®, Pisa · Roma, pubblica con il marchioFabrizio Serra · Editore ®, Pisa · Roma, sia le proprie riviste precedentemente edite con
il marchio Istituti editoriali e poligrafi ci internazionali ®, Pisa · Roma, che i volumidelle proprie collane precedentemente edite con i marchi Edizioni dell’Ateneo ®, Roma,
Giardini editori e stampatori in Pisa ®, Gruppo editoriale internazionale ®, Pisa · Roma,e Istituti editoriali e poligrafi ci internazionali ®, Pisa · Roma.
www.libraweb.net
issn 1827-0506
RELIGIONI IN CONTATTONEL MEDITERRANEO ANTICO
M O DA L I TÀ D I D I F F U S I O N E
E P RO C E S S I D I I N T E R F E R E N Z A
atti del 3° colloquio su« le religioni orientali nel mondo greco e romano »
loveno di menaggio (como)26-28 maggio 2006
a cura di
corinne bonnet · sergio ribichinidirk steuernagel
SOMMARIO
Sergio Ribichini, Religioni in contatto. Introduzione 11Elenco delle abbreviazioni 19
parte primapercorsi e diffusione
Jörg Rüpke, Medien und Verbreitungswege von Religion im Römischen Reich. The-matische Einführung 27
Ennio Sanzi, La trasmissione dei sistemi religiosi complessi nel secondo ellenismo. Qualche esemplifi cazione dall’xi libro de Le Metamorfosi di Apuleio 33
Laurent Bricault, Fonder un lieu de culte 49Valentino Gasparini, Santuari isiaci in Italia: criteri e contesti di diff usione 65Anna-Katharina Rieger, Lokale Tradition versus überregionale Einheit : der
Kult der Magna Mater 89Dirk Steuernagel, Hafenstädte – Knotenpunkte religiöser Mobilität ? 121
parte seconda« culti orientali », paganesimo, giudaismo, cristianesimo
Nicole Belayche, Eric Rebillard, « Cultes orientaux » et pluralisme reli-gieux. Introduction thématique 137
Eleonora Tagliaferro, A proposito della Self-Presentation dell’Ebraismo : presenze e assenze nel Contra Apionem 151
Luc Renaut, Les initiés aux mystères de Mithra étaient-ils marqués au front? Pour une relecture de Tertullien, De praescr. 40, 4 171
Anna Van den Kerchove, La voie d’Hermès, la question des sacrifi ces et les « cultes orientaux » 191
Michela Zago, L’emploi des noms divins dans la Kosmopoiia (pgm xiii) 205Constantinos Macris, Les « hommes divins » et leurs dieux : le cas des cultes
« orientaux » 219
parte terzainterferenze e interazioni, integrazione e rifiuto,
conversione e proselitismo
Christoph Auffarth, Sergio Ribichini, Pluralität, Pluralismus und Exklu-sivität. Thematische Einführung 235
Marie-Françoise Baslez, Du culte de Cybèle au christianisme phrygien : appro-ches d’une identité religieuse régionale 247
Michel-Yves Perrin, De quelques homologies entre ralliements confessionnels en régime chrétien et adhésions au christianisme dans l’Antiquité tardive 263
10 sommario
Ilinca Tanaseanu Döbler, Befreiung aus der Finsternis : Kaiser Julian und die orientalischen Kulte 281
Winrich Löhr, Konversion und Konversionserzählung. Beobachtungen zur Kon-struktion des Religionswechsels in der Spätantike am Beispiel Augustins 303
Benedetto Clausi, Gli spazi del confronto : ascetismo cristiano e « religioni orien-tali » in Ambrogio e Gerolamo 315
Christoph Auffarth, Religio migrans: Die « Orientalischen Religionen » im Kontext antiker Religion. Ein theoretisches Modell 333
LA TRASMISSIONE DEI SISTEMI RELIGIOSICOMPLESSI NEL SECONDO ELLENISMO
qualche esemplificazione dall’xi librode le metamorfosi di apuleio
Ennio Sanzi *
Hugoni Bianchi etIoanni Carolo Montesimagistris carissimissacrum
* Dottore di ricerca in Storia religiosa, Di-partimento di studi tardo-antichi, Università di Messina.
1 Si veda : Hans Robert Jauss, Perché la storia della letteratura ?, Napoli, Guida, 19832.
« mediterranea » · iv, 2007
U n concetto assai caro alla critica letteraria contemporanea è quello
di ‘orizzonte d’attesa’. Con tale espres-sione si vuole focalizzare l’attenzione non tanto sull’autore dell’opera quanto sul fruitore della medesima. Secondo questa corrente che fa capo ad Hans R. Jauss, il lettore fi nirà per ritrovare all’interno dell’opera letteraria soprat-tutto quello che si aspetta di trovarvi o, perlomeno, il suo punto di vista avrà la stessa legittimità di quello di qualsia-si altro lettore e addirittura di quello dell’autore. 1
Crediamo che un tale concetto debba essere tenuto presente, almeno a scopo precauzionale, da tutti quelli che si de-dicano all’analisi storico-religiosa delle testimonianze letterarie. Infatti sono proprio testimonianze di questo genere a venire in soccorso di chiunque cerchi di interpretare i dati forniti dal patri-
monio epigrafi co ed iconografi co ; dati per i quali, almeno in alcuni casi, i te-sti letterari possono costituire reali ru-briche e autentiche didascalie. Proprio per questo motivo, a volte, i testi di tal genere, hanno fi nito per costituire al-cune delle vie maestre lungo le quali i cosiddetti sistemi religiosi complessi hanno continuato in qualche modo a diff ondersi anche dopo la loro dichia-rata soppressione.
Ci auguriamo che possa risultare utile rifl ettere in tal senso su una delle fonti letterarie maggiormente conside-rate dagli studiosi dei ‘culti orientali’. 2 Facciamo riferimento a Le Metamorfosi
2 Su questo specifi co fenomeno religioso del secondo ellenismo nonché per delle indicazio-ni bibliografi che, oltre alla monumentale serie « epro » (continuata ma non sostituita da « rgrw » e numerosi interventi presenti in « anrw » ; si veda : Franz Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain4, Paris, Geuthner 1929 ; Giulia Sfameni Gasparro, Le religioni orientali nel mon-do ellenistico romano, in Storia delle religioni6, a cura di Giuseppe Castellani, 5 voll., Torino, utet, 1970-1971, vol. iii, pp. 423-456 ; Die orientalischen Religionen in Römerreich, a cura di Maarten J. Ver-maseren 1981, Leiden, Brill, 1981 (« epro », xciii) ;
34 ennio sanzi
La soteriologia dei culti orientali nell’Impero romano. Atti del Colloquio internazionale su « La soteriologia dei culti orientali nell’Impero romano » (Roma, 24-28 settembre 1979), a cura di Ugo Bianchi, Maarten J. Vermaseren, Leiden, Brill, 1982 (« epro », xcii) ; Luther H. Martin, Hellenistic Religion. An In-troduction, New York-Oxford, oup, 1987 ; Jona-than Z. Smith, Drudgery Divine. On the Com-parison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, Chicago, University of Chicago Press, 1990 ; Robert Turcan, Les cultes orientaux dans le monde romain2, Paris, Les Belles Lettres, 1992 ; Jaime Alvar et alii, Cristianismo primiti-vo y religiones mistéricas, Madrid, Cátedra, 1995 ; Ennio Sanzi, Soteriologia, escatologia e cosmologia nel culto di Mithra, di Iside e Osiride e di Iuppiter Dolichenus. Osservazioni storico-comparative, Tesi di dottorato, Roma, 1997 ; Jaime Alvar, Los mi-sterios. Religiones « orientales » en el imperio romano, Barcelona, Crítica, 2001 ; Le religioni dei misteri, a cura di Paolo Scarpi, 2 voll. (1. Eleusi, Dionisismo, Orfi smo ; 2. Samotracia, Andania, Iside, Cibele e At-tis, Mitraismo), Fondazione Lorenzo Valla, Mon-dadori, 2002 ; Walter Burkert, Antike Myste-rien. Funktionen und Gehalt3, Berlin, Beck, 2003 ; I culti orientali nell’impero romano. Un’antologia di fonti, a cura di Ennio Sanzi, Cosenza, Giorda-no, 2003 ; Giulia Sfameni Gasparro, Misteri e Teologie. Per la storia dei culti mistici e misterici nel mondo antico, Cosenza, Giordano, 2003 ; Lo-renzo Bianchi, Ennio Sanzi, Carla Sfame-ni, I culti orientali a Roma, Roma, De Rosa, 2004 (« Romarcheologica », xxi) ; Pagani e Cristiani alla ricerca della salvezza (secoli i-iii). xxxiv Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 5-7 mag-gio 2005, Roma, Augustinianum, 2006 (« Studia Ephemeridis Augustinianum », xcvi) ; Religions orientales - Culti misterici. Neue Perspektiven - nou-velles perspectives - prospettive nuove. Im Rahmen des trilateralen Projektes “Les religions orientales dans le monde grèco-romain”, a cura di Corinne Bonnet, Jörg Rüpke, Paolo Scarpi, Stuttgart, Steiner 2006 (« PawB », xvi) ; Die Rolle der orientalischen Kulte insbesondere in der römischen Kaiserzeit, « arg », viii, 2006 ; Ennio Sanzi, Carla Sfameni, Magia e Culti orientali. Studi storico-comparativi su due feno-meni religiosi nella Tarda Antichità, Cosenza, Gior-dano (in corso di stampa).
di Apuleio. Di recente, in occasione di alcune conversazioni private e di alcu-ni seminari universitari, si è sostenuto che la dimensione soteriologica intra ed extra- mondana promessa dalla Iside di
Apuleio trovi le proprie ed esclusive fondamenta nell’adesione del madau-rense al medio-platonismo. In altre parole, se da una parte Iside sarebbe soprattutto portavoce del ‘credo’ fi lo-sofi co dello stesso Apuleio, dall’altra la dimensione iniziatica e le connesse aspettative di natura intra- ed extra mondana promesse dalla dea stessa troverebbero giustifi cazione in tale vi-sione fi losofi ca e non sarebbero state re-cepite dal ‘grande pubblico’ dei fedeli isiaci tout court. 1
Si tratterà, allora, di analizzare l’un-dicesimo libro de Le Metamorfosi 2 nel tentativo di individuare o meno una serie di elementi di tonalità maggiore e/o minore che potessero risultare im-mediatamente riconoscibili allo studio-sus lector ad esse più o meno contem-poraneo al fi ne di trarre delle prime conclusioni circa la potenziale diff u-sione tra il pubblico di Apuleio di una Iside misterica e garante di benefi ci in vitam e nel post mortem. Per constatare la presenza di tali elementi si dovrà fare ricorso non solo ad altre testimonianze letterarie ma anche a documenti epi-grafi ci, papiracei ed iconografi ci, e cioè a documenti che sono la testimonianza diretta e la misura della diff usione del culto della dea egizia.
1 Si veda da ultimo : E. Sanzi, La vittoria sul male nell’interpretatio graeca di un mito egiziano : il De Iside et Osiride di Plutarco, in Origine e feno-menologia del male : le vie della catarsi veterotestamen-taria, xiv Convegno di studi veterotestamentari, Ciampino, 5-7 settembre 2005, Roma (in corso di stampa).
2 Si veda : Apuleius of Madauros, The Isis-Book (Metamorphoses, Book xi), a cura di John Gwyn Griffi ths, Leiden, Brill, 1975 (« epro », xxxix). Abbiamo fatto sempre riferimento a questa edizione per i passi di seguito citati rela-tivi all’ xi libro delle Metamorfosi.
la trasmissione dei sistemi religiosi nel secondo ellenismo 35
2 Apul., Met., xi, 17 : « Ma quando giungem-mo proprio al tempio, il sommo sacerdote, quel-li che portavano le immagini sacre, e quelli che precedentemente erano stati iniziati ai misteri degni di venerazione, raccoltisi nella cella della dea, disposero secondo il rito le statue viventi. Allora uno di questi, quello che tutti chiamava-no scriba, in piedi davanti alle porte, chiamato come in riunione il collegio dei pastofori – que-sto è il nome di quel santissimo collegio – da quello stesso luogo, dall’alto di una tribuna, da un libro di formule recitò fauste preghiere per il grande principe e il senato, i cavalieri e tutto il popolo romano, per i marinai e le navi che bat-tono la nostra bandiera entro i confi ni dei nostri possedimenti, proclamò secondo la lingua ed il rito greco l’apertura della navigazione ».
3 Sulle aretalogie isiache e sul connesso enotei-smo si veda : Jan Bergman, Ich bin Isis. Studien zum memphitischen Hintergrund der griechischen Isi-saretalogien, Uppsala, Berlingska Boktryckeriet, 1968 ; Maria Grazia Sfameni, Le aretalogie isiache : aspetti ellenistici di una divinità egiziana, in Destino e salvezza tra culti pagani e gnosi cristiana. Itinerari storico-religiosi sulle orme di Ugo Bianchi, a cura di Giulia Sfameni Gasparro, Cosenza, Gior-dano, 1988, pp. 219-238 ; Hendrik S. Versnel, Ter Unus. Isis, Dionysos, Hermes. Three Studies in Henotheism2, Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998 ; Joachim F. Quack, “Ich bin Isis, die Herrin der beiden Länder”. Versuch zum demotischen Hinter-grund der memphitischen Isisaretalogie, in Egypt
Appare evidente che non può essere frutto di invenzione letteraria la de-scrizione della ploiaphesia che occupa i capp. 8-17 dell’ultimo libro del roman-zo. È questa una cerimonia pubblica che segna la riapertura della navigazio-ne. Proprio perché cerimonia pubblica, e quindi conosciuta, si può pensare che la descrizione che ne fa Apuleio non sia una semplice rivisitazione artisti-ca, espressione del proprio genio let-terario, ma che in essa il madaurense abbia riproposto quanto il suo lettore poteva avere avuto occasione di vedere in prima persona. Ci sembra degno di nota, allora, che in questa descrizione, in almeno due ricorrenze, si faccia di-retto riferimento agli iniziati del culto isiaco come ad un’enclave che gode di una considerazione specifi ca e di una posizione distinta, se non privilegiata, nell’insieme dei fedeli della dea. Vedia-mo, di seguito, le due ricorrenze nelle quali si fa menzione di questa specifi ca categoria di fedeli :
a) Tunc infl uunt turbae sacris divinis initiatae, viri feminaeque omnis dignitatis et omnis aeta-tis, linteae vestis candore puro luminosi, illae limpido tegmine crines madidos obvolutae, hi capillum derasi funditus verticem praenitentes, aereis et argenteis, immo vero aureis etiam sistris argutum tinnitum constrepentes. 1
b) At cum ad ipsum iam templum pervenimus, sacerdos maximus quique divinas effi gies pro-
gerebant et qui venerandis penetralibus pridem fuerant initiati, intra cubiculum deae recep-ti disponunt rite simulacra spirantia. Tunc ex his unus, quem cuncti grammatea dicebant, pro foribus assistens coetu pastophorum – quod sa-crosancti collegii nomen est – velut in contio-nem vocato indidem de sublimi suggestu de libro de litteris fausta vota praefatus principi magno senatuique et equiti totoque Romano populo, nauticis navibus quaeque sub imperio mundi nostratis reguntur, renuntiat sermone rituque Graeciensi ploiaphesia’. 2
È altresì noto che uno dei momenti forti de Le Metamorfosi sia da individuare nel-l’autoproclamazione durante la quale la dea Iside, secondo lo stile litanico delle cosiddette aretalogie, 3 promettendo il
1 Apul., Met., xi, 10 : « Allora irrompe la mol-titudine degli iniziati ai sacri misteri, uomini e donne di ogni condizione sociale e di ogni età, splendenti nel puro candore della veste di lino, quelle con i capelli profumati raccolti in un velo trasparente, questi rasati del tutto i capelli con il capo brillante facevano echeggiare un acuto tintinnio dai sistri non solo di bronzo e d’argento ma anche d’oro.
36 ennio sanzi
suo aiuto provvidenziale risponde ad un Lucio oramai talmente disperato da invocare la morte. In tale autoprocla-mazione Iside si auto-celebra in chiave enoteistica, si dichiara commossa dalle preghiere del protagonista e garantisce il proprio intervento di dea « benigna e propizia ». 1 In questo momento ol-tremodo signifi cativo dell’ultimo libro del romanzo, una Iside descritta pro-prio come appare nella statuaria con-temporanea, dopo avere promesso ad un Lucio inconsapevole di essere sul punto di redire ad homines la salvezza, gli ingiunge :
Plane memineris et penita mente conditum semper tenebis mihi reliqua vitae tuae curricula adusque terminos ultimi spiritus vadata. Nec iniurium, cuius benefi cio redieris ad homines, ei totum debere, quod vives. Vives autem bea-tus, vives in mea tutela gloriosus, et cum spa-tium saeculi tui permensus ad inferos demearis, ibi quoque in ipso subterraneo semirutundo me, quam vides, Acherontis tenebris interlucentem Stygiisque penetralibus regnantem, campos Elysios incolens ipse, tibi propitiam frequens adorabis. Quodsi sedulis obsequiis et religiosis ministeriis et tenacibus castimoniis numen no-strum promerueris, scies ultra statuta fato tuo spatia vitam quoque tibi prorogare mihi tantum licere. 2
È evidente come tra i momenti cardi-ne di questo passaggio possa ascriversi a pieno titolo la promessa di una bea-titudine oltremondana ; naturalmente si tratta di un modello di beatitudine che richiama modalità eleusine ma che, proprio per questo, fi nirebbe con l’es-sere limitato se letto soltanto quale me-tafora volta ad enfatizzare condizioni privilegiate di natura sofi co-sapienziale
- Temple of the Whole World. Ägypten - Tempel der gesamten Welt. Studies in Honour of Jan As-smann, a cura di Sibylle Meyer, Leiden-Boston, Brill, 2003, (« Studies in the History of Religions. Supplements to Numen », xcvii), pp. 319-366 ; Elena Muñiz Grijalvo, Hymnos a Isis, Barcelo-na, Trotta, 2006 ; Robert Turcan, Isis gréco-ro-maine et l’hénothéisme femninin, in, Nilo into Tiber. Egypt in the Roman World. Proceedings of the IIIrd International Conference of Isis Studies, Leiden, May 11-14 2005, a cura di Laurent Bricault, Miguel J. Versluys, Paul G.P. Meyboom, Leiden-Boston, Brill, 2007 (« rgrw », clix), pp. 73-88.
1 Si veda : Giulia Sfameni Gasparro, Iside Fortuna. Fatalismo e divinità sovrane del destino nel mondo ellenistico-romano, in Le Fortune dell’età ar-caica nel Lazio ed in Italia e la loro posterità. Atti del 3. Convegno di Studi archeologici sull’antica Preneste, Palestrina, 15-16 ottobre 1994, Palestrina, sine nomi-ne, pp. 301-324 = Eadem, Oracoli Profeti Sibille. Rivelazione e salvezza nel mondo antico, Roma, las, 2002, pp. 303-326 ; Eadem, Iside salutaris : aspetti medicali e oracolari del culto isiaco tra radici egiziane e metamorfosi ellenica, in Imago Antiquitatis. Re-ligions et iconographie du monde romain. Hommage off ert à Robert Turcan, a cura di Nicole Blanc, An-dré Buisson, Paris, De Boccard, 2000, pp. 405-415 = Eadem, Oracoli Profeti Sibille. Rivelazione e salvezza nel mondo antico, Roma, las, 2002, pp. 327-342 ; Eadem, The Hellenistic Face of Isis : Co-smic and Saviour Goddess, in Nilo into Tiber..., cit. supra, nota immediatamente precedente.
2 Apul., Met., xi, 6 : « Ricorderai con scrupolo e terrai sempre presente nel profondo del tuo animo che a me sarà consacrato quanto resta del-la tua vita fi no a quando non avrai esalato l’ul-timo respiro. Né è privo di giustizia il fatto che donerai tutto il tempo che vivrai a colei grazie al cui intervento benefi co sarai tornato fra gli uo-mini. Inoltre vivrai beatus e conoscerai la gloria sotto la mia tutela e, trascorso il tempo della tua esistenza, dimorerai negli inferi ed anche là pro-prio in quell’emisfero sotterraneo, così come ora mi vedi, proprio me che risplendo tra le tenebre dell’Acheronte e che regno fi n nei recessi dello Stige adorerai frequentemente perché a te pro-pizia. Inoltre, se avrai promosso il nostro nume con scrupolosi atti di obbedienza, con servizi pieni di scrupolo religioso e con tenace castità, saprai come soltanto a me sia lecito addirittura prorogare ulteriormente la vita oltre gli spazi stabiliti dal tuo destino ».
la trasmissione dei sistemi religiosi nel secondo ellenismo 37
delle quali si fa portavoce il medio-pla-tonismo. Avremo comunque occasione di ritornare su un tal genere di rifl es-sioni.
La descrizione della Iside che si mo-stra a Lucio riprende da vicino quella della statuaria contemporanea al punto che la parole del romanzo potrebbero essre utilizzate per descrivere numero-se e note statue della dea egizia :Iam primum crines uberrimi prolixique et sensim intorti per divina colla passive dispersi molliter defl uebant. Corona multiformis variis fl oribus sublimen destrinxerat verticem, cuius media quidem super frontem plana rotunditas in modum speculi vel immo argumentum lu-nae candidum lumen emicabat, dextra laevaque sulcis insurgentium viperarum cohibita, spicis etiam Cerialibus desuper porrectis conspicua. Tunica multicolor, bysso tenui pertexta, nunc albo candore lucida, nunc croceo fl ore lutea, nunc roseo rubore fl ammida et, quae longe longeque etiam meum confutabat optutum, palla niger-rima splendescens atro nitore, quae circumcir-ca remeans et sub dexterum latus ad umerum laevum recurrens umbonis vicem deiecta parte laciniae multiplici contabulatione dependula ad ultimas oras nodulis fi mbriarum decoriter con-fl uctuabat. Per intextam extremitatem et in ipsa eius planitie stellae dispersae coruscabant earumque media semenstris luna fl ammeos spi-rabat ignes. Quaqua tamen insignis illius pallae perfl uebat ambitus, individuo nexu corona totis fl oribus totisque constructa pomis adhaerebat. Iam gestamina longe diversa. Nam dextra qui-dem ferebat aereum crepitaculum, cuius per an-gustam lamminam in modum baltei recurvatam traiectae mediae paucae virgulae, crispante bra-chio trigeminos iactus, reddebant argutum sono-rem. Laevae vero cymbium dependebat aureum, cuius ansulae, qua parte conspicua est, insurge-bat aspis caput extollens arduum cervicibus late tumescentibus. Pedes ambroseos tegebant soleae palmae victricis foliis intextae. 1
Un altro elemento presente nei primi capitoli dell’xi libro che ben si riallac-cia alla dimensione cultuale pubblica
1 Apul., Met., xi, 3-4 : « In primo luogo dei
capelli foltissimi e lunghi, moderatamente ar-ricciati e sciolti in modo sparso cadevano giù dolcemente lungo il collo divino. Una corona di numerosi fi ori di diversi generi stringeva alla sommità il capo sublime, nel mezzo del quale proprio sulla fronte un disco piatto simile ad uno specchio o piuttosto simbolo della luna, af-fi ancato a destra e a sinistra da serpenti sollevati in spire e ornato nella parte superiore anche da spighe di cereali, irradiava una luce candida. La tunica multicolore intessuta di bisso sottile, ora sembrava splendente di bianco fulgore, ora gialla come il fi ore del croco, ora fi ammeggiante del colore delle rose e, a confondere ulteriormen-te il mio sguardo, un mantello oltremodo nero ma risplendente di una lucentezza oscura che lo avvolgeva tutta intorno e che risaliva dal fi an-co destro fi no alla spalla sinistra ; una parte del lembo lasciato cadere come la toga cadente con pieghe molteplici fl uttuava fi no agli ultimi lembi elegantemente grazie ai piccoli nodi delle fran-ge. Lungo l’orlo ricamato e sull’ampia superfi cie dello stesso mantello risplendevano delle stelle sparse qua e là, e nel mezzo di quelle una luna eff ondeva fi amme di fuoco ; nondimeno da qua-lunque parte ondeggiasse il giro di quell’insigne mantello, una corona intrecciata di fi ori e frutti molto numerosi vi aderiva fortemente con nes-so inseparabile. Inoltre, di gran lunga variegati erano i suoi attributi. Infatti, nella mano destra teneva un sistro di bronzo, e dopo che la dea col braccio aveva vibrato tre colpi per tre volte, attraverso la sua sottile lamina ricurva come un balteo poche verghette attraversate nel mezzo emettevano un sonoro tintinnio. Dalla sinistra pendeva una lampada d’oro a forma di navicel-la, sul manico della quale, in quella parte che è visibile, un aspide si levava sollevando il capo in alto con il collo rigonfi o abbondantemente. Dei sandali intrecciati di foglie di palma, ornamento dei vincitori, proteggevano i piedi divini ». Tra le statue di Iside che corrispondono in larga par-te a questa descrizione citiamo, a scopo esem-plifi cativo, quelle conservate a Napoli (Museo Archeologico nazionale, n. inv. 6372), a Roma (Musei capitolini, Sala del Galata, n. 11, n. inv, 744) e a Vienna (Kunsthistorisches Museum, n. inv. 1-158)
38 ennio sanzi
del culto isiaco è costituito dalla già accennata auto-proclamazione della dea :En adsum tuis commota, Luci, precibus, rerum naturae parens, elementorum omnium domina, saeculorum progenies initialis, summa numi-num, regina manium, prima caelitum, deorum dearumque facies uniformis, quae caeli lumi-nosa culmina, maris salubria fl amina, inferum deplorata silentia nutibus meis dispenso : cuius numen unicum multiformi specie, ritu vario, nomine multiiugo totus veneratus orbis. 1
Segue la nota reductio ad unum in pri-ma persona – come è nello stile delle aretalogie – nella quale la dea elenca le varie divinità femminili a lei ricondu-cibili che sono venerate dai popoli più diversi :Inde primigenii Phryges Pessinuntiam deum matrem, hinc autochthones Attici Cecropeiam Minervam, illinc fl uctuantes Cyprii Paphiam Venerem, Cretes sagittiferi Dictynnam Dia-nam, Siculi trilingues Ortygiam Proserpinam, Eleusinii vetustam Actaeam Cererem, Iunonem alii, Bellonam alii, Hecatam isti, Rhamnusiam illi ; 2
fi no al trionfalismo isiaco esaltato dal-
l’encomio di coloro : « nascentis dei Solis inchoantibus inlustrantur radiis Aethiopes Afrique priscaque doctrina pollentes Aegyp-tii caerimoniis me propriis percolentes appel-lant vero nomine reginam Isidem ». 3
Anche questo passaggio dell’xi libro de Le Metamorfosi trova una precisa ri-spondenza nella documentazione epi-grafi ca e papiracea contemporanea o meno. Sarà suffi ciente in questa sede ricordare il primo dei cosiddetti Inni di Isidoro, l’aretalogia di Kyme e l’aretalo-gia di Maronea. Nel primo documento ricordato si legge :Ploutodovti ba�ivleia qew`n, ïErmou`qi a[na��a, ƒ pantokravteira, tuvch ÆAgaqhv, megalwvnume ÇI�i, ƒ Dhoi` uJyiv�th, zwh`� euJrev-tria pav�h�, ƒ pantoivwn e[rgwn ejmevlh�ev �oi, o[frÆ ajnadoivh� / (5) ajnqrwvpoi�i bivon te kai; eujnomivhn te a{pa�i, / kai; qe�mou;� katev-deixa�, i{nÆ eujdikivh ti� uJpavrchæ, ƒ kai; tevc-na� ajnevdwka�, i{nÆ euj�chvmwn bivo� ei[h, ƒ kai; pavntwn te fuv�in eujanqeva eu{reo karpw`n. ƒ ‚ou` te cavrin �unev�thcÆ oJ pov lo� kai; gai`a a{pa�a / (10) kai; pnoiai; ajnevmwn kai; h{lio� oJ glukufegghv�. / ‚h`i dunavmei Neivlou pota-moi; plhrou`ntai a{pante� / w{rhi ojpwrinh`i, kai; labrovtaton cei`qÆ u{dwr / gai`an pa`�an e[pi, i{nÆ ajnevglipo� karpo;� uJpavrchæ. / o{��oi de; zwvou�i brotoi; ejpÆ ajpeivroni gaivhi. / (15) Qra`/ke� kai; ÓEllhne�, kai; o{��oi bavrbaroiv eij�i, / ou[nomav �ou to; kalovn, polutivmhton para; pa`�i, / fwnai`�i fravzou�Æ ijdivai�, ijdivai ejni; pavtrhi. / ÆA�tavrthn ÒArtemivn �e ‚uvroi klhvæzou�i Nanaivan / kai; Lukivwn e[qnh ¿h¯ Lhtou`n kalevou�in a[na�»�an / (20) Mhtevra dh; klhvæzou�i qew`n kai; Qrhvi>ke� a[ndre�, / ÓEllhne� dÆ ÓHrhn megalovqronon hjdÆ ÆAfrodivth»n / kai; ïE�tivan ajgaqhvn,
1 Apul., Met., xi, 5 : « Eccomi o Lucio com-mossa dalle tue preghiere ! Io sono la madre della natura, la signora di tutti gli elementi, l’origine prima dei secoli, la più importante fra i numi, la regina dei mani, la prima fra i celesti, fi gura uniforme degli dèi e delle dee ; io che regolo con i miei ordini le luminose sommità del cielo, i venti salubri del mare, i desolati luoghi silenziosi degli inferi ; la divinità unica il cui nome tutto il mondo venera in forma varia, con riti diversi e sotto molteplici nomi ».
2 Apul., Met., xi, 5 : « Di qua i Frigi primi fra gli uomini Pessinuntia Mater degli dèi, di là gli autoctoni dell’Attica Minerva Cecropia, ed an-cora i Ciprioti bagnati dal mare Venere Pafi a, i Cretesi arcieri famosi Diana Dictinna, i Siculi trilingue Proserpina Ortigia, gli Eleusini vetu-sta Cerere Attea, ed altri Iuno, ed altri ancora Bellona, gli uni Ecate, gli altri Ramnusia ».
3 Apul., Met., xi, 5 : « (Quelli) che sono illumi-nati dai primi raggi del sole nascente, gli Etiopi, gli Africani e gli Egiziani potenti per la dottrina antichissima, onorandomi con i riti che più mi sono propri, mi chiamano col mio vero nome (di) Iside regina ».
la trasmissione dei sistemi religiosi nel secondo ellenismo 39kai; ïRei`an, kai; Dhvmhtra, / Aijguv ptioi de; Qiou`in, o{ti mouvnh ei\ �u; a{pa�a»i / aiJ uJpo; tw`n ejqnw`n ojnomazovmenai qeai; a[llai. / (25) De�povti, ouj lhvxw megavlhn duvnamivn �ou ajeivdwn, / �wvteirÆ ajqanavth, poluwvnu-me, ÇI�i megiv�th, / ejk polevmou rJumevnh te povlei� pavnta� te polivta�, / aujtou;� kai; ajlovcou� kai; kthvmata kai; fivla tevkna. / o{��oi dÆ ejm moivrai� qanavtou �unevcontai ejn eijrkth`i, / (30) kai; o{�oi ajgrupnivai� megav lai� ojclou`ntÆ ojdonhrai`�, / kai; oiJ ejn ajllotrivhi cwvrhi planowvmenoi a[ndre� / kai; o{�oi ejm pelavgei megavlwi ceimw`ni plevou�i / ajndrw`n ojllumevnwn nhw`n kata; ajgnumenavwn, / �wvzonqÆ ou|toi a{pante�, ejpeuxavmenoiv �e parei`nai. / (35) Klu`qi ejmw`n eujcw`n, megalo�qene;� oujnomÆ e[cou�»a / eujeivlato� ejmoiv te geivnou, luvph� mÆ ajnavpau�on aJpav�h�. / ÆI�ivdwro� / e[graye. 1
La somiglianza con l’aretalogia de Le Metamorfosi non ha bisogno di com-mento.
Per quanto riguarda l’aretalogia di Kyme, Bianchi ha ben messo in luce come il momento centripeto dell’ideo-logia sottesa al testo epigrafi co sia da individuare nell’Egitto ellenistico. 2 In-fatti è forte il debito che la dea, dopo avere ricordato i propri klea, dichiara di avere nei confronti della sua terra natale :Ei|�i� ejgwv eij/ (5)-mi hJ tuvranno� pav�h� cwvra� kai; ejpaideuvqhn uJp»o;¼ / ïErmou`, kai; gravmmata eu|ron meta; ïErmou`, tav te iJera; / kai; ta; dhmov�ia gravmmata, i{na mhv ejn toi`� aujtoi`� / pavnta gravfhtai. – ÆEgw; novmou� ajnqrwvpoi� ejqevmhn,/ kai; ejnomoqevth�a a} oujqei;� duvnatai metaqei`nai. / (10) ÆEgwv eijmi Krovnou qugavthr pre�butavthi. –ÆEgwv eijmi g»u¼/nh; kai; ajdelfh; ÆO�eivrido� ba�ilevw�. – ÆEgwv eijmi hJ karpo;n / ajn-qrwvpoi� euJrou`�a. – ÆEgwv eijmi mhvthr ÓWrou ba�ilevw�. / ÆEgwv eimi hJ ejn tw`/ tou Kuno;� a[�trw/ ejpitevllou�a. – ÆEgwv / eijmi hJ para; gunaixi; qeo;� kaloumevnh. – ÆEmoi; Bouvba�to� / (15) povli� wj/kodomhvqh. – ÆEgwv ejcwvri�a gh;n ajp’ oujranou`. / ÆEgw; a[�trwn
1 Hymn. ad Is., i (= The Four Greek Hymns of Isidorus and the Cult of Isis, a cura di Vera F. Vanderlip, Toronto, Hakkert, 1972, [« American Studies in Papyrology », xii], pp. 17-18) : « Regi-na degli dèi dispensatrice di ricchezza, signora di Ermoutis, onnipotente, Buona Fortuna, Isi-de dal grande nome, altissima Deò, inventrice di tutta la vita, ti prendesti cura di ogni tipo di opera per donare a tutti gli uomini la vita e il buon governo, introducesti le leggi affi nché re-gnasse la giustizia e insegnasti le regole perché la vita fosse decorosa, e inventasti la natura vario-pinta di tutti i frutti. Grazie a te si è costituita la volta celeste, tutta la terra, i soffi dei venti e il sole dalla dolce luce. Per la tua potenza tut-ti i canali del Nilo si riempiono nella stagione asciutta, e l’acqua assai impetuosa si spande su tutta la terra, affi nché il raccolto non sia scarso. Quanti sono mortali vivono nella terra infi nita. I Traci e i Greci e tutti quanti sono barbari pro-nunciano il tuo bel nome, da tutti assai onorato, nelle proprie lingue e nella propria patria. I Siri ti chiamano Astarte, Artemide, Nanaia, i popo-li dei Lici ti chiamano signora Letò, gli uomini Traci ti chiamano Madre degli dèi, i Greci Era dal grande trono, e Afrodite e la buona Estia, e Rea, e Demetra, gli Egiziani Thiouis perché tu sola sei tutte le altre dee che sono chiamate con i loro nomi dai popoli. O Signora, non cesserò di cantare la tua grande potenza, salvatrice im-
mortale, dai molti nomi, Iside somma che metti in salvo dalla guerra tutte le città e i cittadini, loro stessi , le mogli, i beni e i cari fi gli. Quanti sono tenuti prigionieri da un destino di morte, e quanti sono turbati da lunghe veglie angoscianti, e quanti uomini che vanno errando in una ter-ra straniera, e quanti navigano per mare in una grande tempesta mentre gli uomini muoiono sulle navi che si spezzano, tutti costoro si salva-no se chiedono con preghiere che tu li soccorra. Esaudisci le mie preghiere, tu che hai un nome possente, sii a me propizia, metti fi ne ad ogni mia soff erenza. Isidoro ha scritto ».
2 Si veda : Ugo Bianchi, Iside dea misterica. Quando ?, in Perennitas. Studi in onore di Angelo Brelich, a cura di Giulia Piccaluga, Roma, Ate-neo, 1980, pp. 9-36.
40 ennio sanzioJdou;� e[deixa. – ÆEgw; hJlivou kai; �elhvnh»�¼ / porevan �unetaxavmhn. – ÆEgw; qalav��ia e[rga eu|ron. – ÆE/gw; to; divkaion iJ�curo;n ejpoivh�a. – ÆEgw; gunai`ka kai; a[ndra / �unhvgagon. – ÆEgw; gunaixi; dekamhnai`on brevfo� eij� / (20) fw`� ejxenegkei`n e[taxa. – ÆEgw; uJpo; tevknou gonei`� / ejnomoqevth�a filo�torgi`�qai. – ÆEgw; toi`� aj�tovr/goi� goneu`�in diakeimevnoi� teimw‹rÌivan ejpev-qhka: / ÆEgw; meta; tou` ajdelfou`ÆO�ivrido� ta;� ajnqwpofa/giva� e[pau�a. – ÆEgw; muhv�ei� ajnqrwvpoi� ejpevde»i¼/ (25)-xa. – ÆEgw; ajgavlmata qew`n teima`n ejdivdaxa. – / ÆEgw; temevnh qew`n iJdru�avmhn. – ÆEgw; turavnnwn ajrc/a;� katevlu�a. – ÆEgw; fovnou� e[pau�a. – ÆEgw; �tevr/ge�qai gunai`ka� uJpo; ajndrw`n hjnavgka�a. – ÆEgw; / to; div-kaion ij�curovteron cru�ivou kai; ajrgurivou ejpoivh/ (30)-�a. – ÆEgw; to; ajlhqe;� kalo;n ejnomo»qev¼th�a nomivze»�¼/qai. – ÆEgw; �un-grafa;� gamika;� eu|ron. – ÆEgw; dialevktou� / ÓEllh�i kai; barbavroi� e[taxa. – ÆEgw; to; kalo;n kai; aij�cro;»n¼ / diageinwv�ke�qai uJpo; th`� fuv�ew� ejpoivh�a. – ÆEgw; / o{rkou foberwvteron oujqe;n ejpoivh�a. – ÆEgw; to;n ajdivkw� / (35) ejpibouleuvonta a[lloi� {a[llw} uJpoceivrion tw`/ ejpibou/»l¼euomevnw/ parevdwka. – ÆEgw; toi`� a[dika prav��ou�in / teimwrivan ejpitivqhmi. – ÆEgw; iJkevta� ejlea`n enomoq»ev¼/th�a. – ÆEgw; tou;� dikaivw� ajmu-nomevnou� teimw`. – Pa/r’ ejmoi; to; divkaion ij�cuvei. – ÆEgw; potamw`n kai; ajnevmwn / (40) »k¼ai; qalav��h� eijmi; kuriva. – Oujqei� doxav-zetai a[neu th� ej/mh`� gnwvmh�. – ÆEgwv eijmi polevmou kuriva. – ÆEgw; kerauv/nou kuriva eij-miv. – ÆEgw; prau?nw kai; kumaivnw qavla��an. /ÆEgw; ejn tai`� tou` hJlivou aujgai`� eijmi. – ÆEgw; paredreuvw th`æ / tou hJlivou poreiva/. – ÔO a]n ejmoi; dovxhæ, touto kai; telei`ta»i¼. / (45) ÆEmoi; pantÆ ejpeiv kei. – ÆEgw; touv� ejn de�moi`� luvw»i¼. / ÆEgw; nautiliva� eijmi; kuriva. – ÆEgw; ta; plwta; a[plwta poi»w` o{¼/tan ejmoi; dovxhæ. –ÆEgw; peribovlou� povlewn e[kti�a. – ÆE/gwv eijmi hJ qe�mofovro� kalou-mevnh. –ÆEgw; n»hv¼��ou� ejk b»u/q¼w`n eij� fw`n (sic) ajnhvgagon. – ÆEgw; o[mbrwn eijmi; kuriva. – ÆEgw; / (50) to; iJmarmevnon nikw`. – ÆEmou`
to; eijmarmevnon aj kouvei. / Cai`re Ai[gupte qrevya�av me. 1
1 ricis, n. 302/0204 (con qualche modifi ca) : « Demetrio fi glio di Artemidoro, detto anche Trasea, di Magnesia sul Menandro ad Iside come voto (vac.). Queste parole furono trascritte dal-la stele di Menfi , quella che è posta nei pressi dell’Efasteion (vac.). Io sono Iside, la signora di tutto il territorio, fui istruita da Hermes, con Hermes inventai le lettere, quelle sacre come quelle demotiche affi nché tutte le cose non fos-sero scritte con gli stessi (caratteri). Io stabilii le leggi per gli uomini e disposi quelle cose che nessuno può avere la forza di cambiare. Io sono la fi glia maggiore di Kronos. Io sono moglie e sorella del re Osiride. Io sono colei che scoprì il frutto per gli uomini. Io sono madre del re Ho-ros. Io sono colei che sorge nella costellazione del cane. Io sono colei che è chiamata dea dalle donne. Grazie a me venne edifi cata la città di Bubastis. Io separai la terra dal cielo. Io segnai le vie degli astri. Io stabilii il corso del sole e della luna. Io inventai le opere del mare. Io resi sicura la giustizia. Io congiunsi l’uomo e la donna. Io stabilii che la donna portasse alla luce il feto nel decimo mese. Io stabilii che i genitori fossero amati con tenerezza dai fi gli. Io disposi la pena per i genitori che si mostrano incapaci di amare. Io con mio fratello Osiride posi fi ne all’antro-pofagia. Io fondai i riti iniziatici per gli uomini. Io ho insegnato a venerare le statue degli dèi. Io fondai i santuari degli dèi. Io abbattei il potere dei tiranni. Io posi fi ne alle uccisioni. Io determi-nai che le donne fossero amate dagli uomini. Io resi la giustizia più forte dell’oro e dell’argento. Io feci in modo che la verità fosse considerata una cosa bella. Io inventai il contratto matrimo-niale. Io stabilii le lingua per i greci ed i barbari. Io stabilii che la bellezza e la turpitudine fossero distinti secondo (la loro) natura. Io feci sì che nulla fosse più temibile del giuramento. Io ho fatto sì che l’insidiatore cadesse sotto il potere di colui che è oggetto di insidie. Io impongo la punizione per coloro che commettono ingiusti-zie. Io legiferai che si avesse pietà per i supplici. Io rendo onore a coloro che si difendono secon-do giustizia. Presso di me la giustizia è forte. Io sono la signora dei fi umi, dei venti e del mare. Nessuno può gloriarsi senza il mio consenso. Io sono la signora della guerra. Io sono la signora del fulmine. Io calmo ed agito il mare. Io sono nei raggi del sole. Io presiedo al cammino del sole. Ciò che io voglio questo si compie. A me
la trasmissione dei sistemi religiosi nel secondo ellenismo 41
Nell’aretalogia di Maronea, invece, si assiste al trionfo di Atene e in partico-lare di Eleusi ; un trionfo che non può non coinvolgere anche Demetra che proprio ad Eleusi è titolare di un cul-to iniziatico capace di garantire agathè elpís :(...) w{�per ou\n ejpi; tw`n ojmmavtwn, ÇI�i, tai`� eujcai`� / (5) »ejphvk¼ou�a�, ejlqe; toi`� ejpaivnoi� kai; ejpi; deutevran eujchvn: / »ka¼i; ga;r to; �o;n ejgkwvmion tw`n ojmmavtwn ej�ti; krei��on, / ».¼ ÆANOI‚ e[bleya to;n h{lion touvtoi�, kai; to;n �o;n blevpw kov�mon: / (10) peivqomai de; pavntw� �e parev�e�qai: eij ga;r uJpe;r th`� ejmh`� kaloumev/nh �wqeriva� h\lqe�, pw`� uJpe;r th`� ijdiva� timh`� oujk a]n e[lqoi�É qar/rw`n ou\n poreuvomai pro;� ta; loipav, ginwv�kwn o{ti to; ejgkwvmion, / nou`� me;n qeou`, cei`re� de; gravfou�in ajnqrwvpou: kai; prw`/ton ejpi; to; gevno� h{xw, tw`n ejgkw-mivwn poih�avmeno� ajrch;n / (15) th;n prwvthn �ou tou` gevvnou� ajrchvn. Gh`n fa�i pavntwn mh/tevra genhqh`nai tauvthæ de; �u; qugav-thr ej�pavrh� prwvthæ: / �uvnoikon d’ e[labe� ‚evrapin, kai; to;n koino;n uJmw`n qemevnwn gavmon, / toi`� uJmetevroi� pro�wvpoi� oJ kov�mo� ajnevlamyen ejnommati�qei;� / ïHlivw / kai; ‚hlhvnhæ: duvo me;n ou\n ej�te, kalei`�qe de; polloi, par’ ajn/ (20) -qrwpoi�: mov-nou� ga;r oJ bivo� uJma`� qeou;� oi\den: pw`� ou\n tw`n / ejgkwmivwn ouj du�kravthto� oJ lov-go� o{tan devh æ to;n e[painon / polloi`� qeoi`� pronaw`�aiÉ Au{th meq’ JErmou` gravmmaq’ eu|ren / kai; tw`n grammavtwn a} me;n iJera; toi`� muv�tai�, a} de; dhmov�ia / toi`� pa`�in: au{th to; divkaion e[�th�en i{n’ e{ka�to� hJmw`n, / (25) wJ� ejk th`� fuv�ew� to;n qavnaton i[�on
e[�cen, kai; zh`n ajpo; tw`n / i[�wn eijdh`æ: au{th tw`n ajnqwvpwn oi|� me;n bavrbaron, oi|� d’ eJllh/nivda diavlekton e[�th�en i{n’ hæ| to; gev-no� diallav��on mh; mov/non ajndrav�in pro;� gunai`ka� ajlla; kai; pa`�i pro;� pavnta�: / »�¼u; novmou� e{dwka�, qe�moi; d’ ejkalou`nto kata; prwvta�: toi/ (30) -»ga¼raou`n aij povlei� euj�tavqe�an, ouj th;n bivan nomiko;n ajlla; / »t¼o;n novmon ajbiva�ton euJrou`�ai: �u; tima`�qai gonei`� uJpo; / »t¼evknwn ejpoihv�a�, ouj movnon wJ� patevrwn, ajll’ wJ� kai; qew`n / »f¼rontiv�a�a: toigarou`n hJ cavri� kreiv��wn o{te th`� fuv�e/w� th;n ajnavgkhn kai; qea; nov-mon e[grayen: �oi, pro;� katoivkh�in / (35) Ai[gupto� ej�tevrcqe: �u; mavli�ta th`� ïEl-lavdo� ejtivmh�a� ta;� / ÆAqhvna�: kei`qi ga;r prw`ton tou;� karpou;� ejxevfhna�: Triptov-le/mo� de; tou;� iJerou;� dravkonta� �ou ka-tazeuvxa� ajrmatofo/rouvmeno� eij� pavnta� ÓEllhna� dievdwke to; �pevrma: toigarou`n / th`� me;n ïEllavdo� ijdei`n �peuvdomen ta;� ÆAqhvna�, tw`n d’ ÆAqh/ (40) -nw`n ÆEleu�i`na, th`� me;n Eujrwvph� nomivzonte� th;n povlin, th`� / de; povlew� to; iJero;n kov�mon: e[gnw to;n bivon ejx ajndro;� / �une�thkovta kai; gu-naikov�: e[gnw teron th;n gu/nai`ka (...). 1
tutte le cose si arrendono. Io sciolgo quelli (che sono) in catene. Io sono la signora della naviga-zione. Secondo il mio volere io rendo le cose innavigabili navigabili. Io eressi le mura di cinta delle città. Io sono chiamata thesmoforos. Io dagli abissi feci uscire le isole. Io sono signora delle piogge. Io vinco il destino. Il destino mi ubbidi-sce. Salve, o Egitto, che mi hai nutrito ».
1 Yves Grandjean, Une nouvelle arétalogie d’Isis à Maronée, Leiden, Brill, 1975 (« epro », xlix), pp. 17-18 : « E dunque, come già per gli occhi, Isi-de, rispondesti alle mie preghiere, giungi grazie alle lodi anche per (questa) seconda preghiera. Il tuo encomio, infatti, è ben più importante dei (miei) occhi… con questi io ho visto il sole, e vedo il cosmo che è tuo. Sono convinto che tu mi assisterai in ogni caso : e infatti, se invocata sei giunta per la mia salvezza, come non verrai per la tua propria lode ? Dunque con fi ducia io procedo oltre, ben sapendo che l’encomio, men-tre è il pensiero del dio, le mani dell’uomo lo scrivono. E per prima cosa mi rifarò alla stirpe, volendo tracciare l’inizio degli encomi, l’origi-ne prima della tua stirpe. Dicono che la terra sia stata la madre di tutti ; tu sei fi glia di lei che è la prima ; tu prendesti Sarapide come sposo, con l’istituzione della vostra unione si stabilì il comune matrimonio, per i vostri volti il cosmo risplendette, posto sotto la legge di Helios e di Selene ; ebbene mentre voi siete due, dagli uomi-ni siete invocati con molti nomi ; la vita sa infatti
42 ennio sanzi
Proprio la dimensione iniziatica con il connesso esoterismo sottesa al culto eleusino come a quello isiaco ci per-mette di tornare al nostro xi libro ed in particolare a quello che a ragione si può intendere come un Leitmotiv. Dopo un periodo di purifi cazione di dieci gior-ni il nostro Lucio è oramai pronto per sperimentare l’iniziazione isiaca. Ecco quello che ci racconta senza violare il segreto iniziatico (Met., xi, 23) :Iamque tempore, ut aiebat sacerdos, id postu-lante stipatum me religiosa cohorte deducit ad proximas balneas et prius sueto lavacro tradi-tum, praefatus deum veniam, purissime circum-rorans abluit rursumque ad templum reductum,
iam duabus diei partibus transactis, ante ipsa deae vestigia constituit secretoque mandatis quibusdam, quae voce meliora sunt, illud plane cunctis arbitris praecipit, decem continuis illis diebus cibariam voluptatem cohercerem neque ullum animal essem et essem invinius. Quis venerabili continentia rite servatis, iam dies ade-rat divino destinatus vadimonio, et sol curvatus intrahebat vesperam. Tum ecce confl uunt undi-que turbae sacratorum ritu vetusto variis quisque me muneribus honorantes. Tunc semotis procul profanis omnibus linteo rudique me contectum amicimine arrepta manu sacerdos deducit ad ip-sius sacrarii penetralia. Quaeras forsitan satis anxie, studiose lector, quid deinde dictum, quid factum ; dicerem, si dicere liceret, cognosceres, si liceret audire. Sed parem noxam contraherent et aures et lingua illae temerariae curiositatis. Nec te tamen desiderio forsitan religioso suspen-sum angore diutino cruciabo. Igitur audi, sed crede, quae vera sunt. Accessi confi nium mortis et calcato Proserpinae limine per omnia vectus elementa remeavi, nocte media vidi solem can-dido coruscantem lumine, deos inferos et deos superos accessi coram et adoravi de proxumo. Ecce tibi rettuli, quae, quamvis audita, ignores tamen necesse est. Ergo quod solum potest sine piaculo ad profanorum intellegentias enuntiari, referam. 1
che soltanto voi due siete dèi. E come dunque il più diffi cile fra gli encomi quando sarà necessario provvedere all’encomio per molti dèi ? Proprio lei, assieme ad Hermes, inventò le lettere e, fra le lettere, quelle sacre per gli iniziati e quelle pubbliche per tutti ; proprio lei istituì la giusti-zia affi nché ciascuno di noi, come ebbe già la medesima morte per natura, conoscesse anche il vivere secondo le stesse modalità ; proprio lei stabilì la lingua per gli uomini, barbara per gli uni, greca per gli altri, affi nché il genere umano vivesse in armonia, e non solo gli uomini verso le donne ma tutti verso tutti. Tu desti le leggi, dapprincipio si chiamarono thesmoi, e per questo le città furono fondate rettamente poiché fecero ricorso non alla violenza come legge ma ad una legge lontana dalla violenza. Tu decidesti che i genitori fossero onorati dai fi gli, considerandoli non come genitori semplicemente ma come di-vinità. Per questo la riconoscenza è ancora più grande da quando la dea stabilì come legge una necessità naturale. L’Egitto si rallegra per essere per te luogo di soggiorno ; della Grecia tu ono-rasti soprattutto Atene, là invero, per la prima volta, rivelasti i frutti (della terra) ; Trittolemo infatti dopo aver aggiogato i tuoi sacri serpen-ti, andando sul carro distribuì il seme a tutti i Greci ; per questo della Grecia noi desideriamo vedere Atene, e di Atene Eleusi, convinti che la città è ornamento dell’Europa ed il santuario è ornamento della città. Lei stabilì la vita prodotto dell’uomo e della donna…) ».
1 Apul., Met., xi, 23 : « E giacché, come diceva il sacerdote, stava arrivando il momento di chie-dere (l’iniziazione), accompagnato da un corteo di devoti lui mi conduce ai più vicini bagni e come prima cosa mi sottopone al consueto la-vacro e, dopo avere chiesto il permesso agli dèi, mi purifi ca bagnandomi tutt’intorno in maniera santissima ; poi, condotto di nuovo al tempio, trascorse già due parti del giorno, mi fa fermare proprio davanti ai piedi della dea, e impartite in segreto alcune cose che non si possono dire, di fronte a tutti i testimoni ordina che io mi trat-tenga per dieci giorni dal desiderio di cibo, che non mangi carne e non beva vino. Osservate secondo il rito queste cose con una continenza degna di ammirazione, arrivava oramai il giorno fi ssato per la promessa divina, e il sole tramon-tato portava con sé la sera. Allora ecco che con-fl uiscono da ogni parte le turbe dei consacrati
la trasmissione dei sistemi religiosi nel secondo ellenismo 43
Sono diversi gli aspetti rilevanti che possono essere individuati in questo passo : a) parte della cerimonia avviene davanti alla turba sacrorum ; b) il momen-to cruciale della cerimonia riguarda Lu-cio in prima persona e in qualche modo coloro che non sono profani (probabil-mente rimangono solo gli iniziati e i ministri della cerimonia esoterica) ; c) l’iniziazione ha tutte le caratteristiche di un rito di natura misterica piuttosto che misteriosofi ca dal momento che il nostro Lucio sperimenta un viaggio attraverso gli elementi, rasenta l’espe-rienza della morte, si ritrova proiettato in una realtà straordinaria, fi nisce con l’adorare da presso gli dèi inferi e su-peri.
Insomma, non sembra qui che il tipo di iniziazione a cui è stato evocato da Iside in persona sia caratterizzato da un cambiamento di status quale diretta
conseguenza di una rivelazione sofi ca ; piuttosto sembrerebbe che tale cambia-mento si sia realizzato attraverso un au-tentico, pericoloso e spaventoso pathein e non grazie ad un esoterico mathein.La dimensione pubblica trova di nuovo il proprio posto una volta che l’inizia-zione è terminata. Questo ci racconta il nuovo Lucio :Mane factum est, et perfectis sollemnibus pro-cessi duodecim sacratus stolis, habitu quidem religioso satis, sed eff ari deo eo nullo vinculo prohibeor, quippe quod tunc temporis videre praesentes plurimi. Namque in ipso aedis sa-crae meditullio ante deae simulacrum constitu-tum tribunal ligneum iussus superstiti byssina quidem sed fl oride depicta veste conspicuus. Et umeris dependebat pone tergum talorum tenus pretiosa chlamida. Quaqua tamen viseres, colore vario circumnotatis insignibar animalibus ; hinc dracones Indici, inde grypes Hyperborei, quos in speciem pinnatae alitis generat mundus alter. Hanc Olympiacam stolam sacrati nuncupant. At manu dextera gerebam fl ammis adultam facem et caput decore corona cinxerat palmae candidae foliis in modum radiorum prosistenti-bus. Sic ad instar Solis exornato me et in vicem simulacri constituto, repente velis reductis, in aspectum populus errabat. Exhinc festissimum celebravi natalem sacrorum, et suaves epulae et faceta convivia. Dies etiam tertius pari caerimo-niarum ritu celebratus et ientaculum religiosum et teletae legitima consummatio. 1
1 Apul., Met., xi, 24 : « Giunse il mattino e, completato il rito, venni avanti consacrato con dodici stole, invero suffi cienti per un abito reli-gioso, ma non sono impedito da nessun vincolo dal raccontare quello che accadde, poiché allora i moltissimi che erano lì videro. E infatti proprio al centro del sacro tempio mi si ordinò di salire e rimanere sopra un altare edifi cato proprio di fronte alla statua della dea, (ero) ben visibile gra-zie alla veste di bisso dipinta con colori fl oreali, dalle spalle, di dietro, fi no ai talloni scendeva una clamide preziosa, e tale che da qualunque parte avessi guardato appariva tutt’intorno adornata da animali di vario colore : da una parte dei dra-
secondo l’antico rito ed ognuno mi onora con doni diversi. Poi, allontanati tutti i profani, il sacerdote, presa la mia mano, mi conduce nei penetrali del santuario stesso dopo che ero stato coperto con una veste di lino grezzo. Forse tu ti chiederai, o lettore desideroso di sapere, cosa fu detto successivamente e cosa venne fatto ; ed io lo direi se fosse lecito parlare, e tu lo sapresti se fosse lecito ascoltare. Ma entrambe le orec-chie e la lingua incorrerebbero in una pari colpa per quella illecita brama di sapere. Tuttavia non torturerò proprio te così mosso da un religioso desiderio con una attesa che continua a protrar-si. Pertanto ascolta, e comunque credi poiché si tratta di cose vere. Sono giunto al limite della morte e calcata la soglia di Proserpina sono stato trasportato attraverso tutti gli elementi, in pie-na notte ho visto il sole brillare di candida luce, sono stato al cospetto degli dèi inferi e superi e li ho adorati da vicino. Ecco ho riferito a te quelle cose che, benché udite, è necessario che tu le ignori. Pertanto soltanto ciò che può essere raccontato alla comprensione dei profani senza cadere nell’empietà ».
44 ennio sanzi
Interessante notare come uno dei mo-menti collettivi volti a celebrare il nuo-vo iniziato e la grandezza della dea sia costituito da un banchetto. Proprio banchetti rituali in onore di Iside e/o di Serapide sono attestati in fonti papira-cee e letterarie non sempre considerate ma che si rivelano utili per dimostrare come anche un tale tipo di festeggia-menti citato dal madaurense trovi un preciso addentellato nella dimensione reale del culto riservato alle divinità alessandrine. Un papiro di Ossirinco fornisce la testimonianza di un ban-chetto organizzato quale off erta rivolta ad Iside kyria :ejrwta`/ �e Tau`ri� deipnh`ƒ�ai eij� iJevrwma th`� kuriva� ƒ ÒI�eido� eJn tw/` ÆI�eivw/ thæ` h ƒ ajpo; w{r(a�) q. 1
Di banchetti in onore di Serapide ci informano tanto documenti redatti su papiro quanto fonti letterarie nonché resoconti agiografi ci. Tra i diversi pa-piri che sono stati conservati ad Ossi-rinco ne fi gurano di relativi ad inviti
a banchetto nel tempio di Serapide, e se alcuni di questi sembrano avere un semplice carattere sociale, altri sono delle vere e proprie off erte di ringra-ziamento nei confronti del dio in oc-casione di eventi lieti ; addirittura in un piccolo papiro proveniente ancora da Ossirinco è lo stesso dio che invita al banchetto :Kalei` �e oJ qeo;� ƒ eij� kleivnhn geino(mevnhn) ƒ ejn tw`/ Qohreivw/ ƒ au[rion ajpo; w{r(a�) q v 2
Si può notare una reale consonanza con il retore Elio Aristide quando dice :Kai; toivnun kai; qu�iw`n movnw/ touvtw/ qew`/ diaferovntw� koinwnou`�in a[nqrwpoi th;n ajkribh` koinwnivan, kalou`ntev� te ejfÆ eJ�tivan kai; proi�tavmenoi daitumov na aujto;n kai; eJ�tiavtora, w{�te a[llwn a[llou� ejrav-nou� plhrouvntwn koino;� aJpavntwn ejravnwn ou|tov� ej�ti plhrwthv�, �umpo�iavrcou tavxin e[cwn toi`� ajei; kata; tauto;n �ullegomevnoi�. w{�per ÓOmhro� e[fh th;n ÆAqhna`n aujth;n a{ma �pevndein te kai; telei`n e{ka�ta, aujto;� w]n oJmov�pondov� te kai; oJ ta;� �ponda;� de-covmeno�, ejpi; kw`movn te ajfiknouvmeno� kai; kalw`n wJ� auJto;n kwma�tav�, oi} coreuv onte� uJpÆ aujtw`/ th;n ajdea` kakw`n coreivan, a{ma toi`� �tefavnoi� th;n ajgaqh;n eujqu mivan oi[kade eij�enegkavmenoi th;n deutevran ajpodidova�in <�trofh;n> ejpikale�avmenoi.3
La magnifi cenza dei banchetti in ono-re di Serapide viene ricordata anche da Tertulliano che, nel compilare un vero
goni indiani, dall’altra grifi iperborei che l’altro mondo genera in forma di uccello alato. Gli ini-ziati chiamano questa stola olimpica. Io, intanto, con la mano destra portavo una face grande con molte fi amme e una corona di foglie candide mi cingeva decorosamente il capo, ed esse si proten-devano come se fossero dei raggi. E così ador-nato ad immagine del sole e collocato come un simulacro, tirati all’improvviso i teli, il popolo si spostava da una parte all’altra per vedermi. Poi io festeggiai il giorno più felice della mia inizia-zione tra soavi banchetti e faceti convivi. Anche il terzo giorno venne celebrato con eguale rito di cerimonie, ebbe luogo anche una colazione religiosa e il defi nitivo compimento del rituale iniziatico ».
1 P. Oxyr. lxvi 4539 : « Tauris ti invita al ban-chetto in off erta di Iside signora, nell’Iseo, il giorno ottavo dall’ora nona ».
2 Ludwig Koenen, Eine Einleidung zur Kline des Sarapis (P. Colon. inv. 2555), « zpe », i, 1, 1967, pp. 121-126 : « Il dio ti invita al banchetto che avrà luogo nel Thoerio, domani dall’ora nona ».
3 Ael. Arist., In Sarap., 27 (= Aelii Aristidis Smyrnaei quae supersunt omnia, a cura di Brunus Keil, ii vol., Berolini, Weidmann, 1958, p. 360) : « E dunque gli uomini soltanto con questo dio condividono distintamente tutti i sacrifi ci, in-vitandolo a banchetto e mettendolo sempre al primo posto sia come invitato che come padrone
la trasmissione dei sistemi religiosi nel secondo ellenismo 45
elenco di simposi rituali pagani giudi-cati più che pantagruelici e contrappo-sti al morigerato triclinium Christiano-rum, scrive : « Ad fumum cenae Serapiacae sparteoli excitabuntur ». 1A banchetti di tal genere si fa riferi-mento nel racconto greco e copto del martirio dei santi Filemone ed Apol-lonio consumato nella Tebaide per vo-lontà del governatore Satrio Arriano. 2 Proprio quest’ultimo, nel tentativo di far desistere l’amatissimo mimo e fl autista Filemone dall’indomabile vo-lontà di sottoporsi al martirio pur di non abiurare nei confronti della nuova religione, così tenta di blandirlo nella versione greca :
Pei`�on ou\n hJma`� kai; aujtov�, kai; qu`�on toi`� qeoi`�, i{na kai; o[cloi pauv�wntai lupouvme-noi peri; �ou`, mavli�ta dia; ta; rJapiv�mata, a{per e[labe� probracevo�: kajgw; de; ajna�ta;� meta; pav�h� tavxew�, poreuqw`men ejn tw`/ ‚arapivw/, kai; eujwchqw`men ejkei`, ajri�thv�ante~ meta; �ou`. Filhvmwn ei\pe, Mh; ajpatw`, hJgemovn. ÆEgw; ga;r ajpo; tou` nu`n eJ�tiav�ew� ‚arapivou h] eujwciva� meta�cei`n oujk ajnevcomai: ajlla; tou` deivpnou tou` eJpouranivou pro�dokw` metalabei`n, o{per eujtrevpi�ev moi; oJ Cri�tov�. Tau`ta eijpw;n kai; �trafeiv� pro;� to;n o[clon, ei\pen, JUmei`� oiJ dh`moi th`� povlew�, dia; ti; ejluphvqhte rJapi�qevnto� mouv ; pri;n h] corauvlhn me genev�qai, oiJ �unetai`roiv mou ejrrapizovn mou to; prov�wpon, kai; uJmei`� ejgela`te: nu`n de; rJapi�qevnto� mou uJpe;r th`� eij� Cri�to;n piv�tew�, uJmei`� me;n ejluphvqhte, oiJ de; a[ggeloi caivrou�i kai; ajgalliw`ntai. 3
Nella versione copta si legge :Cwtm [E nCwiÇ w VilYmon ntn[t]woun nGr:uCia ntnraSe nmmak anok mn tta-XiC tYrC. ntntwoun ntnbwk etCiooun ntnJwkm Hi ouCop mnn[Ca nai] ntnbwk epCerapin ntnnoJn ntnariCta ere
di casa ; e mentre alcuni dèi con la loro presenza rendono perfetti alcuni banchetti ed altri altri banchetti, egli è colui che con la sua presenza rende perfetti universalmente tutti i banchetti, ha il compito di simposiasta nei confronti di coloro che si raccolgono intorno a lui di volta in volta. Come dice Omero Atena stessa liba e compie ogni cosa, lui è quello che liba e quel-lo che riceve le libagioni, quello che è invitato al banchetto e quello che chiama i compagni al banchetto ; coloro che sotto la sua guida danzano senza temere i mali, con le loro corone se ne tor-nano a casa con una buona disposizione d’animo e sono già pronti a rispondere a loro volta con un altro invito ».
1 Tert., Apol., xxxix, 15 ( = Q. S. Fl. Tertul-liani Apologeticum, a cura di Eligius Dekkers, Tur-nholti, Brepols, 1954 [« Corpus Christianorum Series Latina », i], p. 152) : « Di fronte al fumo di un banchetto in onore di Serapide non si esiterà a chiamare i pompieri ».
2 Si veda : Ennio Sanzi, Magia e Culti orientali iii. Sui cenni a Serapide, ad Iside ( ?) ed alla ma-gia nel martirio greco e copto di Filemone a confronto con alcune fonti iconografi che, letterarie e papiracee, in Hellenisation, Empire and Globalisation : Lessons from Antiquity. Acts of the Panel Held during the 3rd Congress of the European Association for the Study of Religion, Bergen, Norway, 8-10 May 2003, a cura di Luther H. Martin, Panayotis Pachis, Thessalo-niki, Vanias, 2004, pp. 209-234.
3 Act. Sanct., Mart., i : 888 : « Dunque dai retta a noi, sacrifi ca agli dèi, così che tutto il popolo possa smettere di affl iggersi per te, soprattutto a causa delle percosse che tu hai subito poco fa ; ed allora, mossomi da qui con tutta la mia schiera, arriveremo fi no al tempio di Serapide e lì ban-chetteremo lautamente consumando il pranzo insieme a te ». Ma Filemone rispose : « Governa-tore, non t’illudere ! Infatti, da questo momento, non sopporto di prendere parte al banchetto o al pranzo nel tempio di Serapide, ma aspetto di prendere parte al banchetto celeste che Cristo mi ha preparato ! ». Dopo avere detto tali cose, rivoltosi alla folla, aggiunse : « Per quale motivo, cittadini, vi siete addolorati del fatto che fossi stato percosso ? Prima di diventare fl autista i miei compagni schiaff eggiavano il mio volto e voi ri-devate, ed ora, invece, mentre venivo percosso a causa della mia fede in Cristo, vi siete affl itti mentre gli angeli gioiscono ed esultano ».
46 ennio sanzi
penHYt raSe nmmak. aFouwSb de n[i VilYmwn eFJw mmoC Je pariCton rw mpeCerapin mpit[o]St eouwm ebol nHYtF Jin mpinau alla pdipnon ntoF n[ne]touaab pe}[wSt ebol HYtF te-nou [e mprCwtm w nrwme nteiÇpoliC ntaupeuHYt mka<H> Je auT nai nHen-SCnaC. etbe ou ntoF mpeouoeiS eiÇo mmimoC empa}r ,eraulYC erenaSbYr mimoC }aC eHoun Hm paHo. ntwtn de <ne>tetnraSe auw <ne>tetneuVrane koitoiGe mpeouoeiS etmmau neiÇ}[wnt mpnoute mn neFaGGeloC. tenou de tetnrime etbe HenSCnaC eautaau naiÇ. pnoute de raSe eHraiÇ eJwiÇ. 1
Sono proprio passi come quelli di Elio Aristide, di Tertulliano, dei martiro-
logi e le testimonianze papiracee che, nella loro totalità, non lasciano dubbi circa la celebrazione di banchetti rituali in onore di Iside e Serapide, a fare da contrappunto al passo de Le Metamor-fosi lasciando propendere ancora una volta per l’autenticità di quanto il ro-manziere riferisce in merito alla ritua-lità isiaca.
Ottenuta l’iniziazione, Lucio si di-mostra talmente riconoscente nei con-fronti della dea che lo ha salvato da non riuscire ad allontanarsi dal suo cospet-to fi no a quando non viene sollecitato dalla stessa Iside a far ritorno a casa. A questo punto, prima di congedarsi, dal suo animo prorompe una preghiera di ringraziamento nella quale si elencano ancora una volta le eccelse prerogative della dea secondo lo stile litanico delle aretalogie :Tu quidem, sancta et humani generis sospitatrix perpetua, semper fovendis mortalibus munifi ca, dulcem matris adfectionem miserorum casibus tribuis. Nec dies nec quies nulla ac ne momentum quidem tenue tuis transcurrit benefi ciis otiosum, quin mari terraque protegas homines et depulsis vitae procellis salutarem porrigas dexteram, qua fatorum etiam inextricabiliter contorta retractas licia et Fortunae tempestates mitigas et stella-rum noxios meatus cohibes. Te superi colunt, observant inferi, tu rotas orbem, luminas solem, regis mundum, calcas tartarum. Tibi respon-dent sidera, redeunt tempora, gaudent numina, serviunt elementa. Tuo nutu spirant fl amina, nutriunt nubila, germinant semina, crescunt germina. Tuam maiestatem perhorrescunt aves caelo meantes, ferae montibus errantes, serpentes solo latentes, beluae ponto natantes. 2
1 Francesco Rossi, Un nuovo codice copto del Museo Egizio di Torino contenente la vita di s. Epi-fanio ed i martiri di s. Pantaleone, di Ascla, di Apol-lonio, di Filemone, di Ariano e di Dios con versetti di vari capitoli del Libro di Giobbe, « Atti della R. Acca-demia dei Lincei. Serie quinta. Classe di scienze morali, storiche e fi lologiche », vol. i, Roma, R. Accademia dei Lincei, 1893, pp. 3-136 (la cita-zione è a p. 74 ; [abbiamo tentato di emendare il copto alle linee 7 e 10 dove il Rossi legge, ri-spettivamente, ntau peuHYt mka Je e ntwtn de tetnraSe auw tetneuVrane con conseguente traduzione ; il testo in questo passo sembra co-munque corrotto]) : « “Dammi retta, Filemone ! Alziamoci e sacrifi ca in modo da rallegrarci con te, io e tutta la corte. Alziamoci e andiamo alle terme e laviamoci tutti insieme ; poi andiamo da Serapide e mettiamoci a mangiare. Così il nostro cuore potrà gioire con te”. Ma Filemone rispose dicendo : “Ma io del pasto di Serapide ho deciso di non mangiarne più da questo momento, al contrario è alla cena dei santi che volgo lo sguar-do. Ora, non ascoltate ( ?), uomini di questa città, il cui cuore si è addolorato del fatto che mi hanno dato degli schiaffi . Perché dunque, nel momento in cui io ero mimo e non facevo ancora il fl au-tista, e quando i miei compagni mimi mi pren-devano a schiaffi sulla faccia, voi vi rallegravate e gioivate, benché allora facessi arrabbiare Dio con i suoi angeli ? Ma ora, mentre voi piangete a causa degli schiaffi che mi vengono dati, Dio al contrario si rallegra di me” ».
2 Apul., Met., xi, 25 : « Tu, invero, santa e sem-pre pronta a venire in soccorso di tutti gli uo-mini, sempre generosa nei confronti dei mortali, ai miseri in disgrazia accordi l’amore dolce della
la trasmissione dei sistemi religiosi nel secondo ellenismo 47
Sarà interessante notare, anche se in-cidentalmente, che alcuni epiteti con i quali viene invocata Iside in questa preghiera cosi come alcuni di quelli che vengono richiamati dalla dea in perso-na nell’autoproclamazione che com-pare in Met., xi, 5 e che abbiamo già ricordato, oltre ad essere quelli che si ritrovano comunemente nelle aretao-logie stricto sensu sono attestati anche nel patrimonio epigrafi co devozionale isiaco, ora raccolto magistralmente da Laurent Bricault. 1
Iniziamo a trarre delle conclusioni. Quanto descritto da Apuleio in merito alle cerimonie rituali pubbliche del cul-to di Iside, trova riscontro nelle fonti letterarie, iconografi che, epigrafi che, papiracee, agiografi che, molte delle quali sono la diretta espressione del-l’autentica devozione isiaca. A questo punto, se pensiamo che Le Metamor-fosi rientrano nel genere del romanzo e che, almeno potenzialmente, erano destinate ad un gran numero di lettori, sembrebbe riduttivo limitare la portata misterica del culto isiaco in esse atte-stata a semplice risoluzione letteraria del medio-platonismo dell’autore. Se si può arrivare a dedurre l’autenticità dei momenti pubblici del culto isiaco ricordati nel romanzo, sarà ugualmen-te legittimo ritenere che anche la com-ponente iniziatica del medesimo culto accennata dal protagonista senza venire meno ai vincoli del segreto iniziatico sia autentica e non debba essere letta quale fi liazione letteraria di una matri-ce esclusivamente fi losofi ca.
In questo caso l’orizzonte d’attesa dello storico delle religioni interessato a priori alla dimensione intra-mondana dei cosiddetti « culti orientali » avrebbe fi nito col ridurre la portata soteriolo-gica del culto isiaco presentato ne Le Metamorfosi. Naturalmente, nulla osta al fatto che anche la lettura appena presentata risenta dell’orizzonte d’at-tesa dell’autore il quale ha voluto so-
madre. Neanche un giorno o una notte e nean-che un solo momento, per quanto breve possa essere, passa privo della tua benedizione, senza che tu protegga gli uomini in terra e in mare e off ra la tua destra che reca soccorso allontanate le tempeste dell’esistenza, grazie alla quale sciogli anche i lacci inestricabilmente aggrovigliati di ogni destino e calmi le tempeste della fortuna e arresti i crudeli corsi degli astri. Gli dèi superi ti venerano, gli inferi ti onorano, tu fai ruotare la sfera del cielo, illumini il sole, governi il mondo e calchi il tartaro. Grazie a te le stelle diventano propizie, grazie a te tornano le stagioni, gli dèi si rallegrano e gli elementi sono (tuoi) schiavi. A un tuo cenno soffi ano i venti, le nubi dan-no nutrimento, i semi germogliano, i germogli crescono. Gli uccelli che attraversano il cielo, le fi ere che si aggirano sui monti, i serpenti che si nascondono nel terreno, i mostri che nuotano nel mare temono la tua maestà ».
1 Merita di essere ricordato in questa sede che oltre al ricis citato supra, nota 1, pag. 40 l’infaticabile studioso francese è autore di una monografi a intitolata Isis, Dame des fl ots, Liège, C.I.P.L., 2006 (« Aegyptiaca Leodiensia », vii), e di due repertori oltremodo utili relativi ad Iside ed agli dèi della sua cerchia : Myrionimi. Les épi-clèses grecques et latines d’Isis, de Sarapis et d’Anubis, Stuttgart-Leipzig, Teubner, 1996 (« Beiträge zur Altertumskunde », lxxxii) ; Atlas de la diff usion des cultes isiaques (ive s. av. J.-C.-ive s. apr. J.-C.), Paris, De Boccard, 2001 (« MemAcInscr », xxiii). Inoltre, è stato l’ideatore e l’organizzatore di tre colloqui internazionali dedicati allo studio delle medesime divinità : De Memphis à Rome. Actes du
Ier Colloque sur les études isiaques, Poitiers – Futu-roscope, 8-10 avril 1999, a cura di Laurent Bricault, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2000 (« rgrw », cxl) ; L. Bricault (ed.), Isis en Occident. Actes du IIème Colloque international sur les etudes isiaques, Lyon iii, 16-17 may 2002, a cura di Laurent Bricault, Leiden-Boston, Brill, 2004 (« rgrw », cli) ; Nilo into Tiber…, citato supra, nota 7, pag. 35.
48 ennio sanzi
prattutto sollevare delle questioni che fornire delle risposte. Ed allora, da un orizzonte d’attesa ad un altro si potreb-be anche ipotizzare quali potessero es-sere, almeno in parte, le ‘attese’ di Apu-leio : se, come sembra, Le Metamorfosi sono un’opera tarda nella produzione del madaurense, allora il nostro abile retore potrebbe avere affi dato all’ope-ra stessa un’ulteriore difesa dall’accusa di magia che in qualche modo conti-nuava ad accompagnarlo (basti pensare a come Agostino d’Ippona consideri il madaurense). 1 Se fosse così, si spieghe-
rebbe ancora meglio la contrapposizio-ne tra la fortuna caeca e nefaria che tra-mite la magia ha fatto perdere a Lucio la sua natura umana per scaraventarlo nel mondo animale e la fi gura di una Iside benigna e propizia (lei, dea maga per eccellenza eppure, in questo testo, assolutamente contrapposta alla peri-colosa – anche per Apuleio – dimen-sione della magia) che enoteisticamen-te potente è in grado di far tornare tra gli uomini un uomo diventato asino ; è in grado, cioè, di restituire l’uomo alla natura umana. Ma queste ultime rifl es-sioni avranno davvero colto una delle ‘attese’ o saranno da ricondurre al mio orizzonte di attesa ? Non lo so. Di certo Le Metamorfosi hanno ben contribuito alla diff usione di un sistema religioso complesso qual è quello di Iside e degli dèi della sua cerchia, anzi hanno con-tribuito a garantirne la sopravvivenza ben al di là dei roboanti editti dei Co-stantinidi e di Teodosio. 2
1 Apuleio, La magia, a cura di Claudio Mo-reschini, Milano, Rizzoli, 1990, p. 9 (dell’intro-duzione) : « Il compito di demolire la fama di Apuleio mago toccherà ad Agostino, il quale, africano com’era, conosceva meglio degli altri sia gli scritti del suo conterraneo sia la fama che lo circondava. In due libri di quella gigantesca opera che riassume la polemica cristiana contro il mondo pagano nella sua totalità, storica, cul-turale, religiosa (ci riferiamo a La città di Dio), nei libri ottavo e nono, Agostino ribatte punto per punto (anche se talora in modo cavilloso le dottrine platoniche di Apuleio, in particolare la sua demonologia, mentre all’Apuleio mago Agostino riserva le sue critiche nel corso del-l’epistolario ».
2 Le code théodosien. Livre xvi, a cura di Élisa-beth Magnou-Nortier, Paris, Cerf, 2002 (« Sour-ces canoniques », ii).