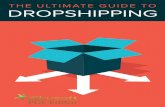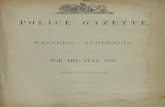A. Guglielmi, G. Prisco, Le operazioni di stacco e la conservazione in situ, in G. Prisco (a cura...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of A. Guglielmi, G. Prisco, Le operazioni di stacco e la conservazione in situ, in G. Prisco (a cura...
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ 15
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ
Antonio Guglielmi, Gabriella Prisco
STACCHII primi stacchi avvennero, a partire dal 1739,ad Ercolano, su proposta di Canart.Trattandosi di un’operazione ‘meccanica’ lenotizie a riguardo sono scarse e non semprescevre da fraintendimenti. È tuttavia possi-bile, analizzando le fonti partenopee, ma an-che il fondamentale testo a stampa diNiccolaZabaglia2, operante in ambito romano –quello da cui provenivano Canart e i suoiaiutanti – e confrontandole con quanto è sta-to possibile osservare sui dipinti a deposito enei siti di provenienza, ricostruirne le fasi sa-lienti (fig. 6), rimaste abbastanza costanti nelcorso del tempo; eventuali varianti verrannodi volta in volta segnalate.Una volta prescelta la porzione di intonacoda prelevare, ne venivano tracciati i contor-ni3 con il carboncino4, e successivamente sipraticava un’incisione con uno strumento(fig. 6a)5. Solo in rari casi le delimitazionidelle parti da staccare sono ancora visibili suidipinti (fig. 7): ciò è avvenuto perché, comespiega, nel 1847, l’architetto Bonucci, a pro-posito della presumibile misura di alcuni di-pinti da staccarsi «[…] questa misura dev’es-sere considerata come approssimativa, poi-ché nel tagliarsi una fabbrica vecchia di tantisecoli possono risultare delle screpolature, ealtre circostanze locali che richieggono nel-l’esecuzione di restringere alquanto o di al-largare la dimensione dell’intonaco»6.Lo scalpello7 serviva poi a creare, intorno aldipinto, lo spazio necessario per l’inserzionedi quattro assi di legno a squadra, collegatefra loro da staffe di ferro ad ‘L’ (figg. 6 b, c).Tali operazioni e i relativi inconvenienti sonoben esemplificati da undocumentodellametàdelXIX secolo8, con il qualeCarloBonucci, inrelazione al progetto di staccare per settori lepareti con scene di caccia e conAchille a Sciro,
nella casa della Caccia9, chiedeva al direttoreAvellino di indicare personalmente le parti datagliare10; ciò perché «queste operazioni equi-varrebbero […] ad una devastazione, e ad unacarneficina», sosteneva l’architetto responsabi-le degli scavi, in quanto i pezzi asportati non sa-rebbero stati più ricomponibili fra loro, essen-do necessario rompere tutt’intorno per circa 1palmo–ossia circa 26 cm–onde creare lo spa-zio per la cassetta11.In ogni caso era necessario, prima dello stac-co, colmare le irregolarità del bordo dell’in-tonaco all’interno della cassetta lignea conuna stuccatura perimetrale12 (fig. 6d); pro-prio grazie alla presenza di tali stuccature, si-curamente eseguite in situ, come dimostraanche anche l’assenza di qualsivoglia pretesadi tipo estetico, possiamo asserire che, in al-cune opere l’attuale cassaforma lignea di con-tenimento è la stessa utilizzata anticamenteper lo stacco: infatti, nel punto di contattotra legno e stuccatura perimetrale in gesso,quest’ultima ‘gira’ e prosegue sul lato internodei regoli13 (figg. 8; 9). In un altro caso l’i-dentità tra cassetta di scavo e la cassaformaattualmente in opera è provata, come hannodimostrato F. Di Cosimo e C. Longo, dai fo-ri al centro di un regolo, unica traccia super-stite dei vincoli utilizzati per la movimenta-zione dopo lo stacco (fig. 85).Sulla scorta di un noto passo del Voyage si èspesso affermato che la totalità degli stacchipiù antichi era eseguita a massello: «[…] onscie la muraille par derrière et on enlève ensuite le tableau […]»14. Purtroppo non èpossibile effettuare alcuna verifica dell’e-sattezza di questa affermazione a partire da-gli intonaci staccati poiché, in laboratorio,essi venivano, salvo eccezioni15, assottiglia-ti e fatti aderire ad un supporto. Anche al-tre fonti, per lo più del XVIII secolo, ac-
Sicura cosa è poi e comprovata da una lacrimevole esperienza,che i dipinti che si lasciano in Pompei, a malgrado di tutte le diligenze
che vi si usano, prontamente vanno alla loro distruzione, sì per le esalazionidell’umidità delle mura, o altre efflorescenze da cui è impossibile di preservarli,
sì per le ingiurie atmosferiche, cui più o meno vanno tutti soggetti,e sì finalmente pel danno che reca loro sovente la mano barbara degli uomini1
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 15
16 ANTONIO GUGLIELMI, GABRIELLA PRISCO
Fig. 6 Ricostruzione dellasequenza operazionale di unostacco in età borbonica:a) incisione sulla parete delcontorno della porzione didipinto da staccare;b) creazione, mediantescalpellatura, dello spazio perl’inserzione della cassetta;c) inserimento della cassetta lignearinforzata agli angoli da staffe diferro ad ‘L’;d) stuccatura perimetrale percolmare le lacune tra la cassetta ela porzione prescelta per lo stacco;e) protezione della pellicolapittorica con fogli di cartainumiditi;f ) tavola lignea fissata sullospessore della cassaforma;g) colatura del gesso attraverso ifori praticati nella tavola;h) inserzione di una leva tra lacassetta e la parete dipinta,percossa per favorire il distaccodell’intonaco.
6a 6b 6c
6d 6f
6g 6h
6e
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 16
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ 17
Fig. 7 MAN inv. n. 8626,pastiche, particolare di uno deglielementi: è visibile un riquadroa carboncino, che indica i limitidello stacco, non rispettati infase di esecuzione.
Fig. 8 MAN sn-18: sono visibilila stuccatura perimetrale e lenumerose tracce del gessoutilizzato per lo stacco.
Fig. 9 MAN sn-18, particolare:stuccatura perimetrale che girasulla faccia interna di un regolodella cassetta lignea.
7
8 9
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 17
cennano al metodo dello stacco a massellocome quello di uso corrente16.A giudicare da quanto è stato possibile osser-vare in situ, sembrerebbe che, in realtà, findai primi anni questa tecnica sia coesistitacon l’altra, che prevedeva la separazione de-gli strati preparatori dalla muratura17, tecni-ca questa descritta, più di un secolo dopo gliinizi degli scavi, da Carlo Ruspi18: non sonoinfatti stacchi a massello, per fare solo qual-che esempio, né quelli nel criptoportico del-la casa dei Cervi di Ercolano, scavata nel174819, né quelli, degli anni ’60, nel tempiodi Iside dove, in corrispondenza degli into-naci asportati, è visibile la muratura antica20.Per contro, uno splendido esempio di staccoa massello, come dimostra l’osservazione in
situ, è quello di un’intera parete del tablinum(92) dei praedia di Giulia Felice (figg. 10;11), avvenuto nel 175521.Fin dagli anni ’30 dell’800 molte voci si le-varono contro questo metodo, giudicato, aragione, molto distruttivo, sottolineando lasuperiorità dello stacco dei soli strati prepa-ratori22. Ciò non significa che, nella prassioperativa, lo stacco a massello sia, da que-st’epoca, scomparso; il processo è, infatti,tutt’altro che lineare. Stacchi a massello av-venivano ancora negli anni centrali del XIXsecolo, come si evince dalle seguenti paroledel soprintendente San Giorgio: «La incari-co di far distaccare dal Sig. Piedimonte la di-pintura a fresco indicante Iside e Mitra, laquale si vede sul muro esterno della casa del-
18 ANTONIO GUGLIELMI, GABRIELLA PRISCO
Fig. 10 MAN inv. n. 8598: paretesud del tablinum dei praedia diGiulia Felice.
Fig. 11 Pompei, praedia di GiuliaFelice, tablinum: la parete suddopo lo stacco a massello.
10
11
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 18
le Sonatrici, e proprio alle spalle del Baccobambino trasportato sul carro da Sileno. Mifa meraviglia come ella non siesi neppure ac-corta che per distaccare quest’ultimo quadroa fresco era mestieri far prima togliere lamenzionata dipintura, quante volte non siavesse voluto distruggerla»23. Inoltre la circo-stanza che un dipinto staccato conservi l’in-tera stratigrafia, compresa parte della strut-tura muraria24, tagliata insieme all’intonaconel 185925, costituisce una prova incontro-vertibile che, alla vigilia dell’Unità, «l’artefi-ce Piedimonte», sordo alle critiche da tempomossegli per il suo operato26, procedeva an-cora secondo lemodalità che gli erano più fa-miliari, ossia quelle dello stacco amassello27.Tornando ai dettagli tecnici dello stacco, èsempre Saint-Non – come pure MarcelloVenuti28 – a fare cenno alla pietra lavagna,che avrebbe avuto funzione di irrigidimentoper la porzione di muro oggetto dello staccoa massello, cui sarebbe stata fatta aderire, insitu, «avec un fort mastic». Si tratta forse diun equivoco: infatti la presenza dell’ardesiaavrebbe comportato, una volta giunta l’ope-ra in laboratorio, uno spreco di tempo e dimateriali, essendo necessario distruggerla,per poter poi procedere alla rimozione del«masso inutile e soverchio»29 costituito dallaporzione di apparato murario e dagli stratipreparatori originali. Del resto proprio l’uni-co stacco a massello a noi noto a non esserestato assottigliato in laboratorio non presen-ta, nel supporto, la lavagna30.È invece acclarato che, fin dai primi stacchi,questa pietra venne utilizzata in fase di re-stauro, dopo l’assottigliamento degli stratipreparatori31.Nella sommaria descrizione delle operazio-ni di stacco, da parte dell’autore del Voyage,viene menzionata la cassetta di conteni-mento dell’intonaco, ma non la colatura delgesso sul recto, che serviva da controforma ea rendere il dipinto solidale con essa32, non-ché ad attenuare le traumatiche sollecita-zioni durante il trasporto33; non si fa nep-pure cenno a qualsivoglia strato interpostoper proteggere la pellicola pittorica e quin-di facilitare la successiva rimozione del ges-so. Poiché sulla superficie dei dipinti deltempio di Iside di Pompei – scavati e stac-cati negli anni ’60 del Settecento, ossia inun periodo assai vicino allo scritto di Saint-Non – si sono rinvenute consistenti traccedi solfato di calcio, che starebbero ad indi-care un contatto diretto tra gesso e dipin-to34, si è ritenuto che questa fosse la prassiadottata nella realtà35; quest’ipotesi sembra,almeno in alcuni casi, confermata dagli evi-
denti residui di gesso che, a causa di un’im-perfetta pulitura36, sono conservati aderen-ti alla pellicola pittorica di alcuni affreschi(figg. 8; 12). Queste tracce sono quanto ri-mane dello strato utilizzato per la messa inopera della controforma durante le opera-zioni di stacco; questo era in origine ben piùalto, tanto da riempire l’intercapedine crea-ta tra la superficie del dipinto e la tavola li-gnea fissata sul fronte della cassaforma dicontenimento (figg. 6 f, g).Tuttavia, anche in questo caso, la prassi po-trebbe non essere stata univoca, come si puòarguire da una nota spese del 1762 dove, «perscippare le pitture», vengono adoperati «can-nelle carta e filo»37. La menzione della cartarimanda all’uso, attestato nel ben più tardoscritto di Carlo Ruspi, di proteggere i dipin-ti con un foglio inumidito (fig. 6e); questanotizia trova conferma nell’utilizzo di fogli di‘carta reale’38, «per coprire dal gesso dette pit-ture», documentato in una nota spese ine-rente a stacchi avvenuti a Pompei nel 183639.L’ultima operazione, come prima si è accen-nato, consisteva nell’estrazione vera e pro-pria, attuata resecando l’intero spessore del-la muratura, nel caso dello stacco a massello;nel caso di quello dei soli strati preparatori,ci si serviva di strumenti di percussione e le-ve funzionali a favorire il distacco dell’into-naco (fig. 6h).Le operazioni di stacco non erano mai esen-ti da rischi, specie nei primi tempi degli sca-vi, tanto che, costantemente, i documentisottolineano l’abilità degli operatori nell’a-sportare per intero la porzione di intonacoprescelta40.Le fonti tendono, per contro, a sorvolaresulla sorte dei frammenti frutto di stacchimal riusciti; particolarmente illuminante è,a tal proposito, la vicenda di un quadrettodi paesaggio scoperto nel 1852 a Pompei,alla presenza dei Granduchi di Russia.Guglielmo Bechi aveva avuto l’accortezza difarlo lucidare a colori dal disegnatoreAntonio Ala prima dello stacco. Avendo poiconstatato «che lo scalpellino Piedimontesordo alle istanze di quei Soprastanti essen-do caduto una picciola porzione della partesuperiore del muro ove doveva distaccarequesta pittura preso da panico timore se neera partito senza darsi la pena ne il pensierodi fare il minimo tentativo onde salvare queidipinti»41 affermava di nutrire buone spe-ranze di ricomporre i frammenti, raccoltidopo l’inevitabile caduta e posizionati «so-pra una gran tavola», proprio grazie a queldisegno; anzi, aveva disposto «che il mede-simo [scil. il disegnatore Ala] assista a tutte
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ 19
Fig. 12 MAN sn-18, particolare:residui di gesso a diretto contattocon la pellicola pittorica.
12
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 19
le commessure dei pezzi; avremo così riuni-te le due specialità meccanica ed artisticaonde assicurare il buon esito di questa ope-razione, che in questo modo è la prima vol-ta che si tenta, e che in molti casi sarà perriuscire utilissimo espediente, come quelloche è applicabile alle pitture di tutti i muricadenti che prima si lasciavano perdere sup-ponendosi impossibile il poterla salvare. Masiccome nil volentibus arduum est così spe-ro con questo fatto di dimostrare che se sifosse prima tentato questo metodo, nonavremmo a deplorare la perdita di tante bel-le dipinture che si sono nei tempi passati la-sciati perire»42. Questo racconto confermala nuova importanza attribuita ai frammen-ti pittorici in caduta che, tramontato, con ilvolgere del XVIII secolo, il gusto per il pa-stiche, venivano spesso a perdersi «in guisache gli artisti ed i curiosi di quelle veneran-de pitture hanno fino ad oggi deplorato in-vano che innumerevoli frammenti ben pre-ziosi di quelli intonachi dipinti fossero sta-ti gettati via fra i calcinacci ed i residui diquegli scavi»43.Ritornando alle operazioni di stacco, non èirrilevante sottolineare, in relazione allo sta-to di conservazione dei dipinti, come già nel1765 Francesco LaVega, a proposito del pro-getto di una copertura provvisoria per il tem-pio di Iside, scrivesse: «ed anche questo ripa-ro lo stimo proprio non solo in questo caso,ma sempre che si scoprino pitture, ancorchési devino tagliare»44.A partire dalla metà degli anni ’20 del XIXsecolo, nei documenti si colgono con chia-rezza alcuni sostanziali cambiamenti, legatiall’organizzazione del lavoro: finché le pittu-re, e con esse le officine di restauro, rimaseroa Portici, tra scoperta e stacco intercorreva, ingenere, un lasso di tempo relativamente bre-ve45; dopo il 1826, per contro, trasferite ope-re e maestranze a Napoli, le pitture prescelteper il museo cominciarono a rimanere in si-tu assai più a lungo, a volte anni, in attesa chefossero reperiti i fondi per il trasferimentodegli operatori sugli scavi46; per i medesimimotivi di ordine economico, risultava con-veniente concentrare gli interventi, per cui siassisteva a vere e proprie campagne di stac-chi, distanziate fra loro nel tempo. Tra i nu-merosi esempi che sarebbe possibile addurre,emblematico ci sembra il caso del dipintocon Perseo e Andromeda della casa deiCapitelli Colorati che, scoperto agli inizi de-gli anni ’30, fu staccato solo trent’anni dopo;inoltre Carlo Bonucci, nel proporre, nel1847, il distacco di alcune pitture, elenca fragli altri il dipinto di alcuni gladiatori coll’i-
scrizione di Venere Pompeiana che «scovertoda circa venti o trent’anni, e sempre espostoalle intemperie, è quasi cancellato» e affermache un dipinto con Ercole e Iole «[…] sco-perto anch’esso da molti anni, è appena di-scernibile»47. Inoltre sembra che non fosseroinfrequenti, da parte degli scalpellini, esita-zioni e incertezze nel procedere alle opera-zioni di stacco, con cui evidentemente nonavevano quotidiana dimestichezza, contra-riamente a ciò che accadeva ai tempi diCanart48.Alcuni esperimenti, alternativi allo staccotradizionale, furono eseguiti, nel 1861, perimpulso del direttore del Museo Borbonico,principe di San Giorgio Spinelli che, anchesul versante dei protettivi, aveva promossoun’ampia ricerca49.Si tratta di una tecnica apparentemente assi-milabile a quella del trasporto su tela, «comea Roma ed altrove per la pittura ad olio ed afresco si va praticando» di cui, si dichiara,non vi era esperienza a Napoli; ci si avvalsepertanto di due artefici romani, GiovanniVirili e Raffaele Ferrari, che attuarono alcu-ni esperimenti su dipinti murali pom-peiani50.È stato possibile rintracciare solo uno deglioggetti della sperimentazione51, ossia un qua-dro, proveniente dalla casa dei CapitelliColorati di Pompei52, raffigurante Perseo eAndromeda53 (fig. 163a).Questo, scavato trail novembre 1832 e il dicembre 1833, mastaccato, come si è detto, solo nel luglio186154, presenta evidenti le impronte della te-la incollata sul recto (figg. 13; 164; 165); que-sto dato è in accordo con alcune voci della no-ta spese contenuta in uno degli incartamen-ti55, quali «tela», «mussolo» e «colla»; la pre-senza di quest’ultima sostanza sembra con-fermata dall’esito della microfotografia dellafluorescenza UV (figg. 166 b, c). Altri mate-riali di più difficile interpretazione, quali «cia-nuro» e «minio», potrebbero indicare rispet-tivamente l’uso di un veleno usato come bio-cida all’interno della colla e di un siccativo.Non è stato purtroppo possibile ispezionare ilverso, sigillato da una tavola di legno. Il sup-porto del dipinto, contrariamente a quellodelle altre pitture napoletane, è costituito dauna tela incollata a un pannello ligneo.Quanto sopra descritto potrebbe, come si è ac-cennato, far pensare ad uno strappo; tuttavia,il sia pur minimo spessore dell’intonachinoconservato, unitamente alle peculiarità dellatecnica esecutiva della pittura romana56, ci hafatto sospettare di non essere di fronte a un ve-ro e proprio strappo, come conferma del restol’impronta in situ (fig. 14): gli estrattisti roma-
20 ANTONIO GUGLIELMI, GABRIELLA PRISCO
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 20
ni potrebbero quindi aver associato elementipropri di questa tecnica – incollaggio di unostrato di «mussolo» e di uno di tela sul recto ecreazione di unnuovo supporto, pure costitui-to da tela – conquella tradizionale dello staccodegli strati preparatori, successivamente estre-mamente assottigliati dal verso57; ciò sarebbe inlinea conquella parte della tradizione romana,risalente a Pietro Palmaroli che, fin dai primianni dell’Ottocento, aveva reagito, con accor-gimenti tecnici analoghi, a questa prassi, checausava la perdita di parte del colore58.Una conferma di questa ipotesi è costituita daun analogo procedimento conservatoci da undocumento siciliano, di dieci anni più antico,
dove, nel lamentarne l’inapplicabilità, permancanza di maestranze specializzate, essoviene così descritto: «Se si volesse poi conser-vare per intero ed altrove collocarsi quanto èstato sinora esistente [scil. l’affresco di PietroNovelli nel Palazzo Sclafani di Palermo] sa-rebbe a farsi una più laboriosa operazione, cioèstaccarlo dalmuro attaccandone pria una for-te tela dalla faccia dipinta, e poi posti in pianoorizzontale tutti i pezzi dell’intonaco già at-taccati alla tela sul piano, e attenuando dallaparte di dietro di detto intonaco, con grossaraspa pria, e poi conpiù fine sino a ridurlo d’u-na leggerissima grossezza, poscia attaccare adun telare ben forte, grande quanto il dipinto,
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ 21
Fig. 13 MAN inv. n. 8996: la luceradente evidenzia le tracce dellatela utilizzata nelle operazioni difacing.
13
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 21
una robustissima tela e questa con abbondan-te colla farla aderire all’intonaco già sottilissi-mo; poi levato il tutto dal piano, toltavi la te-la d’innanzi il dipinto, facendovi i piccoli re-stauri resterebbe il dipinto sulla tela […] »59.Questa tecnica appare dunque estranea allaprassi seguita nel Regno delle Due Sicilie, maè nota e praticata a Roma. Sembra tuttaviache gli ingegnosi artefici partenopei abbianofatto tesoro di quanto fu loro possibile osser-vare nel 1861, se dobbiamo loro attribuire,tramontata la collaborazione con Virili eFerrari, un analogo trasporto, avvenuto setteanni più tardi, del quadro con il Teseo libe-ratore dalla casa di Gavio Rufo60 (fig. 15):l’osservazione diretta fa ritenere infatti che sitratti anche in questo caso di uno stacco as-sottigliato e posizionato su tela. E che questatecnica coesistesse, alla metà degli anni ’60,con quella tradizionale, è ulteriormente atte-stato da una nota di Giuseppe Fiorelli61.Il procedimento, così in contrasto con la tradi-zione, pur caldeggiato da quell’empirico speri-mentatore che fu il principe di San GiorgioSpinelli, non sostituì mai, per motivi econo-mici62, quello tradizionale. Per una volta, dob-biamo essere grati all’oculatezza dell’ammini-strazione: l’osservazione ai raggiUVdel dipin-to con Perseo e Andromeda ha infatti rivelatola presenza dimoltissime cadute di colore, e dialtrettante ampie integrazioni mimetiche63
(fig. 163b).Inoltre le motivazioni – mai esplicitate –che, fin dall’inizio, avevano fatto preferire latecnica dello stacco a quella dello strappo
non avevano perso nulla della loro validità:se da un lato infatti affondavano le radicinella tradizione partenopea, dall’altro si era-no imposte per evidenti motivi legati allatecnica esecutiva stessa dell’affresco roma-no: il livello di carbonatazione e coesionedella superficie di un intonaco antico benconservato è infatti in genere così alto che laforza di trazione della colla utilizzata nellostrappo sarebbe insufficiente al fine di otte-nere una asportazione completa della ma-trice di carbonato di calcio che ingloba ilpigmento; in altri termini, soprattutto neifondi, le estese zone di intonaco dipinto esuccessivamente compresso, levigato e li-sciato (la ben nota politio vitruviana), por-rebbero dei limiti allo ‘strappo’ proprio acausa della estrema compattezza e bassa po-rosità in queste aree della superficie dipin-ta, impedendo alla colla animale impiegataper l’applicazione delle tele la sufficiente pe-netrazione, presa o ‘aggrappaggio’ e conse-guente trazione sulla pellicola pittorica64.Infine, nel caso dello strappo, in particola-re di dipinti murali romani, si verificano de-gli inconvenienti correlati a problemi ottici– e di conseguenza estetici – quali la perdi-ta degli effetti di brillantezza e profonditàdovuta all’esiguo spessore dell’intonachino;al contrario, lo stacco permette di salva-guardare quantomeno queste caratteristichefisiche. Forse anche per questo motivo ilmetodo dei «Napolitani»65 non era stato, fi-no all’isolato episodio da cui abbiamo pre-so spunto, mai messo in discussione.
22 ANTONIO GUGLIELMI, GABRIELLA PRISCO
Fig. 14 Pompei, casa dei CapitelliColorati: impronta dello staccodel quadro MAN inv. n. 8996.
14
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 22
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ 23
Fig. 15 MAN inv. n. 9043:quadro con Teseo liberatore.
LA CONSERVAZIONE IINN SSIITTUU
I motivi della tendenza ad una maggiore con-servazione in situ, percepibile dagli ultimi de-cenni del XVIII secolo e documentata anchedalle spese erogate in più occasioni per ope-re provisionali66 aventi un carattere di mag-giore stabilità che per il passato67 devono, al-la luce di quanto sopra esposto, essere vaglia-ti con prudenza: alla necessità di estesi stac-chi, che pure la commissione nominata nel1834 dall’Accademia Ercolanese propugna-va68, si opponeva la continua scarsezza dimezzi cui sopra si è accennato; questa spessosi intrecciava con i cronici problemi di spaziodel museo, generando un criterio gerarchicotra pitture di eccellenza, le sole degne di esse-re staccate, e dipinti da lasciare in situ69; que-sti ultimi venivano protetti, a loro volta, «se-condo il loro merito»70: troviamo a tal finedettagliatamente menzionati tetti, file di te-gole, tavole, fascine e tele incerate71, che an-davano ad aggiungersi alle chiodature metal-liche utilizzate, fin dal secolo precedente, per
assicurare i dipinti alle pareti72. Inoltre si fa avolte menzione di «fodere a calce» e «lacerti»,in corrispondenza dei vuoti lasciati daglistacchi, per evitare cedimenti degli intonaciantichi superstiti73. Un discorso a parte meritano poi due ulterio-ri tipi di protezione, ossia le lastre di vetro, op-pure di cristallo, e gli sportellini lignei. L’ideadi proteggere porzioni particolarmente pre-gevoli di dipinti in situ risale probabilmenteal periodo francese; in una relazione del 30marzo 1813 della commissione giudicatricedei restauri eseguiti da Pietro La Vega aPompei si legge: «Allorché si trovano in unedifizio delle pitture ben eseguite, oltre di co-vrire con tegole i colli de muri, sarebbe desi-derabile, che si covrissero tutte intere quellestanze, ove si trovassero le più belle, e fare an-cora il tentativo se vi si potessero giudiziosa-mente adattare le lastre di vetro in modo, chel’acqua non penetri tra la pittura, e la lastra»74.Non sappiamo se un’analoga proposta diCamuccini75, avanzata nel 1825, si sia ispi-
15
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 23
1 ASSAN, IV E 3, 12, Pompei. Pitturepompeiane scoperte e distaccate nell’anno1835 a 1851. Pitture ed iscrizioniPompeiane, da scovrire, distaccare e dise-gnarsi.2 ZABAGLIA 1743.3 RUGGIERO 1885, p. 39, relazione del 29luglio 1739: «[…] pinturas […] las qualesestan señaladas conforme se han de cortar[…]».4 Questa pratica è di lunga durata: in unanota del 10 novembre 1846 l’arch.Bonucci chiede al direttore Avellino «ch’el-la indichi (scil. le porzioni da staccare) conriquadro a linee nere su le pareti originali»(ASSAN, IV E 3, 12, Pompei. Pitture pom-peiane scoperte e distaccate nell’anno 1835 a1851. Pitture ed iscrizioni Pompeiane, dascovrire, distaccare e disegnarsi); la nota futrasmessa da F.M. Avellino il 16 novembre1846 (ASN, MPI, b. 435 I/4 1846-51,Rapporto sull’impossibilità di distaccare al-cune pitture dalla casa della Caccia e delleQuadrighe; cfr. Documenti, pp. 246-247,n. 31).5 ASN, CRAntica, f. 1541, inc. 8 (rap-porto di Alcubierre a Tanucci del 29 otto-bre 1763, in parte edito in ALLROGGEN-BEDEL 1976, pp. 153-4; rapporto del 21dicembre 1763 di Canart a Tanucci, pub-blicato in D’ALCONZO 2002, doc. n. 22,pp. 109-110). Sottili contorni incisi sonovisibili, a causa della rimozione della cor-nice, in molte delle pitture con muse stac-cate nel 1755 dai praedia di Giulia Felicee donati dal re Ferdinando, nel 1802, al-la Francia: cfr. DESCAMPS-LEQUIME,DENOYELLE 2008, p. 155 (Calliope); p.165 (Talia); p. 167 (Polimnia); p. 169(Urania). Incisioni più larghe, ma altret-tanto regolari sono state rilevate sul dipin-to con divinità fluviale tra due ninfe, pro-veniente dalla casa delle Vestali VI 1,7 (cfr.PPM IV, 1993, p. 24, n. 37), staccato nel1789; ringraziamo Delphine Burlot, cheha restaurato l’opera, oggi al Louvre, perl’informazione. Per contro l’incisione, vi-sibile in situ, che contorna una figurina dicervo della predella dell’oecus (43) della ca-
sa dei Dioscuri (VI 9, 6.7), è stata forserealizzata in epoca moderna in vista di unfurto, come ipotizzato in PPM IV, 1993,p. 924, n. 127, con fig. a p. 926. 6 Rapporto di Avellino del 10 febbraio1847, che riporta una nota di Bonucci del27 gennaio (ASN, MPI, b. 435 I/4 1846-51, Rapporto sull’impossibilità di distacca-re alcune pitture dalla casa della Caccia edelle Quadrighe; cfr. Documenti, p. 247,n. 32).7 Per l’aspetto degli scalpelli si vedaZABAGLIA1743, Tav. I, n. 12, Scarpello perfar buche nelle muraglie, e n. 13, Lancetta,o Scarpello sottile per pulire, e riquadrare ledette buche.8 Nota dell’arch. Bonucci del 10 novem-bre 1846 (ASSAN, IV E 3, 12, Pompei.Pitture pompeiane scoperte e distaccate nel-l’anno 1835 a 1851. Pitture ed iscrizioniPompeiane, da scovrire, distaccare e dise-gnarsi) trasmessa da F.M. Avellino il 16novembre 1846 (ASN, MPI, b. 435 I/4,1846-51, Rapporto sull’impossibilità di di-staccare alcune pitture dalla casa dellaCaccia e delle Quadrighe; cfr. Documenti,pp. 246-247, n. 31).9 Si tratta della casa della Caccia Antica(VII 4, 48), scavata tra 1833 e 1835 (perla casa cfr. PPMVII, 1997, p. 6 ss.). A die-ci anni dalla scoperta, si proponeva il di-stacco degli intonaci rispettivamente delviridarium (13) e dell’ambiente (6); non acaso la prima scena fu disegnata per la pri-ma volta, forse in vista dello stacco, da S.Mastracchio, la cui attività è concentrataintorno alla metà del secolo (cfr. PPM X,1995, p. 826, fig. 5).10 Cfr. supra, nota 4. 11 Ibidem. 12 La tecnica era la stessa ancora alla metàdel XIX secolo: «Gli artefici Piedimontehan rivestito il dipinto da staccare […] diuna cassa col mastice che essi praticano[…]», come afferma l’arch. GaetanoGenovese in una minuta del 24 novembre1853, in ASSAN, IV E 3, 13, Distacco,trasporto e messa in mostra dei dipintiPompeiani e Spese erogate all’obbietto.
Restauro di sculture. Anni 1852, 1853,1854 (documento pubblicato in SIOTTO2007, p. 151, doc. 25).13 Per la composizione elementale del ma-teriale utilizzato per le stuccature cfr., inquesto stesso volume, P. Bianchetti, G.Sidoti,Caratterizzazione dei materiali diintervento per stuccature, integrazioni, sup-porti, pp. 189-190.14 DE SAINT-NON1781-86, II.15 Cfr. infra, nota 24.16 Cfr. ad esempio WINCKELMANN
[2001], p. 48 (Lettera a Pietro TeodoricoVolkmann del 3 marzo 1762) che, a pro-posito del presunto stacco del Giove eGanimede di Mengs – in realtà un falso –scriveva: «Non potendola segare col muromedesimo, come si usa qui enell’Ercolano, si mise a staccare dal murol’intonaco […]»; e, ancora, precisa, par-lando di quattro pitture rinvenute a pièd’opera, perché già tagliate in antico: «nonfurono però levati colla sega». AncheCreuzé de Lesser (CREUZÉ DE LESSER1806, p. 169) afferma che le pitture veni-vano staccate con parte del muro. 17 Per la coesistenza dei due metodi cfr.PRISCO 2004, pp. 130-131; cfr. ancheSIOTTO 2007, p. 123.18 RUSPI 1864 (il testo, pubblicato postu-mo, è stato scritto dopo il 1857).19 Come è evidente all’osservazione in si-tu. Per la casa e le sue pitture si veda TRANTAMTINH 1988.20 Il modello in sughero del tempio (per ilquale si veda KOCKEL1998, p. 72 ss., Tav.6:13), eseguito da Giovanni Altieri tra il1784 e il 1785, documenta la situazionedopo gli stacchi, con le integrazioni a li-vello e le grappe che fermano gli intonacipericolanti; nella parte bassa della pareteorientale del portico, sotto l’edicola cen-trale, è visibile uno stacco, sotto il quale èindicata la muratura. Questa situazione èconfermata dall’osservazione di quanto ri-mane oggi in situ.21 In assenza di una descrizione di questostacco, si può avere un’idea della sua com-plessità leggendo quella dello stacco a
24 ANTONIO GUGLIELMI, GABRIELLA PRISCO
rata a questa precoce proposta di musealiz-zazione in situ76. Questo tipo di protezione,proposta in concomitanza con la sperimen-tazione della vernice di Andrea Celestino, furealizzata, secondo i voleri del re, per tuttele pitture «riputate di singolar merito», inprimo luogo su quelle scoperte nell’edificiodi Pompei con le nozze di Peleo e Teti, pre-vio trattamento con la suddetta vernice77.Tuttavia questa protezione meccanica nonsembra mai essere stata adottata su larga sca-la78, forse a causa delle intuibili controindi-cazioni sul piano conservativo; inoltre la ne-cessità, a fronte di estese porzioni di into-naco dipinto, di accostare numerose lastredi vetro mediante piombo, faceva sì che lalettura delle scene risultasse compromessa.
Viceversa, quella costituita dagli sportellini li-gnei godette di maggior fortuna, si può pen-sare a causa della sua duplice valenza: accan-to ad uno scopo conservativo79, infatti, si puòagevolmente individuare la volontà di poten-ziare l’effetto delle immagini sulla ristrettacerchia cui era permesso disvelare l’opera80;non a caso tali sportelli risultano adoperati,almeno dagli anni ’20 dell’Ottocento81, percelare agli occhi del pubblico dipinti giudi-cati osceni82, nei rari casi in cui non si deci-desse di procedere, con inusuale celerità, alloro stacco83.Spesso alle sopracitate protezioni meccanicheveniva associata, come si è detto, una barrie-ra chimico-fisica costituita da una vernice, dicui si tratterà più avanti.
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 24
massello di un enorme dipinto muraledalla basilica di San Pietro in ZABAGLIA1743, Tav. XIX.22 Le testimonianze più tarde, infatti, cita-no il vecchio metodo come superato:«Attualmente si è arrivato ad una granperfezione nel levare dalle mura di questiquadri, i quali tagliavansi prima con tuttoil muro» (SCHULZ 1838, p 167, nota 8).23 Nota del 16 dicembre 1850, in ASN,MPI, Commissione di antichità e belle ar-ti, b. 435, II/1. Cfr. anche la risentita ri-sposta dell’architetto Settembre del 21 se-guente, ivi (cfr. Documenti, pp. 247-248,rispettivamente n. 34 e 35).24 La scoperta è avvenuta nel corso dellosmontaggio della struttura di sostegno neilaboratori di restauro del museo diNapoli: cfr. MELILLO 2007, pp. 40-41,figg. 6-9; vi accenna E. Siotto (SIOTTO2007, p. 124).25 Dello stacco del dipinto (MAN inv. n.27683) si parla diffusamente nei docu-menti, datati dal 1 al 12 marzo, contenu-ti in ASSAN, XXI A 5, 2, Distacco di di-pinti e spese correlative 1854-1859 (cfr.Documenti, p. 248, n. 37).26 «[…] oramai è ovvio non esser necessa-rio demolir muri per distaccar dipinti», af-fermava l’arch. Genovese, dissentendo dalmetodo di stacco a massello proposto daiPiedimonte (minuta del 24 novembre1853, in ASSAN, IV E 3, 13, pubblicatain SIOTTO 2007, doc. 25, p. 151).27 Il dipinto proviene da Pompei, VII 6,34-35 (cfr. PPMVII, 1997, p. 209, fig.3). Sarebbe indispensabile verificare se ilpilastro centrale tra le due botteghe che necostituiva, secondo le fonti, il supporto –e che appare, in fotografia, integro – sia,almeno in parte, ricostruito: nella foto-grafia ivi pubblicata (p. 208, fig. 1) la par-te inferiore è coperta da resti di intonaco,e non sembra, quindi, essere di restauro.28 VENUTI 1748, pp. 109-110.29 L’espressione, riferita al restauro dell’o-vale con la Vittoria (MAN inv. n. 8940) ècontenuta in una minuta del 4 gennaio1813 di Arditi al ministro Zurlo (in AS-SAN, IV E 3, 6, Ristauro della antica di-pintura rappresentante la Pace e la Vittoriascoverta a Pompei nell’anno 1813, edita inD’ALCONZO 2002, pp. 72-73, 115-116,doc. n. 37).30 Cfr. supra, nota 24; si tratta però di unostacco della metà del secolo XIX.31 Si veda, ad esempio, il rapporto diAlcubierre del 31 ottobre 1739 pubblica-to in STRAZZULLO 1982a, pp. 133-134 ein D’ALCONZO 2002, p. 99, Doc. 2.32 È questa una costante nelle operazionidi stacco: come viene riferito in un docu-mento del 1836, nello stacco di alcuni di-pinti venne impiegato un considerevolequantitativo di gesso «per la buona gros-sezza data acciò reggessero», (Nota ed im-porto delle spese dell’Intraprenditore Sig.Giuseppe dell’Aquila pe’ lavori eseguiti neldistacco di cinquanta pitture a fresco inPompei, e trasporto delle medesime e nelReal Museo in Napoli, 9 settembre 1836,in ASSAN, XXI A 5, 1.9, Manutenzione edistacco delle dipinture, de’ musaici delleiscrizioni e de’ graffiti pompeiani. Anno1836, pubblicata in SIOTTO 2007, pp.147-8). 33 A tal proposito cfr. in questo stes-so volume, A. Guglielmi, G. Prisco,
Movimentazione e trasporti.34 Così in PANCANI, SERACINI, VANNUCCI1992, p. 130. Va tuttavia osservato che ilsolfato di calcio rinvenuto sulla pellicolapittorica, salvo che sia di apprezzabile spes-sore, non indica necessariamente un con-tatto diretto tra questa e il gesso, poichéquest’ultimo potrebbe essere andato in so-luzione e essere venuto a contatto con lasuperficie attraversando la carta interposta. 35 D’ALCONZO 2002, pp. 20-21.36 Probabilmente esso non è stato rimossocompletamente per il timore di danneg-giare ulteriormente opere che mostravanouno stato conservativo già fortementecompromesso.37 ASN, CRAmministrativa, IIIInventario, Conti e cautele, b. 1175, anni1761-1762, 1762 Volume di note settima-nali delle spese fatte pelle Reali Delizie diPortici e cavamenti di Antichità, c. 127.Ringraziamo José María Luzón e M. delCarmen Alonso Rodríguez per la cortesesegnalazione. Per ‘cannelle’ si intendonoforse le canne per le impalcature, oppureun’incannucciata – peraltro mai attestatanelle fonti – per armare il gesso della con-troforma, o ancora le ‘cantinelle’, ossia i re-goli della cassetta di stacco. SAMPAOLO1998, p. 66, ritiene che la carta sia stata in-trodotta, dopo molti anni, al posto di telidi stoffa; di questi non è però comprova-to l’uso, fino all’esperimento del 1861(per il quale cfr. infra, p. 20 ss.) né dallefonti, né dall’osservazione di alcuna trac-cia di facing sulle opere.38 Il termine ‘reale’ indica un formato dicarta: ad esempio, nella fabbrica diBeranger, a Sora, si producevano, nel1817, fra gli altri tipi di carta: «7. dettaReale grossa bianca; 8. detta Reale finacerulea» (ASN, MinInt 5057, II inv.,Antichità, Belle Arti e scuole di disegno, f.26, nota del 23 giugno 1817).39 Cfr. il documento citato a nota 25. Siveda anche la nota spese del 30 ottobre1852 in cui, accanto a gesso e legno, è at-testata la carta: ASSAN, IV E 3, 13.40 «e si spera che salga sana», questa la for-mula costante che accompagna i primistacchi e il loro trasporto dai cunicoli alpiano di campagna: cfr. ZEVI 1994, p.474; anche Canart, nel 1740, spera «conil divino ajiuto» di riuscire a portare fuoriintera una fontana a mosaico (ASN,CRAntica, I inv., Scavi e Musei, b.1537/77, relazione del 18 novembre1740). Si veda anche l’illuminante rela-zione, del 31 luglio 1743, dell’intendenteVoschi sui danni causati ad una delle duepitture, poste una sopra l’altra, all’atto deltaglio della prima, in RUGGIERO1885, pp.98-99.41Nota di Guglielmo Bechi al Principe diSan Giorgio del 18 maggio 1852: AS-SAN, IV E 3, 13, Distacco, trasporto emessa in mostra dei dipinti Pompeiani eSpese erogate all’obbietto. Restauro di scul-ture. Anni 1852, 1853, 1854, trasmessada San Giorgio il 21 maggio: ASN, MPI,317/7, Pompei, lavori relativi agli scavi edagli oggetti rinvenuti (cfr. Documenti, p.248, n. 36).42Nota di Guglielmo Bechi al Principe diSan Giorgio del 20 maggio 1852: ibidem,pubblicata in SIOTTO 2007, doc. 24, pp.150-1. 43 Lettera del 27 aprile 1849 della Società
Reale Borbonica al Ministro, in ASN,MPI, b. 358 II, fasc. 73, Metodi per ripu-lire le pareti Pompeiane e connettere i fram-menti. Si veda anche l’affermazione, con-tenuta nella nota del 18 maggio 1852 (cit.a nota 42), che esalta il metodo, adottatodi recente, della ricomposizione dei fram-menti, che prima si lasciavano distrugge-re, su lavagna.44 Francesco La Vega a Tanucci, 26 ot-tobre 1765 (ASN CRantica, f. 865):cfr. STRAZZULLO 1982b, pp. 266-7.Sottolineatura di chi scrive.45 Le polemiche relative alla mancataconsegna delle cassette necessarie allostacco sembrano circoscritte agli anni1759/60, in seguito all’introduzione dialcuni cambiamenti nella procedura de-gli ordini e delle acquisizioni: cfr. AS-SAN, VIII D 2, 4. 46 Per questo motivo si trovano attestazio-ni di puntelli e protezioni attuate con ter-ra asciutta e lapillo, in attesa del recupero(si veda ad esempio la nota del 15 marzo1852, in ASSAN, IV E 3, 13 pubblicatain Siotto 2007, doc. 21, p. 149).47 Nota del 27 gennaio 1847, in ASN,MPI, b. 435 I/4, 1846-51, Rapporto sul-l’impossibilità di distaccare alcune pitturedalla casa della Caccia e delle Quadrighe(cfr. Documenti, p. 247, n. 33). I grandiquadri con Ercole e Onfale e il trionfo diBacco che, il 29 luglio 1850, l’AccademiaErcolanese aveva consigliato di asportaredalla casa delle Suonatrici (ossia la casa diMarco Lucrezio Stabio IX 3, 5.24) essen-dosi verificata, nonostante le coperture,una «fioritura di nitro» (relazione del 14maggio 1850 in ASN, MPI, b. 358 II, fa-sc. 73) risultano, da una nota del 15 mar-zo 1852, staccati «da più mesi», ma «an-cora rimasti sul luogo con gran rischio dideteriorarsi» (cfr. rispettivamente la mini-steriale del 29 luglio 1850 e la nota del 15marzo 1852 di Guglielmo Bechi alPrincipe di San Giorgio, in ASSAN, IV E3, 13, Distacco, trasporto e messa in mostradei dipinti Pompeiani e Spese erogate all’ob-bietto. Restauro di sculture. Anni 1852,1853, 1854). Ancora, un piccolo dipintoscoperto il 7 aprile 1859 che «essendoesposto alle intemperie sta giornalmentedegradandosi» verrà staccato solo alla finedi luglio del medesimo anno: ASSAN,XXI A 5, 2, Distacco di dipinti e spese cor-relative 1854-1859.48 Si veda quanto avvenne nel 1825quando, avendo Atticciati temporeg-giato di fronte alla richiesta di staccarealcuni affreschi, l’Accademia Ercolanesepropose di rivolgersi, a Roma, alPalmaroli, anche perché formasse in lo-co degli estrattisti (ASN, MinInt, IIinv., f. 2070, Distacco delle pitture diPompei ed annessione nel Museo (il do-cumento è stato rinvenuto da FrancescaDella Gatta, che ringrazio); si veda inol-tre, sullo stesso argomento, il processoverbale dell’Accademia Ercolanese del-l’8 febbraio e il rapporto del 1 marzo1825, in ASN, MinInt, II Inv., f. 2034,1, Processi verbali delle tornate accade-miche del 1824-1825. Per i frequenti at-triti tra la direzione degli scavi e Raffaelee Luigi Piedimonte si veda, oltre la pre-tesa, cui sopra si è accennato, di proce-dere ad uno stacco a massello, contro ilparere della direzione, l’accusa di aver
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ 25
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 25
abbandonato un’operazione di stacco alprimo segnale di crollo (cfr. supra, p. 19e nota 41). 49 Cfr. PRISCO 2003, p. 133.50 ASN, MPI, Real Museo Borbonico, b.752 I/16, 1861 Nuovo metodo per il di-stacco e trasporto su tela. Cfr. anche AS-SAN, XXI B 10, 30, Dipinti sopra intona-co distaccati e trasferiti nel MuseoNazionale. Spese da pagarsi ai Sig. Virili eFerrari. 1861 (cfr. Documenti, rispettiva-mente p. 249, nn. 39-40 e pp. 248-249,n. 38). Una piccola parte dei documentirelativi a quest’ultimo fascio è stata pub-blicata in SIOTTO 2007, doc. 31-33, pp.153-4; tuttavia, non avendo consultato ifondi dell’Archivio di Stato di Napoli, al-la Siotto sono mancati gli elementi essen-ziali per inquadrare l’esperimento e per in-dividuare le opere.51 Gli altri due dipinti, per ora non rin-tracciati, sono un festone e un’iscrizionesu pietra (ASN, MPI, Real MuseoBorbonico, b. 752 I/16, 1861 Nuovo me-todo per il distacco e trasporto su tela).52 I documenti di archivio segnalano cheda questa casa proviene uno dei dipintioggetto della sperimentazione: cfr. la no-ta del direttore degli scavi di PompeiGaetano Genovese del 30 luglio 1861 inASN, MPI, Real Museo Borbonico, b.752, I/16, 1861 Nuovo metodo per il di-stacco e trasporto su tela ( cfr. Documenti,p. 249, n. 39); si vede anche ASSAN, XXIB 10, 30, Dipinti sopra intonaco distaccatie trasferiti nel Museo Nazionale. Spese dapagarsi ai Sig. Virili e Ferrari. 1861. Il la-voro fu eseguito da Raffaele Ferrari.53 MAN inv. n. 8996. RingraziamoAngela Luppino, che ci ha segnalato l’a-nomalia di questo e del dipinto di cui siparlerà fra breve, entrambi riportati su te-la; perciò, pur non essendo essi compresitra i materiali a deposito, se ne è effettua-to lo studio.54 Cfr. PPM VI, 1996, pp. 1018-1020,figg. 28-30.55 Nota delle spese fatte per togliere un di-pinto di Pompei da Giovanni Virili eRaffaele Ferrari del 28 giugno 1861, inASSAN, XXI B 10, 30, Dipinti sopra in-tonaco distaccati e trasferiti nel MuseoNazionale. Spese da pagarsi ai Sig. Virili eFerrari. 1861 (cfr. Documenti, pp. 248-249, n. 38).56 Cfr. infra, p. 22.57 A tal punto da aver causato danni allapellicola pittorica: cfr., in questo stesso vo-lume, A. Guglielmi, Tipologie di degrado estato di conservazione degli strati preparato-ri e della pellicola pittorica in relazione aimateriali di intervento. Benché nella notaspese di Virili e Ferrari siano assenti glistrumenti tipici delle operazioni di stacco,si può supporre che questi, non essendomateriali di consumo, facessero parte del-l’attrezzatura personale degli estrattisti.58 All’argomento del trasporto dei dipintimurali a Roma ha dedicato un bel saggioF. Giacomini (GIACOMINI 2007, pp. 71-97; in particolare sulle reazioni, all’inter-no del milieu romano, alla tecnica dellostrappo si veda p. 85 ss.; sulla tecnica ‘mi-sta’ dello stacco assottigliato e posizionatosu tela, p. 91 ss.).59 Relazione del 10 luglio 1850 al diretto-re del Dipartimento degli affari internipubblicata in GUTTILLA 2003, p. 241 e
nota 5.60 MAN inv. n. 9043; la casa (VII 2, 16)fu scavata nel 1868. 61Nota s.d., ma degli inizi del 1865, attri-buibile a Fiorelli, in ACSR, Dir. Gen.AA.BB.AA., 1860/1890, I vers., b. 244,111-75.62 Come esplicitato nella nota del 10 lu-glio 1861 del direttore del MuseoNazionale, Principe di San GiorgioSpinelli, al Segretario Generale incaricatodel Dicastero dell’Istruzione Pubblica(ASN, MPI, Real Museo Borbonico, b.752 I/16, 1861 Nuovo metodo per il di-stacco e trasporto su tela; minuta in AS-SAN, XXI B 10, 30, Dipinti sopra intona-co distaccati e trasferiti nel MuseoNazionale. Spese da pagarsi ai Sig. Virili eFerrari. 1861). Anche nella relazione del10 luglio 1850 al direttore delDipartimento degli affari interni citata anota 59 si dice chiaramente che il suppor-to tradizionale, con lavagna e gesso, è assaimeno costoso di quello con tela.63 Cfr. , in questo stesso volume,M. Cardinali, M.B. De Ruggieri,Caratterizzazione dei ravvivanti e pro-tettivi: tecniche di imaging multi spettra-le; A. Guglielmi, Tipologie di degrado estato di conservazione degli strati prepa-ratori e della pellicola pittorica in rela-zione ai materiali di intervento.64 Va inoltre ricordato che, fino a che gliscavi avvennero in galleria, l’umiditàavrebbe impedito un adeguata essicazionedella colla impiegata per far aderire la tela;né sarebbe stato possibile, per evidentimotivi, accendere dei fuochi per favorirneil processo di asciugatura.65 Così lo definisce C. Ruspi (RUSPI1864).66 Previste peraltro dall’art. 82 del‘Regolamento pel Museo RealeBorbonico’ del 1828: nell’autunno diogni anno era prescritto di coprire pavi-menti, mosaici e marmi e di cautelare lepitture.67 Quando le coperture erano realizzatecon gambi di lupini: cfr. la minuta non fir-mata, ma attribuibile a Francesco La Vega,indirizzata al marchese Caracciolo, del 22maggio 1788, in ASSAN, VIII C 4, 3.5.68 Per la posizione dell’Accademia, tenacesostenitrice degli stacchi, cfr. ASN,MinInt II, 2070, Distacco delle pitture diPompei ed annessione nel Museo; per l’isti-tuzione della commissione, portatrice del-la medesima istanza, cfr. la copia di una re-lazione dell’Accademia, firmata daMonsignor Rosini, non datata, (1835?) inASSAN, IV E 3, 12, Pompei. Pitture pom-peiane scoperte e distaccate nell’anno 1835a 1851. Pitture ed iscrizioni Pompeiane, dascovrire, distaccare e disegnarsi.69 Si veda ad esempio la minuta del 20maggio 1876 del Direttore di Pompei alMinistero, in ASSAN, II C 4, 7,Carte re-lative all’invio a Napoli di bronzi, di un su-ghero e di pitture da Pompei, anno 1876; glioriginali sono in ACSR, Dir. Gen.AA.BB.AA. 1860/1890, I vers., b.244.112.14, Pompei. Conservazione nelMuseo di pitture pompeiane. 70 Si veda la minuta dell’architettoBonucci del 4 novembre 1829 in ASSAN,IV E 3, 2; la minuta di Bonucci adAvellinodel 28 gennaio 1847 in ASSAN,IV E 3, 12, e la stessa proposta, trasmessa
da Avellino al Ministro degli AffariInterni, del 5 marzo 1847, in ASN, MPI,328, I/7. 71 Si vedano, a solo titolo di esempio, leprotezioni in situ alla casa delle Suonatrici(1848. Misura ed apprezzo dei lavori di sca-vo eseguiti da Giuseppe e Salvatoredell’Aquila nel mese di febbraio, in ASN,MPI, Real Museo Borbonico, b. 752,II/2).72 L’uso, codificato dal ‘Regolamento pelMuseo Reale Borbonico’ del 1828, art. 79,è attestato fin dal 1765, quando Canartmise 60 chiodi per «fermare» le pitture (9novembre 1765: cfr. HOFFMANN1993, p.248; PAGANO 1997, p. 30). Francesco LaVega, in una lettera a Tanucci del 26 otto-bre 1765 (ASN, CRAntica, f. 865, pub-blicata in STRAZZULLO1982b, pp. 266-7)parla di questo metodo come di una no-vità, applicata da Canart solo un’altra vol-ta e analogo a quello da lui stesso «vedutopratticare in Roma nelle pitture diRaffaele». Tra i numerosi esempi poste-riori, si veda quanto proposto (chiodi dirame al posto di quelli di ferro) in una re-lazione del 30 marzo 1813 della commis-sione giudicatrice dei restauri eseguiti daPietro La Vega a Pompei (in ASN,MinInt, I inv, f. 1007, 4) e i chiodi «di me-tallo ramato» fatti realizzare pochi mesidopo, conformemente ai dettami diBellori, da R. Venuti su incarico del mini-stro Zurlo (cfr. note del 12 e del 24 di-cembre 1813 in ASN MinInt, II inv.,2273/s.n. pubblicate in ADAMOMUSCETTOLA 2004, p. 66); la nota diBonucci ad Avellino del 22 giugno 1847,in ASSAN, IV E 3, 12. Per altri accenni achiodi e grappe cfr. PRISCO ET ALII 2004,p. 71, nota 19. 73 Cfr. i lavori nella «Strada della Fortuna.Seconda Casa dopo il primo [?] Vicolettoin seguito a quella del Fauno», in ASN,MPI, b. 333 I/4, Misura ed apprezzo deiLavori eseguiti dall’Appaltatore Sig. D.Giuseppe dell’Aquila […] dal primoGennajo a tutto Dicembre 1838.74 ASN, MinInt, I inv., f. 1007, 4.75 Già come Ispettore alle PubblichePitture di Roma Camuccini si era piùvolte espresso a favore della conserva-zione in situ, mettendo in atto adegua-te misure di protezione: cfr. GIACOMINI2007, pp. 81-82.76 Cfr. la lettera di Vincenzo Camucciniall’architetto Pietro Bianchi del 26 apri-le 1825 in ASN, MinInt, II inv., f. 2070,Distacco delle pitture di Pompei ed annes-sione nel Museo; il dispaccio del 29 set-tembre 1825 del Ministro G. Ruffo adArditi, in ASSAN, IV E 3, 4, 1811-1829, Esperimento fatto della vernice in-ventata dal Prof. Celestino. Parere dellaSocietà Reale Borbonica su detta vernice.Vantaggi che offre. Preparazione e modo diapplicarla.77 ASSAN, IV E 3, 4. L’esperimento av-venne il 29 settembre 1825.78 Per l’adozione delle lastre in determi-nati casi si veda la nota dell’architettoBonucci del 14 novembre 1829, in AS-SAN, IV E 3, 2; la dettagliata descrizio-ne delle lastre a protezione di un dipintocon ermafrodito nella casa di Adone e diuno con foglie e frutta nella casa delTorello di Bronzo nel 1838, in ASN,MPI, b. 333 I/4, Misura ed apprezzo dei
26 ANTONIO GUGLIELMI, GABRIELLA PRISCO
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 26
Lavori eseguiti dall’Appaltatore Sig. D.Giuseppe dell’Aquila […] dal primoGennajo a tutto Dicembre 1838 (cfr.Documenti, p. 241, n. 8) la menzione dilastre a protezione del tablino della Casadi Apollo in una nota di Bonucci del 5marzo 1839, in ASSAN, XXI A 5, 1.11,Manutenzione e distacco delle dipinture,de’ musaici delle iscrizioni e de’ graffitipompeiani. Anno 1839.79 È il caso di un quadretto di Marte eVenere protetto, nel 1820, con una «cas-setta sulla parte della parete dove esiste, daaprirsi a piacere» (DECARO 1995).80Così V.I. Stoichita (STOICHITA1998, p.69) a proposito delle tende che celavano «icapolavori e le rappresentazioni di carat-tere licenzioso».81 Probabilmente questo atteggiamentocensorio non è anteriore alla restaurazio-ne: Lewis Engelbach, in viaggio in Italianel 1802 (ENGELBACH 1815, p. 114 ss.),
è sorpreso dal diverso senso del pudore de-gli Inglesi, che chiudono le pitture eroti-che con tende, rispetto ai napoletani che,benché abbiano sottratto alla vista il grup-po scultoreo di Pan con la capra, espon-gono tranquillamente nel museo diPortici una teoria di falli. 82 Per la menzione di pitture oscene si ve-da, ad esempio, la minuta dell’architettoBonucci del 4 novembre 1829, in AS-SAN, IV E 3, 2. Anche il famoso dipintocon il Priapo della casa dei Vettii era stato,in una data imprecisata, compresa tra lascoperta, del 1895, e gli anni ’40/’50 delXX secolo, coperto da uno sportellino li-gneo, sostituito poi da una lastra di vetro(cfr. PRISCOETALII2004, p. 74, nota 54).83 Infatti i dipinti di tal genere venivanostaccati, indipendentemente dalle lorocondizioni di conservazione, assai più sol-lecitamente di altri, in conformità conquanto esplicitamente prescritto all’art. 8
del ‘Regolamento e Istruzioni per loScavo di Pompei del 1819’ (ASSAN, IIinv., b. 45, f. 4): «Le oscene saranno subi-to tagliate, ed inviate al Museo». Si vedaad esempio la nota del direttore delMuseo Avellino del 5 agosto 1840 inASN, MPI, b. 328, II/42, 1840 -Trasporto al Real Museo di pitture oscene; ildispaccio del medesimo del 14 marzo1846, in ASN, MPI, Real MuseoBorbonico, b. 328, I, 35, 1844-46 -Trasporto al Real Museo di alcuni dipintirinvenuti negli scavi di Pompei. Ancora, il13 marzo 1853, quattro pitture furonodistaccate «per essere oscene»: cfr. AS-SAN, IV E 3, 13; stessa sorte toccò, nel1859, ad «una dipintura oscena di dueanimali con una vittoria» (nota di SanGiorgio del 1 marzo 1859, in ASSAN,XXI A 5, 2, Distacco di dipinti e spese cor-relative 1854-1859).
Le operazioni di stacco e la conservazione in situ 27
conoscere per conservare ultimo:FONTANA 22-10-2009 16:09 Pagina 27