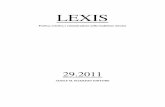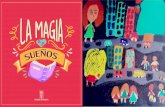Un manoscritto recenziore del 'De Magia' di Apuleio: Il cod. Ambrosiano N 180 sup.
Transcript of Un manoscritto recenziore del 'De Magia' di Apuleio: Il cod. Ambrosiano N 180 sup.
FRANCESCA PICCIoNI
UN MANoSCRITTo RECENzIoREDEL DE mAGIA DI APULEIo:
IL CoD. AMBRoSIANo N 180 SUP.*
1. LA TRADIzIoNE MANoSCRITTA
Questo contributo rientra in un’indagine sui codici del De magiadi Apuleio A (Milano, Biblioteca Ambrosiana, N 180 sup.) e C (Assi-si, Biblioteca del Sacro Convento, 706), mirante a valorizzare due testi-moni finora trascurati, per quanto generalmente ritenuti di valido ausi-lio alla constitutio textus. Ho altrove dato conto delle nuove acquisizio-ni stemmatiche relative alle carte di Assisi1. Presento in questa sede idati concernenti l’Ambrosiano. Il De magia2 di Apuleio costituisce conmetamorphoses e Florida una terna piuttosto compatta nella trasmissio-ne manoscritta3. Sono circa trenta i testimoni superstiti. Generalmen-
* Desidero esprimere la mia viva gratitudine a Giuseppina Magnaldi e Antonio Stra-maglia per la cortese disponibilità a discutere con me singoli aspetti filologici e paleografico-codicologici di questo lavoro.
1 F. Piccioni, Il De magia di Apuleio. Un testimone trascurato: il codice Assisiate 706,in E. Bona – M. Curnis [a cura di], Linguaggi del potere, poteri del linguaggio. Atti del Col-loquio internazionale del PARSA (Torino, 6-8 Novembre 2008), Alessandria 2010, 365-375. L’Assis. 706, estremamente frammentario, viene datato all’XI sec. ed è collocabile, perle caratteristiche della pergamena e la tipologia dei compendi, in area cassinese.
2 Per le questioni relative alla natura dell’opera rimando ai recenti lavori di W. Riess,Paideia at Play: Learning and Wit in Apuleius, Groningen 2008, e C. Schneider, Discoursécoutés, discours prononcés dans l’Afrique romaine: l’Apologie d’Apulée ou le trompe-l’oeil abso-lu, in G. Abbamonte – L. Miletti – L. Spina [a cura di], Discorsi alla prova. Atti del Quin-to Colloquio italo-francese Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza traGrecia, Roma ed Europa (Napoli – S. Maria di Castellabate, 21-23 settembre 2006), Napo-li 2009, 391-419, e alla ricca bibliografia ivi citata.
3 Per una sintetica presentazione della tradizione manoscritta apuleiana si veda P. K.
te fin da metà ’800, con Heinrich Keil4, si fa risalire l’intera tradizioneall’autorevole F (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 68.2),vergato a Montecassino nell’XI sec. Suo apografo diretto è φ (Firenze,Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 29.2), pertinente alla medesimaarea geografica e datato al sec. XII-XIII5. Il codice è ritenuto, no-nostante numerosi interventi arbitrari del librarius, la copia miglioreperché cronologicamente abbastanza vicina a F e quindi anteriore amolti danni del tempo e ad alcune delle mani che hanno agito, spessoalterandone le scritture, sul prezioso capostipite. Purtroppo però φ èposteriore a una vistosa lacerazione prodottasi all’altezza del fol. 160 diF, che ha inficiato la leggibilità e la completezza di met. 8, 7-9. Propriodalla constatazione che in corrispondenza di tali passi tutti i codici noti,φ incluso, presentano lacune o integrazioni (presunte) congetturali,Keil derivò la prova materiale6 della discendenza da F di tutti i recen-tiores. Sui due Laurenziani sono di norma costituiti De magia, meta-morphoses e Florida.
FRANCESCA PICCIoNI
Marshall, Apuleius. Apologia, Metamorphoses, Florida, in L. D. Reynolds [a cura di], Textsand Transmission. A Survey of the Latin Classics, oxford 19862 [19831], 15-16.
4 H. Keil, Observationes criticae in Catonis et Varronis de re rustica libros, Halle 1849,14 segg. e 77 segg.
5 E. A. Lowe, The Unique ms. of Apuleius’ Metamorphoses (Laurentian. 68, 2) and itsOldest Transcript (Laurentian. 29, 2), «CQ», 14 (1920), 150-155, rist. in Id., PalaeographicalPapers, a cura di L. Bieler, I, oxford 1972, 92-98, e E. A. Lowe, The Unique ms. of Tacitus’Histories (Laurentian. 68, 2), in Casinensia, Monte Cassino 1929, 257-272, rist. in Id.,Palaeographical Papers cit., I, 289-302, cui rinvio per una dettagliata descrizione codicologi-ca e paleografica. Mi limito a qualche essenziale ragguaglio: sono entrambi membranacei eimpaginati su due colonne; F è miscellaneo, di due mani diverse ma del pari beneventane ecoeve, che trascrissero l’una Tacito Ann. 11-14 e Hist. 1-5, l’altra Apologia, metamorphoses,Florida (l’ordine è il medesimo nell’apografo φ). In parecchi notabilia di φ è stata da temporiconosciuta la mano del Boccaccio, che postillò ampiamente il codice.
6 Una seconda prova materiale aggiunse R. Helm, Apulei Platonici madaurensis operaquae supersunt, II.2, Florida, Lipsiae 19592 cum Addendis [19101, 19212], XXIX-XXX. Ne hotrattato nel De magia di Apuleio (cit. n. 1), 371-372, cui rinvio data l’importanza centraleche la questione riveste nel caso di C. È tuttavia opportuno, per maggior chiarezza, sinte-tizzare qui le conclusioni cui sono pervenuta. Al fol. 116v F mostra la lezione corretta indu-cat animum, ma, a causa dell’estrema sottigliezza della pergamena, traspare la u della paro-la facundia del recto; ebbene l’erronea lettura inducatu animum è puntualmente ereditatadalla quasi totalità dei codici (talora emendata congetturalmente in inducat in animum),eccezion fatta per i manoscritti della classe I, il cui antenato probabilmente decifrò corret-tamente la scrittura di F. A dire di L. Pepe, Un nuovo codice di Apuleio del sec. XI (Bibl.Comun. Assisi n. 706), «GIF», 4 (1951), 214-225: 216, al fol. 8r, l. 26, C «doveva avereinducat animum», il che «escluderebbe che esso sia copia diretta di F». Notevoli in effettisono le difficoltà di lettura, a causa di una macchia che oscura la pergamena e sbiadisce lascrittura e soprattutto di un numero di protocollo che oblitera, con inchiostro molto scuro,il punto cruciale tra le due parole (il codice fu smembrato nel XVI sec. e le sue carte usate
166
167UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
come coperte di faldoni notarili). Tuttavia risultano ben visibili, anche a occhio nudo, trainducat e -nimum, tracce di due distinte lettere, compatibili con u e con a. La tecnologiainformatica ha dissipato inoltre ogni residuo dubbio: grazie alla cortesia dei responsabili delFondo Antico, ho avuto accesso a una scansione ad altissima risoluzione, su cui si è opera-to con un programma di grafica, contrastando le due tonalità di inchiostro rispetto alla per-gamena, il che mi ha consentito di leggere con assoluta sicurezza sia la u sia la a. Il princi-pale indizio di autonomia si è rivelato viceversa prova materiale di discendenza di C da F.
7 D. S. Robertson, The manuscripts of the Metamorphoses of Apuleius, «CQ», 18(1924), 27-42 e 85-99, e Apulée. Les métamorphoses, texte établi par D. S. Robertson et tra-duit par P. Vallette, I, Paris 1940, XXXVIII-LV.
8 Apulei metamorphoseon libri XI, recensuit C. Giarratano, editionem alteram para-vit P. Frassinetti, Torino 19602 [19291], V-XLVI.
9 J. van der Vliet esaminò diversi codici di XIV-XV sec., in funzione dell’edizione del‘romanzo’ e delle orazioni apuleiane per i tipi della Teubner (Lucii Apulei madaurensismetamorphoseon libri XI, Lipsiae 1897; Lucii Apulei madaurensis Apologia sive De magialiber et Florida, Lipsiae 1900).
10 La suddivisione dei recentiores in quattro classi risale a Robertson, The manuscripts(cit. n. 7).
11 Come ha osservato Lowe, Apuleius’ Metamorphoses (cit. n. 5), 153, per un difet-to di concia nella pergamena di numerosi manoscritti cassinesi dell’XI sec. è sovente svani-ta la scrittura (specie sul lato carne), ripristinata, non sempre correttamente, da più manisuccessive.
12 Cfr. Giarratano, metamorphoseon libri (cit. n. 8), XVII: «manent tamen antiquiorisoriginis indicia, locos dico, ubi non φ, sed A primariam codicis F scripturam restituit».
La conferma di tale configurazione stemmatica arrivò dagli studi diDonald S. Robertson7 e di Cesare Giarratano8, con un importantedistinguo. I due studiosi, sviluppando un’intuizione di Johannes vander Vliet9, verificarono autonomamente che i codici della cosiddettaclasse I10, gruppo di recentiores pre-umanistici e umanistici, consento-no di colmare lacune e offrono lezioni genuine o buoni emendamenticongetturali a fronte di errori, guasti o alterazioni in F e φ. Dimostra-rono infatti per le metamorfosi che il modello diretto o indiretto di talicodici (= a), diversamente da φ, è anteriore a molte delle mani succes-sive che hanno agito su F con erasioni e correzioni che spesso peggio-rano il testo, nonché anteriore al precoce schiarimento di molte scrit-ture11 e alla lacerazione del fol. 160 del Laur. Plut. 68.212. Inoltre talirecentiores rendono possibile l’indispensabile verifica della scrittura di Fnei numerosi luoghi in cui il prezioso testimone, danneggiato pesante-mente dal tempo, è ormai illeggibile. Questo comportava una nettarivalutazione di un buon numero di codici recenti; tra di essi spiccal’Ambros. N 180 sup. (A), concordemente indicato quale migliore rap-presentante della classe I, fondamentale per la constitutio textus perché
restituisce una facies testuale di F piuttosto fedele a quella originaria,superiore per certi versi anche a quella fornita da φ13.
Di tale situazione stemmatica si tiene coerentemente conto solonelle edizioni del ‘romanzo’ curate da Robertson e Giarratano; non cosìin quelle, anche recenti, del De magia. Gioverà forse ricordare che lacollazione completa dell’Apologia sull’Ambrosiano non è mai stata pub-blicata: vi attesero Giarratano, che non editò l’orazione e diede quindiconto solo del lavoro svolto sulle metamorfosi, e Harold E. Butler, cherelegò A tra i deteriores, registrandone solo di rado le lezioni in appara-to e sovente anteponendogli codici più corrotti14. La più recente colla-zione (Giuseppina Magnaldi), mirando in modo precipuo a verificare irapporti tra A e F, è stata edita in modo selettivo15. Sull’opportunità di
168
13 Altro notevole rappresentante della classe I è U (Urbana, University of IllinoisLibrary, Ms. 7, MCA. 2, a. 1389), che si rivela talora ancor più prossimo a F rispetto ad A,a quanto evidenziò nella sua dissertazione dottorale C. E. Finch, The Urbana manuscriptof Apuleius, diss. University of Illinois 1936. Lo segnala Maaike zimmerman, che ringra-zio per avermi consentito in anteprima la lettura del suo contributo, edito in questo stessonumero di «S&T»: Age and merit: the importance of recentiores and incunabula for the textof Apuleius’ Metamorphoses, 131-163: 143 e 153-162, con esemplificazione.
14 Butler, per l’edizione oxoniense che curò insieme a A. S. owen, collazionò perprimo la maggior parte dei recentiores allora conosciuti (tra cui A), ma dopo averne esclu-so l’autonomia da F, assunse per vero l’assetto stemmatico di Keil, dando così per certo chetutti i recenziori offrissero un’immagine di F successiva a quella restituita da φ (Apulei Apo-logia sive Pro se de magia liber, oxford 1914 [= Hildesheim 1967], XXIX-XLIV). Il suo appa-rato ha comunque il merito di render conto delle varianti di numerosi manoscritti. L’edi-zione è inoltre corredata di un ricco e puntuale commento. Alle medesime convinzionistemmatiche è improntata l’edizione, con traduzione francese, di P. Vallette, che si fondasui dati di Butler, ma fa un uso ancor più parco di tutti i codici diversi da F e φ, omolo-gandoli troppo spesso sotto la sigla v = vulgata (Apulée. Apologie, Paris 1924 [19602], XXXI-XXXVIII). In precedenza R. Helm, per l’edizione teubneriana, Apulei Platonici madaurensisopera quae supersunt, II.1. Pro se De magia liber (Apologia), Lipsiae 1905 [19122; 19592 cumAddendis], aveva costituito il testo esclusivamente su F e φ, senza attribuire valore a tutti glialtri codici, che accomuna alle prime edizioni a stampa sotto il siglum v. Espone i criterieditoriali nella Praefatio anteposta all’edizione dei Florida (cit. n. 6), XXIX-XXXII. TuttaviaHelm procedette a una collazione dei due Laurenziani sistematica ed estremamente accu-rata, riferendone in apparato con dovizia di dettagli, al punto che essa resta a tutt’oggiimprescindibile. Infine la recente edizione di V. Hunink, Apuleius of madauros. Pro se Demagia liber (Apologia), Amsterdam 1997, essendo volta in specie a un commento letterario(a integrazione di quello linguistico di Butler – owen), non si fonda su nuove collazioni esi attiene al testo stabilito da Helm, salvo qualche modifica in senso più conservativo, colritorno a lezioni tràdite da F (così l’autore nell’Introduction, 28-32).
15 G. Magnaldi – G. F. Gianotti, Codici ed edizioni, in G. Magnaldi – G. F. Gianot-ti [a cura di], Apuleio: storia del testo e interpretazioni, Alessandria 20042 [20001], 9-25: pas-sim, e G. Magnaldi, Apologia: per una nuova collazione del Laur. 68.2 e dell’Ambros. N 180Sup., in Magnaldi – Gianotti [a cura di], Apuleio cit., 27-36: 34-36, pur confermando ladipendenza di A da F, ribadiscono l’importanza della I classe di codici e la loro centralità
FRANCESCA PICCIoNI
una nuova collazione completa di A ha insistito in tempi recenti LucaGraverini16, poiché il testo critico disponibile dell’orazione è a tutt’og-gi inferiore a quello delle metamorfosi17.
A rendere ancor più articolato il quadro, è stata da tempo affaccia-ta l’ipotesi che possa esistere un secondo ramo della tradizione indi-pendente da F, rappresentato da A e dagli altri manoscritti della classeI, nonché dal cod. Assis. 706 (C). Lo suppose per primo ConcettoMarchesi, in relazione al cod. L1 (Firenze, Biblioteca Medicea Lauren-ziana, Plut. 54.32), vergato dal Boccaccio, codice che egli credette(erroneamente) affatto indipendente da F18. A sua volta Luigi Pepeespresse la medesima convinzione a proposito dei fogli trovati ad Assi-si19. La tesi dell’autonomia di questo ramo ha trovato convinti asserto-ri anche in tempi recenti, a cominciare da oronzo Pecere20, il quale conargomentazioni codicologiche e paleografiche conclude che «a Monte-cassino, nel secolo XI, l’esemplare in cui erano sopravvissute le treopere di Apuleio, prima di andare perduto, fu utilizzato come modello
169UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
ai fini della constitutio, nonché la necessità di sottrarli al ruolo di deteriores cui sono confi-nati. Il ruolo fondamentale dei recentiores (e degli incunabula) è sottolineato a più riprese dazimmerman, Age and merit (cit. n. 13), passim, in specie 152-153, ove nell’annunciare lasua imminente edizione delle metamorphoses nella serie Oxford Classical Texts, la studiosaevidenzia che nessun nuovo testo critico del ‘romanzo’ può essere approntato prescindendodalla collazione dei principali manoscritti della classe I e delle prime edizioni a stampa.
16 L. Graverini, Note di aggiornamento, in o. Pecere – A. Stramaglia, Studi apuleiani,Cassino 2003, 179-202: 183-185.
17 Così già Marshall, Apuleius (cit. n. 3), 16.18 C. Marchesi, Per il testo del De magia di Apuleio, «SIFC», 19 (1912), 293-304: 297-
298, rist. in C. Marchesi, Scritti minori di filologia e di letteratura, Firenze 1978, 1075-1084.19 Pepe, Un nuovo codice (cit. n. 6).20 o. Pecere, Qualche riflessione sulla tradizione di Apuleio a montecassino, in G.
Cavallo [a cura di], Le strade del testo, Bari 1987, 97-124, rist. in Pecere – Stramaglia, Studi(cit. n. 16), 37-60. Le sue conclusioni sono accolte senza riserve da C. Bevegni, recensionea Cavallo [a cura di], Le strade cit., «Maia», 42 (1990), 184-186: 185, e da M. D. Reeve,Conclusion, in o. Pecere – M. D. Reeve [ed. by], Formative Stages of Classical Traditions:Latin Texts from Antiquity to the Renaissance. Proceedings of a Conference held at Erice, 16-22 october 1993, as the 6th Course of International School for the Study of WrittenRecords, Spoleto 1995, 497-511: 506; con prudenza da M. Petoletti, montecassino e gli uma-nisti. III. I Florida di Apuleio in Benzo d’Alessandria, in G. Avarucci – G. Borri – R. M. Bor-racini Verducci [a cura di], Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nelbasso medioevo (secoli XIII-XV). Atti del convegno di studio (Fermo, 17-19 settembre 1997),Spoleto 1999, 224-238: 227-229 e 238 (limitatamente a C, mentre A si considera disceso daF); implicitamente da M. Ferrari, montecassino e gli umanisti. I. Codici e postille, in Avarucci– Borri – Borracini Verducci [a cura di], Libro, scrittura cit., 183-205: 192-193, che defini-sce il frammento assisiate «il più antico» dei tre codici in beneventana custoditi a Montecas-sino, «del sec. XI in.», mentre F sarebbe «databile più avanti nel sec. XI, all’età di Desiderio».
di più copie: C, F e, forse, l’antenato della classe I». Questi i principa-li argomenti:
a. l’ipotesi (formulata da Robertson e Giarratano) che tutte lebuone lezioni tramandate solo dalla classe I trovassero posto in anticonei margini o nell’interlinea di F in alcuni casi non trova conforto nel-l’esame del codice, neanche con l’ausilio della lampada a raggi ultra-violetti;
b. in alcuni luoghi in cui F non presenterebbe difficoltà di lettura,il copista di C non ha trascritto una parola, o parte di essa, in seguitoaggiunta o completata da una seconda mano21;
c. in A si succedono senza soluzione di continuità metamorfosi eFlorida, che F distingue nettamente nell’impaginazione con unvacuum22 di sei righe; inoltre nell’Ambrosiano i quattro libri dei Flori-da23, correttamente indicati negli explicit di F, compaiono come XI, XII,XIII e XIV libro delle metamorfosi. Questo comportamento mal si atta-glierebbe all’uso di F quale antigrafo da parte di a, il deperditus padredell’Ambrosiano. Si dovrebbe ipotizzare che si tratti di un copista tantodistratto e inetto da ignorare i precisi segnali e le indicazioni di F24.
Bisogna tuttavia rilevare con una parte della critica che i copisti diA, come molti coevi, non lasciano mai lacuna «nemmeno dove le lineedi F tralasciate si avvicinano alla decina»25, come si riscontra in corri-
FRANCESCA PICCIoNI170
21 Mi sono occupata diffusamente di questo aspetto nel De magia di Apuleio (cit. n.1), 370-371. In estrema sintesi, i casi addotti a sostegno di questa affermazione vengonomeno, perché si rivelano in realtà, in base all’analisi effettuata direttamente sull’Assisiate, oscritture di prima mano (diserere, fol. 1v, l. 26) o passi di difficile interpretazione in F, pervia delle successive emendazioni che ne inficiano la chiarezza e potevano quindi creareimbarazzo a un copista di non alta levatura come quello di C (dicanto, fol. 1v, l. 20).
22 Espediente abitualmente adottato dagli scribi per segnalare le lacune. Nell’anti-grafo di F la lacuna coinvolgeva senz’altro l’incipit dei Florida, è sub iudice se riguardasseanche la conclusione del ‘romanzo’.
23 Si tratta di 23 excerpta di varia estensione, da pochi righi a diversi folia, di orazio-ni tenute dall’autore a Cartagine, che la tradizione manoscritta presenta divisi in quattrolibri, evidente retaggio di una fase di maggior completezza dell’opera. Secondo o. Pecere,Esemplari con subscriptiones e tradizione dei testi latini. L’Apuleio Laur. 68, 2, in C. Questa– R. Raffaelli [a cura di], Il libro e il testo. Atti del Convegno internazionale (Urbino, 20-23 settembre 1982), Urbino 1984, 111-137, rist. in Pecere – Stramaglia, Studi (cit. n. 16),5-35: 6-7 e 31-32, la costituzione di questa antologia sarebbe ascrivibile allo stesso C. Cris-pus Sallustius, emendator nel 395 a Roma e nel 397 a Costantinopoli di De magia e meta-morphoses, come attestano le undici subscriptiones superstiti. Su Sallustio e le subscriptionessi veda, in questo volume, zimmerman, Age and merit (cit. n. 13), 132-133.
24 Pecere, Qualche riflessione (cit. n. 20), 56. 25 Magnaldi, Apologia (cit. n. 15), 31-33; tale horror vacui può essere addebitato alle più
svariate ragioni: penuria di pergamena, volontà di conferire un’apparente integrità al lavoro,
spondenza dei numerosi passi greci omessi. A maggior ragione si puòsupporre che si siano attenuti al medesimo comportamento «di fronteall’apparente nonsenso di sei linee prive di scrittura»26. Ad ogni modoil problema di un’eventuale recensio collaterale è meritevole di moltaattenzione27. Data la complessità della questione si rendeva più che maiopportuno un attento esame del codice, che ho condotto in una primafase su microfilm e in un secondo momento in loco, con autopsia28. Hoinoltre confrontato sistematicamente tutte le varianti significative di Acon le riproduzioni microfilmate di F e φ.
2. RICoSTRUzIoNE SToRICA
Il codice appartiene al fondo più antico della Biblioteca Ambro-siana, ove è attestato fin dal 1603, anno di fondazione ad opera delCard. Federico Borromeo29.
171UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
tentativo di mascherare l’ignoranza del greco. Pochissimi effettivamente gli spazi vuoti lascia-ti in A nelle carte dell’Apologia; oltre a quelli indicati in Magnaldi, Apologia cit. (3v = Apol. 10,1 in corrispondenza della H maiuscola di Habes e 32v = Apol. 92, 9 in luogo di ut scaeui)segnalo in 11v (= 32, 2) un vacuum davanti a ipse, invece dell’atteso et, e in 23v (= 66, 1) l’am-pio spazio destinato alla maiuscola di Nunc, nel passaggio dal primo al secondo libro.
26 Magnaldi, Apologia (cit. n. 15), 32, cui rinvio per i dettagli. Ivi si sottolinea chequesto comportamento non sembra risalire già ad a, il quale doveva contenere i passi greci,come si evince dall’editio princeps di Giovanni Andrea Bussi (1469). Lo scriba di a avràverisimilmente conservato tra metamorfosi e Florida lo spazio bianco, misconosciuto nellasua funzione dal copista di A e anche per questo facilmente omesso; questi poi, non ren-dendosi conto del passaggio a una nuova opera, avrebbe sistematicamente ‘corretto’ gliexplicit dei Florida. Analoga sfasatura nella numerazione dei libri, con scarto di una cifranelle subscriptiones, si registra in un ramo della paradosi di Marziale, ove è ben spiegabileipotizzando una suddivisione in pentadi (nella fase di passaggio dal rotolo al codice) cheanteponesse ai restanti il Liber de spectaculis: cfr. P. Mastandrea, Per la storia del testo dimarziale nel quarto secolo. Un prologo agli Epigrammi attribuibile ad Avieno, «Maia», 49(1997), 265-296: 283-290.
27 Dello stesso avviso è zimmerman, Age and merit (cit. n. 13), contributo alquale rimando per un dettagliato quadro degli orientamenti della critica dall’ ’800 a oggiriguardo a tale spinoso problema. La studiosa, pur considerando a, antenato della clas-se I, «a very early copy of F» (150; cfr. 150-152), non esclude del tutto e anzi vagliaattentamente l’ipotesi che potesse invece trattarsi di un codice gemello e contempora-neo del Laur. Plut. 68.2. Ritiene infatti di per se stessa plausibile l’idea di Pecere che nelperiodo ‘aureo’ dello scriptorium cassinese siano state realizzate diverse copie a partire dalmedesimo antigrafo di F (146).
28 Ho proceduto a collazionare anche i Florida (foll. 119v-131v) sul codice Ambros.N 180 sup. (in microfilm); i dati rilevati saranno presentati in altra sede.
29 Nel 1603 arrivò in Ambrosiana, tra altri numerosi manoscritti, l’attuale C 90 inf.,di provenienza cassinese, che ha salvato i Dialogi di Seneca. Come l’Apuleio narrativo, così
Di provenienza ignota, si trova tra i codici che Antonio olgiati,primo prefetto dell’Ambrosiana, acquistò forse da antiquari della zona(probabilmente Cremona), per conto del Cardinale30. Qualche detta-glio aggiunge la suggestiva ricostruzione fornita da Giuseppe Billano-vich31. Nel 1331 si trasferì da Firenze a Napoli Niccolò Acciaioli, ilquale, allievo del padre di zanobi da Strada, mantenne sempre conquesti cordiali rapporti. Resosi presto conto dei tesori di Montecassi-no, con la complicità di un monaco, «decise abilmente di fornire Apu-leio». Egli avrebbe quindi procurato a zanobi una delle copie (a)redatte a partire da F, alla stregua di C e di φ, «con l’intesa che sareb-be stata distrutta dopo che se ne era ricavata una copia». Questa copiasarebbe l’attuale Ambrosiano N 180 sup., approntato quindi perzanobi e, anticipiamo, in parte dallo stesso zanobi, che assurge alruolo di vero «protagonista nella scoperta dei classici di Montecassino»32.
FRANCESCA PICCIoNI172
anche Seneca è tra i classici che nel Medioevo hanno circolato solo tramite le copie in bene-ventana allestite nell’XI sec. a Montecassino. Non a caso, dopo secoli di silenzio, i primiriecheggiamenti medievali dei Florida come dei Dialogi si riscontrano nella produzioneagiografica di Guaiferio di Salerno, monaco presso il cenobio (cfr. D. Nardo, La rinascitacassinese dei Dialogi di Seneca, in Id., modelli e messaggi: studi sull’imitazione classica, Bolo-gna 1984, 39-55; su Guaiferio ‘scopritore’ di Apuleio si veda anche zimmerman, Age andmerit [cit. n. 13], 5). La Biblioteca Ambrosiana custodisce un altro manoscritto apuleiano,A 144 sup., cartaceo, XV sec., miscellaneo (Commentarii alle commedie di Terenzio, foll.1r-156v; Apuleio metamorphoses 1, 1-2, 18, foll. 157r-172r), anch’esso acquistato nel1603. Molti ragguagli devo alla cortesia del personale della Biblioteca. Circa la costituzio-ne del più antico fondo Ambrosiano cfr. M. Petoletti, Libri di maestri, libri di scolari allaBiblioteca Ambrosiana di milano, in L. Del Corso – o. Pecere [a cura di], Libri di scuola epratiche didattiche. Dall’Antichità al Rinascimento. Atti del Convegno Internazionale distudi (Cassino, 7-10 maggio 2008), II, Cassino 2010, 537-575: 537-538.
30 Come si legge nella nota descrittiva che soleva apporre sulla carta di guardia ini-ziale: «Felicibus auspiciis Il.mi Federici Card. Borrom. | olgiatus uidit anno 1603». Unascarna descrizione del codice figura nell’Inventario dei manoscritti Ambrosiani stilatonell’’800 da A. Ceruti, oggi disponibile in edizione fotolitografica: cfr. A. Paredi [a cura di],Inventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, Milano 1973.
31 G. Billanovich, L’altro stil nuovo. Da Dante teologo a Petrarca filologo, «Studi petrar-cheschi», n.s., 11 (1999), 1-98: 22-23.
32 Sulla preziosa attività culturale di zanobi a Montecassino e sul suo ruolo nella tra-slazione di numerosi codici del cenobio (Tacito e Apuleio come Varrone e Cicerone) a Firen-ze, cfr. G. Billanovich, I primi umanisti e le tradizioni dei classici latini. Prolusione al corso diLetteratura Italiana detta il 2 Febbraio 1951, Friburgo (Svizzera) 1953, 29-33; Id., L’altro stilnuovo (cit. n. 31), 36-38; più diffusamente, G. Billanovich, Zanobi da Strada tra i tesori dimontecassino, «RAL», s. IX, 7 (1996), 653-663, ripreso e approfondito in Id., Zanobi da Stra-da esploratore di biblioteche e rinnovatore di studi. I. Zanobi da Strada e i tesori di montecassi-no, «Studi petrarcheschi», n.s., 11 (1999), 183-199. A zanobi e non a Boccaccio va, secon-do lo studioso, rivendicato tale ruolo: egli soltanto ebbe il tempo e l’autorità per maneggia-re liberamente i codici e al momento opportuno sottrarli. Infatti, in qualità di vicario del
Dopo la sua morte (1361), il libro passò di mano in mano a lettoritransalpini33.
Del tutto differente sarebbe la situazione secondo Mirella Ferrari eMarco Petoletti, che antedatano per ragioni codicologiche34 il mano-scritto alla seconda metà del XIII sec. e gli attribuiscono probabile ori-gine italo-meridionale, il che non si attaglia al terminus post quem del1331 e alla trascrizione ad opera di zanobi prospettati da Billanovich35.La datazione di A al XIII sec. è accolta da Maaike zimmerman. La stu-diosa suggerisce altresì una terza possibilità, cioè che a (o una sua copia)sia giunto assai per tempo ad Avignone (forse già nel XII sec., secondoRobert Carver) e che il nostro Ambrosiano fosse già stato tratto da taleantigrafo quando zanobi, nominato segretario papale, si trasferì oltral-pe; ad Avignone egli entrò in possesso del codice e (forse) lo annotò.Questo spiegherebbe le caratteristiche francesi di A36.
173UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
vescovo Angelo Acciaioli nell’abbazia di Montecassino (1355-1357), ebbe agio di studiare eannotare, per limitarci a quanto ci interessa più da vicino, tutti i migliori esemplari della tra-dizione apuleiana, da F a φ a C, e in seguito portarli con sé a Firenze. In questo trasferimen-to di codici molto si deve anche alla munificenza di Niccolò Acciaioli, che arricchì le biblio-teche fiorentine di numerosi manoscritti cassinesi (con testamento del 30 settembre 1359:cfr. G. Cavallo, La trasmissione dei testi nell’area beneventano-cassinese, in La cultura antica nel-l’Occidente latino dal VII all’XI secolo, Spoleto 1975, 357-414: 386 n. 144). Sulla centralitàche va in ogni caso riconosciuta a Giovanni Boccaccio nella riscoperta di Apuleio, cfr. G. F.Gianotti, Da montecassino a Firenze: la riscoperta di Apuleio, in C. Allasia [a cura di], Il Deca-meron nella letteratura europea. Atti del Convegno organizzato dall’Accademia delle Scienzedi Torino e dal Dipartimento di Scienze Letterarie e Filologiche dell’Università di Torino(Torino, 17-18 novembre 2005), Roma 2006, 9-46, e zimmerman, Age and merit (cit. n.13), 136-137; circa la continuità della fortuna di Apuleio quale auctor in campo linguistico-stilistico, da età tardoantica fino a età umanistica, si veda invece A. Stramaglia, Apuleio comeauctor: premesse tardoantiche di un uso umanistico, «StudUmanistPiceni», 16 (1996), 137-161, rist. in Pecere – Stramaglia, Studi (cit. n. 16), 119-152, nonché la stessa zimmerman,Age and merit cit., 131-138, con relativa bibliografia.
33 Billanovich, L’altro stil nuovo (cit. n. 31), 24 n. 68.34 Si veda l’uso ‘insulare’, che si osserva in alcuni fascicoli (3-4), di apporre i fori per
la rigatura nel margine interno: cfr. Ferrari, Codici e postille (cit. n. 20), 193-194; Petolet-ti, I Florida di Apuleio (cit. n. 20), 227.
35 Bisogna rilevare che la datazione proposta dai due studiosi non tiene conto, perragioni cronologiche, della ricostruzione avanzata da Billanovich; essa è invece registratacome possibilità in uno studio successivo dallo stesso M. Petoletti, Il Chronicon di Benzod’Alessandria e i classici latini, Milano, 2000, 51-52. Tuttavia egli propone, nella stessa sede,51 n. 43, di ricondurre il codice a un personaggio della corte angioina, tale Nicollaus deAlifia († 1367), il cui nome, eraso e di difficile lettura, pare citato in una nota di possessoal fol. 132v. Lo studioso inoltre mi segnala gentilmente, per verba, che documenti d’archi-vio recentemente individuati quali autografi di zanobi rendono dubbia l’attribuzione a luidi una delle mani dell’Ambrosiano.
36 Appunto la rigatura di tipo ‘insulare’ (supra, n. 34) e lo stile di uno dei copisti(infra, n. 49). Per questa ricostruzione cfr. zimmerman, Age and merit (cit. n. 13), 147-
Copia diretta di A è il cod. London, British Library, Additional2489337, vergato per conto di Sennuccio del Bene, mercante appassio-nato di lettere e amico di Petrarca e zanobi, il quale gli fornì l’antigra-fo per la sua copia, che Sennuccio studiò e copiosamente postillò38.
3. DESCRIzIoNE DEL CoDICE
Presento brevemente i dati codicologici. A è di piccolo formato(cm 24 × 16), membranaceo, con legatura in cartapesta rivestita di per-gamena39; la membrana delle carte è sottile e giallastra. Nascendo comecopia d’uso, il manufatto non è di qualità, come palesano la pelle malconciata (nel lato pelo sono evidentissimi i segni dei follicoli), alcunibuchi, la mancanza di rifilatura40 e dell’intervento del rubricator41. Lecarte di guardia iniziale e finale sono materiale di riuso, essendo in ori-gine parte di un registro contabile (datato ai secc. XIV-XV)42. Lo statodi conservazione è buono; qualche macchia o qualche schiarimentodella scrittura non ne pregiudicano mai la leggibilità.
Il codice contiene Apuleio De magia (1r-36r), metamorphoses (36r-119v) e Florida (119v-131v), Marziano Capella De nuptiis Philologiaeet mercuri 3, 260-261 (132v: si tratta di un breve excerptum di 14 righiin una scrittura meno posata, più corsiva e legata, evidentemente piùtarda)43. Nello stesso foglio compaiono, quasi del tutto erase, una notadi possesso e una di acquisto con prezzo.
La mise en page è ordinata, con rapporto costante tra specchio di
FRANCESCA PICCIoNI174
148; alla n. 64 si rileva inoltre, con relativa bibliografia, che anche un altro manoscrittodella classe I, S (Saint omer, Bibliothèque Publique, 653, sec. XV) si può ricondurre a una‘French phase’ di a.
37 Robertson, The manuscripts (cit. n. 7), 85.38 Il codice londinese mostra la medesima sfasatura di A nella numerazione dei libri,
che rende i Florida un’appendice del ‘romanzo’, errore però prontamente emendato da Sen-nuccio: cfr. Billanovich, L’altro stil nuovo (cit. n. 31), 25. Viceversa proprio zanobi avreb-be copiato gli explicit erronei nell’Ambrosiano.
39 La datazione è fissata al XVII sec., dopo l’arrivo in Ambrosiana, secondo Ferrari,Codici e postille (cit. n. 20), 194 n. 38.
40 Sono chiaramente visibili i forellini guida per la rigatura ora a secco ora a piom-bo, oltre alla rigatura stessa orizzontale e verticale, specie nelle carte iniziali.
41 Manca sistematicamente l’iniziale della parola incipitaria dei vari libri.42 Ferrari, Codici e postille (cit. n. 20), 194 n. 38.43 Anch’essa databile ai secc. XIV-XV secondo Ferrari, Codici e postille cit., 194 n. 38.
scrittura e margini, nonostante il cambio di impaginazione in 9r: sipassa da due colonne su 32 linee a una su 29.
La scrittura è una gotica, posata e regolare (specie da 30r), dimodulo piccolo. È degno di nota il trattamento dei passi greci. I copi-sti che, come vedremo, si sono avvicendati sulle pagine del manoscrit-to apuleiano, ignoravano evidentemente il greco, a giudicare dai tenta-tivi poco felici di riprodurlo (fino a apol. 27, 3) con un ductus scritto-rio incerto spesso fino al limite della decifrabilità44. A partire da apol.31, 5 il librarius ha desistito dall’inutile fatica, omettendo il greco,senza peritarsi di segnalare la lacuna. Comportamento analogo osserve-rà chi gli succede nella copia.
Va infine rilevato un ricorso abbastanza regolare alla distinctio45:sono largamente presenti punti fermi, punti interrogativi46, maiusco-le47. Sono inoltre frequenti segni d’attenzione quali maniculae, fiori sti-lizzati, linee variamente ondulate.
4. I CoPISTI: INDIVIDUAzIoNE DI UNA TERzA MANo
Per quanto attiene ai problemi strettamente paleografici, si è tenta-to di fare luce sulla stratificazione di mani che hanno successivamenteoperato nel codice Ambrosiano copiando, correggendo e postillando.Un primo risultato è consistito nell’individuazione di un terzo copista.Di norma si segnala un unico cambio a 30r, l. 15 (oculos obseruas); acopiare di qui in poi fino ai Florida sarebbe, come detto, zanobi stes-so48. Da questo punto la scrittura si caratterizza per modulo lievementemaggiore, più regolare e tondeggiante; essa appare più ‘piena’ poichénon alterna tratti sottili e spessi, ma predilige questi ultimi; aggiungeinoltre tratti meramente ornamentali ad alcune lettere quali p e q.
175UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
44 Lo si constaterà con evidenza infra, 192-209. Ho tentato, con notevole difficoltà,di riprodurre quanto leggibile in A.
45 La punteggiatura in A è singolarmente vicina a quella di F: «l’impressione dellacopia è fortissima», secondo Magnaldi, Apologia (cit. n. 15), 30.
46 Tre punti disposti a triangolo con piccolo apice.47 Normalizzo, per A come per gli altri codici trattati, l’uso della maiuscola nei nomi
propri.48 Billanovich, L’altro stil nuovo (cit. n. 31), 24: «Annuncio risolutamente: il primo-
genito Ambrosiano fu costruito, con l’aiuto di un copista in 1r-29v, e poi, da 30r copian-do egli stesso, e quindi intensamente postillando, da zanobi da Strada». Sulla presenza didue copisti cfr. anche Butler, Apulei Apologia (cit. n. 14), XXXVII; Magnaldi – Gianotti,Codici (cit. n. 15), 31.
Ma in base all’esame delle singole lettere e dei compendi ritengoinvece che si possano individuare tre mani diverse49: da 1r a 16r, l. 1;da 16r, l. 2 a 30r, l. 14; da 30r, l. 15 a 131v50. Da cuius odore (16r, l. 2)si cambia mano, come si deduce dai seguenti elementi:
a. l’aspetto generale è più spigoloso, angolato, con tratteggio piùfluido (evidente, come si vedrà, nella x e nelle maiuscole), il tratto è piùsottile;
b. la s finale fino a 15v è aperta (cfr. 15v, l. 29 incensus gagates lapis:fig. 1a), con curva superiore appena accennata; da 16r ha forma chiu-sa (cfr. 16r, l. 2 cuius; uenaliciis: fig. 1b, c), con curva superiore e infe-riore che tocca il tratto mediano orizzontale, quasi a formare un 8;
c. la x dal primo copista è tracciata in tre tratti, con l’inferiore sini-stro appena visibile (cfr. 15v, l. 5 exhiberi; l. 10 maxime: fig. 1d, e); da16r lo stesso tratto si sviluppa in elegante linea curva con svolazzo fina-le e la linea ascendente verso destra si richiude in occhiello (cfr. 16r, l.3 experiantur; l. 29 expalluisti: fig. 1f, g);
d. cambia il compendio per l’uscita -tur: una lineetta che curva inalto a destra fino a 15v (cfr. 15v, ll. 26-27 attribuatur; ll. 27-28 patare-tur – per pateretur –: fig. 1h, i); da 16r una sorta di 2 (cfr. 16r, l. 3 expe-riantur; l. 19 moraretur: fig. 1f, l); da 30r una semplice linea ondulata(cfr. 35v, l. 27 ostenditur);
e. il segno tachigrafico per et fino a 15v è piccolo ed esteso in ver-ticale col tratto orizzontale tendente a ripiegarsi quasi in occhiello (cfr.15v, l. 12 et morbido; l. 16 et tenerem: fig. 1m, n); da 16r è di modulo
FRANCESCA PICCIoNI176
49 Una conferma decisiva alle mie osservazioni è venuta dal succitato studio della Fer-rari, a me ignoto al momento della visita in Ambrosiana. Ferrari, Codici e postille (cit. n.20), 194 e n. 38, senza fornire particolari, parla di tre copisti, al secondo dei quali è pro-pensa ad attribuire origine francese per l’aspetto corrente della scrittura.
50 I passaggi da una mano all’altra non coincidono con unità codicologiche (fascico-li) né con snodi concettuali significativi dell’opera, il che rimanderebbe a un ambiente nondi scribi di professione ma di copisti-filologi, ovvero a un ‘circolo di scrittura’, su cui vd.D. Bianconi, Libri e mani. Sulla formazione di alcune miscellanee dell’età dei Paleologi,«S&T», 2 (2004), 311-363: in specie 335. Tuttavia, dato il diseguale profilo dei tre libra-rii e la scarsa competenza linguistica palesata dal primo, è impossibile per l’Ambrosianopensare al lavoro di un sodalizio erudito. D’altra parte è nota l’attività di zanobi nella scuo-la di grammatica ereditata, ancora ventenne, dal padre, nel 1332 a Firenze; proporrei quin-di, con le cautele del caso, che per A si possa piuttosto pensare all’opera di maestro e allie-vi. Un parallelo può essere offerto da una particolare categoria di testi papiracei: F. Pordo-mingo, Antologías escolares de época helenistíca, in Del Corso – Pecere [a cura di], Libri discuola (cit. n. 29), I, 37-69, individua tra i criteri per distinguere le antologie da ricondur-re ad ambito scolastico l’alternanza di parti corrette (trascritte da maestri) a parti vistosa-mente inficiate da errori (trascritte da allievi).
più largo, col tratto orizzontale più lungo, decisamente aperto e spez-zato in due linee (cfr. 17r, l. 6 et illi; l. 28 et cur: fig. 1o, p);
f. è diverso il ductus delle maiuscole vergate dai singoli copisti (sivedano in particolare N, I e V ); peraltro esse non vengono rubricate dalsecondo librarius51.
5. I mARGINALIA
Ho cercato altresì, per quanto possibile, di distinguere le numero-se mani di postillatori e correttori intervenuti sia sul testo (in interlineaoppure in linea con rasure e riscritture), sia nei margini52. Questi ospi-tano nelle pagine iniziali annotazioni fitte il cui numero va progressi-vamente scemando, come di consueto. Si tratta di notabilia, lemmi ocorrezioni con segni di rimando che le collegano con l’errore53.
Ho rilevato l’attività di almeno tre mani distinte, a giudicare dainchiostro, modulo e ductus delle lettere e dalla maggiore o minore cor-sività. La prima mano si caratterizza per una scrittura libera nel tratto,fluida; il modulo è maggiore rispetto a quello delle altre scritture; l’in-chiostro è tendente al giallo. Ad essa vanno ascritte, oltre a numerosinotabilia54, correzioni in margine e in linea55, molte delle quali nonsembrano congetturali, ma desunte dallo stesso antigrafo56. Ritengo
177UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
51 Seguendo una suggestione di Gian Franco Gianotti, ho verificato se la mano che havergato la carte da 16r a 30r non appartenesse a Boccaccio. Non può trattarsi del Certalde-se. Ho confrontato le carte in questione con alcuni specimina del cod. Milano, BibliotecaAmbrosiana, C 67 sup., ovvero il Marziale recentemente riconosciuto quale autografo diBoccaccio: cfr. M. Petoletti, Il marziale autografo di Giovanni Boccaccio, «IMU», 46 (2005),35-55, e Id., Il marziale di Giovanni Boccaccio, in A. M. Morelli [a cura di], Epigramma lon-gum. Da marziale alla tarda antichità. Atti del Convegno internazionale (Cassino, 29-31maggio 2006), II, Cassino 2008, 727-742. L’aspetto generale è affatto diverso e l’esame dellesingole lettere lo conferma: la x (e.g. nox, 10v), il segno tachigrafico per et (115v), il com-pendio per -rum finale (deorum, 115v), le maiuscole (Vaticana, 10v). Del tutto assenti sonoinoltre i segni che Boccaccio distribuisce nei suoi codici: il tipico ce (corrige) che introduce inmargine le correzioni, le graffe a volute floreali, i disegni volti ad illustrare il testo.
52 Ferrari, Codici e postille (cit. n. 20), 194 n. 38, parla di «postille di più mani goti-che, nessuna che mi riesca di identificare».
53 Cfr. infra, 181.54 Ad es. annota a mg. di 13r (38, 3) i lemmi uiuiparos, ouiparos, che Apuleio riven-
dica orgogliosamente nel testo quali calchi dal greco di suo conio.55 Si confronti il modo caratteristico di tracciare certe lettere: e.g. la t con tratto oriz-
zontale molto prolungato in fringulciat (mg. 12r), così come in t umide di 6, 3 (2v, col. 2,l. 21) o in ut di 10, 6 (4r, col. 1, l. 24).
56 Aggiunge ad es. intere espressioni, come carmina dono in 3v (9, 14) o an apud
che questa mano correttrice/postillatrice possa appartenere al secondocopista perché: a) viene a mancare da 30r, in coincidenza col passaggiodal secondo al terzo copista; b) il tratteggio di alcune lettere (come la xe la t) o di compendi (come quello per sillaba in vibrante) e segni tachi-grafici (et)57 è molto simile a quello del secondo librarius.
Il secondo postillatore si distingue per il piccolo modulo delle let-tere (inferiore a quello del testo), per il tratto sottile e per la scritturamolto posata e calligrafica, con tratti della minuscola cancelleresca ita-liana58 (le aste di d e l richiuse in occhiello a bandiera nonché piccolecode ornamentali); sono frequenti gli svolazzi (specie nelle maiuscole),l’inchiostro è grigio. Gli è ascrivibile un nutrito indice dei nomi pro-pri59. Annota inoltre nel margine superiore gli argomenti.
Queste prime due mani operano presumibilmente nel Trecento, adistanza di pochi decenni. Si distingue nettamente invece la terza mano,senz’altro recentissima. La scrittura è molto corsiva, l’asse è fortementeinclinato, sono frequenti le legature. Poiché si tratta di una scritturaormai svincolata da canoni grafici precisi, risulta più difficile datarla; inogni caso non è anteriore al Seicento60. Questa terza mano segnala le
FRANCESCA PICCIoNI178
omnis homines semper disserenti in 5v (15, 10); corregge un incomprensibile in(de) con iti-dem in 4r (10, 5).
57 Mi limito all’esempio del marginale praecipiti euo et occidua senectute di 12v (36, 2),ove la resa di et è perfettamente identica a quella, così caratteristica, del copista di 16r-30r.
58 Si veda A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma 19922 [19891], 150-155.59 Possiamo cautamente andare oltre. Accolta da Billanovich l’idea che la mano di
zanobi da Strada ha operato sui margini dell’Ambrosiano, ho tentato di individuare i mar-ginalia a lui attribuibili, grazie al confronto con scritti di sicura paternità zanobiana. Dalconfronto con le postille di F a lui ascritte pare di poter dedurre che questa mano postilla-trice sia la sua. Inoltre la tipologia stessa delle postille sembra deporre a favore della pater-nità zanobiana: gli interventi sicuramente suoi in F palesano un interesse prevalentementeerudito, limitandosi a estrapolare dal testo e riprendere in margine antroponimi o toponi-mi, esattamente come questa mano postillatrice opera in A. Sulla qualità degli interventi dizanobi in F si veda M. Baglio, montecassino e gli umanisti. II. Codici e postille, in Avarucci– Borri – Borracini Verducci [a cura di], Libro, scrittura, documento (cit. n. 20), 205-224:215, ove si legge anche un’accurata disamina delle caratteristiche della gotica di zanobi. Ladifferenza tra la scrittura testuale e la notulare che si presumono di zanobi, di cui l’ultimaè meno posata e più fluida, può non stupire se si riflette sulla destinazione di quelle scrit-ture: il testo doveva essere potenzialmente letto da chiunque, mentre le note erano desti-nate soprattutto a chi le scriveva. Lo stesso Petrarca, rigoroso nell’adottare la gotica comescrittura libraria per esigenze di chiarezza, predilige la minuscola cancelleresca per le scrit-ture private (si veda l’epistola a Boccaccio del 1366, Fam. 13, 1: la litera deve essere casti-gata et clara, seque ultro oculis ingerens).
60 Per la datazione di queste scritture mi sono valsa del parere di olivetta Schena,paleografa presso l’Università di Cagliari.
lacune in corrispondenza dei passi greci (per es. desunt citata; desuntcitationes; deest uersus) e i passaggi da un’opera all’altra (ripristina l’ex-plicit dell’Asinus aureus e la corretta numerazione dei Florida)61.
6. TIPoLoGIE DI ERRoRI E MoDALITà CoRRETTIVE
La tipologia degli errori e delle varianti grafiche è simile per tuttal’Apologia, nonostante l’avvicendamento di tre librarii. Tuttavia ilprimo copista commette errori molto più numerosi e ingenui. Cio-nondimeno è notevole il suo sforzo di fedeltà all’antigrafo, anche quan-do non lo comprende, come si evince dal trattamento dei passi greci edall’inserzione nel testo di lemmi o glosse.
Ecco ora, divisi per categoria, gli errori più caratteristici riscontra-bili nel corso dell’intera opera62:
– trasposizioni: 60, 5 uendidit fumum per fumum uendidit || 66, 3 memagum per magum me || 96, 6 plenas amoris plenas honoris per plenashonoris plenas amoris;
– omissioni di singole lettere, di particelle (come enclitiche, preposizioni,avverbi) o di più ampie pericopi, talvolta dovute a saut du même aumême: 53, 6 umquam || 57, 6 pro || 64, 5-7 non a me primo… quisnamsit ille (il copista è saltato da quisnam sit ille1 a quisnam sit ille2) || 72, 1uxoris meae || 87, 4 tam per tamque || 98, 8 loqui;
179UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
61 L’incipit dei Florida è segnalato anche da una mano gotica (Primus Floridorum),che non mi sembra però riconducibile a nessuna di quelle individuate. Rilevo inoltre la pre-senza di un’altra mano, assai poco attiva, cui sono da addebitare alcuni lemmi dei marginilaterali, veri e propri ‘titoli di paragrafi’ (de pulchritudine Pithagore, de specie Zenonis, 2r),oltre ad alcuni notabilia. Ad es. a proposito dell’abitudine del coccodrillo di farsi ripulire lefauci da un’amica auis, questa mano chiosa in 3r corcodillus elinguis est (8, 7), secondo unacredenza diffusa in antico, da Aristotele a Plinio. A livello di mera ipotesi, segnalo che essapotrebbe appartenere a Sennuccio del Bene: egli ebbe tra le mani l’Ambrosiano e alcunedelle note al De magia del codice londinese coincidono con quelle di A; inoltre si ritrovanel codice milanese il suo segno di attenzione prediletto, di cui l’Additional 24893 abbon-da, il fiorellino stilizzato, tre punti con un segmento sottostante (e.g. 17r): cfr. Billanovich,L’altro stil nuovo (cit. n. 31), 25. Del resto Sennuccio non sarebbe nuovo a simili iniziati-ve: fu committente e postillatore, oltre che dell’Apuleio londinese, del Livio Harley 2493(1326) e del Virgilio Ambrosiano A 79 inf. (1325; codice tra i più pregevoli dell’Ambro-siana, impreziosito da note di Petrarca e miniature di Simone Martini).
62 Molti di essi, come le numerose trasposizioni e la caduta di parole brevi e pococaratterizzate, quali preposizioni, congiunzioni, pronomi, sono errori di chiara origineauditiva e rimandano dunque alla pratica dell’autodettatura o dettatura. Per una dettaglia-ta classificazione degli errori auditivi cfr. F. Brambilla Ageno, Gli errori auditivi nella tra-smissione dei testi letterari, «IMU», 29 (1986), 89-105.
– aggiunte di termini sottintesi o presunti tali: 58, 9 usque ad aduentum peraduentum || 73, 2 remanerem fieremque per remanerem fierem;
– aplografie: 30, 2 si nescis per sin nescis || 78, 5 famossimas per famosissimas;– dittografie limitate a sillabe o estese a intere espressioni: 4, 12 co|comen-
di per comendi || 5, 1 stu studiis per studiis || 21, 1 aut tutor iter. A1, del.A1c || 30, 7 licicia per licia;
– scambio, spostamento od omissione di compendi o ancora scambi traparole compendiate: 9, 1 moueretur per mouerent || 9, 11 sciatur per sciant|| 10, 4 prostituit per prostituerit || 17, 8 suos per seruos A || 27, 9 inuene-re per iuuenem || 28, 4 eo per eorum || 79, 4 qui per igitur 63;
– errori per omologazione al contesto: 41, 2 in piscem per inspicere (cfr.supra piscis quam inspicere) || 42, 8 uno per eo (cfr. supra unum) || 79, 1escausabundus per excusabundus (cfr. infra causari) || 85, 6 fodiatur perfoditur (cfr. supra laniatur);
– intrusione in linea di glosse ereditate dall’antigrafo64;– errori condizionati dal milieu cristiano: 32, 5 propheta per poeta || 62, 4
tabernacula per taberna.
Le varianti grafiche più diffuse sono le seguenti:
– chiusura sistematica dei dittonghi ae/oe in e non caudata;– propensione generalizzata al betacismo;– caducità dell’aspirata: 67, 1 Erennium per Herennium || 87, 6 asce per hasce;– viceversa aggiunta di aspirata: hore per ore;– rafforzamento dell’aspirata: nichil; michi;– assordimento di sonore: set per sed;– sonorizzazione di sorde: reliquid per reliquit; capud per caput 65;– preferenza per forme assimilate: 69, 4 asseuerabat per adseuerabat || 81, 2
ammirabili per admirabili || 85, 3 affectiones per adfectiones || 85, 7 acqui-sitam per adquisitam; ma 2, 3 adsistere per assistere || 2, 5 idcirco per iccirco;
– oscillazioni nell’uso delle consonanti geminate: 31, 7 crateram per creter-ram || 100, 6 hiccine per hicine || 102, 1 reperisti per repperisti;
– sistematico rafforzamento del gruppo -mn- in -mpn-: dampno per damno;calumpnia per calumnia66;
FRANCESCA PICCIoNI180
63 L’errore di A si spiega bene paleograficamente: igitur è abbreviato g i, qui è abbre-viato qi.
64 Ne tratterò infra, 188.65 D/t sembrano potersi considerare fonicamente equivalenti in posizione finale o nei
composti: cfr. 25, 9 adque scire atque callere.66 Peraltro condiviso dal Laur. Plut. 29.2.
– sistematico rafforzamento del gruppo -gn- in -ngn-: congnouerat percognouerat; mangnus per magnus; dingnus per dignus;
– confusione i/y: phylosophyia per philosophia (passim) || 31, 2 Ytalie per Ita-lie; ma 72, 5 Sirtis per Syrtis;
– alternanze vocaliche: 80, 5 ualitudinis per ualetudinis || 82, 8 defrauden-tur per defrudentur || 99, 5 obstupuerit per obstipuerit.
Le modalità correttive sono le più consuete:
– espunzione (mediante punti sottostanti alle singole lettere o trattini sot-tostanti alle parole) e riscrittura in linea: 7, 5 nomine more || 24, 10 nonlegi non elegi || 27, 1 aīat aiāt;
– accostamento in linea della falsa lectio non espunta e della lectio emenda-ta: 11, 2 esse castum esse per castum esse || 31, 2 adanimaduertisset per ani-maduertisset || 38, 2 quod quid per quid;
– integrazioni interlineari (se di modesta entità) segnalate o meno dacuneo: 4, 8 Velia
˄ oriundum; 27, 1 irreligiosos;– integrazioni e correzioni marginali (se cospicue) con segno di rimando al
testo, segnatamente l’archetto con punto sottoscritto: 18, 4 in illis A1,in istis A2 in mg.;
– correzioni interlineari accompagnate dalla sigla ɫ = lege: 87, 8 ɫ mo muni-tum;
– uso di segni grafici per ripristinare il corretto ordo verborum: 55, 12 etiamʺ ecce; 62, 1 ʺ audisti ʺ omnia; 79, 2 ʺ tandem ʺ quanto A67.
7. IL CoNTRIBUTo DI A AL TESTo
Lavorare su A ha consentito di recuperare molte lezioni esatte afronte di errore o imperfezione grafica in F. Esse sono quasi sempreignorate negli apparati68, dove gli editori le attribuiscono esclusiva-mente a mani recenziori di F oppure alle diverse mani di φ, o ancora arecentiores o alla vulgata (v), o infine le considerano congetture tarde.Ecco l’elenco esaustivo69:
181UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
67 Stesso segno con analoga funzione si trova nel Laur. Plut. 68.2 (e.g. 96, 2 ʺ ergote ʺ); tale signum inversionis è attestato già in codici dell’VIII sec.: cfr. M. Ferrari, Il CodexMuratorianus e il suo ultimo inedito, «IMU», 32 (1989), 1-51: 24.
68 Salvo diversa indicazione: un asterisco (*) accompagna le non numerose voci di Agià segnalate da Butler, Apulei Apologia (cit. n. 14) e da Magnaldi, Apologia (cit. n. 15).
69 Riporto di seguito gli altri codici cui faccio qua e là riferimento nel corso del con-tributo, desumendone le lezioni dagli apparati moderni: V4 = Città del Vaticano, Bibliote-
3, 1 aequitate A Fc φ: aequitatem F1 || 3, 9 uituperationes A φ1c: uiturationes F1 φ1,uituperatione F2 || 6, 1 dentifricio A (enti in ras.) F2: dentifrigio F1 φ || 9, 11 Dio-genis A*: Dyogenis F φ || 10, 5 puerum A φ: puerium F2 (litt. redint.) || 10, 7 nonerant A φ: inerant F2 (litt. redint.) || 11, 2 necesse A φ: nekesse F || 12, 4 commen-det A: comendet F φ || 14, 2 praemio A φ: praemia F || 15, 6 commendabilem A φ:comendabilem F || 16, 4 caua A Fc φ: caiua F1 || 16, 11 cuiusquam A φ: cuiusiquamF || 17, 7 calones A φ1c: calonos F1, colonos F2, caiones φ1 || 18, 8 hodiernum A φ:odiernum F || 19, 4 oneri Ac φc: honeri A1 F φ1 || 19, 5 gubernacula A Fc φ: gur-bernacula F1 || 19, 7 simulatam A* L1 T: simulata F φ || 20, 8 sis A1* φ1c V1 V5 δ:scis F φ1, es A1c, fis V3 M1, si es V2 || 21, 4 namque A φ: nanque F || 22, 3 frugife-ras A φ: frugifera F || 22, 7 uerum tamen A* φ: ueruntamen F || 22, 10 ascitus A*φ1c: asscitus F φ1 || 24, 2 Cyro A: Ciro F φ || 24, 10 eo A φ: ea F || 28, 9 atque AF2 φ: utque F1 || 30, 13 ungues A* φ: unges F || 31, 2 subsiciuam A φ: subsicinamF2 (litt. redint.) || 31, 2 quibusdam A φ: quibus dum F2 (litt. redint.) || 31, 3 emis-se A φ: emissae F2 (litt. redint.) || 33, 2 nominauerunt A2 (in ras.) L3 M1: nomi-nauerant F φ || 36, 3 Theophrastum A v: Theoprastum F φ || 36, 7 quam A* φ1 M1V1 L3: quem F φ1c || 38, 7 Aegyptio A: Aegiptio F φ || 39, 3 cerebrum A* φ2: cele-brum F φ1 || 40, 6 locorum A* M1: locarum F φ || 41, 3 iocinera A2 ed. pr.: iocine-na A1 F φ || 41, 5 nunc A* M1 V5: num F φ || 42, 6 philosophum A (phy-) φ: phi-lophum F || 42, 6 CLX A* φ: OLX F || 42, 7 locorum A* φ (o2 in ras.): locarum F|| 42, 7 defossa A* φ2: defosso F φ1 || 44, 2 exhiberi A φ2: exiberi F φ1 || 44, 5 nume-ro A φ: non F || 44, 9 uellem A* φ2: uelle F φ1 || 45, 4 physicos A: phisicos F φ || 45,5 caducos A* φc: caduco se F φ1 || 45, 7 religionem A* F2 φ U L1: regionem F1 || 46,1 murmure A* F2 φ U L1: marmure F1 || 46, 6 exhibui A φ2: exibui F φ1 || 49, 3his A: hiis F φ || 53, 8 solus A* F2 φ2: solas F1 φ1 || 53, 9 enim2 A* φ: eui F || 54, 6omnes A: omnis F, om s φ || 55, 10 publice A φ: plublice F || 56, 2 Pythagorae scitisA φ2: Pythagora escitis F φ1 || 58, 1 horam A φ2: horum F φ1 || 58, 5 interemisset Aφ2: intere misset (uacuum ante misset) F, interemisse φ1 || 58, 9 tam A φ: tan F || 59,6 beluam A φ1c U: baluam F φ1 || 60, 2 occulta res A φ U: occultares F || 62, 5 ius-sisse A φ: iusisse F || 63, 1 larualem A* φ2 U L1 M1: laruilem F φ1 || 63, 5 scelestus
FRANCESCA PICCIoNI182
ca Apostolica Vaticana, ottob. 2091 (saec. XIV in.); V1 = Vat. lat. 2193 (saec. XIV, ante1348); L1 = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 54.32 (saec. XIV); V3 = Vat.ottob. 2047 (saec. XIV2); U = Urbana, University of Illinois Library, Ms. 7, MCA.2 (a.1389); V2 = Vat. lat. 3384 (saec. XIV, ante 1391); M1 = Venezia, Biblioteca Nazionale Mar-ciana, L. z. 469 (saec. XIV ex.); L2 = Laur. Plut. 54.12 (a. 1425); L3 = Laur. Plut. 54.13(saec. XV); D = San Daniele del Friuli, Biblioteca Comunale Guarnieriana, 91 (saec. XV);T = Toulouse, Bibliothèque municipale, 827 (a. 1468); δ = Leiden, Universiteitsbiblio-theek, oudendorp. 34 (uel Doruillianus, saec. XV, post 1470); V5 = Vat. Urb. lat. 199(saec. XV, post 1474). Non riporto i dati di C, che renderò integralmente noti in un pros-simo lavoro. Il 2 in apice indica genericamente tutte le mani successive alla prima, poichéil numero davvero elevato di correttori che si sono avvicendati sui margini dei codici nonpermette di discernere gli interventi del singolo. Si può invece quasi sempre distinguerel’autocorrezione del librarius, che indico con 1c a esponente. Nei pochi casi in cui non sipuò distinguere fra la prima mano e mani successive, uso c in apice. Segnalo con | l’acca-po; con *** una lacuna; con # la rasura di una lettera. La partizione del testo adottata, incapitoli e paragrafi, è quella dell’edizione Budé (cit. n. 14).
A φ: sceletus F, scelus L3 || 64, 1 laruarum A F2 φ2: larbarum F1 φ1 || 64, 1 oculis Aφ U L1: occulis F || 68, 1 efficio A* L1 T: officio F φ || 68, 4 nupsisset A* F2 (sed -bs-) φ2: nupsisse F1 (sed -bs-) φ1 || 70, 1 infestam A F2 φ: infesta F1 || 70, 7 solitudi-ni A F2: solitudinis F1 φ || 71, 1 istis A φ: histis F || 71, 5 facultatibus A F2 φ: facul-tabus F1 || 71, 6 possidebat A F2 φ: posidebat F1 || 71, 7 aduersari A L3: auersari Fφ || 72, 1 numquam A Fc φ: numquam me F1 || 72, 4 honorem A* F2 φ1c: horem F1
φ1 || 72, 4 salutem A F2 φ: salutum F1 || 73, 4 ni id A (Philomates): nud F1, ut F2
φ || 74, 1 transgredi A F2 φ: trangredi F1 || 74, 1 errorem A φc: herrorem F φ1 || 74,3 reliquit A φ1c: reliquid F φ1 || 74, 5 intemperantissime A F2 φ: intemporantissimeF1 || 74, 6 istis A φ: histis F || 75, 4 iam A*: K iam F1, Ic iam φ1, hic iam F2 φ2 ||76, 3 imaginarium A φ: ymaginarium F || 76, 5 disciplinam A F2 φ: disciplina F1 ||77, 2 referat A* M1 L1 V5 δ: se ferat F φ || 78, 2 mortem A F2 φ2: moram F1 || 78,4 mollitia A F2 φ: molitia F1 || 79, 6 efflictim A F2 v: efflictum F1 φ || 80, 1 nesciitA F2 φ: nisciit F1 || 83, 2 uolarent A F2 φ: uolerent F1 || 83, 3 tumultu A Fc φ: tumul-tum F1 || 83, 7 nunc A* F2 φ: nun F1 || 86, 5 tuis A* L1 L2 V5 T: fuis F, suis φ || 88,4 silice A F2 φ: scilice F1 || 93, 4 re A*: se F φ || 94, 6 errorem A φ: herrorem F || 95,5 orationem A φ: oranem F1, oratinem F2 || 97, 1 tempore A φ: tepore F || 97, 4 Chal-deos A (sed cal-) φ: Chaldeus F2 (litt. redint.) || 97, 7 aliquam A φ L3: aliquem F,alioqui v || 98, 3 suggessistis A φ: suggesistis F || 99, 3 exheredaret A φ: exberedaret F|| 99, 4 oraui A φ1c M1 L3: orauit F φ1 || 101, 4 praeteream A* M1: praetereum F φ|| 101, 4 magna A* L1 M1 T V2: magia F φ || 102, 1 amplam A φ: ammpla F1,ammplam F2.
Come si vede, ognuna di queste lezioni potrebbe essere agevol-mente interpretata come un ritocco congetturale70 da attribuirsi ad a71,oppure allo stesso copista dell’Ambrosiano72. Non si può neppureescludere, nei casi in cui in F è leggibile solo la scrittura (erronea) rein-tegrata da una seconda mano, che A restituisca l’originaria lezione delLaurenziano.
Veniamo alle varianti di A distinte per categoria73.
Varianti sinonimiche: 4, 12 congestus prorsum F φ: congestus prorsus A || 8, 2 saltemF φ: saltim A || 11, 3 muneraretur F φ: ueneraretur A || 28, 3 uere… falso F φ:uere… false A || 28, 6 diuidiae F: inuidiae74 φ A || 32, 2 adiutare F φ: adiuuare A
183UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
70 Tali scritture sono a volte condivise da recentiores appartenenti ad altre classi.71 Sull’oculatezza dei suoi interventi cfr. infra, 186-188.72 Il secondo e il terzo, si intende, meno incolti rispetto a chi vergò 1r-16r.73 Nessuna delle seguenti varianti di A è stata segnalata nell’edizione oxoniense. Gli
elenchi che seguono non si intendono esaustivi.74 È banalizzazione: diuidia ha 5 attestazioni sulla banca dati PHI5 (CD-RoM),
inuidia oltre 400, solo in Apuleio 19; si veda però apol. 82, 5 immanem inuidiam, doveApuleio legge lettere di Pudentilla e commenta che l’interpretazione capziosa di esse gli ha
|| 32, 3 quin2 F φ: quod non A || 42, 6 eiusdem modi F φ: huius modi A || 49, 2docuit F φ: demonstrabit (= demonstrauit) A || 59, 6 facie F φ: specie A || 61, 7materia rariore F φ: materie rariore A || 66, 8 Afro F φ: Africo A || 70, 8 supremo Fφ: summo A || 74, 3 quiduis… quiduis… quamquam F φ: quiduis… quiduis…quamuis A || 93, 4 oliui F φ: olei A || 95, 5 nec1… nec2… nec3 F φ: neque…neque… neque A || 96, 5 supremum F φ: summum A.
Forme verbali o nominali con scambi od omissione di preverbi: 19, 3 praependensF φ: propendens A2 (pro- in ras.) || 21, 1 imminuit F φ: minuit A || 36, 2 accipiat Fφ: suscipiat A || 43, 9 confectus F φ: infectus A || 44, 4 ablegatus F φ: oblegatus A ||48, 9 anquiritur F φ: quaeritur A || 51, 4 occipiat F φ: excipiat A || 54, 7 signasti Fφ: assignasti A || 54, 8 adseruatur F φ: obseruatur A || 71, 4 acceptis F φ: peraccep-tis A || 75, 4 discedunt F φ: abscedunt A || 81, 5 robore F φ: corrobore A || 87, 4 scri-berem F φ: conscriberem A || 92, 10 digressa F φ: regressa A.
Normalizzazioni sintattiche, morfologiche e grafiche: 3, 11 (= 42, 1) multo tantaF φ: multo tanto A L1 || 4, 6 uoltu F φ: uultu A || 9, 3 proxumum F φ: proximumA || 10, 9 coniuncto carmine F φ: in coniuncto carmine A || 18, 6 ciuitatium F: ciui-tatum φ A || 34, 2 exprobrarim F φ: exprobrauerim A || 48, 8 quaesisti F φ: quae-siuisti A || 49, 4 ossi F φ: ossis A V1 V3 V5 || 52, 3 pauimentis F φ: in pauimentis A|| 58, 9 aduentum F φ: usque ad aduentum A || 71, 2 petiuerunt F φ: petierunt A ||73, 7 uirtutium F: uirtutum φ A || 99, 3 insignis F φ: insignes A || 101, 5 nummumF φ: nummorum A.
Mentre le varianti fin qui citate sono tutte chiaramente inferiorialle corrispondenti lezioni di F75, se ne riscontrano altre che potrebbe-ro invece apparire equivalenti.
In 45, 8 aliqui F φ: aliquis A, aliquis merita attenta valutazione, in quanto assaipiù raro in funzione aggettivale.
In 53, 8 sigillo F φ: signo A, signum è meno usuale nell’accezione di ‘sigillo’.
In 102, 6 eminiscimini F (d in mg.) φ: reminiscimini A, reminiscor, nel significatorarissimo di ‘immagino’, trova un parallelo nell’Apologia (54, 1)76.
FRANCESCA PICCIoNI184
procurato un odio smisurato. Poiché in 28, 6 Apuleio annuncia che parlerà di tali lettere,se inuidia è una congettura del copista rivela una conoscenza notevole del testo.
75 Sono nella stragrande maggioranza facilmente giustificabili come banalizzazionisemantiche o morfologico-sintattiche. Si veda qualche esempio: in 49, 4 la perla arcaica diF ossi (da un desueto nom. ossum) diventa in A l’usuale ossis (da os); in 58, 9 il raro costrut-to transitivo di maneo (aduentum… manserunt) è normalizzato in A in usque ad aduen-tum… manserunt. Sovente poi tali varianti di A sono condizionate dal contesto: ad es. in74, 3 la serie trimembre di F quiduis… quiduis… quamquam diventa in A quiduis… quid-uis… quamuis, per omologazione fonica; allo stesso modo in 66, 8 Afro… Africano di F dàluogo in A a Africo… Africano.
76 Ma il caso di 102, 6 può essere condizionato dal contesto: reminiscimini quodrespondeatis. Bisogna avvertire tuttavia che la constitutio textus di 54, 1 è assai controversa.
In 42, 3 secreto loco F φ: secreto aliquo loco A, è consona al passo l’idea di indeter-minatezza di aliquo aggiunto da A.
Allo stesso modo, adeguato al contesto e rispondente all’usus apuleiano appare 81,5 transuerteretur F φ: conuerteretur A. Mentre transuerto è un hapax in Apuleio,conuerto, che conta otto attestazioni, si riscontra in met. 3, 14, 3 in meum conuer-tit exitium, nello stesso senso traslato di ‘volgere in danno’ (uertere in exitium / inaccusationem).
In 84, 7 prouulgari F φ: promulgari A, promulgari viene stampato sia nell’edizioneAldina sia da oudendorp, col supporto di 11, 6.
Risultano inoltre molto calzanti consociis rispetto a consciis (42, 3 consciis F φ: con-sociis A) e demum rispetto a deinde (103, 1 deinde F φ: demum A).
Infine in 27, 10 sancte F φ: secreto A, la scrittura di A produce un testo plausibile:habet quiddam Apuleius domi quod secreto colit, giacché proprio sul lato occulto dellareligiosità di Apuleio gli accusatori intendono insistere (cfr. capp. 56 e 61-65)77.
Queste particolari varianti potrebbero indurre il sospetto delladerivazione autonoma rispetto a F. Tuttavia a un esame attento all’ese-gesi del contesto sembrano configurarsi piuttosto quali acute alterazio-ni apportate ope ingenii dal copista di a (padre di A), la cui competen-za linguistica si metterà in luce nel prossimo paragrafo. Discuterò alcu-ni casi exempli gratia, a partire proprio dall’ultimo menzionato.
L’affermazione di 27, 10 segue a un elenco di accuse rivolte adApuleio, maliziosamente formulate dall’autore (in discorso diretto, cosìda apparire citazione ad litteram dei suoi avversari), in modo che risul-tino palesemente assurde:
7 ‘Cur mulier libera tibi nupsit post annos XIII uiduitatis?’ Quasinon magis mirandum sit quod tot annis non nupserit. […] 9 ‘Atenim maior natu non est iuuenem aspernata’. Igitur hoc ipsumargumentum est nihil opus magia fuisse, ut nubere uellet mulieruiro, uidua caelibi, maior iuniori. 10 Iam et illa similia: ‘Habetquiddam Apuleius domi quod sancte colit’. Quasi non id potiuscrimen sit, quod colas non habere.
Sancte colit conclude, in perfetta coerenza, una serie di accuse deltutto improbabili; secreto colere viceversa, pur apparentemente plausibi-le, interrompe la paradossalità del discorso.
185UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
77 In base all’esame su microfilm, secreto non è riconducibile a F e φ quale varianteinterlineare o marginale.
Così anche l’inserimento di aliquo nell’espressione secreto aliquoloco (42, 3), se non vogliamo interpretare aliquo quale falsa lectio diloco, potrebbe voler enfatizzare, con la carica di indeterminatezza cheporta, l’aura di mistero che trasuda dal passo:
3 Igitur ad praescriptum opinionis et famae confinxere puerumquempiam carmine cantatum remotis arbitris, secreto loco, arula etlucerna et paucis consciis testibus, ubi incantatus sit, corruisse,postea nesciente‹m› sui excitatum 4 – nec ultra isti quidem progre-di mendacio ausi.
Aliquo risulta tanto più pleonastico in quanto si riscontra a pocadistanza la presenza di un altro indefinito, quempiam78. Ragioni disenso e al contempo questioni di stile sconsigliano dunque di preferirela scrittura attestata da A.
Altri casi, come 53, 8 signo in luogo di sigillo, possono agevolmen-te essere intesi quali glosse intruse nel testo al posto della vera lectio.
Infine, come gli stessi sostenitori dell’autonomia ammettono,molte varianti trasmesse solo dalla classe I si rivelano antiche variantiinterlineari o marginali di F successivamente erase e oggi visibili solocon l’ausilio di strumenti ottici. Purtroppo nel caso delle varianti pecu-liari ora rilevate su A, questo controllo chiarificatore non è stato ad oggipossibile; tuttavia in tal senso si può forse spiegare un caso come 102,6 ove eminiscimini di F è accompagnato a margine da d = dubium, chedi norma segnala nel Laur. Plut. 68.2 passi di dubbia costituzione: pro-babilmente il reminiscimini attestato da A trovava in origine posto nel-l’interlinea di F.
8. LA FISIoNoMIA DI a
L’attenta osservazione delle varianti e degli errori di A ha consenti-to non solo di delineare il profilo dei librarii che lo hanno vergato, maanche di ricostruire in filigrana la fisionomia del codice, ora deperditus,che essi usarono quale antigrafo: a. Il caso più significativo è 73, 4 niid A (Philomates): nud F1, ut F2 φ. Davanti a un incomprensibile nuddi F, che una seconda mano e φ correggono malamente in ut, a distin-gue correttamente in ni id, come farà Philomathes Pisanus, cui gli edi-tori attribuiscono ni id.
FRANCESCA PICCIoNI186
78 Devo ad Antonio Stramaglia questa notazione di stile.
Degno di nota è anche 25, 9 nosse F2 φ1c (se in ras.): nosce F1, nosce-re A L3, ove lo scriba di a evidenzia analoga competenza linguistica eintelligenza del testo. Si può pensare che il copista di a abbia visto lalezione errata di F1 nosce, prima della correzione nosse, che si trasmettea φ, ma rendendosi conto che in quella sede era necessario un infinito,abbia emendato in noscere79.
Nello stesso senso si può interpretare 24, 2 uideo φ1c (in ras.): ui .Ideo F, uidi ideo A: davanti a errore in F, a e φ trovano soluzioni diver-se, ma egualmente accettabili.
Stesso acume appare in 51, 2: davanti a un erroneo aures sonora etdi F (per aures sonorae: così Salmasius), A offre, coerentemente concor-dati, due nom. sing. auris sonora et.
In 51, 9 F (con φ) ha medici confessione qui adduxit ad mea ratio-cinatione (per ac mea: così Ursinus); rilevata l’incongruenza sintattica, ilcopista di a emenda in ad meam ratiocinationem80.
Il copista di a palesa poi un’accortezza particolare nel decifrarescritture poco chiare o sigla di F: 66, 3 uideretur F1c φ2 A: uidetur F1,uideret φ1. In F re, aggiunto in seconda battuta dal copista, quasi obli-tera il compendio per -ur, il che spiega l’errore di φ, ma viene corretta-mente inteso da a.
In 75, 4 iam A: K iam F1, Ic iam φ1, hic iam F2 φ2, il K di F, beneinteso quale segno d’integrazione, non viene introdotto nel testo néadattato in hic.
Ancora in 99, 2 quod A: đ (= quid/quod) F, quide φ, un quid cor-retto in scribendo in quod in F (đ) induce all’errore il copista di φ, nonquello di a.
Infine in 101, 6 tutor F (u1 in ras., tu in mg.) A: tu tutor φ, un’in-certezza nel ductus di u1 di tutor in F spinge il librarius a riscrivere tunel mg. sinistro. Poiché tutor inizia un rigo, è facile leggere tu tutor,come φ; a invece comprende che la lezione esatta è tutor.
Altrettanto istruttivi circa la facies di a risultano alcuni errori del-l’Ambrosiano. Si riesce in certi casi a intuire i relativi errori e le moda-
187UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
79 Non era a priori inammissibile che la lezione genuina fosse l’inf. pr. noscere e chea sbagliare fosse stato il primo copista di F. Tuttavia, da un verifica su W. A. oldfather –H. V. Canter – B. E. Perry, Index Apuleianus, Middletown 1934, noscere risulta non altro-ve attestato in Apuleio, mentre nosse ha quattro attestazioni sicure nel De magia, tra cui unpasso (39, 1) in cui, come in 25, 9, si fa ricorso all’associazione scire… nosse.
80 Tale scrittura, attribuita negli apparati a L1 e V5, va antedatata.
lità correttive dell’antigrafo; ad es. in 11, 3 morsibus uersi di A (per uor-sibus) lascia presupporre un errore di a con correzione interlineare(morsibusuersi).
Come glosse81 presenti nell’interlinea di a si dovranno interpreta-re i casi seguenti:
6, 5 gingiuam] corolam… gingiuam A || 24, 8 populi Romani] gentis populis A || 49,2 docuit] demonstrabit A || 82, 8 cuiauis] cui quaelibet auis A.
Quali lemmi presenti a margine di a si vedano:
13, 5 enim de speculo] de obiectu enim de speculo A || 40, 6 atque] atque crimina A.
Per l’abitudine di a di annotare correzioni e/o varianti interlinearisi considerino:
10, 3 Perillam] P. H. Perillam A (in a c’era forse .PH.Perillam); 24, 4 est concessum] .l.concessum A (l = lege sembra una sigla anteposta da a per introdurre una variante)82.
9. I RAPPoRTI GENEALoGICI DI A CoN F E CoN φ
Se per C si è individuata una prova materiale di discendenza daF83, più opinabile potrebbe sembrare la valutazione di A. Tuttavia,come si è visto, le lezioni esatte reperibili in A possono essere interpre-tate come lievi ritocchi congetturali apportati dal competente copistadi a al testo tràdito da F. Esistono poi varianti apparentemente adiafo-re, che tuttavia non sembrano superiori alle corrispondenti lezioni di F,e che si possono probabilmente spiegare come innovazioni volontarie ocome glosse che, intese quali correzioni, hanno finito per sostituire lelezioni genuine.
Ho potuto altresì rilevare, se non prove certe, almeno forti indizi didipendenza di A da F84. Alcuni errori dell’Ambrosiano si spiegano facil-
FRANCESCA PICCIoNI188
81 Che a volte si accompagnano alla parola glossata, talatra finiscono per sostituirla.Rare le glosse di A: ricordiamo 4, 10 obliterat glossato in interlinea con delet obscurat; 49,2 trifariam spiegato a margine con triplex.
82 La presenza di glosse, varianti, rinvii interni o ‘indici’ marginali intrusi nel testo èdel resto bene attestata anche in altre tradizioni, quale quella varroniana delle Res Rusticae, sucui G. Magnaldi, Antichi marginalia nelle Res Rusticae di Varrone, «S&T», 6 (2008), 35-72.
83 Si veda supra, 166-167 n. 6.84 Tralascio i numerosi casi già efficacemente discussi in Magnaldi, Apologia (cit. n. 15),
27-31; mi limito a ricordare, come particolarmente significativi, 87, 8 equisionum F, equisio-
mente alla luce di rese grafiche inconsuete in F. Così in 37, 1 Sophocles F(-cl- d uidetur) φ: Sophodes A, dove a una lettura distratta dell’antigrafo(facilitata dall’ignoranza dell’antroponimo) il gruppo -cl- appare d.
La mise en page di 102, 4 heredem relinqueret F (here|de7) φ A1c:heredem de relinqueret A1, può giustificare l’iniziale errore di A (poiprontamente emendato): il colpo d’occhio sull’accapo di F poteva esse-re fuorviante.
L’abitudine del librarius di F di abbreviare le cariche istituzionalisempre in egual modo85, senza dare indicazioni sul caso, talvolta indu-ce A all’errore, come in 85, 2 procōs (= proconsulari uel proconsulis) F φ:proconsul A.
A eredita dal padre a un’immagine di F fedele fin nelle particolari-tà grafiche, come in 68, 2 Aemilia φ: A emilia F A, o in 82, 5 quaeris φ:qua eris F A.
Tale fedeltà è in molti casi superiore a quella di φ:
11, 3 vs (= uersus) ante lasciuus F A (solo A conserva scrupolosamente il siglum diF) || 15, 12 contrauersim F A: contra uersis φ || 17, 7 manio bis F A: marco bis φ|| 18, 9 manius F A: marcus φ || 22, 3 prae F A: pro φ || 24, 3 sit spectandum F A:spectandum est φ || 30, 3 uerisimiliter F A: uerisimilia φ || 31, 4 amissurum F A (sedamm-): emissurum φ || 42, 7 parti F A: parte φ2 (te in ras.) || 46, 3 pollicitus F A:es pollicitus φ || 48, 13 potuero F A: potero φ || 54, 8 promptaria F A: promptoria φ|| 69, 4 approbant F A: approbabant φ || 75, 1 qua F A: in qua φ || 76, 4 pudoredispoliato F1c A: pudore dispolito F1, dispoliato pudore φ || 76, 5 immedicatum M1V5: imeditatum F, immeditatum A, meditatum φ || 87, 8 uere F A: uero φ.
Vengono fedelmente riprodotte anche due evidenti voces nihili:
37, 4 aquam ed. Iunt. post.: ta quamquam F (d in mg.) A, tamquam φ || 75, 1 diperduint Casaubonus: deperduint F A, deperdunt φ.
189UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
num A || 93, 2 qđ (= quod; đ in ras. ex ue7) F, quod est A, in cui l’Ambrosiano eredita sia l’er-rore che l’autocorrezione di F. Verisimile altresì che in 74, 4 paucis φ: K paucis F, perpaucis A,il perpaucis di A si debba a fraintendimento del siglum di integrazione di F (K o IC). Su K cometipico segno di correzione nei manoscritti biblici (scritti per cola et commata), cfr. R. Weber,La lettre grecque K employée comme signe de correction dans les manuscrits biblique latins écrits«per cola et commata», «Scriptorium», 9 (1955), 57-63; per una rassegna dei sigla integrativi-correttivi cfr. L. Havet, manuel de critique verbale appliquée aux textes latins, Paris 1911, 376-380. L’impressione di una stretta familiarità tra A e F è rilevata anche da zimmerman, Age andmerit (cit. n. 13), 150, che sottolinea tuttavia la difficoltà di definire in modo netto la rela-zione parentelare tra i due codici, dato il carattere mediato del loro rapporto.
85 Cfr. 85, 2 imp. (= imperatoris) e la subscriptio in F, capp. 65-66 Cl. maximum pro-cōs (= proconsulem).
Perciò, per quanto A sembri configurarsi quale codex descriptus, nonrisulta tuttavia da ciò inficiata la sua utilità. Infatti, come Robertson eGiarratano hanno dimostrato per le metamorfosi, A conserva una faciesdi F più prossima all’originaria di φ, come si evince dai casi seguenti:
21, 3 coercere F2 (h eras.) φ: cohercere F1 A || 21, 5 onere Fc (h eras.) φ Ac: honereF1 A1 || 25, 9 quod F2 φ: quid F1 A || 29, 6 parantur F2 φ: paratur F1 A || 42, 8habere m. Catonem edd.: habere# Catonem F φ (in utroque m eras.), haberem Cato-nem A || 61, 7 impetratos F2 φ: impetratus F1 A || 76, 1 effeta F2 φ: effecta F1 A ||77, 1 quadragiens F2 (a2 inter lin.): quadrigiens F1 A, quadragies φ2 (a2 in ras.) ||95, 6 detractum F2 φ: retractum F1 A.
A questi casi si può forse aggiungere 7, 3 homini φ: homini# F,hominis A.
Una particolare rilevanza rivestono i seguenti luoghi in cui A, inaccordo con F1, attesta la lezione esatta, successivamente alterata nelcapostipite da mani posteriori (per contro φ1 concorda con F post cor-rectionem):
2, 6 quitus F1 φ2 (ce quitus in mg.) A: quintus F2 φ1 || 25, 7 en F1 A: em F2 φ || 28, 1aquae F1 A: atquae F2 φ || 73, 2 publice F1 A: puplice F2 φ || 73, 3 publicae F1 A: pupli-cae F2 φ || 75, 2 comisatoribus F1 A (sed -mm-): comesatoribus F2 φ || 75, 4 illa F1 A:inquam illa F2 φ || 75, 4 et quasi F1 φ2 A: et qui quasi F2 φ1 || 77, 6 alumentum F1 A:aIumentum Fc, adiumentum φ || 78, 5 famosissimas F1: formosissimas F2 (inter lin.) φ,famossimas A86 || 80, 4 deuerticulum F1 A: diuerticulum F2 (i1 in ras.) φ.
Nelle edizioni e negli studi specifici87 si avanza talora, a livello disuggestione, l’ipotesi della contaminazione tra a e φ da parte di A. I duecodici condividono infatti buone congetture ed errori che potrebberosembrare coniunctivi. Eccoli di seguito88:
2, 6 percelli set iam edd.: percellis etiam F, perpellis etiam φ, propellis etiam A || 6, 3puluisculum F Ac: puluis|culum φ, puluis culum A1 || 6, 5 Hiberorum F φ1c A2 (/. ɫyber- in mg.): Heberorum φ1, Hebreorum A1 || 9, 12 delicia est et v: delitia est et F1
(et eras. sed dispici potest), delitescet F2 (tescet in ras.), delicie stet φ A1c (-tie), deli-tie stet et A1 || 24, 9 pari F A2 (ri in mg.): patri φ A1 || 28, 6 diuidiae F: inuidiae φA || 30, 11 paria F1 φ1c: pariam F2, patriam φ1 A || 36, 6 adnitar M1 V5: adnitur
FRANCESCA PICCIoNI190
86 L’aplografia non compromette la possibilità di riscontrare la prima scrittura di F.87 Butler, Apulei Apologia (cit. n. 14), XXXVII; Magnaldi, Apologia (cit. n. 15), 33-34.88 Escludo dal novero consonanze che riguardino semplici alternanze morfologiche
(e.g. gen. in -um/-ium) o fonico-grafiche (geminate/scempie).
F, adnititur φ A || 49, 3 uuida F: humida φ (m in ras.) A || 51, 10 uanas et φ: uanased F, uana et A || 53, 4 linteolo F: linteola φ A.
Mentre in alcuni casi si può agevolmente pensare a concomitanzain errore o a banalizzazione, indipendente nei due copisti, altri casirisultano quantomeno opinabili. Così 6, 5: che la lezione corretta siaquella di F non c’è dubbio89. L’Hebreorum di A si può spiegare comeinconsapevole sostituzione (facilitata dall’assonanza) di una parola piùfamiliare, dovuta al retroterra culturale del copista90. Senz’altro peròtrovare Heberorum in φ poteva agevolare la confusione: da Heberoruma Hebreorum bastava una semplice metatesi.
Ancor meno scontato appare 9, 12 delicia est et v: delitia est et F1
(et eras. sed dispici potest), delitescet F2 (tescet in ras.), delicie stet φ A1c
(-tie), delitie stet et A1. Bisognerebbe presupporre da parte di entrambii copisti un errore di distinctio91 (delitiae stet), con conseguente monot-tongazione92. Si può pensare che il copista di A avesse davanti due scrit-ture, di cui una già corrotta, con errore di divisio verborum, e l’altra incui la congiunzione et si leggeva separatamente. Se avesse avuto davan-ti solo la lezione di F1 (delitia est et), difficilmente avrebbe inglobato lacongiunzione in stet per poi riscriverla.
Possiamo aggiungere un caso curioso: 6, 3 puluisculum F Ac,puluis|culum φ, puluis culum A1. L’errata distinctio di A1 potrebbe tro-vare forse spiegazione nell’accapo di φ, anche se il fatto che si tratti didue lessemi di senso compiuto facilitava comunque il fraintendimento.
Dunque, se di contaminazione tra a e φ si può parlare, è statamolto limitata.
In conclusione, come per C, anche per A saremmo in presenza diun testimone rappresentante non di una recensio collaterale, ma dell’u-nica tradizione manoscritta avente come capostipite F. CionondimenoA permette di riscontrare utilmente le scritture di F attraverso l’intera
191UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
89 Ne fa fede Catullo 39, 9 che parla di Hiberi e non di Hebraei.90 Il copista di A opera agli inizi del XIV sec., quando il problema ebraico è partico-
larmente vivo: al 1290 risale l’espulsione degli Ebrei dall’Inghilterra, al 1306 dalla Francia;nella peste nera del 1348 sono accusati di essere untori, con pozione magica fatta di erbe eurina. Giustappunto di urina si tratta nel nostro passo.
91 Forse favorito dalla rarità del singolare delicia (è arcaismo plautino). I copisti, abi-tuati al plurale, saranno stati portati a leggere deliciae (stet).
92 E scambio consonantico nel caso di φ. Gli scambi occlusiva dentale sorda/velaresorda, ove a seguire vi sia i semiconsonatica, sono piuttosto frequenti.
Apologia (così come, d’altronde, in metamorfosi e Florida) e merita per-ciò di figurare con maggior sistematicità negli apparati.
10. DATI DI CoLLAzIoNE
Fornisco di seguito, per la prima volta in modo integrale, i dati dicollazione raccolti con autopsia dell’Ambros. N 180 sup. Ne registro lescritture, verae o falsae93, in tutti i casi in cui esse, a qualunque manoappartengano, divergono da quelle di F e φ94. Il lettore avrà in tal modola possibilità di ricostruire la fisionomia precisa di questo ‘nuovo’ testi-mone e di valutarlo autonomamente.
1r: 1, 1 Inscriptio legitur in A: Apulei Platonici Madaurensis pro se apud Cl. Maxi-mum liber primus incipit; deest in F, legitur in φ: MADAURENSIS APULEIPLAToNICI DE MAGIA LIBER PRIMUS || 3 confiso A, confisus F φ || unumA, mei F φ || 5 priuingni A F1, priuigni F2 φ || 6 ultra A, ultro F φ || crebis A, cre-bris F φ || 7 alicuius A, acrius F φ || accepit A F φ1, occepit φ1c || 2, 1 qui A, quemF φ || paulo A F, patulo φ || occisus A, occisum F φ || 2 uidetur A1, uideretur A1c
(inter lin.) F φ || quam A F φc, quam iam φ1 || 3 postea A1, postera A1c F φ ||Pudentis A F φc, prudentis φ1 || 5 tu om. A || sustinerem A, sustinere F φ || 6 fac-tura A, facturum F φ || quitus A F1 φ2, quintus F2 φ1 || est om. A1, add. inter lin.A1c || propellis etiam A, percellis etiam F, perpellis etiam φ || 7 ita ut totiens A1,ita totiens A1c F φ
1v: 2, 9 extraneum A F φ1c, excidoneum φ1 || 11 unum A, ut F φ || 3, 1 aequita-te A Fc φ, aequitatem F1 || fretus A F φc, frectus φ1 || dixi A F φc, dixit φ1 || 5 cumiam A F2, cuia F1 φc, cumia φ1, cuius L1 V1 V4 V5 δ M1 || proximo crimine A1c
(inter lin., crimine om. A1) Fc (pro##ximo, in ras. a dispici potest) φ1, pro maximocrimine φ2 L3 V2, proximam crimini V5 δ || 6 et multa A1, multa A1c F φ || phylo-sopho A, philosophos F φ || effutierunt A F φ2, effitierunt φ1 || 7 auramento A,auctoramento F φ || deprehensa A, depensa F1, depreensa F2 φ || 8 que A, qui Fφ || 9 falsas A F1 φ, falsa F2 || uituperationes A φ1c, uiturationes F1 φ1, uitupera-tione F2 || etiam om. A1, inter lin. add. A1c
2r: 3, 11 quantum mellie A1, contumeliae A1c F φ || tanto A L1, tanta F φ || ei A,ea F φ || 12 tpr (= tempore) A, turpe F φ || erit ita A, erit etiam F φ || 4, 1 diser-tissimum A F2 φ, dissertissimum F1 || 2 et Tannonius A, Tannonius F φ || quam
FRANCESCA PICCIoNI192
93 Eccezion fatta per le mere varianti grafiche. Le registro esclusivamente laddove talialternanze grafiche abbiano conseguenze sul senso (un esempio per tutti, l’uso sistematicoda parte dei primi due copisti di aut per haud). Le segnalo inoltre regolarmente quandointeressano antroponimi o toponimi.
94 Nel caso di loci vexati, se non espressamente indicato altrimenti, do per implicitala concordanza in errore di A con F e φ.
A, quidem F φ || dissertissimus A, disertissimus F φ || 3 obprobrassent A1, oppro-brasset A1c (sed ob-) F φ || Hetori A, Hectori F φ || 4 oyīsaποe 7 pltc uθε o nεci-kiδe 7 δωνον οccα κε nαytoiδ ω cιΝ εκω doy k7piHc ελoyιο A (οὔ τοι… ἕλοιτο edd.ex Hom. Il. 3, 65 sq.) || 5 munera m A1, munera A1c F φ || aspernunda A F φ1,aspernanda φ2 || suetai A1, sueta A1c F φ || obtingeret A, obtingunt F φ || 6 et A,etiam F φ || 7 Phitagora A, Pithagoram F φ || esse se A, se esse F φ || 8 Velia om.A1, inter lin. add. A1c || 9 hore honessimos A, ore honestissimos F φ || ornaueruntA F2 L3, ornauerint F1 φ || 10 obliterat A1 F φ, delet obscurat A2 inter lin. || 12orore A1, horrore A2 F φ || stupeo A, stuppeo F φ || tormento A F1 φ1, tomentoFc φc || hirtus A (ex correct.) F1c φ, irtus F1 || prorsus A, prorsum F φ
2v: 4, 12 co|comendi A, comendi F φ || 13 quasi in mg. iter. A1c (perspicuitatiscausa) || intenduntur A, intenderunt F φ || refutantur A1, refutatur A1c F φ || 5, 1uo A1, aeuo A1c (inter lin.) F φ || stu|studiis A1, studiis A1c F φ || 2 quidem A v,quid F φ || 3 dicanto A F1c (in mg.) φ L1, dicunto F1, dicant F2 L3 || uero om. A|| 4 cogita A1, cogitaui A1c (ui inter lin.) F f || audes A, auderem F φ || 5 estet A2 inras., extet F φ || dissereret A1, disserere A2 F2 φ1c, diserere F1, deserere φ1 || 6 iamA Fc φ, et iam F1 || dissertabo A F2 φ1c, disertabo F1 φ1 || 6, 1 dentifricio A (entiin ras.) F2, dentifrigio F1 φ || ad quandam A1, ad quendam A1c (e inter lin.) F φ ||Calpurnianum A F φ1c, Calprunianum φ1 || eam licteram A1, eas litteras A2 (sedlict-) F2 φ, eas literas F1 || crimine A, commune F φ || 3 properis A F1 φ, prosperisF2 || misi… nolit uideri post gingiuam (6, 5) leguntur in A F (K in mg. add.) φ;inuersionis signa ante misi et post uideri add. φ2 || dtium A1, dentium A2 (en interlin.) F φ || horis A1, oris A1c F φ || puluis culum A1, puluisculum Ac F,puluis|culum φ || t umid##e A (t A2), tumidulae F φ || gingiulae A1, gingiuulae A2
F φ || 4 quidem omnino A, quid omnino F φ || uolit A, nollit F φ1, nolit φc L3 V1|| 5 Calpruniano A1, Calpurniano A2 F φ || miserum A, miserim F φ1c (fort. ex -em) || sprutitissimo A1, spurtitissimo A2, spurcissimo F φ || irritu A1, ritu A2 F φ|| Hebreorum A1, Hiberorum A2 (/. ɫ yber- in mg.) F φ1c, Heberorum φ1 || Catu-lus A1, Catullus A2 F φ || corolam drusam A1, densam A2, russam F φ || punicareA, pumicare F φ || 7, 1 uidelicet A in ras. (dƚ inter lin.) || denti fricium A1, denti-fricium Ac F φ
3r: 7, 2 aut A, haud F φ || sordidum siner ante uspiam iter. A1, del. A1c || apertummundum A F1 φ1, apertum immundum F2 φ2 δ || 3 hos A, os F φ || hominis A,homini# F, homini φ || illud A, ille F φ || 4 hominisi A1, hominis A1c F φ || auc-tum A, actum F φ || 5 nomine more A1, more A1c F φ || uestibilum A1, uestibu-lum A2 F φ || 6 m A1, meo A1c (eo inter lin.) F φ || 7 humile et A F1c φ, umile estet F1 || 8, 1 Aemi|emilianus A1, Aemilianus A1c F φ || 2 planum A, plane F φ ||unquam A, numquam F φ || iustius om. A || obteruerit A F1c φ, obteruerat F1 ||saltim A, saltem F φ || 3 fetutis A1, fetutinis A2 (ni inter lin.) F φ || 4 lentam A, lae-tam F φ || 5 se A1, sese A1c (in mg.) F φ || 6 ago A, ego F φ || Nillo A1, Nilo A1c Fφ || prigandos A, purgandos F φ || 7 haīā A1, haīā ut A2, hiauit F φ || 9, 1 uorsus AF1, uersus F2 φ || amata|torios A1, amatorios A1c F φ
3v: 9, 1 moueretur A, mouerent F φ || 3 mangus A1, magus A2 F φ || quia om. A|| usquam A, unquam F φ || portionem suspiccionem A1, suspicionem A1c F φ ||
193UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
aptam A F2 (ap redint.) φ1, apertam φ2 || 4 tamen id A, id tamen F φ || 5 amari-torios A, amatorios F φ || 6 ineius A1, Teius A2 F φ || Lacaedeminius A1, Lacaede-monius A2 F φ || cum aliis innumeris A2 in ras. || 7 dulcedinem A, dulcene F1, dul-cedine F1c φ || 8 Catullus A, Catulus F φ || 9 fallonem A, Solonem F φ || MhρωΗεικεjρωjν κ cijta y cτοματοσ A || 11 Diogenis A, Dyogenis F φ || sciatur A1, sciantA1c F φ || pi#gere A (fort. eras. n) || 12 Cricias A (ut semper) φ, Critias F || delitiestet et A1, delitie stet A1c φ (-cie), delitia est et F1, delitescet F2, delicia est et v ||Carine A ut semper, Charine F φ || remaneat A1, remanet A1c F φ || potior A, potiarF φ || sum A, sim F φ || 13 et om. A1, inter lin. add. A2 || postumum A1, postre-mum A1c F φ || 14 carmina dono2 om. A1, in mg. add. A2 || autem om. A1, interlin. add. A2 || dona et nam A F φ1, dona et iam φ1c || 10, 1 abes A (littera H rubri-catori relicta), Habes F φ
4r: 10, 2 quam A1, quod A2 F φ || 3 Catulum A1 (Catullus in mg. A2) F φ1, Cat-ullum φ2 || quos A, quod F φ || Lerbia A1, Lesbia A2, Lesbiam F φ || Codia A1,Clodia A1c F φ || nominaret A, nominarit F φ || Tycidam A, Ticidam F φ || quisqueA, quod quae F φ || P. H. Perillam A, Perillam F φ || Propertiam A F, Propertiumφ || dissimilet A1, dissimulet A2 F φ || Tibulum A1 φ1, Tibullum A2 F φ1c || DeleiaA1, Delia A2 F φ || uerssu A1, uersu A1c F φ || 4 Lucullus A, Lucullum F φ || inpro-bari A, improbarim F φ || prostituit A, prostituerit F φ || 5 quantum A, quanto Fφ || ın A1, itidem A2 (in mg.) F φ || puerum A φ, puerium F2 (litt. redint.) || bucol-lico A1, buccolico A2, bucolico F φ || 6 bussecas A1, bussequas A2 F2, busequas F1
φ || rusticanos A1, rusticanus A2 F φ || agrestius A1, agrestis A2 F φ || longne A1,longe A1c F φ || ut om. A1, inter lin. add. A2 || 7 Platonius A1, Platonis A2 F φ ||non erant A φ, inerant F2 (litt. redint.) || deus scit A, deus sit F1 φ1, deussit F1c (inmg.) F2 (inter lin.) φ2 || 8 poetes A, potes F φ || αστΗρ aρ M ες ε Ηιζ|ω οιοιΗ εωος Hyn δε θyHωH yοyοεισ ΗεροσεΗοσ θιΜεΗοισ A (ἀστὴρ… φθιμένοις edd. exDiog. Laert. 3, 23) || 9 eiusdem A F1 φ, equidem F2 (litt. redint.) || in coniunctoA, coniuncto F φ || HyH οικει dεHνλεɦεy σu οcH HοH ειιο7ι καλλυσ 7 ν## κaιι-ια7ι pεpικλεπειaι θyMj . nyεισ κyσιH οσjεοH επαιHσει yθεpοHοy κ xo7o φaidροHαπολεσαMεH A (νῦν… ἀπωλέσαμεν edd. ex Diog. Laert. 3, 23) || 10 commemo-rem] com ex correct. A || Syracosano A, Siracusano F φ || ω 7 εκοH εκHHHao οyp# oeραιωιοH A (ὦ ἐμὸν… Δίων edd. ex Diog. Laert. 3, 23) || 11, 2 Catulum A1,Catullum A2 F φ || esse castum esse A, castum esse F φ || decet] in ras. ex debet A|| uerssicuɫos A, uersiculos F φ || necesse A φ, nekesse F || 3 morsibus uersi A1,uersibus inter lin. A1c, uorsibus F φ || ueneraretur A, muneraretur F φ || vs (= uer-sus) ante lasciuus A F || lasciuus A F φ2, laciuus φ1
4v: 11, 3 lepodio|ora A, lepidiora F φ || 4 audes huius A1, audes his A2, aude sisF1 φ, aude igitur F2, audes igitur L3 D V1 V3 || Aemiliare A1, Aemiliane A2 (n
inter lin.) F φ || 5 Maxime A, Maximum F φ || pudicitius A, pudicius F φ || quan-tum simplicius A, quanto simplicius F φ || 12, 1 rarissime A, rarissimo F φ || cui-quam A1, cuique A2 F φ || profatis A1, profanis A2 F φ || ingnita A1, incognita A2
(co inter lin.) F φ || 2 earum A2 inter lin. (non liquet A1) || percita A F1 φ1c, per-ciorum φ1 || pecuniis A, pecuinis F φ || 3 et om. A1, inter lin. add. A2 || 4 eiusamore A, amorem eius F φ || non om. A1, inter lin. add. A2 || commendet A,comendet F φ || 5 diligendum forma A, forma diligendum F φ || ammoneant A
FRANCESCA PICCIoNI194
F1 φ, commoneant F2 (co redint.) || 6 relinquatur A1 L1, relinquat A1c F φ, reli-quit T, relinquit δ || amabis A, amabit F φ || amas A, amat F φ || 13, 3 attendeA, attente F φ || 5 de obiectu enim A1, enim A1c F φ || peculo A1, speculo A2 (s interlin.) F φ || longna A1, longa A2 F φ
5r: 13, 5 censiora A, censoria F φ || 6 credam A1, credas A2 F φ || negu`o A, negaroF φ || accipe A, accipi F φ || exornare A1, exornari A1c F φ || 7 timelicum A,thimelicum F, themelicum φ || consuesse A F1c φ, consuesset F1 || gragidi A,tragidii F φ1, tragoedi φ1c || croco orta A, crocota F φ || centungulo A1 F1c (in mg.),centunculo A2 F1c φ1c, centulo F1 φ1 || rebus et A, rebus F φ || careor A1, careo A2
F φ || 8 doceas A F2 L2 V1 V2, docear F1 φ || 14, 1 fatuor A, fatear F1, fateor Fc φ|| tamen A2 in ras., tandem F φ || 2 an tu A2 in mg. (non liquet A1) || ingnorans A,ignoras F φ || nihil om. A1, inter lin. add. A2 || esse celas A1, esse A1c F φ || inspec-tabilius A1, inaspectabilius A2, aspectabilius F φ || quid A (id in ras.), quod F φ ||praemio A φ, praemia F (a in ras.) || 3 qui A, quid F φ || 4 diutino A2 (ti inter lin.,non liquet A1) F2 (litt. redint.) φ1, diutina φ2 V1 V3 L3 || 6 eandem A, eadem F φ ||aequeua A F1 (in mg.) φ, equa F2 (litt. redint.) || ad obeunde A1, ad obeuntem A2
F φ || participaret A1, participat A2 F φ || 7 luctum A1, luto A2 F φ || re A1, aere A2
F φ || lapidum A1, lapide A2 F φ || ca A1, cera A2 (in mg.) F φ || pigmento A2 inras. || illicitum A1, illitum A2 F φ || copiam A, quopiam F φ || 8 fabra A F1c φ, fubraF1 || 15, 1 Hagessilai A1 (Hagessilaus in mg. A2), Hagesilai F φ
5v: 15, 1 pingni A1, pingi A2 F φ || fingni A1, fingi A2 F φ || 2 statis A1, statuis A2
(u inter lin.) F φ || 5 pulcritudoine A1, pulcritudine A1c φ1, pulchritudine F φ2 || 6commendabilem A φ, comendabilem F || tengnet A1, tegeret A2 F φ || 8 primariosA1, primarium A1c F φ || artificium A, artificem F φ || 9 ahusisset A1, ausisset A2 Fφ, hausisset v || con(tra)gruentiam A1, congruentiam A2 F φ || 10 sibi A, igitur F φ|| adseuerda A1, adseueranda A2 (an inter lin.) F φ || rectori A, rhetori F, rethori φ ||an apud omnis homines semper disserenti om. A1, in mg. add. A2 || angrorum A,agrorum F φ || 11 non A, nec F φ || inuise A1, inuisere A2 (re inter lin.) F φ || 12similitudine ipsius rationis A, ipsius similitudinis rationem F φ || iungni A1, iugiA2 F φ || contrauersim A F, contra uersis φ, contrauersum V2 || 13 prolinquati A1,proliquati A2 F φ || extralio A F φ1, extrario φ1c || adque A1 ut saepe, atque A2 F φ|| inuniti uel muniti A, uniti F φ || 14 tantum A2 in ras. || oculis om. A1, in mg. add.A2 || ue|ueris A1, ueris A1c F φ || 15 tang(unt) A F, tangant φ
6r: 15, 15 imaguitur A, ymaginentur F φ || 16, 1 uel2 om. A || 2 defentiora A1,defectiora A2 F φ || actiora A, auctiora F φ || 3 et om. A1, inter lin. add. A2 || 4 cauaA Fc φ, caiua F1 || 5 fiant A1, fiat A1c F φ || 6 quam A1, quae A2 F φ || uir in mg.A2 (eras. A1) || admirabilem subtilitatem A1, admirabilis subtilitate A2 F φ || aut A,haud F φ || inspexerant A1, inspexerat A1c F φ || 7 Aemilianum A1, Aemiliane A2
F φ || an A, ac F φ || puluiusculo A1, puluisculo Ac F φ || chiesta A, Thiesta F φ ||9 et om. A || 10 et1 om. A1, inter lin. add. A2 || 11 cuiusquam A φ, cuiusiquam F|| tegerem A1, tegere A2 F φ || 12 est tenebris A1, e tenebris A2 F φ || 13 tpr (= tem-pore) A, ipse F φ || luciffuga A1, lucifuga A1c F φ || 17, 1 seruorne A F1, seriorneF2 (ri litt. redint.), seruosne φ (s2 in ras.) || an habeas A F φ1, habeas φ1c, tu habeasv || agār A1, agrum A2 (rum inter lin.) F φ || opera A1, operas A2 (inter lin. et in mg.)F φ || 2 eandem A1, eadem Ac F φ || tue A, a te F φ
195UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
6v: 17, 2 abiecit A F2 (ab litt. redint.) U, obiecit φ || quaquam A, quanquam F φ|| eam A1, oeam A2 (o inter lin.) F φ || 3 quid A, quod F φ || potı A1, potuerimA2 (tuerim in mg.) F φ || manu mittere A F2 φ, manum mittere F1 || 4 consuet A1,consuetudinem A2 (udinem inter lin.) F φ || uelit A, dicit F2 (litt. redint.), uenit φ ||suo A, seruo F φ || paculis A1, pauculis A2 (u inter lin.) F φ || die om. A1, in mg.add. A1c || 5 cum A1, cur A2 F φ || 6 phylosophum A, philofum F1, philosofumF2, philosophum φ || ementri A1, ementiri A2 (i1 inter lin.) F φ || sectorem A1, sec-tatorem A2 (ta inter lin.) F φ || paucitatem A1, paucitate A2 F φ || 7 suos A, seruosF φ || Manio bis A1 (Manius Curius in mg. A2) F, Marco bis φ || ter om. A1, interlin. add. A2 || calones A1 (in mg. iter. A2) φ1c, calonos F1, colonos F2, caiones φ1 ||8 Pirro A, Pyrro F φ || pautiores A, paucioris F φ || suos A, seruos F φ || 9 aut A,autem F φ || operatione A F φ1, oratione φ2 V5 || Inspania A, Hispania F, His-paniam φ || proficiscetur A, proficisceretur F φ || 10 iusisse A1, iussisse A2 (s1 interlin.) F φ || de menssa A1, de mensa A2 F φ || Hyspaniam A1, in Hispaniam A1c (in
inter lin.) F φ || 11 legisses A, legisset F φ || paucitatem A F1c φ1c, pacitatem F1 φ1
|| 18, 2 potens A2 (non liquet A1) || benesuanda A1, benesuada A2 (in mg. iter.) Fφ || nmine umquam A1, neminem umquam A2 (e inter lin.) F φ || 3 iniquum A1,inguinum A2 F φ || 4 set A1, si A2 F φ || in illis A1 F φ, in istis A2 in mg. || 5 illus-tris A F (sed inl-), illustres φ
7r: 18, 5 paupertas ab incunabulis nutricata est iter. A1, del. A1c || incunabilis A,incunabulis F φ || nutricata] nutri- in ras. A (nutricata in mg. iter. A2) || 6 ciuita-tum A φ, ciuitatium F || repertrix A2 (-trix in ras.) || omni A, omnis F φ || 7 Focio-ne A, Phocione F φ || 8 proqua A, proque F φ || ego A1, eo A1c F φ || hodiernumA φ, odiernum F || simpulo A F1 φ1, simpuuio F2 φ1c || 9 sedent A, sederent F φ|| Manius A F, Marcus φ || 10 Agripa A, Agrippa F φ || tenius A, tenuis F φ || col-latris A1, collatis A1c F φ || extantibus A F φ1, sextantibus φ2 || 11 Regulis A, Regu-lus F φ || 12 omnes illae A F1c φ, illae omnes F1 || remisisse A1, remissae A1c F φ ||audesne A, auderesne F φ || 19, 1 Cladius A, Claudius F φ || irridendam A in ras.|| 2 austerem A1, austerae A2 F φ || sec(us)tae A, sectae F φ || tanquam A, tamqueF φ || non putas… opulentiae A F φ1c in mg., om. φ1 || amiciciorem A, amicioremF φ || cohertae A1, cohercitae A2 (ci inter lin.) F φ || ue ante fortunam A1, del. A1c
|| tunicam A F1c φ, punicam F1 || 3 gestatur et trahytur A1, gestatur et trahaturA2, gestetur et trahatur F φ || propendens A2 (pro- in ras.), praependens F φ || 4et A1, etenim A1c (enim in mg.) F φ || honeri A1 F φ1, oneri Ac φc || exuberet A,exuberat F φ || 5 gubernacula A Fc φ, gurbernacula F1 || facillius A1, facilius A1c Fφ || quam A1, quod A1c F φ || 6 ipsius A1, ipsis A2 F φ || cultu] cul- in ras. A, inmg. iter. A2 || spe A, specie F φ || 7 simulatam A L1 T, simulata F φ, simulate M1δ || frugimur A1, fungimur A1c F φ
7v: 20, 1 facere ante pauperem iter. A1, del. A1c || possunt A1, poscit A2 (in mg.) F1c
(cit redint.) φ, possit V1 || 2 minimum A1, qui minimum A2 (qui inter lin.) F φ || 3aestimantur A (sed ante animo) F1c φ, aestimatur F1 || genus A, egenus F φ || adomne A1, et ad omne A2 (et inter lin.) F φ || mortibus A1, montibus A1c F φ || 4confessione A, confessio est F φ || 5 Phylus A, Philus F φ || Le|lelius A1, Lelius A1c
(in mg. iter. A2) F1c φ, Lellius F1 || quantam A1 F φ, quantas A1c || 7 fuerint A,fuerunt F φ || 8 sis A1 φ1c V1 V5 δ, es A1c (inter lin.), scis F φ1, fis V3 M1, si es V2
FRANCESCA PICCIoNI196
|| appedenti A, appetendi F φ || 9 igitur Aemiliane A2 (in mg.) F φ, non liquet A1 ||extrareis A1 (in mg. iter. A2), extrariis F φ || 21, 1 hac A, ac F φ || ut tutor A1, auttutor A1c (a inter lin.) F φ || minuit A, imminuit F φ || aut tutor ante aut inimicusiter. A1, del. A1c || obprobare A, opprobrari F φ || animalilibus A, animalibus F φ ||2 gracilillare A1 (in mg. iter. A2), gracili lare F φ || quam A1, quod A1c F φ || abso-no A, obsono F φ || 3 quantum lacumque A, quantulacumque F φ || uiduntur A,uidentur F φ || cohercere A F1, coercere F2 (h eras.) φ || beatior in ras. A (in mg. iter.A2) || qua A1, quanto A1c (nto inter lin.) F φ || 4 namque A φ, nanque F || 5 honereA1 F1, onere Ac Fc (h eras.) φ || stentui A1, sustentui A2 (in mg.) F φ
8r: 21, 6 minimus A1, minimis A1c F φ || 22, 2 quam A, quem F φ || 3 solitan-tem A1, solitatem A1c F φ || frugiferas A φ, frugifera F || prae A F, pro φ || orna-tissimas A F1c φ, hornatissimas F1 || 4 comperata A, comperta F φ || humi litateA1, humilitate Ac, utilitate F φ || car A1, carmine A1c (ine in mg.) F φ || 5κρhτhτιςuολιςεςτιMελω εHjιjHοπι7y φωτςοHτω A (‹πήρη›… τύφῳ edd. ex Diog.Laert. 6, 5, 2) || 6 phylosophus A, philosophis F φ || quadri|drigas A1, quadrigasA1c F φ || 7 iste A, ista F φ || secute A, sectae F φ || insingnia familiae A, familiaeinsignia F φ || uerum tamen A φ, ueruntamen F || dadema A1, diadema A1c (i interlin.) F φ || pud pontificibus A1, pontificibus A1c F φ || gallerum A1, galerum A1c
F φ || lituum A, lituus F φ || 9 inuitus A1, inuictus A1c (c inter lin.) F φ || mendi-cabilia A, mendicabula F φ || animi A V5 M1 T, animis F φ || 10 orbis post purga-tor iter. A1, del. A1c || ascitus A φ1c, asscitus F φ1 || ulla una A1, una A1c F φ || 23,1 sensum A F φ1, censum φ2 v || diserundum A F φ1, disserundum φ2 || num A,ne F φ || nescis A1, nescias A1c (a inter lin.) F φ || 4 conteptu A, contemptu F φ,contemptum V1 V2
2 || 5 tu1 A2 (non liquet A1)
8v: 23, 5 quanti A, quantum F φ || tandem A, tanti F φ || lignum A (sed lingn-)F1c φ, ligni F1 || est A, eius F φ || 6 unicus A1, unicum A1c F φ || tamen A1, tuusA2 (in mg.) F φ || exarabras A1, exarabas A2 F φ || 7 cunte A1, cum te A1c F φ ||iestam A, istam F φ || 24, 1 Getulae A1, Getuliae A1c (i inter lin.) F φ || ostendisscis A, ostendi scis F φ || Semigaetulam A F, Semigaetulum φ || 2 uidi ideo A, ui. Ideo F, uideo φ1c (in ras.) || aut A, haud F φ || Cyro A, Ciro F φ || 3 ut A, ubi Fφ || sit spectandum A F, spectandum est φ || 4 .l. concessum A, est concessum Fφ || Tharsium A, Thasium F φ || filiasi um A, Phliasium F φ || terra ea|lumpna A1,terra et alumpna A2 (t inter lin.), terrae alumna F φ || clemens A1, clemens et A2
(et inter lin.) F φ || solus A, sol F φ || soccidum A1, sucidum A2 F φ || 5 hospitaliA, hospitium F Ф || 6 ut A, non F φ || solstitia A1, sollertia A1c (sed sol-) F φ ||insigniorem A1, insigniores A1c F φ || sochordissimos A1, socordissimos A2 F φ ||sithas A, Scythas F φ || Maletides A, Meletides F φ || 7 h A1, hoc A1c (oc inter lin.)F φ || 8 gentis populis A1, populis A1c F, populi Romani φ1c (in ras.) || 9 coepi AFc φ, coepit F1 || patri A1 φ, pari A2 (ri in mg.) F || tueor A2 (tu inter lin., #eor A1)|| 10 succensseas A1, suscenseas A1c (sed succ-) F φ || non legi non elegi A1, nonelegi A1c F φ
9r: 24, 10 eo A φ, ea F || 25, 2 at A F1c φ, ad F1 || et carmina A, carmina F φ ||seruum et A, seruum ut F φ || deparicis A1, deparcis A1c F1c φ1, parcis F1, parci F2,deparci φ2 || 3 expergescimini A F1, expergiscimini F1c φ || Claudum A, Claudium
197UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
F φ || seruum A, seuerum F φ || 4 et conuicia A, conuicia F φ || affertis A, aufer-tis F φ || quam A, quin F φ || immunia A F φ1, immania φ2 M1 T || 5 nam A, iamF φ || ad ipsum A F1c φ, dipsum F1 || accessum A1, accensum A1c F φ || frustra A1,frustrata A1c F φ || defraglauit A F, deflagrauit φ || 6 flamma A, flammam F φ ||stipulam A, stipula F φ || cupitu A, crepitu F φ || nullis A F1c φ, nullos F1 || 7 enA F1, em F2 φ || ullis A, nullis F φ || 9 quid A F1, quod F2 φ || ago A F φ1, ego φ2
v || est crimen A, crimen est F φ || noscere A L3, nosce F1, nosse F2 φ1c (se in ras.)|| 10 ipsius A, ipsa F φ || 11 λυκΒαρο οy οιρ οyε Η ει Ηοι βασιλειοσ παιδα Ια Γοσ Γοyον ΗοΗα καικα τεξ σεο πσιΗεισιΝ δεεɬειλει ΗεΗιο 7 τρεεοο αΗΗδι αειτ τοιδοɬαρτεσΗ λι κα τε παρεσο7εσοφωπετ οσκαιο τατοσ και οσο σαφρενΗισ Ια Ιοσ καιοαpδριοτατοσy Hoblε ΗΗα ΓειωΗ τε διδα σκειj hΗ ζοοιροασ7ροycο ροΜαζyεσπ A
9v: 25, 11 δε το ποθωΗθεραπΙα διδασκει dΗ α ταΒσιλιλλικα A (δὶς ἑπτὰ… βασιλικάedd. ex Plat. Alcib. 1, 121 E) || 26, 1 pergnara A, pergnaram F φ || diuinis A, diui-ni F φ || 3 quippe A, quippe qui F φ || doceantur A1, docetur A1c F φ || mangnumA1, mangum A1c, magum F φ || aut A, haud F φ || 4 item A, idem F φ || PlatoniA, Plato in F φ || çalenosi A1, çalenoxi A2 (x inter lin.), zalmoxi F1c (x ex corr.) φ|| τατ δεεποδ7τ ει Ηyτο ισ λοΓοy σιιιοσ Ηαλοισ A (τάς δὲ… καλούς edd. ex Plat. Char-mid. 157 A) || 5 nosse ## non A || zamoxi A, zalmoxi F φ || 6 comunionem A,communione F φ || ad omnia ad omnia A1, ad omnia A1c F φ || opido A1, oppi-do A2 (p inter lin.) F φ || 7 cat cetera A1, cetera A1c F φ || 8 in om. A1, inter lin.add. A1c || 9 mangnum A1, mangum A1c, magum F φ || 27, 1 eorum A F φ1, eosφ2 in mg. || corporum A1c in mg. (non liquet A1) || inreligios A1, irreligiosos A2 (os
inter lin.) F φ || eosque A, eoque F φ || ainat aiant A1, aiant A1c F φ || AnaxagoraA, Anaxagoram F φ || Epicurum A1 (e ex correct.), et Epicurum A2 (et inter lin.) Fφ || 2 non metū A, nominent F φ || qui A, quasi F φ || 3 de hinc A, dein F φ ||epedocli A, ē. pedocli F, Empedocli φ || cathormee A, cathormoe F φ || Socrati AF φ1c, Socratis φ1 || Ιω vΓοθον A, τὸ ἀγαθόν F φ
10r: 27, 4 ui|uiris A1, uiris A2 F φ || 5 ea om. A || obiectata A, obiecta F φ || 8 nes-cia A, nescio F φ || 9 inuenere A, iuuenem F φ || ipso A, ipsum F φ || uellet om. A|| uiro A F1c φ, uido F1 || 10 quidam A, quiddam F φ || secreto A, sancte F φ || 12magi an A, magian F φ || 28, 1 contemptus A, contentus F φ || largitus A1, largiterA1c F φ || aquae A F1, atquae F2 φ || 2 sint A, sunt F φ || non negabo sed perindeatque si facta sint ante fatebor iter. A1, del. A1c || 3 false A, falso F φ || habeat potiusA, potius habeant F φ || 4 eo A, eorum F φ || deinū uel demum A, dein F φ || 5 falsoA F φ1, falsa φ1c M1 || Prudentilae A1, Pudentilae A1c, Pudentillae F φ
10v: 28, 6 humane A, immane F φ || inuidiae A φ, diuidiae F || h(uius) sce A,huiusce F φ || et om. A1, inter lin. add. A2 || 7 de A, te F φ || meo A, meae F φ ||8 Potentianus A, Pontianus F φ || 9 atque A F2 φ, utque F1 || omnis A, omni F φ|| 29, 3 phyrigionibus A, phrigionibus F, frigionibus φ || 4 sed A, si F φ || conuiuoA, conuiuio F φ || 5 olus A F1, holus F1c φ || 6 enim om. A || absonare A1, obsonareA2 (in mg.) F φ || edilia A, edulia F φ || quasi A, quae F φ || despenso A, depensoF φ || paratur A F1, parantur F2 φ || 7 atque solent A, ad quod solent F φ || 8 nul-lum A F φ1, nullam φ2 || traxauere A, taxauere F φ || conteneretur A, contem-neretur F φ
FRANCESCA PICCIoNI198
11r: 30, 1 leporem A, lepores F φ || 2 si A, sin F φ || 3 uerisimiliter A F, uerisi-milia φ || 4 brutusque frigidus A, brutus et frigidus F φ || 5 tam non impudens A,Tannoni Pudens F φ || 6 Virgilium A F1c φ, Vergilium F1 || 7 licicia A1, licia A1c
F φ || scripsit serio A, serio scripsit F φ || 8 nascentis A F1c φ, nascentes F1 || froA1, fronte A2 (te inter lin.) F φ || reuulsum A F φ1, reuulsus φc || 9 tergenda A1,detergenda A2 (de inter lin.) F φ || 10 in om. A || operas ante herbas add. A1, del.A1c || squamas A1, tu squamas A2 (in mg.) F φ || partim A, pratum F φ || 11 pa-triam A φ1, paria F1 φ1c, pariam F2 || aliam A F2, alia F1 φ || tragrediis A, tragoediisF, tragediis φ || 12 angnoscens A, agnoscent F φ || 13 erunt A1, eruunt A2 (u interlin.) F φ || ungues A φ, unges F || bicodilae A, bicodulae F φ || umuentum A1,humuentum A2 (h inter lin.), hinnientum F φ, hinnientium M1 L3 || 31, 1 longneA1, longe A1c F φ || faciat A, facit F φ
11v: 31, 1 uideatur A, uidetur F φ || coiectem A, coniectem F φ || 2 et orasti A1,et oroasti A1c, zoroastri F φ || adanimaduertisset A, animaduertisset F φ || YtaliaeA, Italiae F φ || subsiciuam A φ, subsicinam F2 (litt. redint.) || quibusdam A φ, qui-bus dum F2 (litt. redint.) || 3 emisse A φ, emissae F2 (litt. redint.) || 4 amissurumA (sed amm-) F, emissurum φ || fuisset A F φ1, fuisse φ1c || quidem A F2 (litt.redint.), quid# φ || 5 meminera A1, meminerat A2 (t inter lin.) F1c (in mg.) F2 φ,meminerit F1 || scripsisse A φ, scripsisset F || mondum A1, modum A1c F φ || ἣτόσα… χθών (Hom. Il. 11, 741) om. A (desunt citata m. recentissima in mg.) || 6τῇ πλεῖστα… λυγρά (Hom. Od. 4, 229) om. A || 7 aliquos A, aliquo F φ || et om.A1, inter lin. add. A2 || folles A, follem F φ || Elena A, Helena F φ || crateram A,creterram F φ || 8 reperiti A, reperti F φ || herbarunt A, erbarum F, herbarum φ ||et1 om. A1, inter lin. add. A2 || ut surculorum A, et surculorum F φ || ut penitusA, et penitus F φ || 9 cerimomias A, cerimonias F φ || et2 om. A1, inter lin. add. A2
|| consci#a A || posthanc A1, posthac A1c F φ || c(on)solatia A, cum Salacia F φ ||portu num A, Portuno F φ || Nereidum A F2 φ, Nerei F1 || transferuntur A, trans-ferentur F φ || 32, 2 uidere A, uidetur F φ || magias A, magicas F φ || adiuuare A,adiutare F φ || dum A, num F φ || ipse A (uacuum ante), et ipse F φ || miopaoresA1, mioparones A1c inter lin., myoparonem F φ || pyrata A1 F φ, et pyrata A2 ||profossor A, perfossor F φ || 3 quod non possit A, quin possit F φ || testitudinemA1, tristitudinem A1c (tristitudo in mg. add. A2) F φ || 4 idcirco omnia A, omniaidcirco F φ || sithus A, si tus F φ || cassiam A, casiam F φ || cum om. A || ut etmedicamento A1, et medicamento A1c F φ || 5 propheta A1, poeta A2 (in mg.) F φ|| Farum A, Pharum F φ
12r: 32, 5 fame A, famem F φ || propulsa A1, propulsasse A1c (sse inter lin.) F φ ||6 delphynos A, delfinos F φ || scillas A, scillam F φ || omnis A F1 φ, omnes F1c ||omni genere A, omnium generum F φ || piscis A F1 φ, pisces F2 || 8 paraueris AF, parauerit φ1, papaueris φ2 || semissem A F1, emissem Fc (in ras.) φ || patareturA, pateretur F φ || 33, 2 nominauerunt A2 (post nominaue eras. A1) L3 M1, nomi-nauerant F φ || 3 impisciundum A, inspiciundum F φ || quod A, quidem F φ || 4cognite A, cogniti F φ || 6 utusque A, utriusque F φ || ac diu] ac inter lin. A2, diuin ras. || 7 femina A, feminal F φ || meo libro A, libro meo F φ || interfemineumA, interfeminium F φ || 34, 1 sordida A1, sordidiora A2 (ior inter lin.) F φ || 2exprobrauerim A, exprobrarim F φ || lateret A, blateret F φ || nequaquam om. A1,
199UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
in mg. add. A2 || fringulitiat A1, fringultiat A2 (in mg., sed -ciat) F φ || obmitescatA, ommutescat F φ || 3 interfeminam A F1 φ, interfeminiam F2, interfemineumM1 V5, interfeminium v
12v: 34, 4 uerisimilem A, uim similem F φ || 5 at quaesisse A F, acquisisse φ, siquaesisse M1 || ueretillam A F φ1c, uerentillam φ1 || et denuo A1, ut denuo A2
(inter lin.) F φ || 6 non tamen A1, tamen A1c F φ || tam om. A || ar A1, argumen-tum A2 (gumentum inter lin.) F φ || capillum A F1, capillo F1c φ || ancipitrem A1 (inmg. iter. A2), accipitrem F φ || 7 has A1, hasce A2 (ce inter lin.) F φ || 35, 1 fin-gneritis A, fingeretis F φ || 2 montis A, motis F φ || 3 dictis A1, dicitis A1c (i2 interlin.) F φ || plurimisos A F φ1, plurimos φ2 M1 V5 || cum chalar striatam A1 (calarstriatam A2 in mg.), conchalam striatam F φ, conchulam striatam M1 V5, conchamstriatam T || terentem A1, teretem A2 F φ || 4 muscumque A1, muscum et A2 (et
inter lin.) F φ || tera A1, cetera A2 (ce inter lin.) F φ || litorum A F1 φ, locorum F2
|| 7 mxīe A1, Maxime A2 (a inter lin.) F φ || diucle A1, diu hercle A2 (inter lin., seder) F φ || perpesset sise quod A, perpessus sis equidem F φ || 36, 2 praecipiti aeuoet occidua senectute in mg. iter. A2 || suscipiat A, accipiat F φ || 3 Aristotilem Aut semper, Aristotelen F, Aristotilen φ
13r: 36, 3 Theophrastum A, Theoprastum F φ || 4 relinquerunt A, reliquerunt Fφ || 5 eruditionem A, eruditione F φ || περὶ… ἱστορίας om. A || recta A F φ1, sectaφ2 || 6 cum quesita A, conquisita F φ || fuit illis A, illis fuit F φ || choibilius A,cohibilius F φ || adnititur A φ, adnitur F, adnitar M1 V5 || deflecta A1, defecta A1c
F φ || 7 quam A φ1 M1 V1 L3, quem F φ1c || 8 prometij A, prome tu F φ || est A,e F φ || seduplici A, sedulique F φ || 37, 1 Sophodes A1 (in mg. iter. A2), SophoclesF (-cl- d uidetur) φ || erupidia emulus A1, Euripides A2 in mg., eum ripidiaemu-lus F1, Euripidi aemulus Fc φ || accusaret A, accusaretur F φ || colona eum A,Coloneum F φ || cum in eo A, tum in eo F φ || 2 addisse A1, addidisse A1c (di interlin.) F φ || audaciter A, audacter F φ || condepnaret A, condemnarent F φ || 3 etom. A1, inter lin. add. A2 || 4 haec A, et F φ || in principio A, de principio F φ ||deinde A, dein F φ || ta quamquam A F (d in mg.), tamquam φ, aquam ed. Iunt.post. || 38, 1 phylosophycum A, philosophorum F φ || 2 y memento A1, etmemento A2 (inter lin.) F φ || quod gignarantur A1, quod gignerantur A1c interlin., progignantur F φ || et2 om. A1, inter lin. add. A2 || quod quid A, quid F φ ||subentant A F1c φ, subent F1 || 3 mebris A, membris F φ || discerit A1, discernitA2 inter lin., discrerit F φ || post Graeci add. ita A || ζῳοτόκα et ᾠοτόκα om. A || 4uictu membrisque A1, uictu et membris A2 (et inter lin.) F φ
13v: 38, 4 aetatibus A1, et aetatibus A2 (et inter lin.) F φ || quod A, quidem F φ ||7 Aegyptio A, Aegiptio F φ || 8 σελάχεια… συναγελαστικά om. A || 9 possem A,possum F φ || perere terere A1, terere A1c F φ || adgregredi A, adgredi F φ || et c adcetera A1, ad cetera A1c F φ || recito A1, recita A1c (a inter lin.) F φ || 39, 1 in om.A || 2 piscium genera A, genera piscium F φ || cognorat A F1c φ, cognouerat F1 ||3 aenias pera A F1c, aenas pera F1, aeniaspera φ || umbraciae A F φ1, Ambraciaeφ2 || bonus A, bonus est F φ || summe A, sume F φ || Targenti A F1, Tarenti Fc φc,tarrgenti φ1 || cerebrum A φ2, celebrum F φ1 || suppremi A F, supremi φ || umbraminque A F1 φ1, umbramque F2 φ2 || 4 iusulentus A1 F φ, iussulentus A1c (s interlin.) || reprehendam A, reprehendar F φ
FRANCESCA PICCIoNI200
14r: 40, 1 studiosus A1, instudiosus A1c (i�inter lin.) F φ || 2 natura e A F φ1, natu-rae φ2 || intersperssa A1, interspersa A1c F φ || 3 suppetia A1, suppeticia A1c (ci interlin.), suppetias F φ || 4 nominat A, norant F φ || actor A, auctor F φ || omerus A1,Homerus A1c (h inter lin.) F φ || 5 me om. A || tumero A1, numero A1c (n inter lin.)F φ || libros A F2 φ, liberos F1 || ἀνατομῶν om. A || 6 atque crimina A1, atque F φA1c || pisculum A1, pisciculum A1c (ci inter lin.) F φ || in cospectum A, inspectumF φ || locorum A M1, locarum F φ || 7 ego nichil A, nihil ego F φ || si quae ea siqueat A1, si queat A1c F φ || 8 ostundi A, ostendi F φ || 9 accurratius A1, accura-tius A1c F φ || 10 scit A, sit F φ || 11 scelli A, aselli F φ || 41, 1 fuerat A1, ferat A2
F φ || coco A, coquo F φ
14v: 41, 2 hepetiam A, hepetia F φ || obsono A F1 φ1, obsonio F2 φ2 || accuran-dam A F φ1, accusandam φ2 || in piscem A, inspicere F φ || 3 hariolus A, hariolisF φ || iocinena A1 F φ, iocinera A2 (in mg.) || 4 et1 om. A1, inter lin. add. A2 || 5nunc A M1 V5, num F φ || marinis illecebris om. A1, in mg. add. A2 || negabunt AF1c φ, negabant F1 || Gentuliae A, Getuliae F φ || 6 περὶ… θηριακά om. A || pos-tularent eum A, eum postularent F φ || 7 nihil A, nonnihil F φ || ἀμεταμέλητον…παίζειν (Plat. Tim. 59 D) om. A || 42, 1 tanto A L1, tanta F φ || 2 maleficia magi-ca A, magica maleficia F φ || exdorsare A, exdorsari F φ || 3 secreto aliquo loco A,secreto loco F φ || consociis A, consciis F φ || nesciente A F, nescientem φ || 4 ausiA F φ1, ausi sunt φ2 || 6 philosophum A (sed phy-) φ, philophum F || huius A,eiusdem F φ || legeret rallibus A F φ1, legere Trallibus φ2 || CLX A φ, oLX F || 7idemque A, itemque F φ || quinguentos A, quingentos F φ || Nidigidium A1 (Nigi-dius A2 in mg.), Nigidium F φ
15r: 42, 7 instintos A, instinctos F φ || locorum A φ (o2 in ras.), locarum F ||defossa A φ2, defosso F φ1 || crumena A, crumina F φ || parti A F, parte φ2 (te inras.) || 8 uno A, eo F φ || haberem Catonem A, habere# Catonem F φ (in utroquem eras.) || 43, 1 dicam me A1, dicamne A1c F φ || 2 intersitus A F φ1, intersitas φ2
M1 T L3 V5 || 5 digne om. A || in corpore A, corpore F φ || an A F φ1, aut φ2 T ||7 sum A, sim F φ || 9 morbor A1, morbo A1c F φ || infectus A, confectus F φ || autA, an F φ || facile A, facie F φ || conquessatus A, conquassatus F φ || hebes om. A1,inter lin. add. A2 || 44, 2 adsint A1, adsunt A2 F φ || exhiberi A φ2, exiberi F φ1 ||homines A, omnes F φ || despiciant A, despuant F φ
15v: 44, 3 nega A1, negate A1c F φ || uenire A, uenirem F φ || numerorum A1,numero A1c F φ || 4 conuinctum A, conuictum F φ || rus diu A, rusa de omniumdiu F φ1, nisi rus adeo iam diu φ2 in mg., nisi de omnium consensu rus diu V5 ||oblegatus A, ablegatus F φ || agros A F2 φ, gros F1 || 5 numero A φ, non F || 6opido A1, oppido A2 F φ || qui A, quod F φ || exoleis A φ, exolęis F, exulet T ||adueat A1, aduehat A2 F φ || 7 seruuos A1, seruos A1c F φ || accuratorum A F φ1,accusatorum φ2 (in mg.) M1 L3 || 9 uellem A φ2, uelle F φ1 || etiam add. post ades-set A || tibi om. A1, inter lin. add. A1c || hic om. A || contraxisses A1, contraxissetA1c F φ || 45, 2 nunc A M1, num F φ || 3 pataretur A, pateretur F φ
16r: 45, 4 physicos A, phisicos F φ || exploraret A, exploret F φ || a cuius odorealius librarius in A || odore A F1c φ, odores F1 || 5 caducos A φc, caduco se F φ1 ||7 religionem A F2 φ U L1, regionem F1 || refragaretur A F1c φ, se fregaretur F1 ||
201UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
8 de te A, tete F φ || dementiri A, dementire F φ || ludricum A, ludicrum F φ ||non A, num F φ || aliquis A, aliqui F φ || 46, 1 Tannonius A1 F φ, tanntonius A1c
|| murmure A F2 φ U L1, marmure F1 || spē A, speciem F φ || 2 quo A, quos F φ|| liberalitatis A, libertatis F φ || 3 pollicitus A F, es pollicitus φ, pollicitus es δ || 4respectus A F, respectas φ || dicerit A F, dixerit φ
16v: 46, 5 hoccine bis A F1 φ, hocine bis Fc || 6 exhibui A φ2, exibui F φ1 || 47, 1quod A F φ1, quot φ2 || 2 aut2 om. A || 7 ad A F φ1, at φ1c || nominasti sancit A Fφ1, nominastis an ut φ2 || 48, 1 incantatam a me A, a me incantatam F φ || 2accersero A, accessero F, accessere φ || interdicitis A, dicitis F φ
17r: 48, 3 illi A Fc φc, illis F1 φ1 || ultra A, utra F φ || eorum A, earum F φ || 5 neubi A, necubi F φ || cunctando A, percontando F φ || 6 duddum A1, dudum A1c
F φ || dum A, cum F φ || emolumentum A φ, emulumentum F || incantandi A F1c
φ, intantandi F1 || 8 tertio A F1c φ, tertia F1 || quaesiuisti A, quaesisti F φ || que-reres A, quis ei res F, qui scires φ2 (in ras.) || sunt A, sint F φ || 9 quaeritur A, anqui-ritur F φ || 13 potuero A F, potero φ || 49, 2 igitur om. A || demonstrabit (i. e.demonstrauit) A, docuit F φ
17v: 49, 2 causam morborum omnium trifariam A1 F φ, causa morborumomnium triplex est A1 in mg. || 3 humida A φ (m in ras.), uuida F || 4 ossis A V1V3 V5, ossi F φ || 50, 1 praecipua si A F φ1, praecipua sit φ2 || n morbi A1, morbiA1c F φ || 3 compescant A, compensat F φ || 4 deinde A, dein F φ || arcem etregiam A F1 φ, arcem egregiam F2 || 5 strangulatione A F1c φ, stranguilatione F1
18r: 50, 7 ἱερὰν νόσον om. A || uere om. A || nuncuparent A, nuncuparunt F φ ||sanctissimam steam A, sanctissimasteam F1, sanctissima est eam F2 φ2 (ē in ras.) ||51, 2 redundauit A F2 φ, redudauit F1 || aut quamquam A, haudquaquam F φ ||ceruis A, ceruix F φ || auris A, aures F φ || sonora et A F, sonore et φ || 3 dextraeA ut semper, dexterae F φ || 4 excipiat A, occipiat F φ || 6 non uidentibus A,inuidentibus F φ || 7 praesagio A F1c φ, praesagium F1 || 9 meam ratiocinationemA L1 V5, mea ratiocinatione F φ (sed meam φ2) || rectam A, recte F φ || 10 uanaet A, uana sed F, uanas et φ || calumpnias caducas A, caducas calumnias F φ (sed-mpn-) || 52, 1 si om. A
18v: 52, 1 ipso A, isto F φ || 2 contendere A φ2 (in ras.) L1, contenderi F, si con-tendere V5 T || alii A, aliis F φ || 3 in pauimentis A, pauimentis F φ || 53, 1 cri-minaris A F2 φ, criminari F1 || 2 sudariola A1 (in mg. iter. A2) φ2, sudariolo F, suda-rio φ1 || 4 linteola A φ, linteolo F || 5 quod A, quoniam F, om. φ || omnes A, omnisF φ || 6 fuerunt add. post philosophorum A || accerrimi A1, acerrimi A1c F φ || hiisA, is (pro iis) F φ || umquam om. A
19r: 53, 7 interrogaret A F φ1, interrogares φ2 || 8 etiam ille A, eccille F φ || uobis-cum A, nobiscum F φ || solus A F2 φ2, solas F1 φ1 || signo A, sigillo F φ || 9 enim2
A φ, eui F || 11 fuerit A, uiderit F φ || 54, 1 quod uis A, quiduis F φ || 2 com-minui A, communi F φ || 3 condempnaret A, condemnet F φ (sed -mpn-) || 4 autA, haud F φ || dices A, dicas F φ || si A, sic F φ || 5 ut sumptu A, ut sumtu F φ,utrum tu T
FRANCESCA PICCIoNI202
19v: 54, 6 omnes A, omnis F, os φ || facescitur A, facessitur F φ || 7 statu e femo-re A F φ1, statuae femore φc || assignasti A, signasti F φ || 8 obseruatur A, adserua-tur F φ || promptaria A F, promptoria φ || 55, 2 et A, etiam F φ || 5 est transtulitpost attigerit A || 6 ut rem uentosissimam A, utrem uentosissimum F φ || 7 illa A,illas F φ || obuolutis A, obuolutas F φ || mox A, mos F φ || 8 quia A, qui F φ
20r: 55, 8 prophanis A F, profanis φ || 9 uanas A F φ1, uarias φ2 L2 || 10 deamVenerem… Aesculapii A1 (Venus Esculapius A2 in mg.), oeam ueneram… Aes-culapii F φ || publice A φ, plublice F || magestate A, maiestate F φ || nox sempercesuit A, nos semper censui F φ, nossem percensui v || 12 etiam ʺ ecce A, ecceetiam F φ || auditione A F2 φ U L1, auditionem F1 || ista A F2 φ U L1, istam F1 ||56, 2 Pythagorae scitis A φ2, Pythagora escitis F φ1 || 4 ad A Fc U, adu F1, adij φ|| praetereat A F2, praeter ad F1, praetereat ad φ || gratiam A F φ1, gratia φ2
20v: 56, 7 agnomen uɫ a e duo A, adgnomen tae i duo F1 (tae i litt. maior.),adgnomenta ei duo F2, agnomenta ei φ || duritatem A, diritatem F φ || contemp-tum Mezentius A F1c φ, contemptum ezentius F1 || 8 inducat. animum A, indu-cat animum F φc L1, inducatu animum φ1, inducat in animum edd. uett. || 9 signoA, signum F φ || 10 annuctiare A, enuntiare F φ || 57, 2 iussi A, Iuni F φ || ApioA1 (Apius Quintianus A2 in mg.), Appio F φ || Alexandriae A ut saepe, AlexandreaeF φ || tamen te edoce A U L1, tamentae dae F1, tamen taedae F2, tamen atedae(uel taedae) φ || 4 Vlixi A F2 φ U: alixi F1 || affuit A, afuit F φ || 5 nindorem A1,nidorem A1c F φ
21r: 57, 5 abusque A F, obusque φ || aboleat A, oboleat F φ || 6 pro om. A || 58,1 horam A φ2, horum F φ1 || 2 rectam A, recta F φ || condidisse A, contendisseF φ || quia A, qua F φ || 4 egregia eruditione A F1c φ, egregie ruditione F1 || nomi-no A Fc φ, nommino F1 || 5 interemisset A φ2, intere misset F, interemisse φ1 ||7 ueri simile A F2 φ, ueris simile F1 || 8 fumigatus A F φ1, fumigatos φ2 || 9plumbe ac A F φ1, plumbeae ac φ2 || tam A φ, tan F || usque ad aduentum A,aduentum F φ
21v: 59, 2 an A F1 φ, a Fc || 3 quid A F1c, quod F1 φ || 4 non quin A F1c φ, qui nonquin F1 || ullo om. A || 5 oculis om. A || 6 beluam A φ1c U, baluam F φ1 || specie A,facie F φ || mandetis A, madentis F φ || cilia turgentia A F2 φ L2 L3 V1, ciliatur gen-tia F1 || 7 abligurrium A, abligurriuit F φ || uindicandam A, uenditandam F φ
22r: 60, 2 aut quamquam A, haudquaquam F φ || occulta res A φ U, occultaresF || 3 iste A, ille F φ || 4 obuoluisse A, oboluisse F φ || 5 commoraui A, eumemo-raui F1, commemoraui F1c φ || iudicem timere A, iudice timerem F φ || ne ut A,ut ne F φ || crassum foret A F1c φ, foret crassum F1 || uendidit fumum A, fumumuendidit F φ || 61, 2 colore A, colere F φ || βασιλέα om. A || 4 ut ei praesto essentA, ut ei praesto adesset F1 φ1, ei praesto ut adesset F1c, ut ei ut praesto adesset φ2
|| 5 Saturnius A, Saturninus F φ || 6 geometrias A, geometricas F φ || euoxo A Fφ1, de buxo φ2, buxo M1, e buxo T
22v: 61, 7 mihi1 om. A || impetratus A F1, impetratos F2 φ || materie A, materiaF φ || gratum mihi A, mihi gratum F φ || 8 set A, secundum F φ || ita A F2 φ U
203UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
L1, itam F1 || 62, 1 ʺ audisti ʺ omnia A, omnia audisti F φ || 2 et postea A, posteaF φ || dono mihi A, mihi dono F φ || 3 supplicio A, suspicio F φ || quod A F1c φ,quid F1 || 4 quo A F φ1c, eo φ1, quod φ2 in mg. || tabernacula A, taberna F φ || 5quid est A, quidem F φ || quemquem A F, quamquam φ1, quemquam φ2, quemM1 V5 || affuisse A, afuisse F φ || iussisse A φ, iusisse F || 63, 1 euisceratam A F1c
φ U L1, enuisceratam F1 || larualem A φ2 U L1 M1, laruilem F φ1 || 2 tamen uidensA F φ1, tam euidens φ2 M1 || ademptam A, adempta F φ || 3 quo eum A U L1,ququo eam F, quoquo eam φ || uictimas A F φ1, uictimis φ2 M1 V1 V5 || 4 durumA, dudum F φ || audire A F, audirem φ || scelestum A φ1, sceletum F φ1c
23r: 63, 5 ea A, em F φ || scelestus A φ, sceletus F, scelus L3 || scelestum A, scele-tum F φ || 6 scelestus A F2 φ1, sceletus F1 φ1c || hiccine A, haeccine F φ || 7 en A,em F φ || pala est rici A F1 φ1, pala est risi F1c φ1c || utrique A, utrimque F φ || 9quis A, qui F φ || 64, 1 aut A F2 (a in ras.) L1, duit F1 φ2, det φ1 || malam A φ2,malam magnam F, magna φ1 || oculis A φ U L1, occulis F || 2 abest A F φ1, abes φ2
|| 3 uestiuit A F1 φ, uestigauit F2 || estimo A F1 φ, extimo F1c (d in mg.) || 4 τὸνὑπερουράνιον… νῶτον om. A || 5-7 non a me… quisnam sit ille om. A || baliseusA, basileus F φ
23v: 64, 8 suspicationem A, suspicionem F φ || βασιλέα om. A || tacebo A L1 V5T, taceo F φ || 65, 3 confundam A, confutatam F φ || 5 θεοῖσιν… θεοῖς (Plat. Legg.12, 955 E) om. A || 6 censet et A, censet F φ || immolandas A Fc φ, immolansdasF1 || 7 χρυσὸς… ὡσαύτος (Plat. Legg. 12, 955 E) om. A || 8 post uidetis legitur inA: EGo G. CRISPUS SALUSTIUS EMENDAVI RoME FELIX. Apulei Plato-nici Mandaurensis pro- se- apud Cl. Maximum proconsulem De magia liber primusexplicit. Incipit liber secundus; in F: EGo G. CRISPUS SALUSTIUS EMEN-DAVI RoME FELIX. APULEI PLAToNICI MADAURENSIS PRŌ SĒ APUTCL. MAXĪMŪM PRŌCŌS DE MĀGĪA LĪB I EXPLICIT. INCIP LĪB II.LEGE FELICITER; in φ: Ego Crispus Salustius emendaui Rome felix. APULEIPLAToNICI MADAURENSIS PRo SE DE ARTE MAGIA LIBER PRIMUSEXPLICIT INCIPIT LIBER SECUNDUS MAGIE || 66, 1 unc A (littera Nrubricatori relicta), Nunc F φ || 2 ut A, nisi F φ, et nisi V5
24r: 66, 3 me magum A, magum me F φ || conspexisset A, comperisset F φ || quo-modo A, qui non modo F φ || sene A, sed ne F φ || laesus est A F1 φ, laesos est F2
|| uideretur A F1c φ2, uidetur F1, uideret φ1 || 4 Supplicius A1, Sulpicius A2 (inmg.) F φ || 5 omnes A M1, homines F φ || 6 affuisset A φ1, amfuisset F, aufuissetφ2, abfuisset M1 L3 || capulari om. A || 8 ergo A, ego F φ || Africo A, Afro F φ ||odio A φ1, odium F φ2 || 67, 1 inuidia A Fc φ, inuidiam F1 || Erennium A, Heren-nium F φ || 2 quin A F φ1, quinque φ2 || quas A F1 φ, quo F2 || 3 coactam om. A|| libidinem A F2 φ, lubidinem F1 || tabules A, tabulae F φ || 4 inuidiossima A,inuidiosissima F φ || effundere A F φ1, effuderunt φ2 L1
2, effudere M1 V1 D T δ ||inter mulieri et amanti lacuna trium litt. in F, duarum in φ, deest in A || arbitriisA, arbitris F φ
24v: 67, 6 intellegeretur A (sed intellig-) F2 φ, intelletur F1, intellegetur L2 V1 ||68, 1 efficio A L1 T, officio F φ || recognoscat A, re cognita F φ || perductum A1,inductum A1c (in inter lin.) F φ || ad hoc A, adhuc F φ || feceritis A M1 L1 V5, feci-
FRANCESCA PICCIoNI204
ros F φ, fecistis T δ || mendacii A L1 V5 T, iudicii F φ || 2 A emilia A F, Aemilia φ|| pupillos in potestate aui relictos paterni A, pupillos relictos in potestate paterniaui F φ || 4 inuita A F1 φ, inuitam F2 || nupsisset A F2 (sed -bs-) φ2, nupsisse F1 (sed-bs-) φ1 || 5 condicionem A F2 φ, conditione F1 || 6 pueros A, puerorum F φ || fco(= facto) A, fato F φ || 69, 1 aegritudine A F1 φ1, aegritudinem F2 φ2
25r: 69, 2 intimi A, intimis F φ || extremum A F1c φ1c, extremam F1 φ1 || 3 uali-tudinem om. A || 4 approbant A F, approbabant φ || 5 in mente A, in mentem Fφ || tamen A, tum F φ || aiebat A F φ1, agebat φ2 || 6 illi A, ipsi F φ || seque A, seseF φ || 8 manu A F1c φ2, manud F1, manum φ1 || 70, 1 infestam A F2 φ, infesta F1
|| morat A, norat F φ || 2 etiam nunc A, etiamnum F φ
25v: 70, 4 teste et indice A, testem et indicem F φ || scire A F1 φ1, sciret F2 φ2 ||6 hereditatem om. A || uita A, auitam F φ || eam de A, eandem F φ || 7 uxoris A,uxori F φ || solitudini A F2, solitudinis F1 φ || 8 summo A, supremo F φ || 71, 1istis A φ, histis F || cuiuis liquere posse A, posse cuiuis liquere F φ || 2 petieruntA, petiuerunt F φ || 4 peracceptis A, acceptis F φ || confert A, conferret F φ || 5facultatibus A F2 φ, facultabus F1 || 6 sextertium A φ, sestertium F || possidebat AF2 φ, posidebat F1 || 7 aduersari A L3, auersari F φ || 72, 1 interpretatione A, inter-pretationem F φ, inter precationem M1
26r: 72, 1 numquam A Fc φ, numquam me F1 || uxoris meae om. A || 2 aliquemA, aliquam F φ || 4 honorem A F2 φ1c, horem F1 φ1 || salutem A F2 φ, salutum F1
(.l. in mg.) || 5 saltim A, saltem F φ || hymem A, hiemem F φ || Sirtis A φ, SyrtisF || 73, 1 adiuuatur A F1, adiuuantur F1c φ || 2 publice A F1, puplice F2 φ || fie-remque A, fierem F φ || 3 publicae A F1, puplicae F2 φ || 4 ni id A, nud F1, ut F2
φ || et om. A
26v: 73, 6 quabus A, qualibus F φ || deque A F1, deoque F2, quandoque φ1,denique φ2 M1 V5 || 7 probes pectus semet A, probe spectassem et F2 (a et sem inras.) φ2, probes pect# semet φ1 || uirtutum A φ, uirtutium F || matrimoniali quan-tisper A F1 φ, matrimoni aliquantisper F2 || 8 mallet omnibus aliis A, aliis omni-bus mallet F φ || 9 tantam horam A, tantulam moram F φ || 74, 1 transgredi A F2
φ, trangredi F1 || errorem A φc, herrorem F φ1 || 2 conspecta A M1, conspecti F (din mg.) φ || disciuisse A, desciuisse F φ || matrimonium nostrum ne A, ne matri-monium nostrum F φ || 3 quamuis A, quamquam F φ || animi foeda A, foedaanimi F φ || et illi A, eccilli F φ || reliquit A φ1c, reliquid F φ1 || 4 perpaucis A, K
paucis F, paucis φ || nisi A F φ1, nam si φ2, ne si M1 || 5 hic est A φ, K hic est F ||fautor A, fax F φ || intemperantissime A F2 φ, intemporantissime F1 || 6 istis A φ,histis F || litium omnium A, omnium litium F φ || fasorum A, falsorum F φ
27r: 74, 7 exonis A F1 (uel exoms) φ1, exossis F2 φ2 || impuditiam A, impudicitiamF φ || 75, 1 qua A F, in qua φ || deperduint A F, deperdunt φ || 2 comisatoribus A(sed -mm-) F1, comesatoribus F2 φ || ad introeundum metus est ulli A, ulli adintroeundum metus est F φ || 4 iam A, K iam F1, hic iam F2 (in mg.) φ2, Ic iam φ1
|| illa A F1, inquam illa F2 φ || et inter A, inter F φ || non tam A F φ1, nota φ2 M1V5 T || abscedunt A, discedunt F φ || et quasi A F1 φ2, et qui quasi F2 φ1 || 5 facietA, faciat F φ || 6 hominibus A, omnibus F φ || 7 flax A F φ2, fax φ1 || depascitur A,
205UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
depaciscitur F φ || 8 totus A, tutus F φ || reliquit A φ2, reliquid F φ1 || sextertiumA, sestertium F φ || XXX A, XXX F φ || 9 crederis (uel credens) A, crederes F φ
27v: 75, 9 nequit A, ne quid F φ || 76, 1 effecta A F1, effeta F2 φ || 3 imaginariumA φ, ymaginarium F || derelictum A F1 φ1, derelictam F2 φ1c || 4 pudore dispolia-to A F1c, pudore dispolito F1, dispoliato pudore φ || 5 disciplinam A F2 φ, disci-plina F1 || immeditatum A, imeditatum F, meditatum φ, immedicatum M1 V5 ||77, 1 quadrigiens A F1, quadragiens F2, quadragies φ2 (a2 in ras.) || post sump-tionem A, praesumptione F φ || deuorat A, deuorarat F φ || in ea moliendum A,mea moliendum F φ || 2 obiurgaret A, obiurgare F φ || quia A, quam F φ || refe-rat A M1 L1 V5 δ, se ferat F φ || res A, rem F φ || 3 faciat A F1c φ, faciant F1 ||abducturum A F1c, abducturam F1 φ || 4 defletit A, deflectit F φ
28r: 77, 5 ut A, it F φ || 6 accensisse A, accessisse F φ || alumentum A F1, aIu-mentum Fc, adiumentum φ, alimentum D L2, alimenta L1 || 78, 1 iram extimuitA, ira extumuit F φ || ita ut A, ut F φ || digna A F φ2, dignam φ1 || 2 mortem AF2 φ2 (in ras.), moram F1 || 4 clitemestrae A φ2, clite menstrae F (d in mg.) φ1 ||mollitia A F2 φ, molitia F1 || 5 famossimas A, famosissimas F1, formosissimas F2
(inter lin.) φ || agebant A, aiebant F φ || 6 praedicatione A, praedicationem F φ ||79, 1 escausabundus est A, excusabundus e F φ, excusabunda et D, excusabundase V5 || Fedra A, Phaedra F φ || hominibus A, omnibus F φ || 2 animo etiam A,etiam animo F φ
28v: 79, 2 ʺ tandem ʺ quanto A, quanto tandem F φ || 3 quintum est A, quin-tum e F φ1, quin tu me φ2 L3, quid non M1 || a maleficii A1, maleficii A1c F φ || 4qui A, igitur F φ || qui si A, quid si F φ || 5 adque A, atqui F φ || 6 inquit animiA φ2, inquid animi F φ1, inquieti animi V5 || efflictim A F2, efflictum F1 φ || 80,1 ergo1 om. A || nesciit A F2 φ, nisciit F1 || 2 se A, sese F φ || 3 non putabat A F1
φ, putabat F2 || clamatis A, clamantis F1 φ, clamantes F2 || 4 deuerticulum A F1,diuerticulum F2 (i1 in ras.) φ
29r: 81, 1 me A, memet F φ || obmissa A, omissa F φ, obnisa M1 || 2 tam2 om. A|| 3 quis isyphas A (sed ysi-) F2, qui sisyphas F1 φ, quis Sisyphus v || PhirinondasA, Phrinondas F φ (sed fri-) || 4 machi A φ, macchi F, macci v || bachones A, boc-chones F φ, buccones v || 5 mirum A F1 φ, merum F2 || corrobore A, robore F φ|| quod A, quae F φ || conuerteretur A, transuerteretur F φ || 82, 2 Ἀπολέιος…σωφρονῶ om. A || 3 interposuit A, interposui F φ || excepta A, excerpta F φ || 5qua eris A F, quaeris φ || consciuere A, conciuere F1 φ, conciuesre F2 (s inter lin.)|| 7 si A, sic F φ || 8 cui quaelibet auis A, cuiauis F φ || defraudentur A F2, defru-dentur F1 φ
29v: 82, 9 tunc om. A || 83, 1 βουλομένην… σωφρονῶ om. A || 2 uolarent A F2 φ,uolerent F1 || 3 tumultu A Fc φ, tumultum F1 || 4 ne ascultarent A, nec ausculta-rent F φ || 6 aures A, artes F φ || 7 nunc A F2 φ, nun F1 || se fert A F φ1, se effert φ2
M1 || calumpnias emergit A φ, caluminas emergit F || 84, 1 amens amens A, amensamans F φ || 2 ἐγὼ… ἐκφ om. A || 3 magica A1, magia A1c F φ || uix A, uis F φ
30r: 84, 6 corroborentur A, corroborarentur F φ || 7 promulgari A, prouulgari Fφ || 85, 2 proconsul A, procōs (= proconsulari uel proconsulis) F φ, proconsuli M1
FRANCESCA PICCIoNI206
|| strupra A, stupra F φ || 3 ab oculos obseruas alius librarius (fortasse Zanobi) inA || 5 infautis A, infausti F φ || 6 fodiatur A, foditur F φ || 8 praeco qui bis A F1
φ1, praecoqui bis F2 φ1c, praecoci bis v
30v: 86, 1 olimpiadis A F1, olimpiaden F1c, olimpiadem φ || 2 aduersus bis A,aduersum bis F φ || 3 ncquam A, numquam F φ || alias om. A || 4 ac tam A F1c φ,ad tam F1 || optuto A (sed obt-) F φ1, optutu φ2 || capesceret A F, capesseret φ || 5tuis A L1 L2 V5 T, fuis F, suis φ || 87, 1 neque inanimum A F2 φ, neque unanimumF1, nequeo in animum M1 || me A F φ1, mei φ2 L3 || 2 ergo A, ego F φ || 4 con-scriberem A, scriberem F φ || tam A, tamque F φ || 5 ubi A, ut F φ || legeret A1,legit A1c (it inter lin.) F φ || 6 ἐλθὲ… σωφρονῶ om. A
31r: 87, 8 opilionum A, upilionum F φ || equisionum A, equisinum F1, equiso-num F1c (o inter lin.) φ || subscriptis A, subscripsisse F φ || munitum A1, moni-tum A1c (ɫ mo inter lin.) F φ || uere A F, uero φ || 10 populum A F φ1, in populumφ2 || 11 sint A, sunt F φ || 88, 1 nummum A1 F φ, nummorum A1c (morum interlin.) || 3 ncquam A, numquam F φ, nusquam M1 || dicito A, ducito F φ || 4 siliceA F2 φ, scilice F1 || 6 παίδων… ἐπὶ σπορᾷ om. A (deest uersus in mg. m. recentiss.)|| 89, 1 paucis tibi A, tibi paucis F φ || nec A, necesse est F1, necesse non est F2
(non inter lin., esse est del.) φ
31v: 89, 2 asseruantur A φ2, adseruantur F1c φ1, adferuantur F1 || iam om. A || 3lignum A, linum F φ || 4 est A, sit F φ || ille A, ipse F φ || 5 bis A F1c, huis F1, hisφ || inuenias A, inuenies F φ || 6 audeas sesquealtera A, audesesque altera F φ,audes sesquialtera M1 L1 V5 T || duxisses A, dixisses F φ || pro computationis A,computationis F φ || aperisse A φ, adperisse F, aperuisse V5 || 7 numerasti A F φ1c,nominasti φ1 || 90, 1 et A, etsi F φ || 2 poterint A F, potuerint φ1c (ue in ras.) ||uel ad malitiam A F1 φ, uel malitiam F1c || 4 si nusquam A M1 L2 L3, sinus quamF, sinusquam φ
32r: 90, 5 quamlicet A, quamlibet F φ || 6 his Moses A F, hismesos φ || 91, 1 sus-citarunt A, suscitarint F φ || 2 rusum A, rursum F φ || 3 praetabilius A, praesta-bilius F φ || 4 nacci A F φ1, nauci φ2 || 7 modo A F φ1, modo promissam φ2 (m.saec. XVI in mg.) L3 V1 V5 || 8 coniectionem A F φc, coniectationem φ1 || uno om.A || obedisse A, obisset F φ || 92, 1 Aemilianum A F φ1, Aemilianus φ2 || num-mum A1 F φ, nummorum A1c (morum inter lin.) || filii A, filiis F φ || 2 capiens Aφ1c, capens F φ1 || dotabit A, dotauit F φ || 3 locuplex A, locuples F φ || multis A,et multis F φ
32v: 92, 5 nulli A, molli F φ || 6 nouum A F, nouam φ2 (a in ras.) || acceptissimamaritis A, maritis acceptissima est F φ || 7 cum1 om. A || 8 inpossibile A, inrepos-sibile F φ1, irreposcibile φ2 || ab om. A || suspectans A F1c φ, expectans F1 || 9 utscaeui om. A, uacuo relicto quinque uel sex litt. || oīs (= omnis) A, ominis F φ || 10regressa A, digressa F φ || habes A F φ1, habet φ2 V1, habens M1 L1, habeat V5 ||11 docte A, dote F φ || acta A1, aucta A1c (u inter lin.) F φ || 93, 1 animo om. A ||2 quod est A, quem F1, quod F1c (đ in ras.) φ || 3 uilia estimatis A F φ1, uili aesti-matis φ2 || 4 re A, se F φ
207UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
33r: 93, 4 olei A, oliui F φ || 5 ex ea quam tribuisset parte A, ex ea parte quamtribuisset F φ || 6 res om. A || exaudi A, extudi F φ || 94, 2 dum A, cum F φ ||postularet A, postularat F φ || 5 acceptis A F1c φ, utceptis F1 || operiebatur A φc,opperiebatur F φ1 || 6 errorem A φ, herrorem F || discendi A, dicendi F φ || 7 etquidem A F2 φ, et quide F1 || perlegam A L1, praelegam F φ || tu om. A || fuerintA, fuerunt F φ || 8 tempore A F φ1, temporis φ2 || 95, 3 me A, in F φ || 4 malis AF φ1, malit φ2 || sic A, si F φ || cum A F2 φ, cu F1
33v: 95, 5 orationem A φ, oranem F1, oratinem F2 || neque Gr. … neque Caes.… neque ort. A, nec Gr. … nec Caes. … nec ort. F φ || Grachus A φ1, GracchusF, Graccus φ2 || 6 retractum A F1, detractum F2 φ || 96, 1 commemorationi A,commemoratione F φ || ratio A, oratio F φ || 2 audesne ne A, audesne F φ || teergo A φ, ´´ergo te´´ F (´´ inuersionis signa fort. ab ead. m.) || illum A, ille F φ ||cum A F φ1, eum φ2 M1 L3 V1 || 3 debuisses A, debes F φ || doluisset om. A || 4acta om. A || in eo A, meo F φ || uictricum A, uitricum F φ || 5 Cartagine A φ,Carthagine F || summum A, supremum F φ || 6 promisit A F1 φ1, praemisit F1c
φ2 || plenas amoris plenas honoris A, plenas honoris plenas amoris F φ || 97, 1tempore A φ, tepore F || 2 promere A, promerem F φ
34r: 97, 4 Chaldeos A (sed cal-) φ, Chaldeus F2 (litt. redint.) || confixerunt A, con-finxerunt F φ || 7 heres A, heredes F φ || aliquam A φ L3, aliquem F, alioqui v || 98,1 ait A F φ1, at φ2 L3 V1, ac M1 || 2 temperat A F1c φ, temperet F1 || ac fouet A F1c
φ, fouet F1 || 3 a me hoc A, hoc a me F φ || suggessistis A φ, suggesistis F || 4 tuampietatem A, pietatem tuam F φ || 5 aduersarie A F1 φ1, aduersare Fc φc, aduersarisφ2 (inter lin.) M1 L1 || 6 fugela om. A || in conuiuium A, conuiuium F φ
34v: 98, 7 conuiuo A, conuiuio F φ, conuiuiorum M1, in conuiuio v || honesteA, honestus F φ || 8 a om. A || adhuc graecissat A, graecissat F φ || Latine enim Aφ, enim Latine F || loqui om. A || 9 donassetne A φ2, donasetne F φ1 || adiuuanteA, adnitente F φ || donate A, donata F φ || 99, 1 uos qui A, uosque qui F φ || 2post hoc A, posthac F φ || nil boni A, boni F φ || quod A, đ (= quid/quod) F,quide φ || priuignus A F, priuigni φ || 3 Pudentille A F1c φ1, Pudentilla F1 φ2 ||scripserit A T V5 M1, scribseret F φ1c, scriberet φ1 L3 V1 D, scripsit L1 V2 || in-signes A, insignis F φ || exheredaret A φ, exberedaret F (inter x et e incerta littera,fort. b) || 4 oraui A φ1c M1 L3, orauit F φ1 || ne A1, ni A1c F φ || 5 hunc se A F φ1,huncce φ2 || obstupuerit A, obstipuerit F φ || terras A, terram F φ || 6 ratus A φ1c,ratis F φ1 || aequi A, aeque F φ
35r: 100, 2 nequis A, ne si quid F φ || tabulis A F1c φ, tabulin F1 || 3 uerum A,uere F φ || quini A F φ1, quidni φ2 || 5 potius legis A, lege potius F φ || Scinius A,Sicinius F φ || hoc A F2 φ, ho F1 || 6 donauerat A, donaueras F φ || 9 maritum AF2 φ, maritu F1 || efflictum A, efflictim F φ || accusabat A, accusauit F φ || 101, 1adicio A F φ1, abicio φ2 || qui A, quid F φ || 2 potuit A, poterit F φ || 4 ne quidA φ, c nequid F || praeteream A M1, praetereum F φ || magna A L1 M1 T V2,magia F φ || 5 nummorum A, nummum F φ
35v: 101, 6 Coruius A, Coruinius F φ, Coruinus D L3 T M1 V5 || uir ornatus AF2 φ, uiror natus F1 || tutor A F, tu tutor φ || 8 non bis A, num bis F φ || 102, 1
FRANCESCA PICCIoNI208
quod A F1c, quid F1 φ || amplam A φ, ammpla F1, ammplam F2 || 3 adhortatu Aφ, adhortatu# F (eras. compendium pro m) || 3 ante me illis A, illis ante me F φ ||4 deuinctam A, deuincta F φ || heredem de relinqueret A1, heredem relinqueretA1c F φ || difficilem A, difficile F φ || 5 substituite A F1c φ, sustituite F1 || 6 remi-niscimini A, eminiscimini F (d in mg.) φ || 7 necesse A F1 φ, nekesse F1c || adhor-tum A F φ1, adortum φ1c || 8 hostenditur A F, ostenditur φ || 9 quia ommutuistisA, quid ommutuistis F φ || belli A, libelli F φ || formatum A F2 φ, formormatumF1
36r: 103, 1 demum A, deinde F φ || 2 splendidos A φ, spendidos F || 4 me om. A|| 5 tuam estimationem A, existimationem tuam F φ || quam potestatem uereriom. A || a procōs A φ2, ac procōs F φ1 || improber A φ, improbe# F (eras. r) || postdixi legitur in A F φ: Apulei Platonici Madaurensis pro se (sed prosae F φ) de magialiber secundus explicit. Ego Salustius emendaui Rome felix.
ABSTRACT
In the frame of recent research concerning the manuscript tradition ofApuleius’ De magia with the aim of exploiting a few witnesses so far disregarded,in spite of their significant contribution to the constitutio textus, a thorough col-lation of the Ambrosianus N 180 sup. (= A) has been effected. The hypothesis hasbeen often advanced that this codex, the best representative of Class I, belongs toa collateral recensio, independent from Laur. Plut. 68.2 (= F), usually consideredthe ancestor of the entire tradition and the codex optimus. The fresh collation ofA strongly suggests its dependence from F; so, the numerous exact readings of A,in correspondence with mistakes or graphic inaccuracies in F, can be easily inter-preted as slight conjectural adjustments. However, the importance of theAmbrosianus codex is not invalidated. In fact, just as Robertson and Giarratanohave proved for metamorphoses, we can confirm for De magia too that A keeps afacies of F close enough to the original, not yet damaged by time and not yetaltered by later hands. And the closeness of A to F is, in many cases, superior tothat of Laur. Plut. 29.2 (= φ), normally considered the best apograph of F. So, Ais a necessary instrument to check the numerous readings of F now unattainable.The data collected through the autoptical collation of A are systematically sup-plied for the first time.
FRANCESCA PICCIoNIUniversità di Torino
209UN MANoSCRITTo RECENzIoRE DEL DE mAGIA DI APULEIo
FIG. 1. PARTICoLARI DEL CoD. MILANo, BIBLIoTECA AMBRoSIANA, N 180 SUP.
Grafia di s
1a mano 2a mano
a. fol. 15v, l. 29 b. fol. 16r, l. 2 c. fol. 16r, l. 2
Grafia di x
1a mano 2a mano
d. fol. 15v, l. 5 e. fol. 15v, l. 10 f. fol. 16r, l. 3 g. fol. 16r, l. 29
Compendio per -tur
1a mano 2a mano
h. fol. 15v, ll. 26-27 i. fol. 15v, ll. 27-28 l. fol. 16r, l. 19
Segno tachigrafico per et
1a mano 2a mano
m. fol. 15v, l. 12 n. fol. 15v, l. 16 o. fol. 17r, l. 6 p. fol. 17r, l. 28
FRANCESCA PICCIoNI210
INDICE GENERALE
Gabriel Nocchi MacedoFormes et fonctions de l’astérisquedans les papyrus littéraires grecs et latins 3
Luigi PiacenteSul prestito librario nell’antica Roma 35
Enzo PugliaLa rovina dei libri di Anzionel De indolentia di Galeno 53
Paolo MiliziaConsiderazioni sul segno di fine paroladel mediopersiano epigrafico 63
Diletta MinutoliUn codice di Giona tra Firenze e Berlino:PSI X 1164 + BKT VIII 18 93
Daniele BianconiUn altro Plutarco di Planude 113
Maaike ZimmermanAge and Merit:The Importance of recentiores and incunabulafor the Text of Apuleius’ Metamorphoses 131
Francesca PiccioniUn manoscritto recenziore del De magia di Apuleio: il cod. Ambrosiano N 180 sup. 165