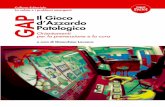"Gioco d'infanzia" di Giovanni Comisso: dal manoscritto alla stampa
Transcript of "Gioco d'infanzia" di Giovanni Comisso: dal manoscritto alla stampa
Miryam Grasso
Gioco d’infanzia di Giovanni Comisso: dal manoscritto alla stampa
1. Genesi del testo
Scritto tra il luglio del 1931 e l’aprile del 1932, Gioco d’infanzia fu ispirato dal Grand Tour orientale che aveva impegnato Comisso tra il 1929 e il 1930. Il roman-zo accolse tra le sue pagine i pensieri e le avventure che non avevano potuto trovare spazio nei reportages pubblicati tra la primavera e l’estate del 1930 sul “Corriere della Sera” (poi rivisti e raccolti nel volume Cina-Giappone)1. Oltre al viaggio in un Oriente mitico e carico di sensualità, che aveva condotto Comisso verso una progressiva liberazione dei sensi vissuta come ritorno alla fanciullezza, alla stesura di Gioco d’infanzia contribuì anche il clima culturale europeo di quegli anni, che vide l’affermarsi del culto dell’infanzia e dell’adolescenza e la diffusione del mito degli enfants terribles – soprattutto grazie alla “Nouvelle Revue Française” e, in Italia, a riviste come “Solaria” e “La Voce”.
La prima stesura del romanzo è tramandata dal manoscritto conservato pres-so l’Archivio Comisso della Biblioteca Comunale di Treviso. Si tratta dell’unico testimone autografo ad oggi disponibile. Il manoscritto, che consiste di quattro quaderni scolastici, include anche una serie di appunti preparatori inediti che rivelano il progetto di realizzare un’opera di più ampio respiro, intitolata Vita d’androgine, suddivisa in tre parti. Gioco d’infanzia sarebbe confluita all’interno di questa trilogia come prima parte; la seconda e la terza parte, invece, sarebbero state dedicate rispettivamente al proseguimento del viaggio in Oriente e al ritorno in Europa di Alberto, protagonista dell’opera.
Le annotazioni rivelano un’opera progettata con precisione e costruita su un equilibrato intreccio tra due piani temporali: il presente del viaggio e il passato e i ricordi di Alberto. Il gioco di richiami e rimandi sarebbe stato evidente soprat-tutto nel finale, che avrebbe dovuto riprendere due episodi del primo romanzo della trilogia.
Nel corso della scrittura di Gioco d’infanzia, Comisso non mancò di manife-1 Giovanni Comisso [= C], Cina-Giappone, Milano, Treves, 1932.
84 Otto/Novecento, 2/2014
stare il suo entusiasmo, soprattutto nella corrispondenza con i Mazzolà2. A stesura conclusa inviò una copia del romanzo a due lettori d’eccezione: Umberto Saba e Benjamin Crémieux. Saba giudicò l’opera positivamente3, mentre Crémieux, pur complimentandosi, avanzò alcune riserve sulla struttura dell’opera, lamentando la natura ripetitiva degli episodi erotici4.
Comisso, pur non mostrandosi totalmente convinto dalle critiche di Crémieux, decise comunque di dedicarsi a una revisione dell’opera, che considerava ancora incompleta5.
L’opera sarà pubblicata solo nel 1965 da Longanesi in appendice a una nuova edizione di Amori d’Oriente6, in una forma che si discosterà notevolmente da quella del manoscritto. Nel passaggio all’edizione a stampa, infatti, numerosi brani ed episodi verranno soppressi, e Comisso – com’era tipico del suo modus operandi – introdurrà una serie di ritocchi e correzioni che interesseranno soprattutto la grafia e la punteggiatura.
Non è possibile conoscere nel dettaglio le fasi e le modalità della revisione di Gioco d’infanzia. Non si conservano, infatti, bozze o autografi di stesure intermedie dell’opera. Inoltre, negli anni che precedono l’edizione definitiva, Comisso non fa più parola del romanzo né nei suoi diari, né nella corrispondenza. Possiamo quindi ricostruire il processo di revisione solo parzialmente, tenendo conto delle modifiche introdotte già nel manoscritto del 1931-32 e dei brani pubblicati separatamente, su rivista o in raccolta, tra gli anni ’30 e gli anni ’50.
2 In una lettera a Maria Mazzolà del 27 luglio 1931, Comisso si riferisce a Gioco d’infanzia chiamandolo «capolavoro» (C, Vita nel tempo: lettere, 1905-1968, a c. di Nico Naldini, Milano, Longanesi, 1989, p. 167). In una lettera del 22 gennaio 1932, invece, dice che il suo lavoro ha «una linea umana veramente grande» e di essere sicuro di poter «toccare la fine mirabilmente» (C, Trecento lettere di Giovanni Comisso a Maria e Natale Mazzolà: 1925-1968, a c. di Enzo Dematté, Treviso, Editrice Trevigiana, 1972, p. 70).
3 Saba, in una lettera a Comisso datata 28 maggio 1932, scrive di Gioco d’infanzia: «Credo che, dopo les Enfants terribles di Cocteau, sia il più bel libro moderno che ho letto». Aggiunge anche: «La morte del padre è tra le più belle cose del libro; ma non è la più bella: tutto il libro è ugualmente bello» (Rolando Damiani, Notizie sui testi in C, Opere, a c. di Damiani e Naldini, Milano, Mondadori, 2002, p. 1684).
4 Dopo aver letto il romanzo, Crémieux scrive: «Je comprends qu’il vous soit impossible de publier ce livre en Italie, mais ne croyez pas qu’il vous sera très aisé de lui trouver en France un édi-teur. / La difficulté résulte de ceci que votre livre ne progresse pas, n’aboutit pas. A partir de la page 80, on a l’impression que vous piétinez sur place, que vous égrenez vos souvenirs érotiques et qu’il n’y a aucune raison que vous ne continuiez pas jasqu’à la page 300 au lieu de vous arrêter à la page 111. Le sujet central du livre, qui est la conquête de la liberté sexuelle, la volonté de se limiter au domaine de la sensualité est traité à fond dans les 80 premières pages. Celles qui suivent ne sont pas de moindre valeur, mais elles n’apportent (sauf l’anecdote) rien de nouveau au lecteur. Et le lecteur attend un dépassement de cette sensualité et il est déçu de ne pas le trouver» (ibidem, pp. 1683-4).
5 Cfr. C, Vita nel tempo: lettere, 1905-1968, cit., p. 173.6 Gioco d’infanzia e Amori d’oriente sono indissolubilmente legati tra loro. Le affinità tra i due
romanzi, scaturiti entrambi dallo stesso viaggio in Oriente, non riguardano solo la materia narrati-va, ma si manifestano anche nelle concordanze e nelle precise riprese testuali che li caratterizzano.
85
2. Descrizione dei testimoni
2.1. Il manoscritto
L’autografo conservato nel Fondo Comisso (ms. 9, I, 1) è costituito da quattro quaderni scolastici rilegati insieme. Per una svista dell’autore o di chi si occupò di sistemare il materiale dell’archivio la posizione del secondo e del terzo quaderno risulta invertita; l’ordine corretto è indicato dalla numerazione romana presente sulle copertine anteriori.
I fogli dei quattro quaderni sono rigati e solitamente sono utilizzati sia sul recto che sul verso.
Il primo quaderno consta di trentanove carte. La numerazione va da 1 a 75, quindi per pagina, con i numeri trascritti solo sul recto di ogni carta, nell’angolo destro del margine superiore. Nella numerazione, pertanto, compaiono solo i numeri dispari (fanno eccezione il 34, probabilmente per una svista dell’autore, e il 60, trascritto però sul verso e con matita rossa). Nel margine superiore del recto della prima carta è trascritto il titolo dell’opera, Gioco d’infanzia, con accanto un’in-dicazione temporale, «Luglio 1931», mese in cui inizia il lavoro di composizione. Immediatamente sotto è presente un altro titolo, «L’umano desiderio». Si tratta, come vedremo più avanti, del titolo originario della trilogia Vita d’androgine che Comisso aveva progettato di scrivere. Il verso dell’ultima carta del quaderno con-tiene un breve elenco di parole, per lo più illeggibili perché vi è stato sovrapposto lo schizzo di una natura morta. Nel margine inferiore sono annotate alcune cifre. Sulla copertina posteriore sono stati appuntati alcuni indirizzi e altre cifre e calcoli. L’inchiostro utilizzato è di colore nero. La numerazione delle pagine è trascritta a matita; inoltre, alcune parole nel testo sono state sottolineate con una matita rossa, forse nel corso del processo di revisione. La parte compresa nel quaderno si conclude con la lunga sequenza in cui Alberto ricorda la morte del padre.
Il secondo quaderno è composto da quarantuno carte, l’ultima delle quali è un foglio non rigato. La copertina anteriore è firmata. A differenza del primo quaderno, la numerazione non è per le pagine, ma per le carte. Il numero è apposto sempre nell’angolo destro del margine superiore del recto. Le prime diciotto carte e le ultime due non sono numerate; sulla diciannovesima è trascritto il numero 19, mentre le carte seguenti sono numerate da 1 a 20. L’indicazione temporale presente su questo quaderno – anche in questo caso aggiunta nel margine superiore del recto della prima carta – è «ott. 1931». Il verso della terzultima carta e il recto e il verso delle ultime due carte contengono una serie di schemi e di elenchi di parole chiave. Sulla copertina posteriore sono presenti altre annotazioni e un disegno. L’inchiostro utilizzato è di colore nero; l’inchiostro blu è utilizzato solo per una nota sulla copertina anteriore e per sottolineare l’annotazione «ott. 1931», separandola così da un’aggiunta in margine superiore che fa parte del testo del romanzo. Viene utilizzata anche la matita per alcune integrazioni agli appunti nella parte finale. Il quaderno contiene la parte della narrazione che va dal secondo incontro con Hans fino alla prima parte dell’episodio della caccia alle gazzelle.
Il terzo quaderno comprende trentasei carte, tutte rigate tranne l’ultima e
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
86 Otto/Novecento, 2/2014
una carta aggiuntiva, assicurata alla terzultima carta con un fermacampione. Si tratta del foglio di guardia anteriore del quarto quaderno; sul recto è trascritto solo il numero romano «IV», mentre il verso include una sequenza narrativa aggiunta in un secondo momento. Tutte le carte sono numerate. La numerazione presenta anche in questo caso alcune irregolarità: va da 31 a 33, quindi da 24 a 26, infine da 2 a 31. Alla carta del quarto quaderno è assegnato il numero 32, come si evince anche dall’annotazione «vedi pag 32 IV», trascritta nel punto del testo dove do-veva essere inserito il passo contenuto nella carta aggiuntiva. Il foglio di guardia posteriore del quaderno non è numerato e ne è utilizzato solo il recto, che include altri appunti preparatori: una scaletta e un elenco di parole chiave. Sulla copertina posteriore è annotato un indirizzo. Anche in questo caso è presente una data nel margine superiore del recto della prima carta, «genn 1932». L’inchiostro utilizzato è esclusivamente di colore nero. Il quaderno include la parte che va dalla conclusione dell’episodio della caccia fino all’arrivo a Colombo.
Del quarto quaderno, che include la conclusione del romanzo, sono utilizzati solo il recto e il verso delle prime nove carte e il recto della decima carta. Anche in questo caso le carte sono numerate, sempre nella stessa posizione, dal 32 al 41. In questo caso sono presenti due date: una, «20 marzo 32», nel margine superiore del recto della prima carta; l’altra, «Pasqua 1932», subito sotto la conclusione del romanzo. Anche in quest’ultimo quaderno l’inchiostro adoperato è nero.
2.1.1. Gli appunti inediti
Prima di tentare una classificazione degli interventi di modifica introdotti nel manoscritto, è opportuno soffermarsi sugli appunti inediti contenuti nei quaderni. Essi ci permettono di entrare nel laboratorio comissiano, fornendoci importanti informazioni sia sul metodo di lavoro seguito dall’autore che sulla genesi dell’opera.
Come si è già detto, nel primo quaderno è presente una lista di parole chiave; sono chiaramente leggibili, però, solo le parole «Madre» e «Marzo».
Il secondo quaderno è il più ricco di appunti: si tratta di una serie di schemi ed elenchi di parole chiave che occupano le ultime pagine. I primi tre schemi oc-cupano due facciate, e rappresentano la struttura che avrebbe avuto la trilogia Vita d’androgine. Questo titolo è appuntato sopra i tre schemi, nel margine superiore del verso della carta di sinistra, ed è preceduto da «L’umano desiderio» cassato (probabilmente un primo titolo, scartato in un secondo momento).
I tre schemi sottostanti corrispondono ognuno alle tre parti che avrebbero composto l’intera opera. Al di sopra di ogni schema sono collocati un numero romano che ne indica la posizione nell’ordine della trilogia («I», «II», «III») e un titolo: «Verso l’infanzia» per il primo schema, «Sotto il vento giallo» per il secondo, «Solitudine e sterilità» per l’ultimo.
Nella parte inferiore del primo schema, a destra, si legge l’annotazione «Per Pasqua»; sotto il secondo, sempre a destra, è annotato: «maggio / giugno / luglio / agosto»; infine, sotto l’ultimo schema è annotato «1933». Si tratta di indicazioni relative a una probabile data di composizione di ognuna delle tre parti dell’opera.
Tutti e tre gli schemi sono costruiti allo stesso modo. Ognuno di essi è com-
87
posto da una linea orizzontale che occupa le due pagine; al di sopra e al di sotto della linea è collocata una serie di cerchi collegati alla linea orizzontale. I cerchi racchiudono all’interno parole, sintagmi e nomi di località corrispondenti agli episodi che avrebbero costituito la struttura narrativa dell’opera; sono disposti da sinistra verso destra, secondo l’ordine della narrazione. In ogni schema, la parte inferiore alla linea è riservata agli episodi del presente, mentre la parte superiore è riservata a un piano temporale diverso, ossia al passato, ai ricordi che quegli episodi e quelle avventure risvegliano. Sempre nella parte superiore sono collocate eventuali annotazioni aggiuntive, non relative ad episodi specifici, ma alla struttura narrativa in generale.
Alcuni cerchi sono collegati tra di loro, rispecchiando quel gioco di rimandi e richiami che avrebbe caratterizzato l’opera. È questo il caso, ad esempio, del cerchio corrispondente al finale della terza parte. Essa avrebbe dovuto riprendere due episodi della prima parte. Il cerchio, all’interno del quale si legge: «Come il vecchio di lungomare», è collegato attraverso una linea a un cerchio del primo schema con scritto all’interno «Chioggia lungomare». Al di sotto del cerchio vi è l’annotazione: «come un albero di veliero che abbattuto cade in mare, marcisce e si riduce a polvere sulla sabbia / Riprendere il motivo avuto alla morte del padre. (A)», in cui (A) è un segno di richiamo che rimanda a un’annotazione presente nel primo quaderno del manoscritto di Gioco d’infanzia («(A) riprendere in fine al libro»), tra le pagine in cui Comisso scrive dell’episodio della morte del padre di Alberto. E la figura del «vecchio di lungomare» rimanda all’episodio corrispon-dente a «Chioggia lungomare» trascritto nel secondo quaderno: una passeggiata sulla spiaggia densa di presagi di morte. Evidentemente si trattava di due episodi di importanza cruciale per Comisso.
Probabilmente, nell’andare avanti con la scrittura degli episodi corrispondenti, Comisso procedeva cassando i vari cerchi degli schemi, uno dopo l’altro. Ciò è probabile perché l’unico schema in cui la maggior parte dei cerchi risulta cassata (mediante l’apposizione di segni a forma di croce) è il primo, che corrisponde anche all’unico dei tre romanzi che Comisso scrisse.
Sul verso della penultima carta del quaderno si leggono i seguenti elenchi:“amicizia con Pietro.”Porto Said.“Morte del padre”col marinaio.“Lotte di famiglia appena finita la guerra.
ricordi di guerraricordi di campagna | Piave / Ernesto. / cochi.ricordi d’infanzia | Maria. / ragazzi gigli onigo sera
guerra
cameriere.marinaio.
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
88 Otto/Novecento, 2/2014
ufficialetedescopasseggeri
«Guerra» risulta cerchiato, così come «ufficiale». Gli elementi dell’ultimo elenco sono raggruppati mediante una parentesi graffa aperta.
Sul recto dell’ultima carta troviamo altri tre schemi, molto più sintetici rispetto a quelli delle pagine precedenti. Sopra ogni schema è aggiunto un numero romano che identifica la parte dell’opera corrispondente.
Lo schema corrispondente alla prima parte è costituito da tre riquadri posti uno accanto all’altro: «Morte del Padre», «Lungomare di Chioggia», «Infanzia»; sottostante a ogni didascalia è una lettera dell’alfabeto (rispettivamente A, B e C).
Anche lo schema corrispondente alla seconda parte è costituito da tre riquadri, in questo caso disposti verticalmente: uno superiore, all’interno del quale è scritto: «Follia»; uno intermedio, tripartito: «Sud Cina», «Shanghai», «Giappone»; uno inferiore, con all’interno «Pekino».
Lo schema della terza parte, infine, è identico allo schema della prima; le tre parti individuate sono in questo caso «Paese Natale», «Parigi» e «Dissoluzione».
Al di sotto di questi tre schemi troviamo un elenco di parole chiave raggrup-pate da una parentesi graffa con accanto la parola «Sensualità»:
infanziaadolescenzagiovinezzaguerradopoguerraviaggio[illeggibile]Parigi
Il recto dell’ultima carta del terzo quaderno è invece occupato dal seguente elenco:
1) Postriboli – nausea – ritorno / al cugino e / a Ernesto.2) guerra – licenza – ragazzi – / vecchio – (alternative) / della libertà delle offerte3) dopoguerra – furore in crescendo.
Seguono quindi:
Seilon Penang
infanzia (Giardino – gigli. | uominifigurine – [illeggibile].)Jino.
Balia – mammelle.
89
2.1.2. Interventi sul manoscritto: correzioni, aggiunte, espunzioni
A pagine che testimoniano una stesura sicura e priva di ripensamenti, con ritocchi minimi o del tutto assenti, si alternano nel manoscritto pagine affollate di inter-venti. Alcune correzioni e varianti seguono sulla stessa riga la lezione precedente cassata e sono state quindi introdotte in itinere, contemporaneamente al processo di scrittura. Altre modifiche sono state introdotte sfruttando gli spazi interlineari o i margini della pagina; non essendo però presenti visibili differenze tra gli inchiostri adoperati, non sappiamo quali interventi tra questi siano stati immediati e quali, invece, tardivi e introdotti in occasione di una (o più) riletture.
Sul piano della grafia, gli interventi di modifica sono quasi del tutto assenti; si tratta per lo più di correzioni di errori ortografici e sviste di vario genere («ra-nicchiato» → «rannicchiato»; «mecca» → «Mecca»; «alberto» → «Alberto»; «dipi-gere» → «dipingere»; «sampe» → «zampe»; «camice» → «camicie»; «colleggio» → «collegio») o di aggiustamenti di maiuscole e minuscole nel caso in cui vengano modificati i confini della frase e la punteggiatura.
A livello morfologico, talvolta all’uso della seconda persona plurale reveren-ziale si sostituisce quello della terza persona singolare («alla vostra ironia» → «alla sua ironia»; «Vi prego» → «La prego»; «Non c’è bisogno che nascondete il vostro desiderio» → «Non c’è bisogno che nasconda il suo desiderio») o viceversa («può fare quello che vuole» → «potete fare quello che volete»). È presente, in particolare, un’oscillazione tra il lei e il voi nei dialoghi tra Alberto e il personaggio di Hans, che nella stampa si risolverà a favore della terza persona. Abbastanza frequente è anche la sostituzione di tempi verbali, principalmente dell’indicativo imperfetto con il passato remoto.
Sono frequenti i casi in cui il soggetto viene reso implicito dalla frequente espunzione del pronome personale egli. Altre volte, con tendenza inversa, il sog-getto è reso esplicito mediante aggiunta di egli o dei nomi propri dei personaggi. Altri pronomi espunti frequentemente sono loro, esso e gli.
Spesso risultano soppressi anche sintagmi (es. «nell’attimo immediatamente successivo al tramonto»), proposizioni o frasi («lo guardava avidamente con uno sguardo fermo»; «Intese, fino a che non venne l’ora di cena annunziata dai colpi del gong»; «Ora egli sentiva lontano quel tempo, ma riconosceva di essersi strana-mente riavvicinato. col sogno»).
Gli interventi più frequenti sul manoscritto consistono nell’aggiunta di singole parole (oltre ai soggetti, spesso sono aggiunti aggettivi o avverbi: timide, piccolo, appena, ora), sintagmi («ad Alberto», «del vaporetto», «sino al ventre», «per la partenza»), proposizioni («se ne aveva da conoscere», «senza sentirne la minima pena») o frasi indipendenti («Ne farò un capolavoro», «Ed egli attendeva che s’av-vicinassero»). Di solito si tratta di aggiunte negli spazi interlineari o in altri spazi rimasti liberi sulla pagina, come ad esempio i margini.
Numerose sono le varianti introdotte attraverso la sostituzione di parole o sintagmi («per mettersi in bocca una sigaretta» → «per mettersi alle labbra una sigaretta»; «trentina di lire» → «pugno di lire»; «i fanali dell’auto» → «i fanali della macchina»; «colorati di blu» → «colorati di azzurro»; «Hans se n’accorse» → «Hans
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
90 Otto/Novecento, 2/2014
si volse per vedere»; «a contatto della carne» → «a contatto del corpo»; «toccherebbe a lei di consolarmi» → «toccherebbe a lei di farmi coraggio»), per lo più per mezzo di aggiunte in interlinea sopra la lezione precedente cassata, e talvolta sulla stessa riga, a destra della lezione scartata. Più raramente, la nuova lezione è scritta su quella eliminata o è ricavata dalla precedente mediante l’aggiunta o l’espunzione di prefissi o suffissi («rosa» → «rosata»; «salì» → «risalì»; «mattinata» → «mattina»).
Le sostituzioni, naturalmente, non sono motivate solo dal gusto personale dell’autore; spesso sono operate per evitare ripetizioni, quando la lezione scartata è già presente all’interno dello stesso periodo in una delle proposizioni successive.
È interessante soffermarsi su una sostituzione in particolare, giuocare in luogo di divertirsi, all’interno di una sequenza – censurata nel passaggio all’edizione a stampa – dal contenuto omoerotico, nella quale si racconta l’incontro con il ma-rinaio. Quando Alberto gli chiede chi altri prima di lui lo abbia trovato bello, il marinaio risponde:
– Ero imbarcato come sguattero in un vapore mercantile che andava da Genova all’A-merica. Io dormivo vicino alla cucina, solo, una notte sento aprire la porta, subito volevo gridare credendo che fosse qualche marinaio che venisse a rubare, invece era l’ufficiale in seconda. Voleva un bicchiere d’acqua e caffè, poi si sedette sul mio letto. Voleva giuocare. Venne quasi tutte le sere ed aveva una grande paura che suo figlio che era a bordo come marinaio, potesse accorgersene. Aveva una paura che mi faceva ridere. Lasciavo che si di-vertisse e mi dava sempre qualcosa così quando sbarcai a Genova mi trovai con duecento lire messe da parte... (I, c. 7v.)
La sostituzione è forse operata per evitare una ripetizione, visto il successivo divertisse. La scelta di giuocare, però, non sembra casuale: le parole appartenenti alla sfera semantica del gioco hanno infatti un’importanza cruciale in Gioco d’infanzia, fin dallo stesso titolo, come è evidente rileggendo la conclusione del romanzo nell’edizione del ’65:
“I miei piaceri” si disse, “non sono stati che un proseguimento dei miei giochi d’in-fanzia”. Ebbe il senso del tempo.
“Verrà un giorno” si disse ancora, “che qualcuno mi porterà giù per le scale della mia casa, chiuso in una bara, ma io avrò eseguito interamente il mio gioco d’infanzia.”7
È evidente, dunque, come i termini relativi al gioco facciano riferimento all’omosessualità e alla possibilità per il protagonista di ritornare all’infanzia e alle sue prime esperienze sessuali con i compagni di gioco di allora, illudendosi così di perpetuare la fanciullezza per ingannare il «senso del tempo» ed esorcizzare la paura della morte.
Per quanto riguarda gli interventi di riscrittura, questi interessano soprattutto brevi passi. Spesso Comisso è intervenuto per renderli più sintetici e ottenere una maggiore concentrazione semantica («Pensava che i nuovi paesi che l’attendevano non sarebbero state che delle delusioni» → «prevedeva sicura la più completa delu-sione»; «disse che tutte le donne ànno il sangue una volta al mese» → «spiegò ogni cosa») o, al contrario, per aggiungere dettagli e particolari («Attese nella stanza per
7 C, Amori d’oriente e Gioco d’infanzia, Milano, Longanesi, 1965, p. 286.
l’ora indicata» → «Il letto ampio fatto per gli amori, la stanza segreta gli rendevano piena di lusinghe l’attesa»).
Le riscritture che coinvolgono interi brani sono quasi del tutto assenti. L’au-tore, di solito, si è limitato a cambiare solo l’ordine interno ai brani, suddividendo il testo in brevi porzioni mediante barre verticali e numerando i segmenti così ottenuti, aggiungendo i numeri corrispondenti nell’interlinea superiore.
In diversi casi la narrazione è stata integrata aggiungendo nuove sequenze. Quando queste aggiunte erano troppo estese per essere contenute nei margini superiore o inferiore della pagina, venivano trascritte su pagine ancora inutilizza-te – quando necessario, anche su pagine di altri quaderni – e separate con linee orizzontali dal testo principale. Con l’uso di richiami, l’autore ha poi indicato il punto in cui le avrebbe inserite. Ne riportiamo di seguito qualche esempio, nella forma definitiva tramandata dal manoscritto. Uno di questi passi è un’aggiunta alla narrazione della caccia alle gazzelle:
Alberto s’interessò subito a lui: “È da molto tempo in colonia” gli chiese guardandolo negli occhi grigi e chiari fortissimi nella pupilla contratta dalla luce. “Tre anni, eh! oramai sono un vecchio coloniale!” e sorrise increspando le guance asciutte e rosee. “Non sembra, la vedo così per nulla abbronzata” ribatté Alberto divertendosi di vederlo arrossire e rimanere confuso, lo tolse egli stesso dall’impaccio: Lei sconvolge la teoria che sia questo sole che faccia annerire questa gente; e non à l’aspetto di essere un uomo da ufficio.” L’ufficiale di bordo li interruppe sollecitando di prendere. (III, c. 2.)
Il brano seguente, invece, è quello trascritto sulla carta staccata dal quarto quaderno e inserita all’interno del terzo, e descrive l’attesa snervante di Alberto all’appuntamento con l’ufficiale a Colombo:
Ritornò sotto al portico camminò fumando. Le luci gli riescivano acutissime punte. Non vedeva che esse. Tutto il resto gli riappariva confuso sotto l’impulso della sua rabbia. Erano le sette e trequarti. Egli oramai era sicuro che non sarebbe più venuto. Se ne sentiva convintissimo. “O non à potuto venire, oppure è sceso a terra con altro mezzo ed è anda-to a divertirsi per suo conto.” si diceva e pensava che egli che così francamente gli aveva assicurato che sarebbe stato alle sette precise sul molo era capacissimo di mentire. Eppure non poteva decidersi ad andarsene. Accese una sigaretta e si disse che appena finita se ne sarebbe andato. La finì e rimase: “Al prossimo arrivo del motoscafo. Basta, me ne vado.” Il motoscafo arrivò. Nessuno discese, si diede ad imprecare contro di lui. Il motoscafo ripartì, l’onda venne a sbattere contro le pietre e si decise di contare fino a trecento poi se ne sarebbe andato. I numeri gli morivano a fior di labbra, arrivò al cento e smise seccato. Uscì dal portico:
In altri casi, invece, i richiami sono stati utilizzati per modificare la posizione di una sequenza all’interno del testo e spostarla più avanti o più indietro.
Alcuni brani risultano soppressi già nel manoscritto, anche se le espunzioni nel passaggio alla stampa sono decisamente più vistose e numerose. Tra i passi più consistenti ad essere stati espunti nell’autografo vi sono alcune parti del dialogo tra Alberto e il marinaio, contenuti nel secondo quaderno:
“Non ài mai posato per nessuno” gli chiese Alberto.
91Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
“No, ma dei signori ànno voluto farmi delle fotografie.”“Come? così col tuo coltello da lavoro al fianco; lo sai che ài un aspetto da pirata? Il
marinaio sorrise e (II, c. 4v.)
[...] e rispondergli:“Sì, me l’ànno detto altri?”“Chi? delle donne?”“Anche.”“Ma, anche dei signori? però non ti devi muovere.”Il marinaio ritornò nella posizione di prima e stando così disse:“Qualche forestiero a bordo. (II, c. 5r.)
Nel terzo e nel quarto quaderno sono stati soppressi anche i seguenti passi:Ma Alberto finiva coll’accorgersi come questo ufficiale fosse divenuto il suo pensiero
costante e si riprometteva alla tappa di Colombo di stare con lui e di realizzare il suo desiderio. Comprendeva la sua timidezza e circospezione tra i compagni e non voleva pregiudicare quanto all’ultimo incontro era stato raggiunto. (III, c. 21v.)
Ora ripensava alla prima donna che aveva avuto, l’anno prima di andare soldato. Ma quello gli era già più diverso e lontano, del ragazzo di otto anni. C’era uno dei compagni di scuola che ambiva di essere l’iniziatore dei vergini (III, c. 24v.)
“Ma come sono belli questi isolani. Osservate questo” e gli indicò il ladro di ombrel-le. “Sono belli e corrottissimi” disse Hans che scrutava una per una le fotografie. “Poi ne cercherò qualcuno per voi, ora voglio osservare bene i tipi pericolosi.” “Andiamo” disse Alberto. Trovava esagerato che Hans volesse ingraziarsi la sua riconoscenza con questa precauzione, ma l’idea del piacere lo lusingava. (IV, c. 1r.)
Il brano soppresso più esteso è quello che riguarda l’incontro di Alberto con Cribol, uno dei suoi compagni di giochi durante l’infanzia. L’autore aveva inizial-mente intenzione di inserire il passo nel testo mediante un richiamo. Il brano, poi, è stato interamente cassato e scartato, forse perché ritenuto superfluo:
Durante un periodo di licenza dal fronte, s’erano incontrati in treno. Cribol ritornava sul Carso, dove aveva più volte combattuto. E gli aveva detto: “Bei tempi, quando s’andava al Piave a nuotare. Se vuoi che ritorniamo a vivere come allora io sono pronto a darmi disertore.” Alberto non aveva avuto il coraggio di acconsentire, aveva capito come l’anima di lui avesse amato quei giorni con più potenza della sua. Poi dopo la guerra aveva saputo ma con incertezza che s’era dato disertore, che era stato in prigione, un pizzicagnolo di quel paese che aveva incontrato in città, come gliene chiese gli aveva risposto che era finito male e che era meglio non parlarne. (III, c. 30.)
2.2. I brani pubblicati su rivista
Prima dell’uscita del romanzo nel ’65, Comisso pubblicò alcuni brani estratti dal romanzo su alcune riviste italiane e francesi e in volume.
Come si è già detto, non disponiamo di testimoni autografi per il periodo compreso tra la prima stesura del romanzo e l’uscita dell’edizione a stampa. In
92 Otto/Novecento, 2/2014
93
quegli anni l’autore si dedicò sicuramente ad altre stesure, che purtroppo sono andate perdute. Gli unici testimoni (anche se di natura parziale) che risalgono a questo periodo intermedio sono i brani del romanzo pubblicati separatamente in quegli anni.
Non tutte le testate, tuttavia, sono facilmente reperibili, anche perché Comisso spesso pubblicava racconti e articoli su riviste locali o di scarsa diffusione.
A questi testimoni si aggiunge il materiale autografo conservato presso la Biblioteca di Treviso, relativo all’episodio della morte del padre.
Di solito la versione pubblicata su rivista si caratterizza per ritocchi alla grafia e alla punteggiatura, varianti, aggiunte ed espunzioni, e si colloca a metà strada tra l’autografo e l’edizione a stampa: conserva ancora parte delle lezioni del pri-mo, ma presenta già varianti e modifiche che è possibile ritrovare nella seconda. In alcuni casi, tuttavia, Comisso preferisce ritornare indietro alla versione meno recente. Come è già stato osservato da Rolando Damiani8, del resto, nel corso della revisione di un’opera Comisso non adottava mai una linea correttoria precisa e non si atteneva in maniera coerente a un modello specifico di lingua scritta, ma modificava il testo di edizione in edizione «come se avesse una ineliminabile e perenne scrittura d’istinto»9.
L’episodio della morte del padre fu pubblicato su “Letteratura” nel 1937 con il titolo «La morte del padre». Nel Fondo Comisso della Biblioteca Comunale di Treviso si conservano una copia delle pagine della rivista contenenti l’episodio con alcune correzioni autografe e una versione dattiloscritta dello stesso brano, intitolata «La presenza del padre» (ms. 10, II, 1). Il dattiloscritto non è datato, ma è probabilmente successivo alla pubblicazione su “Letteratura”, dato che presenta ulteriori modifiche rispetto al manoscritto, oltre a includere quelle già introdotte nel ’37. Con questo stesso titolo, l’episodio venne pubblicato nel 1963 nel secondo volume di Nuovi racconti italiani10, in una versione pressoché identica a quella del dattiloscritto, dal quale differisce solo per alcune varianti.
Da un confronto tra le diverse versioni dell’episodio è evidente come Comisso fosse solito tornare su quanto scritto, introducendo di volta in volta una serie di modifiche e ritocchi più o meno consistenti. La maggior parte delle varianti riprese nell’edizione a stampa risulta introdotta già nella versione pubblicata su “Lette-ratura” e nel dattiloscritto; quando in entrambe le occasioni sono state introdotte varianti e Comisso non ne inserisce una completamente nuova nella stampa, di solito è la variante del dattiloscritto, più recente, ad essere preferita – ma non sempre: in alcuni casi viene recuperata la lezione della versione pubblicata nel ’37.
La breve sequenza censurata nell’edizione del ’65, riguardante il ritorno a Milano dopo la morte del padre, risulta già espunta nel ’37: la narrazione si ferma al viaggio di ritorno e alle riflessioni di Alberto suscitate dal paesaggio, che egli osserva dal finestrino del treno.
8 Cfr. Damiani, Notizie sui testi, cit., p. 1756.9 Ibidem.10 AA.VV., Nuovi racconti italiani 2, a c. di Luigi Silori, Milano, Nuova Accademia Editrice,
1963, pp. 165-79.
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
94 Otto/Novecento, 2/2014
Il secondo episodio uscito su “Letteratura” è Lungo la spiaggia del mare, pub-blicato sulla rivista nel 1940. Si tratta di una sequenza in cui Alberto ricorda una passeggiata lungo il mare carica di presagi di morte. Di questo brano abbiamo realizzato un’edizione che è stata posta in appendice, alla quale rimandiamo.
L’incipit del romanzo, infine, uscì con il titolo Gioco d’infanzia sulla rivista “Ca Balà”, probabilmente negli anni Cinquanta. Una copia del brano, ritagliata dallo stesso Comisso, è conservata nel Fondo omonimo; dal ritaglio non si può evincere la data. Come nei casi precedenti, la versione pubblicata su rivista conserva ancora molti elementi in comune con il manoscritto, ma presenta già alcune modifiche che saranno riprese nell’edizione a stampa – in particolare, l’espunzione di alcuni brevi passi. Introduce, inoltre, alcune varianti che non saranno conservate nel passaggio alla stampa, in quanto Comisso preferirà recuperare la lezione dell’autografo.
2.3. L’edizione a stampa
Anche nel caso dell’edizione del ’65 di Gioco d’infanzia Comisso non sembra avere seguito un progetto definito nel corso della revisione; sembra essersi affidato an-che questa volta al suo gusto personale. È comunque possibile individuare alcune tendenze negli interventi di modifica.
Per quanto riguarda il piano della grafia e della fonetica, le forme che pre-sentano elisione o troncamento sono sostituite con le corrispondenti forme piene («d’un» → «di un»; «s’era» → «si era»; «s’allontanava» → «si allontanava»; «gran» → «grande»; «pur» → «pure»; «son» → «sono»).
Nel caso delle preposizioni articolate formate a partire da con, la forma sin-tetica è sostituita con quella analitica («con» → «con i»; «col» → «con il»; «colla» → «con la»).
Frequente è anche l’eliminazione delle d eufoniche nei casi in cui non avviene incontro tra due vocali identiche, ma a seguire la congiunzione e o la preposizione a è una parola che inizia con vocale diversa.
La punteggiatura è oggetto di numerosi ritocchi: i segni di interpunzione ven-gono ora eliminati, ora aggiunti, ora sostituiti; i confini delle frasi o dei capoversi vengono spesso modificati.
Sul piano della morfologia ritroviamo alcune tendenze presenti già nel ma-noscritto. Tra queste, la sostituzione della seconda persona plurale reverenziale con la terza singolare, per lo più in dialoghi nei quali si utilizza la terza singolare in tutte le altre battute e la seconda persona plurale è presente solo per via di una probabile svista dell’autore: nel primo dialogo del secondo quaderno tra Alberto e Hans, nel quale alcune battute erano state modificate allo stesso modo, come si è già visto, nell’autografo («Ma credete che si possa fare distinzione?» → «Ma crede si possa fare distinzione»; «Cosa è la vostra anima» → «Cosa è la sua anima»; «I vostri sensi non ànno limiti» → «I suoi sensi non ànno limiti»; «causa di una vostra maggiore infelicità» → «causa di una sua maggiore infelicità»); in uno scambio di battute tra Alberto e l’amico dell’ufficiale («Non avete altra passione che questa?» → «Non à altra passione che questa?»); in alcune battute all’interno di un altro dialogo con Hans («Portatemi in qualche parte» → «Mi porti da qualche parte»;
95
«Non dovete preoccuparvi» → «Non deve preoccuparsi»; «il vostro buddismo» → «il suo buddismo»; «la vostra vocazione» → «la sua vocazione»). In un caso, inoltre, la terza persona singolare viene sostituita con la seconda plurale. Si tratta di una domanda che Alberto indirizza a un personaggio al quale si rivolge usando sempre il voi: il pescatore che incontra durante la passeggiata lungo il mare («Cosa è che pesca?» → «Cosa è che pescate?»). La variante è presente già nella versione pubblicata su rivista dell’episodio.
Più frequenti rispetto al manoscritto sono anche le modifiche ai tempi verbali.Si riconferma la tendenza all’eliminazione del pronome personale soggetto.
Talvolta il soggetto è reso implicito anche quando corrisponde a un nome proprio. Molto ricorrente è l’eliminazione dell’aggettivo possessivo suo, come quella di congiunzioni (a essere interessata è soprattutto e, specie se collocata all’inizio della frase). Piuttosto frequenti sono le inversioni nell’ordine delle parole («data solo» → «solo data»; «chiara giungeva» → «giungeva chiara»; «grinze minutissime» → «minutissime grinze»; «uscire subito» → «subito uscire»; «fu subito» → «subito fu»; «più non trovarono» → «non trovarono più»; «caldo umido» → «umido caldo»).
Accanto alle numerose sostituzioni di carattere occasionale, vi sono alcune pa-role, sintagmi e avverbi sistematicamente sostituiti in tutto il testo («piroscafo» → «nave», «l’uomo dai baffi» → «il vecchio cacciatore», «sino» → «fino», «ci» → «vi»).
Talvolta vengono recuperate nell’edizione a stampa alcune lezioni scartate nel manoscritto: è, ad esempio, il caso di cannocchiale, nel manoscritto sostituito con binoccolo. Nel riscrivere frasi e passi più estesi, a volte Comisso procede semplifi-cando e sintetizzando («teneva fissi su di lui gli occhi» → «lo fissava»; «una delle sue mani rossicce e contorte» → «la mano contorta»; «avido e timoroso subito gli rivolse la domanda» → «gli chiese»); altre volte, invece, aggiunge sintagmi, proposizioni o periodi, o rielabora la sequenza modificandone l’ordine interno. Forniamo di seguito alcuni esempi di passi riformulati; a sinistra trascriviamo la versione definitiva tramandata dal manoscritto autografo (A), a destra la versione dell’edizione a stampa (St).11
11 L’edizione alla quale si fa riferimento è quella del 1965, già citata alla n. 7.
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
A StTutti questi particolari di quei giorni lon-tani egli aveva rivissuto in quell’ora incer-ta tra la notte e l’alba, navigando nel Mar Rosso. Il mare balenava d’una luce che non era più quella della luna. Con la freschezza dell’aria si sentiva libero dall’incubo che lo aveva svegliato; era contento della sua vita passata, si compiaceva dei suoi eccessi come di passaggi obbligati del suo spirito. A poco a poco il sonno lo riprese socchiudendogli gli occhi sul cuscino che era tutto umido del suo sudore. (I, c. 39r.)
Dopo questa rievocazione poté riprendere il sonno e dormì sereno fino all’alba. (p. 228.)
In questo caso, Comisso condensa un brano del manoscritto in un’unica frase, eliminando una breve sequenza introspettiva.
A StAd un tratto l’ufficiale disse: “Qui ci so-no degli sciacalli, se si fosse ferito, la cosa può essere seria.” “Ma non è possibile! co-me può essersi ferito?” domandò Alberto con fermezza. “Eh! chi sa mai, un salto, un colpo partito inavvertitamente dal suo stesso fucile, le combinazioni sono tante!” Ad Alberto non importava [...] (III, c. 2v.)
[...] e disse: “Non si sarà ferito?”. L’ufficiale si rivolse a guardarlo e si passò una mano sulla fronte, come per togliersi il sudore. L’altro continuando sempre a guidare, dis-se: “Come vuole che si sia ferito, non è un ragazzo”.“Si fa così presto, un salto, un colpo par-tito inavvertitamente dal suo stesso fucile, le combinazioni sono tante” disse Alberto e proseguì perché si divertiva vedere l’uffi-ciale soffrire.“Il brutto è che qui vi sono gli sciacalli e se è stato ferito, all’odore del sangue...” Intese l’ufficiale trarre un sospiro e lo vide rannic-chiarsi, non gli importava del suo dolore, né che l’altro fosse rimasto ferito o ucciso, [...] (p. 259.)
Le battute che nel manoscritto erano pronunciate dall’ufficiale nella stampa sono dette da Alberto. La preoccupazione dell’ufficiale risulta più evidente, grazie alle aggiunte con le quali il passo è arricchito («si passò una mano sulla fronte, come per togliersi il sudore»; «si divertiva vedere l’ufficiale soffrire»; «Intese l’uffi-ciale trarre un sospiro e lo vide rannicchiarsi»). Meglio descritto è anche lo stato d’animo di Alberto, sempre mediante aggiunte («si divertiva vedere l’ufficiale»; «del suo dolore, né che l’altro fosse rimasto ferito o ucciso»).
96 Otto/Novecento, 2/2014
97
A StRicordava i suoi cappelli rialzati sulla fron-te secondo la moda del tempo, e la stanza vicino alla cucina dove ella dormiva, il suo letto largo, ed ella nei pomeriggi estivi, quando sua madre dormiva, lo portava nel suo letto: il grande caldo pomeridiano, la stanza in penombra gli faceva mettere la testa sotto le sottane: l’odore acuto della sua carne, tra il pelo, in mezzo alle gambe; radicato nella sua anima; ora era riappar-so, sentiva con sicurezza d’aver vissuto quel momento, ma non poteva convincersi d’es-sere stato lo stesso. Non ricordava quanti anni egli poteva avere allora, ma pensava che non dovevano essere più di sette od otto. “L’Elvira! L’Elvira.” Si ripeteva, non poteva ricordare più altro di lei; camminava impettita. (III, c. 24r.)
La sua serva, mentre sua madre dormiva, lo portava nella sua stanza, vicino alla cucina, nel suo letto largo e come per dargli il buio che doveva indurlo al sonno gli cacciava la testa sotto alle sue sottane e aveva sentito l’odore acuto della sua carne, quell’odore che si era radicato nella sua carne e ora era riapparso.Quella donna, quella serva di casa, aveva i capelli rialzati sulla fronte secondo la moda del tempo e camminava impettita. (p. 272.)
I particolari che riguardano la descrizione dell’aspetto della serva, che nel manoscritto si trovavano in apertura e in chiusura del brano, qui vengono rag-gruppati alla fine, in un unico breve capoverso. Alcuni particolari presenti nel manoscritto, inoltre, vengono eliminati («il grande caldo pomeridiano», «la stanza in penombra»), così come una consistente porzione della parte finale del passo.
Anche il finale del romanzo risulta riscritto:
A StApparve la luce tra le fronde delle palme agitate in cima agli esili tronchi da un vento inavvertibile. Alberto si alzò in piedi. Alcu-ni indigeni spingevano in mare le barche in secca, alzavano una piccola vela bianca e quadrata e partivano. Allora con pronta ebrezza riconfermò a sé stesso come nei suoi piaceri egli non continuava altro che i suoi giuochi di fanciullo. E come questi volevano sopravvivere in lui nella certez-za d’essere le gioie libere e più intense nel mondo oppresso dal lavoro e dalle leggi.L’ordine delle cose tra la luce irruente, il vento, le acque ondulate e gli uomini gli appariva preciso e inalterabile ed egli si sen-tiva in esso, vivere sicuramente. (IV, c. 10r.)
Apparve la luce tra le palme agitate da un vento inavvertibile. Alberto si alzò in piedi. Sulla spiaggia alcuni indigeni spingevano in mare le barche.“I miei piaceri” si disse, “non sono stati che un proseguimento dei miei giochi d’infan-zia.” Ebbe il senso del tempo.“Verrà un giorno” si disse ancora, “che qualcuno mi porterà giù per le scale della mia casa, chiuso in una bara, ma io avrò eseguito interamente il mio gioco d’infan-zia.”La luce cresceva irruente assieme al ven-to tra le palme e il mare. Sulle barche gli indigeni alzarono piccole vele bianche e partirono.L’ordine di ogni cosa gli apparveinalterabile. (p. 286.)
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
98 Otto/Novecento, 2/2014
Il finale nella versione di St non è rassicurante come quello di A: Alberto non si sente più «vivere sicuramente» all’interno dell’ordine inalterabile delle cose, anche perché i suoi piaceri non sono più le «gioie libere» contrapposte al mondo «oppresso dal lavoro e dalle leggi». Alberto avverte ora «il senso del tempo» e sa che i suoi piaceri non sono altro che un modo di perpetuare l’infanzia e di sfuggire, in questo modo, al tempo e alla morte; ma sa anche che il gioco si concluderà, e allora non potrà più evitare la «bara». A consolarlo pare esserci solo la certezza che, per allora, avrà «eseguito interamente» quel gioco. Le aggiunte di brani nell’edizione a stampa sono rare.
Il passo seguente è integrato alla fine del brano in cui Alberto ricorda l’incon-tro con il «vecchio di lungomare»; così come la passeggiata, anche questo ricordo lo induce a pensare alla morte:
Gli spuntò improvviso il ricordo della allegra e gioiosa speranza dei vitelli, quando abitava in campagna: nell’andare ad abbeverarsi sfuggivano al bovaro e saltavano per il cortile con la coda rialzata diritta. Erano passate decine di anni e quei vitelli erano ineso-rabilmente finiti al macello e all’annullamento anche delle loro ossa. (p. 236.)
Un’altra aggiunta, che comporta però anche una parziale sostituzione, è alla fine del secondo quaderno. «L’ho sentito sparare verso i piedi della montagna» diviene:
[...] lo sentivo sparare sulle stesse gazzelle che poi venivano a fuggire dalla mia parte. Dopo che ò visto il gruppo di cinquanta, ò sparato come un pazzo, poi non ò più sentito sparare dalla sua parte.» Sembrava preso da un incubo nascente. L’altro era sicuro di avere inteso uno sparo, lontano verso le pendici della montagna e pensava si fosse inoltrato da quella parte. L’ufficiale guardò penosamente il cielo che si oscuriva. (pp. 257-8.)
Spesso modifiche o brevi aggiunte si riscontrano laddove un brano è stato censurato. In alcuni casi viene ripresa una piccola porzione del brano eliminato. Ad esempio, in corrispondenza del primo episodio censurato nel secondo quaderno viene ripresa una domanda di Hans, «Stasera mi porterete la frutta?». La frase che nell’autografo segue il brano soppresso, «Alberto si ritirò nella sua cabina», viene modificata: «Hans si era avvicinato ad Alberto e quasi aggressivo gli disse: “Stasera mi porterà la frutta.” Alberto lo promise e si ritirò nella sua cabina».
Talvolta le riprese non si limitano a qualche frase, ma l’autore recupera passi più estesi del brano censurato, rielaborandolo. È il caso, ad esempio, di un brano del terzo quaderno nel quale l’autore condensa nell’unica figura di un cugino, Mario, i personaggi del cugino stesso (il cui nome non è però presente nel mano-scritto) e di Cribol, mentre diversi passi vengono ripresi e rimaneggiati, modifican-done l’ordine. In molti casi, tuttavia, l’autore non ritiene necessario aggiungere o riprendere nulla, limitandosi alla semplice espunzione della sequenza interessata.
Per quanto riguarda i brani soppressi, questi sono numerosi e più o meno estesi: si va da passi lunghi poche righe a sequenze che occupano diverse pagine del manoscritto. Naturalmente non si può parlare di censura in tutti i casi in cui una sequenza viene espunta; spesso si tratta di parti del testo ritenute per qualche ragione superflue ed eliminate a vantaggio di una maggiore compattezza narrativa.
99
Non sempre, inoltre, le censure consistono nell’eliminazione di sequenze. Nel brano citato di seguito, nella versione del manoscritto, Alberto pensa per un istante all’abbraccio materno durante un amplesso (e questo pensiero, insieme ad altri elementi presenti nel romanzo, potrebbe essere considerato un sintomo del complesso edipico del protagonista12):
A StAllora si infervorì, l’avrebbe percossa, sof-focata, la strinse quasi ringhiando. – Sta ferma. – le ripeté con violenza. Ebbe pre-sente sua madre nell’atto di abbracciarlo prima di partire, poi l’imagine si confuse coll’ufficiale che aveva visto quel giorno sul ponte di comando, e il piacere gli si accrebbe, infine, alto, sospeso tra la luce e il vento rivide il marinaio, il suo volto gli apparve vicino, rosso, carnoso, compiacen-te: chiuse gli occhi, tra barbagli di luce e si abbatté contro la donna che serpeggiava per sciogliersi. (II, c. 31r.)
Allora si inferocì, l’avrebbe percossa, soffo-cata, la strinse quasi ringhiando: <<Sta fer-ma>> le ripeté con violenza. Ebbe presente l’ufficiale visto sul ponte di comando e il piacere gli si accrebbe, infine alto, sospeso tra la luce e il vento rivide il marinaio, il suo volto gli fu vicino, rosso, carnoso, compia-cente, chiuse gli occhi tra barbagli di luce e si abbatté contro la donna che tentava di sciogliersi. (pp. 246-7)
È probabile che Comisso, giudicando il momento in cui Alberto pensa alla madre un elemento non presentabile ai suoi lettori, abbia preferito riscrivere il passo.
I brani censurati hanno un contenuto principalmente – ma non esclusiva-mente – omoerotico13. Alcuni riguardano episodi erotici del viaggio (come la scena nel bagno pubblico di Porto Said, o l’incontro con il marinaio), altri riguardano ricordi del protagonista, come gli incontri con altri soldati in guerra o i “giochi d’infanzia”, le prime esperienze sessuali vissute prima con i compagni di giochi, poi con i compagni di scuola. Anche la sequenza che descrive la permanenza di Alberto in una «piccola città sul mare, vicino a Venezia» è incentrata su un incon-tro erotico, in questo caso con una donna. Ad essere esclusi dall’edizione del ’65, però, non sono soltanto brani caratterizzati da un contenuto che poteva essere considerato sconveniente. L’autore, ad esempio, sopprime anche una sequenza in cui Alberto scrive una lettera alla madre e a un amico, alcuni passi in cui ricorda della passeggiata lungo il mare di Sottomarina e un breve ricordo di guerra.
12 Nel romanzo Alberto compie un percorso caratterizzato da un continuo fuggire e ritornare all’imago materna, che può essere cancellata definitivamente solo nella bara. Cfr. Gilbert Bosetti, Il mito solariano dell’infanzia e della adolescenza nell’opera narrativa di Giovanni Comisso, in AA.VV., Comisso contemporaneo. Atti del convegno. Treviso, 29-30 settembre 1989, Treviso, Edizioni del “Premio Comisso”, 1989, pp. 133-59, e Bartolo Calderone, «Gli inferni intimi» di Cocteau (e Comisso), in Della visione e dell’enigma, Acireale-Roma, Bonanno, 2011, pp. 155-74.
13 La maggior parte dei brani censurati è stata trascritta e pubblicata da Nico Naldini in appen-dice all’edizione di Gioco d’infanzia da lui curata (C, Gioco d'infanzia, a c. di Naldini, Parma, Ugo Guanda Editore, 1994). I brani sono ora inclusi in Damiani, Notizie sui testi, cit., pp. 1686-710.
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
100 Otto/Novecento, 2/2014
Pensare che Comisso abbia censurato numerose parti di Gioco d’infanzia soltanto perché le giudicava inappropriate e scabrose sarebbe un giudizio superfi-ciale e riduttivo. Sulle sue scelte influirono di certo diverse ragioni, a cominciare da quell’inquietudine che provava sempre nei confronti delle sue opere e che lo spingeva a sottoporle a continue revisioni e modifiche.
Il fatto che abbia scelto di censurare – per intero o in alcune parti – soprattutto le scene erotiche ci fa pensare ai giudizi di Crémieux, il quale aveva rimproverato il carattere ripetitivo e monocorde di quelle scene. Secondo l’italianista francese, il libro non era ben costruito; proprio per questo non era stato possibile a Comisso trovare un editore in Francia. È probabile quindi che in seguito Comisso abbia cercato di rendere l’opera più compatta dal punto di vista narrativo, tenendo presente anche l’opinione di Crémieux e sopprimendo a tale scopo soprattutto le scene erotiche – nonostante non si mostrasse particolarmente risentito per le osservazioni dell’italianista francese14.
Nella lettera che scrive il 2 agosto 1932 da Treviso agli amici Maria e Lino Mazzolà, Comisso spiega perché non ha ancora fatto leggere il suo libro anche a loro: è «molto trepidante per esso» e non è ancora sicuro «del suo effettivo valore»; inoltre, «l’opera non è ancora finita» e ha intenzione di continuare a lavorarvi. Nello scusarsi, Comisso spiega le ragioni di questo pudore servendosi delle parole che Saba gli aveva scritto dopo la lettura di Gioco d’infanzia: la sua opera è «tre-mendamente tragica»15. Saba, in particolare, aveva definito il romanzo come «un libro tragico», «una corsa tragica ed affannosa verso l’illuminazione finale»16. E la corsa è tragica perché, come ha scritto Gilbert Bosetti, Alberto è «condannato a cambiare continuamente di partner perché rifiuta narcisisticamente l’altro e perché deve sfuggire al Cronos che divora la giovinezza»17. La tragicità dell’illuminazione finale si fa ancora più evidente, come abbiamo visto in precedenza, nel finale dell’e-dizione a stampa, nel quale l’autore rende esplicito un legame tra Eros e Thanatos che, come ha osservato Bosetti, nel caso di Gioco d’infanzia si fa particolarmente evidente nei brani censurati18. Ad esempio, in un brano soppresso che comprende una serie di ricordi dei tempi di guerra, Alberto si lascia stringere in un abbraccio dal soldato mentre il cannone, come un «richiamo della Morte»19, si fa sentire più intenso, e si abbandona a un amplesso con un compagno «col piacere dato dalla disperazione di morire»20. I brani censurati, confermando questo connubio tra Eros e Thanatos, danno al gioco che risale all’infanzia «il senso tragico di un destino»21.
La «corsa tragica» di Alberto, quindi, è un continuo fuggire dalla morte. E se è solo nella bara che si concludono i giochi d’infanzia, per Alberto continuare
14 «Crémieux mi à scritto bene; ma fa alcune riserve di critica che però non mi convincono [...]» (C, Vita nel tempo: lettere, 1905-1968, cit., p. 173).
15 Cfr. ibidem.16 Umberto Saba, in Damiani, Notizie sui testi, cit., p. 1684.17 Bosetti, cit., pp. 156-7.18 Cfr. ibidem, p. 152.19 Ibidem, p. 153.20 C, Amori d’oriente e Gioco d’infanzia, cit., p. 269.21 Cit., p. 152.
101
a reiterarli non significa solo sfuggire al passare del tempo e alla morte, ma anche andare inesorabilmente incontro alla conclusione del gioco e alla morte stessa.
Alberto, come tanti personaggi comissiani, non è altro che un alter ego dell’au-tore: insieme al suo personaggio, anche Comisso giunge alla stessa tragica illumi-nazione, rendendo l’opera una confessione – fatta a se stesso prima ancora che agli altri – che riguarda la sua natura profonda. Si spiega alla luce di questo la riluttanza nel condividere la sua opera, così come la scelta di autocensurare soprattutto quei brani che erano maggiormente legati a un’intuizione tanto tragica e a una confes-sione così intima.
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
102 Otto/Novecento, 2/2014
AppenDICe
Lungo la spiaggia del mare (da Gioco d’infanzia)
Proponiamo di seguito l’edizione di un brano di Gioco d’infanzia, pubblicato per la prima volta – con il titolo Lungo la spiaggia del mare – nel 1940 su “Letteratura”. L’episodio consiste in un flashback, e vede il protagonista Alberto ricordare una passeggiata lungo la spiaggia di «una piccola città di mare» (denominata «Sotto-marina» nel manoscritto).
Nell’autografo (A) l’episodio è concepito già come una sequenza autonoma; è, infatti, preceduto e seguito da segni di divisione che lo separano dal resto del testo.
Nella versione pubblicata su “Letteratura” (Riv) la porzione del brano che riguarda il ricordo della passeggiata è in corsivo; l’ultimo capoverso, che vede il ritorno al presente e ai pensieri di Alberto, è in tondo.
Nell’edizione a stampa (St) la sequenza del brano dedicata al ricordo è in corsivo, preceduta e seguita da tre asterischi, esattamente come nel caso degli altri flashbacks presenti nel romanzo. La parte finale del brano è integrato con il testo seguente, senza differenziazioni o segni di separazione di alcun genere, a differen-za di quanto è invece osservabile in A, dove i segni di divisione non seguono la sequenza del ricordo, ma il capoverso finale, che in Riv è in tondo.
Come emerge dalla lettura dell’apparato dell’edizione critica proposta, la ver-sione del brano pubblicata su rivista conserva ancora numerosi elementi presenti nell’autografo. Al contempo, è possibile osservare come molte modifiche presenti nell’edizione a stampa siano state introdotte già nella versione pubblicata su rivista. Numerosi sono, inoltre, gli interventi introdotti in Riv e ripresi poi in St dopo essere stati oggetto di ulteriori modifiche.
Questa tendenza si fa più evidente, in particolare, negli interventi che inte-ressano passi specifici: nel passaggio da A a St, attraverso Riv, Comisso sembra in molti casi aver cercato una maggiore sintesi e concentrazione semantica, elimi-nando sintagmi, frasi, perfino brevi sequenze. All’interno di questo processo, Riv si colloca in uno stadio intermedio tra A e St.
1. Criteri di edizione
Il testo di riferimento adottato è quello dell’edizione a stampa, riservando l’appa-rato alle varianti di A e Riv. In tal modo il lettore può avere un’idea più chiara del processo di revisione e in particolare di come, in numerose circostanze, Comisso abbia proceduto scartando e condensando progressivamente il testo fino a raggiun-gere la forma definitiva. La porzione di testo cui si fa riferimento in apparato è seguita da una parentesi quadra. I passi più lunghi non vengono citati per intero, ma se ne riportano solo le parole iniziali e finali separate da tre puntini [...].
Di volta in volta viene specificato se una variante è presente solo nell’autografo (A) o nella versione pubblicata su rivista (Riv).
Quando le varianti o le indicazioni tra parentesi non concernono l’intera porzione di testo citata, ma solo una sua parte, il punto di attacco è indicato con
103
un asterisco. Di seguito si fornisce l’elenco delle abbreviazioni e dei segni conven-zionali adoperati:
agg. in interl. sup. = aggiunto in interlinea superiorein interl. sopra xyz cass. = variante aggiunta in interlinea sopra la lezione precedente cassataprecede/segue cass. = variante cassata prima o dopo la parola di riferimento[…] = parola o espressione illeggibile
Quando A e Riv concordano non è indicata alcuna sigla. Quando le differenze testuali di A e Riv sono minime, per evitare di appesantire l’apparato, viene tra-scritta solo la versione tramandata da Riv, indicando le varianti di A tra parentesi.
Il testo del manoscritto collazionato in apparato è stato trascritto rispettandone le particolarità grafiche. Sono state mantenute, nello specifico, le oscillazioni del pronome sé con e senza accento; sono state invece uniformate con l’accento le versioni non accentate dell’avverbio sì.
Sono stati riprodotti fedelmente i diversi segni adoperati nell’autografo per indicare l’apertura e la chiusura del discorso diretto; di questi, nel brano prescelto, Comisso adopera solo le virgolette e i due punti.
È stata corretta la seguente svista d’autore: pantanoli > pantaloni.
2. proposta di edizione critica
Ricordò un giorno in cui era andato in una piccola città di mare, deciso di imbarcarsi su qualche veliero da pesca e di abbandonare la sua casa. Rivisse quel giorno1.
Era giunto2 sulla riva del canale3 fitto di velieri. I marinai lavoravano alle reti, alle vele e a dipingere le prue, altri camminavano sul marciapiede sconnesso facendo risuonare gli zoccoli4. Passò sul lungo5 ponte che portava alla spiaggia6. Alcune vele si aprivano e preso il vento partivano7. Vedeva nel fondo delle acque8 serpeggiare le alghe
1 Ricordò ... giorno.] L’incipit del brano è stato modificato rispetto alla versione di A e Riv: Il (su La) mattino *sereno (precede cass. fresco e) si presentiva dalle prime voci giù nella calle delle venditrici di verdura. Erano come squilli a svegliarlo e a *comandargli (in interl. sopra spingerlo cass.) di alzarsi, la donna non era più al suo fianco. Si vestì in fretta e senza lavarsi uscì desideroso dell’aria del mare. A Il mattino sereno si presentiva dalle voci chiare delle venditrici di verdura giù nella calle: erano come squilli a svegliarlo e a comandargli di alzarsi; la donna non era più al suo fianco. Si vestì in fretta e senza lavarsi uscì desideroso d’aria di mare. Riv
2 Era giunto] Giunse manca l’a capo precedente3 sulla riva del canale] in riva al canale A4 zoccoli.] zoccoli di legno. segue I loro volti bruniti dal sole* trapelavano (precede cass. erano)
un vivo rossore eccitato dal vento fresco. A I loro volti bruni di sole si arrossavano eccitati dal vento fresco. Riv
5 lungo] agg. in interl. sup. 6 ponte che portava alla spiaggia] ponte che attraverso la laguna porta *all’altro paese (al paese
di Sottomarina A) e alla spiaggia.7 partivano] partivano, le piccole case *del paese (di Sottomarina A), fitte di finestre apparivano
in sole e in ombra tutte in fila lungo la laguna percorsa da fremiti di vento.8 delle acque] agg. in interl. sup.
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
104 Otto/Novecento, 2/2014
e alto nel cielo strati leggeri di nubi che si dissolvevano. Non sapeva9 se camminava sospeso sulle acque10: tanta11 era la sua ebrezza12. Finito13 il ponte14 sentì15 i piedi16 affondare nella sabbia17, che ondulava18 tra macchie di erba19 ispida e ingiallita. Alcuni vecchi stavano distesi20 dentro a buche, difesi dal vento21, pareva22 dormissero o spiassero il mare che si distendeva fermo e verdastro23. Arrivò alle capanne per i bagni estivi24 in parte sommerse dalla sabbia accumulata dal vento25. Si26 prolungavano in fila27 sulla spiaggia larghissima28 per la bassa marea29, rattristiva l’abbandono del luogo, la fermezza del mare e il suo stare30 ritratto31 da terra32 come incominciasse a prosciugarsi per sempre. Lunghi33 strati di alghe34 stavano deposti sulla riva35 e36 davanti37 a lui38 la spiaggia si protendeva39 lontano e deserta40. Guardò a lungo la limpidezza del cielo41:
9 Non sapeva] Egli non sapeva A10 sospeso sulle acque:] sulle acque o *sospeso: (sospeso. A)11 tanta] Tanta A12 ebrezza] ebbrezza Riv13 Finito] Ma come terminò A Ma finito Riv 14 ponte] ponte,15 sentì] e sentì A16 i piedi] i suoi piedi17 nella sabbia,] nella sabbia. Riv segue e (in interl. sopra tra cass.) l’aria stagnante al riparo delle
case *con l’acuto sentore delle cipolle, (inizialmente come acuto era il sentore, come trasformato in con aggiunta di l’cass. era il dopo acuto) *gli vietavano di (in interl. sopra non osava più cass.) avanzare (segue cass. come aggravato da una stanchezza immensa). In A, l’autore era inizialmente intenzionato a modificare l’ordine in tra l’aria stagnante al riparo delle case; infatti, in interl. sopra l’aria troviamo 2 cass.; al riparo delle case è racchiuso tra due barre verticali, con 1 cass. in interl. sopra riparo.
18 che ondulava] Al di là delle case la sabbia ondulava19 di erba] d’erba20 distesi] distesi con la pancia a terra21 dentro a buche, difesi dal vento,] entro a buche (nelle piccole insenature A) difese dal vento.22 pareva] E pareva A Pareva Riv23 verdastro] precede cass. grigio 24 per i bagni estivi] per i bagni estivi, (in A per i bagni estivi è agg. in interl. sup.)25 vento.] il punto è su virgola segue cass. grige e tri26 Si] su si27 fila] fila, A 28 larghissima] divenuta larghissima A29 marea,] marea; segue nonostante la limpidezza del cielo, A30 rattristiva l’abbandono del luogo, la fermezza del mare, e il suo stare] si (precede cass. un)
sentiva rattristire dalla desolazione del luogo, dalla fermezza del mare e dal suo stare A si rattristiva all’abbandono del luogo, alla fermezza del mare e al suo stare Riv
31 ritratto] così ritratto32 terra] terra, Riv33 Lunghi] Grandi34 di alghe] d’alghe A35 sulla riva] lungo la riva36 e] agg. in interl. sup.37 davanti] su Davanti38 a lui] agg. in interl. sup.39 protendeva] su protenteva40 deserta.] deserta A41 Guardò a lungo la limpidezza del cielo:] manca in A Guardò a lungo la limpidezza del cielo; Riv
105
la tristezza disparve42. Affrettò il passo sulla sabbia quasi asciutta43 dove non trovava alcuna impronta di piede. L’acqua ferma terminava in una schiuma saponosa che veniva assorbita lenta dalla sabbia44, il mare invero moriva45.
Quasi posò il piede sulla carogna di un46 cane47, mezza sepolta, aveva i denti bianchissimi scoperti48. Era putrida e gonfia. Nessuno appariva all’orizzonte, il mare era senza vele, desiderava proseguire ancora49, la50 solitudine lo esasperava51, quando intese
42 la tristezza disparve.] e la tristezza disparve. A segue Lo spazio piano, immenso e raggiungibile lo invitava a camminare lungo il mare. (inizialmente con l’animazione datagli dallo spazio piano, immenso e deserto, come raggiungibile e senza anima viva. Ed egli sentiva avidamente il desiderio di andare avanti lungo il mare, di essere in quella solitudine e di poter incontrare qualcuno. a di-sparve. segue cass. con l’animazione datagli Lo da dallo e agg. in interl. sopra e deserto, con cass. lo invitava ... lungo il mare è agg. in interl. sup. e sostituisce e senza anima ... qualcuno. a sentiva precede cass. dava a mare segue e probabilmente non cass. per una svista) segue quindi La (su la precede cass. Era) solitudine *piena di silenzio (precede cass. stessa così immensa e segue cass. il mare taceva [...]) gli eccitava con lusinga e ardente speranza il desiderio di incontrare qualcuno. A Lo spazio piano, immenso, raggiungibile lo invitava a camminare lungo il mare; la solitudine piena di silenzio ora gli dava un desiderio d’incontri. Riv
43 asciutta] asciutta,44 L’acqua ... sabbia,] In certi punti i cumuli d’alghe sparivano lasciando così la sabbia tutta
levigata scendere sino all’acqua ferma bordeggiata da un nastro di spuma saponosa. A L’acqua ferma terminava in una schiuma saponosa che veniva lentamente assorbita dalla sabbia. Riv
45 il mare invero moriva.] Il mare gli riesciva veramente morto. A Il mare veramente moriva. Riv L’a capo seguente manca sia in A che in Riv. Segue invece: Osservò (precede cass. e osserva) altrove dei pezzi di legna anneriti e corrosi dall’acqua e come egli li prendeva *si disfacevano (ce è agg. in interl. sup.) *tanto erano marciti. (precede cass. come pezzi) A Osservò altrove pezzi di legna anneriti e corrosi dall’acqua e come provò a coglierne subito si disfacevano, tanto erano marciti. Riv
46 di un] d’un Riv 47 cane,] cane Riv 48 Quasi posò il piede ... scoperti.] Poi la carogna d’un cane mezza sepolta, coi denti bianchis-
simi scoperti, *cui (precede cass. su) quasi posava il piede lo *sgomentò (su sgomentava precede cass. spaventò) con nausea. A
49 proseguire ancora,] ancora di proseguire A ancora proseguire. Riv segue una breve sequenza presente sia in A che in Riv, ma soppressa nell’edizione a stampa: Il sole (precede cass. [...]) gli batteva sugli occhi e verso terra non lo seguiva che il rialzo della sabbia accumulata dal vento contro le siepi di canne poste a riparo degli orti. Anche qui dove venne a spiare, non scorse nessuno: il verde cupo delle ortaglie si distendeva *interrotto (precede cass. tra) dal bianco di casette sparse che spuntavano come pezzi di vele ferme. Si fermò e si distese sulla sabbia fredda e asciutta da cui spuntavano dei fili di dura erba. Ripensò alla donna che era stata con lui nel suo letto, ebbe (agg. in interl. sup.) un attimo d’orgoglio ricordando come *era riescito a farla (in interl. sopra ella cass.) smaniare sotto ai suoi impeti, ma non la desiderava più. *Rivedeva (precede cass. Sentiva) i volti rossi e bruni dei marinai al lavoro sui velieri nel canale. A Il sole gli batteva sugli occhi; verso terra, dopo le capanne, la sabbia si accumulava contro una siepe di canne a riparo di grandi orti che si stendevano sino alla laguna. Anche qui non scorse nessuno: il verde cupo dell’ortaglia si distendeva interrotto dal bianco di casette sparse che spuntavano come pezzi di vele immobili. Si fermò e si distese sulla sabbia fredda ed asciutta tra fili di dura erba. Ripensò alla donna che era stata con lui ed ebbe un attimo d’orgoglio ricordando come era riescito a farla smaniare sotto i suoi impeti: non la desiderava più. Ripensava ai volti rossi e bruni dei marinai al lavoro sui velieri del canale. Riv
50 la] La 51 esasperava,] esasperava. segue Stava per alzarsi e riprendere *il cammino (a camminare A)
lungo il mare, verso un punto lontano dove gli sembrava che un uomo stesse sulla spiaggia,
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
106 Otto/Novecento, 2/2014
dalla parte degli orti52 il rumore di una siepe53 di canne che veniva squarciata54 e un uomo scese verso di lui portando un grande rastrello di ferro sulle spalle55. Camminò56 svelto, rispose appena al suo saluto57 e si fermò vicino all’acqua58, dove si tolse i calzoni59 per legarseli attorno alla schiena60. Riprese il rastrello61 ed entrò62 nelle acque raspandole nel fondo63. Camminava all’indietro64 e rastrellava65 a passi celeri e misurati. Avanzava verso l’acqua più fonda66 e allora si rialzava i lembi della camicia67 scoprendo le sue gambe fino al ventre68. Ogni tanto69 sollevava il rastrello70 e vi toglieva71 tra i denti le erbe72 impigliate73 e qualche pesce74 che riponeva75 in un cestino76 dietro alla schiena77. Si allontanava78 verso l’acqua profonda e poi ritornava verso la bassa79. Egli non poteva
52 quando intese dalla parte degli orti] quando dietro a se intese 53 di una siepe] della siepe54 squarciata] squarciata,55 e un uomo ... spalle.] si volse e scorse uno che con un grande arnese di ferro *sulle spalle
(agg. in interl. sup.) fatto a denti *simile ad un rastrello (come un rastrello A) scendeva verso di lui. 56 Camminò] Camminava A. 57 rispose appena al suo saluto] non (precede cass. e) gli diede il saluto A rispondendo appena
al suo saluto Riv58 all’acqua,] all’acqua.59 dove si tolse i calzoni] Qui depose l’arnese, si tolse i pantaloni, A Qui si tolse i pantaloni, Riv 60 per legarseli attorno alla schiena.] se (precede cass. che) li legò attorno alla vita, si assestò un
*cestino (su [...]) dietro alla *schiena (schiena, A)61 Riprese il rastrello] e *ripreso (su [...]) l’arnese che aveva la forma d’un arco A e ripreso
l’arnese Riv62 ed entrò] entrò63 raspandole nel fondo] immergendolo e tenendolo rasente al fondo64 all’indietro] a dietro schiena (agg. in interl. sup.) A65 rastrellava] rastrellava il fondo66 fonda] profonda67 della camicia] della camicia. (segue cass. per non bagnare) A della camicia, Riv 68 scoprendo le sue gambe fino al ventre] Ritornava verso l’acqua bassa e allora le sue gambe
*arrossate (in interl. sopra forti e bianche, cass. arrossate era inizialmente su bianche) dal freddo dell’acqua, apparivano *scoperte (agg. in interl. sup.) fino al ventre. A ritornava verso l’acqua bassa e allora le sue gambe arrossate dal freddo apparivano scoperte sino al ventre. Riv
69 Ogni tanto] Di tanto in tanto70 il rastrello] il suo rastrello di ferro,71 e vi toglieva] toglieva72 le erbe] delle erbe73 impigliate] impigliate, A74 e qualche pesce] o un pesce75 riponeva] deponeva76 in un cestino] nel cestino77 dietro alla schiena] dietro la schiena Riv78 Si allontanava] S’allontanava a zig-zag A S’allontanava, Riv79 verso l’acqua ... bassa.] ora verso l’acqua alta, ora verso la bassa. A ora verso l’acqua profonda,
ora verso la bassa. (segue un a capo) Riv
107Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
trattenersi dal seguire quel passo svelto, forte, ritmico e indifferente al freddo80. A81 un certo momento i loro sguardi si incontrarono82 e allora gli chiese83: «Cosa è che pescate84?
» Rispose appena85 e subito proseguì86 nel suo andare all’indietro, curva la testa e quasi imbronciata87. Nella celerità del passo la camicia si apriva ai lati88. Ogni tanto89 si fermava90 per riporre91 qualche pesce nel cestino92. «Ma non vi è pericolo che l’acqua così fredda vi faccia male93?» gli aveva chiesto94 con dolcezza. «No, io sono abituato95»
80 Egli non poteva trattenersi ... freddo.] Alberto s’era alzato e lo raggiunse seguendolo attratto. *Non si poteva (precede cass. Il pescatore che col suo arnese di ferro.) *smettere (precede cass. [...]) di seguirlo, fingeva di interessarsi alla pesca, ma quello che *gli (agg. in interl. sup.) dava piacere ed esasperazione insieme erano *le (da quelle) gambe forti, svelte, ritmiche nel passo e così *indifferenti (precede cass. sofferenti) al freddo. A Alberto s’era alzato e lo raggiunse seguendolo attratto. Non poteva smettere di seguire, quel passo svelto, forte, ritmico e così indifferente al freddo. Riv segue un breve passo espunto nell’edizione a stampa, ma presente sia in A che in Riv, in due versioni leggermente diverse che riportiamo di seguito: Quando il pescatore s’allontanava verso l’acqua alta e sollevava la camicia per non bagnarla scoprendo parte dei suoi fianchi, egli come accecato arrivava a camminare senza accorgersi tra il primo strato dell’acqua ferma e schiumosa e si bagnava le scarpe e non *vi (su ne) faceva caso. A Quando il pescatore s’allontanava verso l’acqua più fonda, egli arrivava a camminare senza accorgersi sul primo strato d’acqua schiumosa. Riv
81 A] Ad82 i loro sguardi si incontrarono] il pescatore alzò lo sguardo verso di lui A il pescatore alzò lo
sguardo Riv 83 allora gli chiese] allora avido e timoroso subito gli rivolse la domanda A subito allora Alberto
gli chiese Riv 84 pescate] pesca A85 Rispose appena] Gli aveva appena risposto A 86 proseguì] aveva proseguito A87 all’indietro (...) imbronciata.] a dietro schiena; A all’indietro, curva la testa attenta e quasi
imbronciata. Riv segue una breve sequenza soppressa nel passaggio all’edizione del ’65: *l’acqua (precede cass. per) si faceva estremamente bassa ed egli si allontanava dalla riva, allora per essergli più vicino, Alberto, s’era tolto le scarpe e rimboccati i calzoni fino al ginocchio, ed entrato nell’acqua senza badare al freddo, *lo aveva raggiunto. (precedono gli e cass. s’era fatto) Volle sapere come si chiamava quell’arnese di ferro. :Schiacciadiavoli: rispose il pescatore senza guardarlo e continuando *a (da ad) proseguire. A L’acqua si faceva estremamente bassa: dovette allontanarsi dalla riva. Per essergli più vicino, Alberto, si tolse le scarpe, rimboccò i calzoni sino al ginocchio entrò nell’acqua senza badare al freddo e lo raggiunse. Volle sapere come si chiamava quel rastrello di ferro. «Schiacciadiavoli» rispose il pescatore senza guardarlo e proseguendo. Riv
88 Nella celerità ... ai lati.] Nella celerità del passo la camicia che era aperta ai lati, lasciava vedere il suo ventre, *contro cui (in interl. sopra che cass.) l’acqua fluiva continuamente. A Nella celerità del passo la camicia s’apriva ai lati, e l’acqua fluiva continuamente contro il ventre. Riv
89 Ogni tanto] Di tanto in tanto90 si fermava] si arrestava91 riporre] riportare Riv92 qualche pesce nel cestino.] qualche pesce nel cestino o per togliervi le erbe rastrellate tra i
denti. A qualche pesce nel cestino, o per toglierne le erbe rastrellate tra i denti. Riv93 che l’acqua così fredda vi faccia male] che vi fate male A che vi facciate male Riv94 aveva chiesto] chiese 95 No, io sono abituato] No io misuro bene i miei passi A Nò, io misuro bene i miei passi. Riv
108 Otto/Novecento, 2/2014
gli aveva risposto quasi con disprezzo96. In fine sollevò97 il rastrello98, lo pulì99 e andò sulla riva per rimettersi i calzoni100. Quell’uomo101 non gli parlava102 preso da pensieri freddi e lontani103. Voleva insistere ma non osava e allora senza salutarlo era ritornato nella solitudine verso le capanne sommerse104. Assorto nell’estro violento del passo105, un punto nero lontano tra il mare e la spiaggia lo attrasse sicuro fosse un altro pescatore106. Prese a correre, un uomo avanzava spingendo una carriola che cigolava nel silenzio107.
96 gli aveva risposto quasi con disprezzo.] gli rispose. segue un passo soppresso: Alberto sentiva il freddo *che gli saliva (salirgli A) alle ginocchia, *soffriva, (soffriva A) ma non voleva ritornare sulla spiaggia. Il paese era lontano *confuso, (confuso A) appiattito *tra il (col A) grigio della spiaggia deserta. Giunsero ad un punto dove il mare formava una grande ansa che si impaludava.
97 In fine sollevò] Il pescatore sollevò.98 il rastrello] il suo arnese A99 lo pulì] lo pulì dalle erbe100 sulla riva ... calzoni.] verso la riva. segue un brano soppresso: Ritornarono sulla sabbia asciutta.
Il pescatore si sedette per terra e si *mise (in interl. sopra pose cass.) a disporre nel cestino i pesci pescati. Alberto lo guardava e voleva parlargli, scorgeva le sue coscie e il suo ventre che si asciugavano al sole appena nell’orlo della camicia che usava come un *corto (agg. in interl. sup.) gonnellino di sotto la grossa giacca. Tutto d’un tratto gli chiese se aveva fatto il soldato. “Si” gli rispose guardandolo appena. “E siete sposato?” – “Sì, ò due figli da mantenere, la vita è dura, caro signore.” Alberto s’era sentito intimidire e respingere, non osava più stargli vicino. Non sentiva più nessuna attrazione per lui, si sedette discosto e *si diede (in interl. sopra prese cass.) a togliersi la sabbia che gli si era appiccicata ai piedi, poi si infilò a fatica e con fastidio le calze e le scarpe che non volevano entrare per l’umido che aveva preso le calze. A Giunto sulla sabbia asciutta si sedette per terra e si mise a disporre nel cestino i pesci pescati. Alberto lo guardava e voleva parlargli ancora, ma non osava, si infilò a fatica e con fastidio le calze e le scarpe che non volevano entrare per l’umido. Riv
101 Quell’uomo] manca l’a capo precedente102 parlava] parlava, 103 preso da pensieri freddi e lontani] rimaneva seduto come immerso in pensieri freddi e lontani104 Voleva insistere ... sommerse.] Lo indispettiva e a poco a poco sentiva di odiarlo. Si alzò e
senza salutarlo ritornò nella solitudine verso il paese lontano, tale era il silenzio che sentiva il fruscio del suo vestito nella celerità del passo perché voleva scacciare il freddo che dalle gambe gli saliva a tutto il corpo. Il cinguettio d’un uccello sulla siepe di canne lo spronò come *fosse (agg. in interl. sup.) la voce del pescatore che aveva lasciato. A Alberto si rialzò e senza salutarlo ritornò nella solitudine verso le capanne sommerse. Tale era il silenzio che sentiva il fruscio del suo vestito nella celerità del passo. Voleva scacciare il freddo che dalle gambe gli saliva per tutto il corpo e quasi correva. Riv
105 Assorto nell’estro violento del passo,] Accelerò il passo assorto puramente nell’estro violento del passo, ripreso ogni tanto dal disgusto per quel luogo e il desiderio di ritornare alla sua casa la sera stessa. A Era puramente assorto nell’estro violento del passo, Riv
106 un punto nero ... pescatore.] Ma un punto nero tra il mare e la riva si faceva lontano sem-pre più determinato, fino a che s’accorse che era un uomo che avanzava spingendo una carriola. A quando un punto lontano nero tra il mare e la riva attrasse il suo sguardo sicuro che fosse un altro pescatore. Riv
107 Prese a correre ... nel silenzio.] Accelerò il passo, anche l’altro avanzava più rapido; prese a correre, poi dovette fermarsi sentiva le gambe pesare e gli mancava il respiro, poche centinaia di metri lo divideva dall’uomo che avanzava sempre spingendo la sua carriola che *già (agg. in interl. sup.) si sentiva cigolare nel silenzio. A Prese a correre, il punto si faceva sempre più nitido fino a definirsi in un uomo che avanzava spingendo una carriola. Si fermò stanco, poche centinaia di metri lo dividevano dall’uomo che avanzava sempre spingendo la carriola che cigolava nel silenzio. Riv
109
Non riusciva a calmare la sua ansia108, già lo distingueva109, gli parve110 ossuto e curvo. Riprese a camminare111, poco dopo si accorse del grigio dei suoi baffi112, era vecchio113, rossiccio agli zigomi, tesa la pelle lustra e intontito114 negli occhi lagrimosi115. Aveva fermato la carriola116 per raccogliere117 alcuni pezzi di legno118, poi lento aveva rivolto su di lui uno sguardo avido, indimenticabile, che si fece fermo sostenuto da un’ossessione oscura119. Lo oltrepassò e proseguì120 per sfuggirlo121, ma intese122 dietro a sé123 il cigolio124 della carriola che lo seguiva. Si volse, l’altro125 accelerava il passo per raggiungerlo. Si fermò126 e lo attese.127 Si sentì guardare con quegli occhi da vecchio cane mentre diceva: «Come è giovane lei»128. E129 sputò il tabacco130 che teneva in bocca. Le sue parole si
108 Non riusciva a calmare la sua ansia,] Non sapeva dominare la sua ansia, camminava, si volse un attimo; il pescatore era già lontano ed era ritornato a pescare. A Non sapeva calmare la sua ansia, riprese a camminare più forte che poteva, si volse un attimo: il pescatore era già lontano ed era ritornato a pescare. Riv
109 già lo distingueva] Già distingueva dell’altro le forme A Già distingueva l’altro Riv 110 parve] pareva111 Riprese a camminare,] manca 112 poco dopo (...) baffi,] Era scalzo. Distinse il grigio dei suoi baffi. A Era scalzo e svelto, poco
dopo distinse il grigio dei suoi baffi. Riv 113 era vecchio,] Vecchio: A Vecchio, Riv 114 intontito] inebetito A inebidito Riv 115 negli occhi lagrimosi] nello sguardo lagrimoso A116 Aveva fermato la carriola] Fermò (precede cass. Quando fu presso a lui) la sua carriola, (virgola
su e) A Aveva fermato la carriola Riv 117 per raccogliere] raccolse A118 legno,] legno. (segue cass. gettati sulla spiaggia) A legno Riv119 poi lento aveva rivolto ... ossessione oscura.] Lentamente rivolse (precede cass. ed Alberto si
sentì in interlinea sopra e uno sguardo lento e fermo cass. al quale segue cass. lo *guardava (da guardò) avidamente con uno sguardo fermo. segue cass. su Alberto) il suo sguardo avido, fermo e indimenti-cabile sostenuto da un’ossessione oscura. A e poi lentamente aveva rivolto sul Alberto uno sguardo avido, fermo ed indimenticabile, sostenuto da una ossessione oscura. Riv
120 Lo oltrepassò e proseguì] Alberto (agg. in interl. sup.) proseguì (su Proseguì) A Alberto lo oltrepassò e proseguì Riv
121 per sfuggirlo] come per sfuggirlo A122 intese] dopo poco intese A poco dopo intese Riv 123 per sfuggirlo] come per sfuggirlo A.124 cigolio] cigolo Riv 125 l’altro] egli A126 Si fermò] Alberto si fermò127 attese.] attese: 128 Si sentì guardare ... «Come è giovane lei».] Cosa raccogliete? gli domandò con violenza. “Un
po’ di legna da ardere” e si fermò e si sedette sulla carriola, riprendendo a guardare coi suoi occhi da *vecchio (agg. in interl. sup.) cane. “Ma come può bruciare questa legna?” / “Si asciuga al sole, colla pazienza... come è giovane lei!” A «Cosa raccogliete?» gli domandò con violenza. «Un po’ di legna da ardere». Si fermò e si sedette sulla carriola, riprendendo a guardare coi suoi occhi da vecchio cane. «Ma come può bruciare questa legna?» – «Si asciuga al sole, colla pazienza.... Come è giovane, lei». Riv
129 E] e A 130 il tabacco] del tabacco A
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso
110 Otto/Novecento, 2/2014
allungavano tremanti131, a un tratto132 sollevò133 la mano contorta134 e la protese per toccargli i calzoni135. «Che bella stoffa, Dio sa quanto costerà»136. Gli aveva detto e teneva la mano sospesa137. «Che bella stoffa»138. Aveva ripetuto ancora139 e gli toccò i calzoni140, poi più su141 sotto alla giacca142. Egli si era fatto indietro,143 dicendogli aspro di non toccarlo, di continuare a raccogliere la sua legna.144 Il vecchio si era sputato alle mani145 e aveva ripreso146 a spingere la carriola147 che cigolava148. La solitudine149, la desolazione data dal mare150 fermo151 e ritratto parevano gravare152 sulle spalle curve del vecchio che153 si allontanava154.
***
Riudiva presente il cigolio di quella carriola, aveva rivissuto in quella giornata lungo al mare155. Sentiva che sarebbe diventato come quel vecchio. Gli spuntò
131 Le sue parole si allungavano tremanti,] Aveva un tono allungato e malinconico nella voce. A 132 a un tratto] Poi A ad un tratto Riv133 sollevò] allungò A 134 la mano contorta] una delle sue mani rossicce e contorte A la mano rossiccia e contorta Riv 135 e la protese per toccargli i calzoni.] la protese verso Alberto (manca in A) e gli toccò la stoffa
dei pantaloni:136 «Che bella stoffa, Dio sa quanto costerà»] “Che bella stoffa; che è...dio sa quanto costerà..”
A «Che bella stoffa che è... Dio sa quanto costerà?» Riv 137 Gli aveva detto ... sospesa] E teneva la mano sospesa (segue cass. senza sapere)138 «Che bella stoffa».] Rialzò lo sguardo timidamente verso quello di Alberto che *s’era fatto
(precede cass. diveniva) aspro e incuriosito. “Cosa avete fatto nella vostra vita?” “Il pescatore, *una brutta vita... (precede cass. via per il mare... ma adesso) che bella stoffa, è fina proprio” A Rialzò lo sguardo timidamente verso quello di Alberto che s’era fatto aspro e incuriosito: «Che mestiere avete fatto da giovane?» gli chiese. «Il pescatore, una brutta vita. Che bella stoffa, è proprio fine». Riv
139 Aveva ripetuto ancora] manca140 e gli toccò i calzoni,] E (e A) ritornò a posare la mano sui pantaloni, (pantaloni A) 141 su] su, Riv 142 sotto alla giacca] al lembo della giacca 143 Egli si era fatto indietro,] Alberto si fece *indietro: (indietro. A) 144 dicendogli aspro (...) legna.] “Andate! Andate! continuate a raccogliere la vostra legna.” A
«Andate, andate, continuate a raccogliere la vostra legna». Riv 145 si era sputato alle mani] si alzò, si sputò sulle mani146 aveva ripreso] riprese147 la carriola] la sua carriola A148 che cigolava.] che cigolava a brevi intervalli accompagnando il suo passo scalzo. (segue cass.
che lasciava delle grandi im) A che cigolava a brevi intervalli accompagnandolo nel passo scalzo. Riv 149 solitudine] solitudine del luogo A150 dal mare] da quel mare A151 fermo] su [...]152 parevano gravare] gravavano come un peso153 che] su [...]154 si allontanava.] s’allontanava. A s’allontanava; Riv segue Ed Alberto si disperava come se
tutto pesasse sulle sue spalle che *sentiva (precede cass. egli) intirizzire e perire per il *suo (agg. in interl. sup.) tempo futuro. A ed Alberto si disperava come se tutto pesasse sulle spalle che sentiva intirizzire e perire. Riv
155 Riudiva ... mare.] La stessa disperazione *ritornava in lui (agg. in interl. sup.) ora che ricordava e riudiva come presente il cigolio della carriola accompagnare quei passi *scalzi (agg. in interl. sup.) che non davano alcun rumore sulle sabbia umida. A La stessa disperazione ritornava in lui, ora, che
111
improvviso il ricordo della allegra e gioiosa speranza dei vitelli, quando abitava in campagna: nell’andare ad abbeverarsi sfuggivano al bovaro e saltavano per il cortile con la coda rialzata diritta. Erano passate decine di anni e quei vitelli erano inesorabilmente finiti al macello e all’annullamento anche delle loro ossa156.
Avrebbe157 voluto essere già come158 quel vecchio159 per sapersi160 più vicino alla morte161.
Nel corridoio venne battuto l’annuncio della cena162. Non ne volle sapere e sommerse il capo sotto al cuscino163 per non intendere e non vedere più nulla. Si mordeva le labbra164, infine il sonno lo prese e gli ridiede la calma per tutta la notte.
ricordava e riudiva come presente il cigolio della carriola accompagnare quei passi scalzi che non davano alcun rumore sulla sabbia umida: Riv
156 Gli spuntò ... delle loro ossa.] manca 157 Avrebbe] avrebbe Riv sia in A che in Riv manca l’a capo precedente158 essere già come] essere già159 vecchio] vecchio, A 160 sapersi] essere161 alla morte.] a morire, segue un’altra sequenza soppressa: ma (in interl. sopra e cass.) come per
uno strappo nella disperazione gli balzò *vivo (precede cass. più) e desiderabile ostinato nel suo freddo lavoro, l’altro, il pescatore camminante con l’acqua alle coscie intento a rastrellare il fondo. Non gli importava più dell’Oriente. A ma come uno strappo, nella disperazione gli risorse vivo e dominante, ostinato nel suo freddo lavoro, l’altro, il pescatore che camminava con l’acqua alle coscie, intento a rastrellare il fondo. Riv
162 Nel corridoio ... cena.] Il gong *venne (veniva A) battuto nel corridoio per annunziare la cena. manca l’a capo precedente
163 sotto al cuscino] sotto il cuscino Riv 164 labbra,] segue i suoi sensi si disperdevano nella stanchezza,
Grasso, “Gioco d’infanzia” di Giovanni Comisso