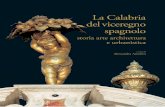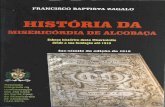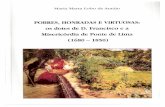Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo. Le pergamene del...
Transcript of Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo. Le pergamene del...
Negli ultimi anni la storiografia ha riposto molte attenzioni nel tentativodi illustrare le articolate tipologie che caratterizzarono le numerose asso-ciazioni confraternali sorte nel XIII secolo in risposta a un bisogno di spiri-tualità nuovo e all’aspirazione a una più attiva partecipazione dei laici al-l’interno della vita della chiesa. Gli indirizzi più recenti hanno sottolineatola necessità di approfondire, attraverso l’esame sistematico della documen-tazione conservata nei fondi archivistici propri delle confraternite, la com-prensione del movimento confraternale in tutte le sue dimensioni e compo-nenti.
L’archivio della Misericordia è costituito da una quantità ragguardevoledi documenti, che, per quanto rimangano fino ad ora in massima parte ine-diti, non sono comunque sconosciuti, ma già più volte sono stati utilizzati inpassato da un nutrito gruppo di storici – si ricordano, tra gli altri, Mazzi,Locatelli e mons. Chiodi, a cui si deve il riordino dell’archivio confraternale–, che ha dato alle stampe un discreto numero di saggi. Tuttavia un certoisolamento storiografico accusato da Bergamo ha in qualche caso reso diffi-coltosa la ricostruzione di un quadro completo e ha costretto al confrontocon altre aree contermini meglio studiate – su tutte l’area veneta ad operadella De Sandre Gasparini –, nella ricerca di preziosi suggerimenti che per-mettessero di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità del contesto ber-gamasco.
Dai dati raccolti in seguito allo spoglio delle pergamene dell’Archiviodella Misericordia, del Fondo Pergamene, dell’Archivio degli Orfanotrofi –tutti conservati presso la Biblioteca Civica Angelo Mai – e dell’Archivio Ca-pitolare, è stato in parte possibile approntare una sintesi che avessel’obiettivo di fare luce intorno alle origini del consorzio della Misericordia,a quei problemi storicamente complessi che si accompagnano alla sua sto-ria, nonché a quell’intreccio di fatti e di volontà che ne stanno alla base.L’impossibilità, inoltre, di descrivere le confraternite come realtà immutabi-li nel tempo ha reso necessaria la scelta di definire un preciso ambito cro-nologico – la seconda metà del secolo XIII – in cui esaminare l’evoluzionedell’istituzione.
Sotto il profilo tematico, si è inteso offrire un contributo che, pur nellaconsapevolezza della difficoltà di fornire un quadro esauriente, illustri i rap-
11
GIANMARCO COSSANDI
FERMENTI RELIGIOSI E SPINTE ISTITUZIONALIA BERGAMO TRA XIII E XIV SECOLO.
LE PERGAMENE DEL CONSORZIO DELLA MISERICORDIA
porti tra la Misericordia e le istituzioni religiose e civili di Bergamo, qualeorganizzazione si diede l’associazione e come si svolse la sua opera assi-stenziale nel periodo tra XIII e XIV secolo, cercando di mantenere il piùpossibile distinti campi, che nella realtà dei fatti furono invece strettamenteintrecciati tra di loro.
La Misericordia e la Chiesa
La confraternita della Misericordia, organizzata in forma giuridica nel1265, fu un’indubbia creazione della società cittadina e della chiesa di quelmomento, tuttavia è possibile delineare al meglio le sue origini percorrendoa ritroso la vita religiosa dei decenni precedenti. Nonostante la storiografia,fin dall’inizio del secolo, abbia accordato alle vicende della chiesa di Berga-mo molta attenzione e molti interventi – in particolare assai dibattuta è sta-ta la questione del contrasto tra i capitoli delle cattedrali di San Vincenzo eSant’Alessandro – è interessante richiamare alcuni aspetti utili ad inqua-drare il contesto da cui nacque e in cui si inserì l’azione della Misericordia.
Nel 1226 e nel 1230 l’allora vescovo Giovanni Tornielli, a conferma delfavore concesso alle nuove forme di vita religiosa, accolse in Bergamo inuovi Ordini Mendicanti, Domenicano e Francescano, affidando loro il com-pito di attuare una pastorale fortemente improntata verso una energica lot-ta all’eresia dilagante, che potesse dare nuova credibilità alle istituzioni ec-clesiastiche in quegli anni divise1. Vertevano, infatti, alcune controversie trail capitolo di Bergamo e i monaci vallombrosani di Astino, nonché tra il ca-pitolo di S. Vincenzo e lo stesso vescovo2. I vescovi, dunque, trovatisi soli adaffrontare da un lato le pressioni del comune e dall’altro il manifestarsi delmalessere ereticale, non sempre seppero contrapporvisi in modo efficace.Vennero inoltre a mancare i sostegni del monachesimo tradizionale che,condizionato dalla crisi del sistema feudale, stentava ad adeguarsi al nuovostato di cose, rappresentando un passato in alcuni casi ancora influente eoperante dal punto di vista economico e sociale, ma che per lo più si rivela-va superato sul piano degli ordinamenti, degli istituti, degli ideali e dellacultura. Il clero secolare, da parte sua aveva manifestato qualche difficoltà
12
G. Cossandi
1 GIUSEPPE RONCHETTI, Memorie istoriche della chiesa e della città di Bergamo, Bergamo1807, rist. an. Brembate Sopra (Bg) 1973, II, p. 228; ANACLETO MOSCONI e SERAFICO LORENZI, Iconventi francescani del territorio bergamasco. Storia, Religione, Arte, Edizioni BibliotecaFrancescana, Milano 1983, p. 9; ANTONIO PESENTI, Dal comune alla signoria (1187-1316), inStoria religiosa della Lombardia. Diocesi di Bergamo, a c. di ADRIANO CAPRIOLI - ANTONIO RIMOLDI
- LUCIANO VACCARO, La Scuola, Brescia 1988, pp. 95-96; MARIA TERESA BROLIS, Gli Umiliati a Ber-gamo nei secoli XIII e XIV, Vita e Pensiero, Milano 1991, p. 197; VENTURINO ALCE, Fra Damianointarsiatore e l’ordine domenicano a Bergamo, Bergamo 1995 (Contributi allo studio del terri-torio bergamasco, 14), p. 18.
2 LUIGI DENTELLA, I vescovi di Bergamo, Tipografia S. Alessandro, Bergamo 1939, pp. 186-188.
nel rispondere ai nuovi compiti pastorali posti dalla civiltà comunale3. Inquesta situazione critica Innocenzo III, mutando radicalmente le strategiedella gerarchia ecclesiastica nei confronti delle richieste di rinnovamentoreligioso, acconsentì alla formazione di nuovi ordini, ognuno dei quali sep-pe trovarsi una sfera d’azione consona alle proprie peculiari caratte ri sti -che4. La rispondenza di questi nuovi ordini alle esigenze del tempo ne spie-ga il grande successo, la rapida diffusione, l’azione che suscitarono tra i fe-deli e le reazioni che finirono per provocare fra i vescovi5. Questi infatti ave-vano dimostrato nel corso dei primi decenni del Duecento una generaleinefficienza di atteggiamenti e di interventi nei confronti degli eretici, chefavorì tra il 1227 ed il 1233 un trasferimento di competenze, in particolaresu iniziativa di papa Gregorio IX, delegando a tale ufficio i Domenicani6.
Il vescovo di Bergamo, dunque, conferì al priore dei Domenicani la chie-sa di S. Stefano e l’annessa prebenda sacerdotale, con l’obbligo di servire lachiesa e l’omonima parrocchia – obbligo da cui furono esentati nel 1234 etrasferito alla vicina chiesa di S. Giacomo –; mentre concesse ai Francescanila chiesa di S. Maria della Carità7. In questo modo i due Ordini vennero atrovarsi nella posizione ideale per poter avvicinare il maggior numero dipersone e dare avvio a una profonda penetrazione tra la popolazione, ri-uscendo così a creare, soprattutto i Predicatori, legami continuativi e dura-turi con i ceti dominanti della società urbana e ad acquisire grande presti-gio presso quelli subalterni, ponendosi al centro di un intenso sistema di re-lazioni ed interessi. Dandosi come obiettivo la propaganda presso le classipiù umili e lo sradicamento delle correnti ereticali, contribuirono a quel ge-nerale consenso a cui aspiravano le nuove élites cittadine8.
13
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
3 GREGORIO PENCO, Storia della chiesa di Italia, I. Dalle origini al Concilio di Trento, JacaBook, Milano 1977, pp. 332, 353, 388.
4 ROBERTO RUSCONI, Predicazione e vita religiosa nella società italiana da Carlo Magno allaControriforma, Loescher, Torino 1981, p. 114.
5 RAUL MANSELLI, I vescovi italiani, gli ordini religiosi e i movimenti popolari religiosi nelsecolo XIII, in Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII). Atti del II convegno di sto-ria della chiesa in Italia (Roma, 5-9 sett. 1961), Antenore, Padova 1964, pp. 320-322; FLAVIA
LENI, Cronache domenicane in Bergamo medioevale (1218-1456). Contributo allo studio dellastoria della chiesa di Bergamo, Tesi di laurea a.a. 1966-1967, p. 8.
6 UGO GUALAZZINI, Il “populus” di Cremona e l’autonomia del comune, Zanichelli, Bologna1940, pp. 166-167; G. PENCO, op. cit., pp. 362-363.
7 BIBLIOTECA CIVICA DI BERGAMO (d’ora in poi BCBg), Archivio degli Orfanotrofi, n. 1272;BCBg, Fondo pergamene, nn. 3976, 3977; ARCHIVIO CURIA VESCOVILE DI BERGAMO (d’ora in poiACVBg), Pergamene, n. 163; G. RONCHETTI, op. cit., II, p. 328; A. MOSCONI e S. LORENZI, op. cit.,p. 13; V. ALCE, op. cit., pp. 18-19.
8 A. PESENTI, op. cit., pp. 95-96; LESTER K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità: confraternitelaiche a Bergamo nell’età del comune, Lubrina, Bergamo 1988, pp. 39-41; MARIAROSA CORTESI,Pinamonte da Brembate tra storia e agiografia, in Bergamo e S. Alessandro. Storia, culto, luo-ghi, a c. di LELIO PAGANI, Edizioni dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo, Bergamo1999, p. 75; FULVIA MILESI, I frati predicatori a Bergamo nel XIII secolo, Tesi U.C. rel. Annama-ria Ambrosioni, a.a. 1999-2000, pp. 43, 58-64, 128, 142. Considerazioni analoghe, anche senon direttamente collegate al caso bergamasco, si ritrovano in: ENRICO GUIDONI, La città dal me-dioevo al rinascimento, Laterza, Bari 1981, pp. 124-125.
Con l’affermazione degli ordini mendicanti inoltre assume uno sviluppodel tutto nuovo la funzione religiosa della città: l’orientamento degli stessi astabilirsi in città si inserisce nel generale movimento di urbanizzazione ca-ratteristico del XIII secolo. Francescani e Domenicani rifiutano la scelta diuna vita eremitica per dedicarsi ad una vita urbana e giustificano questapreferenza in base ad una serie di ragioni che confermano l’importanza,anche religiosa, ormai rivestita dalla città9. I nuovi Ordini assumono in mo-do tempestivo una nuova funzione nel favorire il consolidamento del poterereligioso, la pace cittadina, il coordinamento e la centralizzazione delle di-verse parti della città10. La rapida diffusione dei due Ordini deriva dalla loroefficace e provvidenziale risposta alle ansie di rinnovamento e alle intensetrasformazioni sociali che trovano nei comuni italiani del tempo il loro cli-ma. Il popolo nuovo della civiltà comunale sentiva il bisogno di qualcunoche, vivendo realmente vicino, ne condividesse l’esistenza e i problemi, neravvivasse la fede e ne purificasse i costumi contro i pericoli della violenza,dell’avidità e dell’eresia. Ma è soprattutto un nuovo concetto di vita religio-sa quello che viene progressivamente elaborandosi e che sarà condiviso da-gli Ordini Mendicanti11. Pertanto la forza dei nuovi Ordini rovescia posizionitradizionali, dal rapporto immediato con le folle si creano nuovi equilibri, dicui le famiglie aristocratiche e i ‘politici’ più spregiudicati debbono tenereconto12. La documentazione restituisce testimonianza di consistenti rappor-ti tra i Domenicani e le famiglie di Bergamo dei Suardi, ai quali era affidata– non senza qualche contrasto e abuso13 – la riscossione delle decime inLallio, dei Rivola, Colleoni, Azuelli e da Bonate14. Tuttavia il reclutamento
14
G. Cossandi
9 RENATO BORDONE, La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV), Loescher, Torino1984, p. 90.
10 E. GUIDONI, op. cit., p. 123.11 G. PENCO, op. cit., p. 369.12 F. LENI, op. cit., p. 33; R. MANSELLI, I vescovi italiani … cit., pp. 320-323; GIOVANNI
MICCOLI, Gli ordini mendicanti e la vita religiosa dei laici, in Storia d’Italia, Einaudi, Torino1972, II, p. 800; LUIGI PELLEGRINI, Frati minori e “Lombardia” nel secolo XIII, in Il francescane-simo in Lombardia. Storia e arte, Silvana, Cinisello Balsamo (Mi) 1973, p. 55; A. PESENTI, op.cit., pp. 95-96; L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., pp. 39-41; M. CORTESI, Pinamonteda Brembate … cit., p. 75; F. MILESI, op. cit., pp. 43, 58-64, 128, 142.
13 Si deve al vescovo Algisio, nel 1258, l’investitura a Lanfranco Suardi del diritto di riscuo-tere le decime spettanti alla chiesa dei Domenicani di S. Stefano nel territorio di Lallio; tuttavianel luglio del 1297 il vescovo Giovanni da Scanzo, non essendovi alcuna prescrizione che con-sentisse ad un laico una così lunga detenzione di decime ecclesiastiche, stabilendo “quod pos-sessio decimarum et omnis laycis interdica et quod layci usurpantes sive detinentes easdemsacrilegium incurrerunt et inter anticristos alio modo minimi reputantur”, intimò sotto pena discomunica a Suardo, figlio del suddetto Lanfranco, di rimettere il possesso di quelle decime(BCBg, Archivio degli Orfanotrofi, n. 1247); cfr. anche: G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 287-288;ANGELO MAZZI, Aspetti di vita religiosa e civile nel secolo XIII a Bergamo, “Bergomum”, vol. IV(1922), pp. 253-254.
14 Tra gli altri: BCBg, Archivio degli Orfanotrofi; nn. 55, 750, 925, 1132, 1247; si vedanoanche: GIROLAMO TIRABOSCHI, Chiese e conventi domenicani, ms. BCBg, MMB 732, f. 11; F.MILESI, op. cit., pp. 43, 128, 142.
dei frati tra le famiglie ‘nobili’ e l’intenso intreccio di legami che si veniva acreare tra interno ed esterno del convento potevano spesso rivelarsi ambi-valenti: se da un lato garantivano al convento un vantaggioso sostegno eco-nomico e sociale, dall’altro potevano talvolta condizionarne le scelte15. I te-stamenti appaiono invece un chiaro indicatore dell’attrazione e dell’influen-za morale esercitata dai Predicatori sulla pietà popolare e di come, in misu-ra preminente rispetto ai Minori, fossero riusciti a ritagliarsi grande spazioall’interno della geografia religiosa e nel panorama devozionale dei fedeli16.Il lascito testamentario esprime, infatti, un legame più diretto, una fiduciapiù stabile nei confronti dell’Ordine che il testatore, in questo modo, poneallo stesso livello delle istituzioni che appartengono al suo ambito di vitaquotidiano17. I lasciti in favore dei Predicatori risultano inseriti in un ampioquadro di riferimento, la loro novità si colloca nell’orizzonte della pietà in-dividuale, in un intreccio di esperienze religiose frutto del rinnovamento ec-clesiale che la città aveva saputo esprimere nel suo tessuto. I laici vivendonel mondo e continuando a sfruttare le possibilità che esso offriva, ne fece-ro il campo per l’esplicazione delle proprie capacità per procurarsi un certobenessere, pur non dimenticando l’aldilà e la salvezza dell’anima, comechiaramente dimostrano le donazioni pro anima e i numerosi lasciti testa-mentari pro remedio anime18.
Il successo conseguito fece dunque nascere nei Domenicani l’esigenza diuna chiesa molto più capiente, in grado di accogliere i numerosi fedeli, cosìche il 21 agosto del 1244 si diede avvio ai lavori di costruzione della nuovachiesa di S. Stefano19. Quasi trent’anni dopo, nel 1277, anche i Francescani
15
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
15 RAFFAELLA CICERONI, Il convento di San Nicolò e la città (1270 circa - 1350), in I frati pre-dicatori nel Duecento, “Quaderni di storia religiosa”, vol. 3 (1996), Cierre, Verona 1996, p.110.
16 Il primo testamento nel quale compaiono beneficiati i Domenicani risale al 1239 (BCBg,Archivio degli Orfanotrofi, n. 1193), a cui ne fanno seguito molti altri, cfr. BCBg, Archivio degliOrfanotrofi, nn. 1132, 1155, 1289, 1298, 3979. Per quanto riguarda alcune puntuali conside-razioni sull’analisi dei testamenti come fonte storica si rimanda a: ROBERT BRENTANO, Conside-razioni di un lettore di testamenti, in Nolens intestatus decedere. Il testamento come fontedella storia religiosa e sociale. Atti dell’incontro di studio (Perugia, 3 maggio 1983), EditriceUmbra Cooperativa, Perugia 1985, pp. 3-9; DANIELA RANDO, “Ad confirmationem sancte et ca-tholice fidei christiane”. La prima presenza domenicana, in I frati predicatori nel Duecento …cit., p. 69.
17 CHARLES M. DE LA RONCIÈRE, Tra preghiera e rivolta. Le folle toscane nel XIV secolo, Jou-vence, Roma 1993, p. 168.
18 PAOLO BREZZI, Il secolo del rinnovamento. La rinascita politica, economica e spiritualedel Duecento (1190-1313), Eurodes, Roma 1973, pp. 521-522.
19 Per la posa della prima pietra fu chiamato il bergamasco Guala, allora vescovo di Bre-scia: “Die dominico undecimo exeunte mense augusti. Ad ecclesiam Sancti Stephani Perga-mensis. Congregata ibi multitudine civium et vicinorum dicte vicinie Sancti Stephani proptercelebrationem missarum, cum dominus Guala, Dei gratia Brixiensis episcopus, ad postulatio-nem domini Alberti de Tertio, Dei gratia electi et capituli Pergami, posuisset primarum lapi-dem in hedificatione ipsius ecclesie Sancti Stephani nove costruende; amonitione facta omni-bus astantibus, tam ab ipso domino episcopo, quam ab ipso domino electo, quod hedificatiodicte ecclesie grata esse debeat et accepta maxime omnibus civibus Pergamensibus et maxime
abbandonarono la primitiva chiesa di S. Maria della Carità e si trasferironoin S. Giovanni Battista, ottenendo pure il permesso di eseguire alcuni lavoridi ampliamento che portarono successivamente alla realizzazione del com-plesso del convento di S. Francesco20.
L’opera dei Mendicanti prese definitivamente quota a partire dal 1251,nel momento in cui papa Innocenzo IV nominò alla cattedra episcopale diBergamo il domenicano Algisio da Rosciate21. Questo vescovo si preoccupòdella vita religiosa maschile, effettuando numerose donazioni in favore deimonasteri di Vall’Alta e Astino, e di quella femminile, accogliendo nel 1258le domenicane nel convento di Matris Domini, si adoperò inoltre pressopapa Alessandro IV perché togliesse l’interdetto alla città, e soprattutto in-tensificò la lotta all’eresia e contro i suoi protettori ghibellini22. In Bergamol’eresia aveva trovato, per quasi tutta la prima metà del XIII secolo, un ter-reno favorevole anche a causa dell’assenza di una azione pastorale coeren-te da parte dei vescovi, più interessati alla difesa delle loro proprietà e deiloro diritti feudali23. A questo proposito rese possibile nel 1253 – forse nona caso anno della canonizzazione del domenicano san Pietro martire –l’istituzione della Milizia della Santa Croce, una confraternita parainquisi-toriale facente capo ai Domenicani, in particolare a Pinamonte da Bremba-te. Il Pellegrino, basandosi probabilmente su documenti ancora in possessodella società al tempo della redazione della sua cronaca (1553), annotache:
Multi etiam laboratores ingressi sunt in hanc vineam circa annum Domini1253 quando societas militiae Sanctae Crucis instituta, et ordinata fuit in ae-de S. Stephani ordinis praedicatorum, sub prioratu prefati Fratris PinamontisBergomensis civis24.
La stessa notizia è ripresa anche dal Seroghetti, che, in qualità di colla-boratore di Pinamonte nel costituire la societas, aggiunge il nome di Alberto
16
G. Cossandi
vicinis eiusdem ecclesie ipse dominus electus Pergamensis excomunicavit et anathematizavitomnes, qui dicto operi resisterent et rebelles esse invenirentur. Factum est hoc anno Dominimillesimo ducentesimo quadragesimo quarto, inditione secunda. […]” (BCBg, Fondo pergame-ne, n. 4053). Una puntuale discussione sulla data di questo documento, escludendo le erroneeproposte della storiografia precedente, è stata approntata in: M. CORTESI, Pinamonte da Brem-bate … cit., p. 73.
20 G. RONCHETTI, op. cit., II, p. 328.21 L. DENTELLA, op. cit., p. 203; A. PESENTI, op. cit., p. 99; V. ALCE, op. cit., p. 20.22 V. ALCE, op. cit., p. 22; FRANÇOIS MENANT, Bergamo comunale: storia, economia e società,
in Storia economica e sociale di Bergamo, Bergamo 1999 (Fondazione per la storia economicae sociale di Bergamo. Istituto di studi e ricerche), II, p. 76.
23 A. PESENTI, op. cit., p. 99.24 BARTOLOMEO DE PEREGRINIS, Opus divinum de sacra ac fertili Bergomensi vinea, Brixiae,
apud L. Britannicum, 1553, II, cap. 35; CELESTINO COLLEONI, Historia quadripartita de Bergomoet suo territorio, Brescia 1618, II, p. 389; M. CORTESI, Pinamonte da Brembate … cit., p. 76;MARIAROSA CORTESI, Memorie di S. Grata. Per un cammino verso la santità, in MARIAROSA CORTESI
e GIORDANA MARIANI CANOVA, Il legendario di Santa Grata. Tra scrittura agiografica e arte, LI-TOSTAMPA istituto grafico, Bergamo 2002, p. 29.
de Foro, dal 1245 nominato da papa Innocenzo IV inquisitore generale del-la Lombardia25:
Hic anno 1253 nimium consulti in erigenda Confraternita SS.mae Crucis,quae opera B. Pinamontis et P. Alberti de Foro inquisitoris instituta fuit in ec-clesia S. Stephani ad tutamen fidei Catholice; huic enim societati nomen de-dere et operam centum ex nobilioribus patriae cum numerosa moltitudine ci-vium, quorum religiosa pietas professa est se suasque vires imprendere inhereticorum profligatione26.
Sebbene entrambe le notizie siano plausibili, esistono comunque oggetti-ve difficoltà circa la comprensione storica di questa confraternita, poiché –come generalmente è avvenuto per questo tipo di fondazioni – non si è con-servata la normativa statutaria e non vi è neppure alcun riferimento indi-retto in qualche altro documento coevo; soprattutto appare assai arduo e li-mitato al campo delle ipotesi ogni tentativo di ricostruzione del gruppo so-ciale aderente. I dati disponibili non sono sufficienti a chiarire se anche inBergamo, come in generale avvenne, la Chiesa coinvolse in tale organizza-zione difensiva esclusivamente la classe dirigente, offrendo in cambio, oltreai benefici spirituali, privilegi ed immunità di ordine giuridico, sociale edeconomico27. Esisterebbero, a mio avviso, in mancanza della normativa sta-tutaria ragionevoli dubbi anche sullo status dell’istituzione, se cioè, in ana-logia con le contemporanee esperienze dell’Italia settentrionale e centrale,si trattasse di una vera e propria confraternita – deporrebbe a suo favorel’identificazione della chiesa di S. Stefano come sede sociale – o piuttostouna più libera associazione di laici militanti, preparati per difendere la reli-gione e capaci di assolvere l’incarico di ufficiali dell’inquisizione, in ottem-peranza con quanto richiesto nel 1252 da papa Innocenzo IV con la bollaAd Extirpanda. Il loro compito potrebbe essere stato quello di di sputare congli eretici, o presunti tali, invitare i cattolici più tiepidi ad agire, esortare ilpopolo ad esigere dai governanti l’applicazione delle leggi contro l’eresia ead inserire tali norme negli statuti comunali. Inquadramento e formazionereligiosa miravano, infatti, in queste prime fasi a combattere le dottrine ere-ticali con rinnovate forme di organizzazione del laicato28.
Nel frattempo aveva però preso corpo un bisogno di spiritualità nuovoche, accompagnato da una crescente autonomia dei laici nei confronti delclero secolare oltre che dalle aspirazioni a una pratica cristiana più rigorosa
17
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
25 M. CORTESI, Pinamonte da Brembate … cit., pp. 75-76.26 DOMENICO M. SEROGHETTI, Opus chronologicum, de ortu, et progressu et statu religionis
praedicatorum in civitate Bergomi, BCBg, SPECOLA DOC. 1253/3, pp. 9-1027 LORENZO PAOLINI, Le origini della “Societas Crucis”, “Rivista di storia e letteratura religio-
sa”, vol. 2 (1979), p. 192; M. CORTESI, Pinamonte da Brembate … cit., p. 76.28 GILLES GERARD MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel me-
dioevo, Herder, Roma 1977, II, pp. 761, 767; D. RANDO, op. cit., p. 68; V. ALCE, op. cit., p. 22;JOHN HENDERSON, Pietà e carità nella Firenze del Basso Medioevo, Le Lettere, Firenze 1998,pp. 38-39.
e a una più concreta partecipazione religiosa, sociale e politica dei ceti me-di, andava creando le premesse e il contesto per la nascita di confraterni-te29. In altre parole i laici aspiravano ad uscire dallo stato di inferiorità che,sul piano religioso, ne caratterizzava la condizione30. Già a partire dal XIIsecolo prese avvio un periodo di straordinaria fioritura di opere caritativo-assistenziali: quei laici devoti, uomini e donne, che desideravano dareespressione ai propri aneliti di partecipazione diretta alla vita della chiesa,trovarono uno dei mezzi più consoni di espressione proprio nella praticadella carità. È il periodo in cui all’interno delle città comunali sorgono nuoviospedali urbani, la cui fondazione non è più dovuta soltanto all’iniziativavescovile, ma anche a laici facoltosi o a corporazioni laicali, manifestazionedi quel ‘cristianesimo civico’ che animò fin dal loro sorgere i comuni e checonsisteva in un insieme di valori civici e religiosi coinvolgenti la chiesa lo-cale ed i poteri civili31.
L’elemento associativo è la caratteristica essenziale degli ospedali medie-vali, che nella fase originaria si costituiscono spesso come comunità religiosenelle quali convivevano assistiti ed assistenti, fratres, sorores e conversi32.Ma gli ospedali erano generalmente di ridotte dimensioni, per cui per ri-spondere ai bisognosi che, sempre più numerosi, spinti dalla miseria, si af-follavano nei sobborghi della città, il movimento caritativo si allargava fino aorganizzarsi in un vero e proprio reticolo assistenziale. Già dagli ospedali,poi, si irradiava una sorta di solidarietà esterna, che si esplicava nella distri-buzione di viveri ed elemosine, e nella ricerca dei moribondi e dei cosiddettipoveri vergognosi. Generalmente però si trattava di enti che non tendevanoad individuare una propria competenza specifica, ma al contrario a com-prendere, in modo più ampio possibile, tutte le necessità dei bisognosi33. Nu-merosi furono gli ospedali di cui si ha notizia in Bergamo a partire dalla se-conda metà del XII secolo, nati e legati all’iniziativa di ordini religiosi – come
18
G. Cossandi
29 RAUL MANSELLI, La religione popolare nei secoli XII-XIII, in Problemi di storia della chie-sa. Il medioevo dei secoli XII-XV, Vita e Pensiero, Milano 1976, p. 80; M. CORTESI, Pinamonteda Brembate … cit., p. 76; M. CORTESI, Memorie … cit., pp. 23-24.
30 ANDRÉ VAUCHEZ, I laici nel Medioevo. Pratiche ed esperienze religiose, Il Saggiatore, Mi-lano 1989, p. 112.
31 COSIMO DAMIANO FONSECA, Forme assistenziali e strutture caritative della chiesa nel me-dioevo, in Chiesa e società. Appunti per una storia delle diocesi lombarde, a c. di ADRIANO CA-PRIOLI - ANTONIO RIMOLDI - LUCIANO VACCARO, La Scuola, Brescia 1986, p. 286; C.M. DE LA RONCIÈRE,Tra preghiera e rivolta… cit., p. 100; MARINA GAZZINI, L’esempio di una “quasi-città”: gli ospe-dali di Monza e i loro rapporti con Milano (secoli XIII-XV), in Ospedali e città. L’Italia del Cen-tro-Nord, XIII-XVI secolo. Atti del Convegno Internazionale di Studio tenuto dall’Istituto degliInnocenti e Villa i Tatti (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies). Fi-renze 27-28 aprile 1995, a c. di ALLEN J. GRECO e LUCIA SANDRI, Le Lettere, Firenze 1997, p.188.
32 MARIA TERESA BROLIS, Comunità ospedaliere dell’Italia centro-settentrionale (sec. XII-XV).Modelli, episodi e protagonisti, in Corpi, “fraternità”, mestieri nella storia della società euro-pea, a c. di DANILO ZARDIN, Bulzoni, Roma 1998, p. 74.
33 GIULIANA ALBINI, Città e ospedali nella Lombardia Medievale, CLUEB, Bologna 1993, p. 9.
è il caso dell’ospedale vallombrosano di Astino – o dei laici, che talvolta cer-cheranno il sostegno del capitolo canonicale di S. Alessandro34.
Questa solidarietà, figlia di un nuovo spirito cittadino, evolve spontanea-mente verso nuove forme istituzionali, nate per supplire ai bisogni più ur-genti dei poveri e dei malati o semplicemente per fare rinascere quelle pic-cole comunità cristiane, che la crescita delle vicinie aveva disperso35. Furo-no, però, gli Ordini Mendicanti, spesso supportati dalla progettualità dei ve-scovi e del clero delle vecchie istituzioni, che, a partire dagli anni sessantadel Duecento – periodo per cui si è parlato di ‘trionfo dei Mendicanti’ –, so-prattutto in ambiente urbano, seppero collegare alla loro attività questenuove forme di vita religiosa, al cui interno venivano a fondersi spiritualitàe sentimento religioso unitamente ad aspetti sociologici, politici ed economi-ci. Con l’istituzione delle confraternite si coglie la capacità catalizzante degliOrdini Mendicanti nei confronti del laicato devoto, ma anche comel’inquadramento religioso del laicato fosse inteso quale adesione ad unacondizione che privilegiava le opere, le pratiche di carità e la devozioneespressa dalle opere stesse36. Le confraternite si sovrappongono alle prece-denti forme di organizzazione del laicato devoto; i confratelli continuano acondurre la propria vita nella società e la loro associazione ha come unicoscopo quello di riunire le loro forze in vista di un preciso obiettivo: aiutospirituale reciproco, raccolta e distribuzione di elemosine, assistenza ai fu-nerali, nonché diffondere l’influenza dei Mendicanti per migliorare lo statomorale e religioso della società37.
19
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
34 MARIA TERESA BROLIS, All’origine dei primi ospedali in Bergamo: l’iniziativa dei laici nelXII secolo, “Rendiconti dell’Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lette-re e Scienze Morali e Storiche”, vol. 127 (1994), pp. 54-55, 63; M.T. BROLIS, Comunità ospeda-liere … cit., p. 81.
35 F. MENANT, Bergamo comunale … cit., pp. 65-68.36 G. MICCOLI, op. cit., pp. 793-794, 825; G.G. MEERSSEMAN, op. cit., p. 950; ANTONIO RIGON, Pe-
nitenti e laici devoti fra mondo monastico-canonicale e ordini mendicanti: qualche esempio inarea veneta e mantovana, in Le confraternite in Italia tra Medioevo e Rinascimento, a c. di GA-BRIELE DE ROSA, “Ricerche di storia sociale e religiosa”, voll. 17-18 (1980), pp. 64-65; ROBERTO RU-SCONI, Confraternite, compagnie e devozioni, in La chiesa e il potere politico dal Medioevo all’e-tà contemporanea, a c. di GIORGIO CHITTOLINI e GIOVANNI MICCOLI, Einaudi, Torino 1986 (Storiad’Italia. Annali, IX), pp. 470-473; GIUSEPPINA DE SANDRE GASPARINI, Il movimento delle confrater-nite in area veneta, in Le mouvement confraternel au moyen âge. Actes de table ronde organi-ste par l’Université de Lausanne avec le concours de l’École française de Rome et de l’Unité as-sociée 1011 du CNRS “L’institution ecclésiale a la fin du moyen âge”. Lausanne 9-11 mai 1985,Librairie Droz, Genève 1987, p. 370; L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., pp. 25, 65; M.CORTESI, Pinamonte da Brembate … cit., p. 69; GIANCARLO ANDENNA, Forme confraternali in Italiasettentrionale tra XII e XV secolo, in Tra nord e sud. Gli allievi per Cosimo Damiano Fonsecanel sessantesimo genetliaco, a c. di GIANCARLO ANDENNA - HUBERT HOUBEN - BENEDETTO VETERE,Congedo, Lecce 1993, pp. 19-21; MARINA GAZZINI, Uomini e donne nella realtà ospedaliera mon-zese dei secoli XII-XIV, in Uomini e donne in comunità, “Quaderni di storia religiosa”, vol. 1(1994), Cierre, Verona 1994, p. 127; LAURA GAFFURI, Prediche a confraternite, in Il buon fedele.Le confraternite tra medioevo e prima età moderna, “Quaderni di storia religiosa”, vol. 5(1998), Cierre, Verona 1998, p. 56; F. MENANT, Bergamo comunale … cit., pp. 65-66.
37 F. MENANT, Bergamo comunale … cit., p. 76.
Tuttavia a Bergamo la prima esperienza confraternale fu precedente al-l’avvento dei Mendicanti. A partire dal 1159 presso il monastero vallombro-sano del S. Sepolcro di Astino svolgeva la propria attività una congregazio-ne del S. Sepolcro – di cui non si è conservata la normativa statutaria –, co-munemente conosciuta come Consorzio dell’ospedale di Astino. Ne faceva-no parte uomini provenienti dalla città e dai sobborghi di Bergamo che, tra-mite donazioni, rendite affittuarie e vendite, raccoglievano il denaro che ve-niva distribuito ai poveri, ai carcerati e ai bisognosi38.
In Bergamo l’opera degli Ordini Mendicanti si concretizzò comunquenella nascita di una importante confraternita. Durante l’episcopato del do-menicano Erbordo, in linea con la maggior parte delle congregazioni sortein quegli anni sotto il patrocinio della Vergine39, venne fondato il Consorziodella Misericordia per combattere l’eresia e per organizzare l’assistenzapubblica, bisognosa di una razionalizzazione e un disciplinamento, sotto ilcontrollo della gerarchia ortodossa40. È difficile determinare se e quanto ab-bia influito in questa nuova fondazione la precedente esperienza della Mili-zia della Santa Croce. Entrambe nacquero sotto l’egida domenicana, ed inparticolare di Pinamonte da Brembate di cui dell’una fu ispiratore, dell’altraredattore della regola e membro fino al 1282; ma i pochi elementi a dispo-sizione non permettono di fornire delle conclusioni incontrovertibili. Rima-ne tuttavia aperto il campo delle ipotesi: la Milizia e la Misericordia furonodue confraternite distinte con finalità diverse, che operavano in parallelo.Appare in questo caso singolare che nelle poche attestazioni documentariein cui vengono registrate alcune condanne per eresia non compaia alcun ri-ferimento all’operato della Milizia e i proventi – difficile stabilire se tutti osoltanto un terzo, come affermato dal Mazzi41 – derivanti dalle pene pecu-niarie inflitte siano versati alla Misericordia, a testimonianza quanto meno
20
G. Cossandi
38 L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., p. 55.39 Circa la dedicazione delle confraternite alla Vergine si vedano: G. MICCOLI, op. cit., pp.
825-829; G.G. MEERSSEMAN, op. cit., pp. 762-763; R. MANSELLI, La religione popolare … cit., p.85 ed ENRICO CATTANEO, Città e religione nell’età dei Comuni, Vita e Pensiero, Milano 1979, p.59, i quali individuano in questa scelta da un lato una positiva riaffermazione della tradizionecattolica contraddetta dagli eretici, dall’altro un indice del mutamento della pietà popolare edella sensibilità religiosa.
40 L. DENTELLA, op. cit., p. 210; GENNARO MARIA MONTI, Le Confraternite Medievali dell’Altae Media Italia, La Nuova Italia, Venezia 1927, I, pp. 94-95; GIUSEPPE LOCATELLI, La casa dellaMisericordia in Bergamo, “Bergomum”, vol. IX (1931), p. 124; GIUSEPPE BARACCHETTI, La “Do-mus Magna” della Misericordia, “Bergomum”, vol. XXXIX (1965), p. 65; F. LENI, op. cit., pp.60-62; G. MICCOLI, op. cit., pp. 797, 810, 825; G.G. MEERSSEMAN, op. cit., pp. 773-774, 968-969;G. DE SANDRE GASPARINI, Il movimento delle confraternite … cit., p. 383; A. PESENTI, op. cit., pp.102-103; L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., pp. 26, 57; V. ALCE, op. cit., p. 22; MARIA
TERESA BROLIS, Confraternite bergamasche bassomedievali. Nuove fonti e prospettive diricerca, “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, vol. 2 (1995), p. 342; M. CORTESI, Pinamonteda Brembate … cit., pp. 77-78. Circa la ricomposizione dell’archivio della Misericordia, si ve-da: LUIGI CHIODI, Nel settimo centenario di fondazione della Misericordia Maggiore di Bergamo,“Bergomum”, vol. XXXIX (1965), pp. 3-96.
41 A. MAZZI, Aspetti di vita religiosa … cit., p. 234.
di un possibile legame di quest’ultima con l’operato degli inquisitori. Si po-trebbe al contempo ammettere che la Misericordia, ferma restandol’esistenza di relazioni personali tra le due istituzioni, fu una filiazione dellaprecedente Milizia, che in questo caso avrebbe operato solo per un breveperiodo. Il 1265, anno di inizio dei nuovi statuti, delle nuove matricole, deinuovi registri contabili, corrisponderebbe a un momento di riforma e di ri-organizzazione – o di organizzazione a partire da un periodo di vita piùspontaneo ed informe – della societas, che, aprendosi ad accogliere le nuo-ve esigenze del popolo e accordando maggiore spazio alle nuove classiemergenti, attuò una decisa apertura verso finalità assistenziali, in conse-guenza anche ai possibili problemi connessi alla gestione della lotta antiere-ticale, tanto che durante tutto il Duecento l’eresia rimane un fattore impor-tante della vita religiosa, ma anche sociale e politica di Bergamo42.L’atteggiamento del comune di Bergamo nei confronti dell’eresia fu, infatti,di diretta connessione sia in linea di fatto che di diritto.
A partire dal 1221 la S. Sede, attraverso il cardinale Ugolino di Ostia –impegnato nel condurre a termine un più ampio disegno che prevedeval’appello per l’arruolamento e il finanziamento della quinta crociata, l’invitoalla pacificazione fra le città e fra le fazioni, la lotta all’eresia e la difesa dellelibertà ecclesiastiche –, si era invano adoperata affinché il comune di Berga-mo inserisse nei suoi statuti le disposizioni contro gli eretici emanate dal IVConcilio Lateranense e riconosciute dalle leggi imperiali43. Un nuovo tentati-vo fu compiuto nel settembre del 1227, su invito di papa Gregorio IX, dalcardinale Goffredo Castiglioni, che oltre ad imporre al comune una normati-va contro l’eresia, intervenne per pacificare le fazioni e nominò anche unnuovo podestà. Nel 1229 il podestà Pagano della Torre – nel 1227 podestà diBrescia, città che dal 1224 aveva inserito nei suoi statuti le costituzioni impe-riali – decretò l’applicazione di tali disposizioni, ma durante la guerra civileche si combatté in quell’anno vennero liberati gli eretici imprigionati e il po-destà successivo mise fine alla repressione. Sulla città cadde pertanto nuova-mente la scomunica. Dall’interdetto furono risparmiate soltanto le monachedel monastero benedettino di S. Grata: nel 1235 Gregorio IX concesse loro dipoter, a porte chiuse e senza suonare le campane, celebrare i loro uffici, la
21
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
42 L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., p. 57.43 “[…] dominus Hugo Dei gratia Ostiensis et Velletrensis episcopus, Apostolice Sedis lega-
tus, ex parte domini pape et domini imperatoris et auctoritate legationis qua fungebatur amo-nuit Lanfrancum Multidenarium potestatem Pergamensem et consilium totum vice communisipsius civitatis, et eis precepit, ut infra terminum ordinatum per dominum imperatorem omniastatuta ipsius civitatis que sunt contra ecclesiaticam libertatem penitus de capitularibus suisremoveant et abradano, et ea vel similia de cetero non resumant vel observent. Item ut leges etconstitutiones domini imperatoris die coronationis sue editas contra hereticos et pro conser-vando ecclesiastica libertate et constitutionem domini pape super eisdem factam, quas ibi legifecit, debeant observare et [in] statuto communis Pergami ponere eas […]”, cfr. GUIDO LEVI, Re-gistri dei cardinali Ugolino d’Ostia e Ottaviano degli Ubaldini, Forzani e C., Roma 1890 (Fontiper la Storia d’Italia, 8), pp. 94-95.
messa e ricevere il vescovo, purché quest’ultimo fosse in comunione con lachiesa romana. Le negligenze nella persecuzione dell’eresia si mescolavanoalla lotta politica e di fatto, nel contenzioso con la curia di Roma, a numerosiatti di indipendenza visti come ostili alla chiesa, come la scelta di un podestàproveniente dalle città nemiche del papa e l’assoggettamento dei beni dellachiesa alle imposte comunali. Questa situazione finì per mutare con la mortedell’imperatore Federico II e con il conseguente declino del partito ghibellinoin Lombardia: in Bergamo la podesteria dei della Torre e la successione didue domenicani – Algisio da Rosciate ed Erbordo – all’episcopato favorironola ripresa della lotta antiereticale. L’accoglimento della normativa antiereti-cale negli statuti cittadini avvenne dunque nel 1267:
tempore potestarie excelsi militis domini Napulionis de la Turre potestatis co-munis Pergami, de voluntate sapientis viri domini Conradi de Concorezio giu-risperiti vicarii ipsius domini potestatis, et de voluntate conscilii generalis co-munis Pergami et per ipsum dominum vicarium et conscilium ad instantiamet requisitionem fratrum Oldevrandini Regini de Gussaco et Henrici de LallioPredicatorum ordinis deputatorum ab apostolica Sede inquisitorum hereticepravitatis44.
Una delle prime finalità dichiarate dalla Misericordia fu proprio la lottaall’eresia, a cui si accompagnava una proposta caritativa e devozionale, chesi rivolgeva all’intera città con l’intento di realizzare l’unità cittadina nellesue componenti laica ed ecclesiale. Questo aspetto appare chiaramente dal-la lettura dell’incipit della regola45:
22
G. Cossandi
44 Lo statuto di Bergamo del 1331, a c. di CLAUDIA STORTI STORCHI, Giuffré, Milano 1986, p.73. Sulla questione, si vedano: G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 230, 235-236, 239, 320; A. MAZZI,Aspetti di vita religiosa … cit., p. 210; L. DENTELLA, op. cit., p. 194; BORTOLO BELOTTI, Storia diBergamo e dei Bergamaschi, Edizioni Bolis, Bergamo 1989, II, pp. 154, 183, 211; A. PESENTI,op. cit., pp; 97-102; ANNA CASO, Napoleone della Torre, in Dizionario Biografico degli Italiani,Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1989, XXXVII, p. 621; ARVENO SALA, Le famiglie Suardie Colleoni nei primi secoli del comune di Bergamo, “Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Artidi Bergamo”, vol. LI (1990), pp. 316, 323; AUGUSTINE THOMPSON, Predicatori e politica nell’Italiadel XIII secolo. La “grande devozione” del 1233, Editrice Biblioteca Francescana, Milano 1996,pp. 185-186; D. RANDO, op. cit., p. 55-61; F. MENANT, Bergamo comunale … cit., pp. 73-74.
45 La prima edizione della regola è stata curata dal Locatelli in: GIUSEPPE LOCATELLI,L’istruzione in Bergamo e la Misericordia Maggiore, “Bollettino della Civica Biblioteca di Ber-gamo”, vol. V (1911), pp. 28-34; di cui diede anche una traduzione italiana in: GIUSEPPE LOCA-TELLI, L’istruzione in Bergamo e la Misericordia Maggiore, “Bollettino della Civica Biblioteca diBergamo”, vol. IV (1910), pp. 62-69; si deve al Roncalli una parziale traduzione italiana dellastessa: ANGELO RONCALLI, La “Misericordia maggiore” di Bergamo e le altre istituzioni di benefi-cenza amministrate dalla Congregazione di carità, Tipografia S. Alessandro, Bergamo 1912,pp. 38-40; una recente edizione della regola è apparsa nell’apparato documentario di: L.K.LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., pp. 107-121; si deve a M.T. Brolis, G. Brembilla e M.Corato, con la collaborazione di Attilio Bartoli Langeli, l’ultima edizione, cfr. MARIA TERESA BRO-LIS - GIOVANNI BREMBILLA - MICAELA CORATO, La matricola femminile della Misericordia (1265-1339), Stabilimento Tipografico Pliniana, Selci-Lama 2001 (Sources et documents d’histoire duMoyen âge publiés par l’École française de Rome, 4), pp. 65-79.
Incipit consortium seu congregatio sancte Misericordie domini nostri IesuChristi et gloriose virginis Marie. […] Hec sunt ordinamenta congregationis etfraternitatis sancte Misericordie ad honorem domini nostri Iesu Christi etbeate et gloriose virginis Marie matris Dei et omnium sanctorum, ad confir-mationem et exaltationem sancte fidei catholice et ad confusionem et depres-sionem hereticorum et omnis heretice pravitatis46.
A cui segue:
Facta […] cum auctoritate et voluntate venerabilis patris domini fratris Her-bordi pergamensis episcopi Ordinis Predicatorum cui, tamquam patri et do-mino spirituali, omnes devote obbedire debemus et cum voluntate et consiliodominorum prelatorum Sancte Pergamensis Ecclesie, videlicet domini Gui-scardi arcidiaconi et domini Iohannis prepositi et domini Bertolotti || archi-presbiteri et aliorum dominorum canonicorum et cum consilio et assensu fra-trum Predicatorum et fratrum Minorum et aliorum fidelium laicorum47.
La nascita della Misericordia non si configurerebbe, dunque, come unaesclusiva emanazione degli Ordini Mendicanti, in particolare dei Domenica-ni, che a differenza dei Francescani riuscirono in modo più efficace ad inse-rirsi nel quadro della vita ecclesiastica cittadina, ma come l’incontro di piùvolontà ed espressione di forze in quel momento convergenti e solidali48.Connubio già di per sé singolare, poiché per consuetudine in molte altre cit-tà si ebbe una confraternita che si appoggiava ai Predicatori e un’altra aiMinori49, mentre, in questo periodo, ancora difficile appariva talvolta il rap-
23
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
46 BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 1r.47 BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 1r-1v. Si confronti a questo proposito lo Statuto della
Congregazione di S. Domenico (pubblicato in: G.G. MEERSSEMAN, op. cit., pp. 628-629) istituita aBologna nel 1244, nel quale si possono riscontrare evidenti analogie con la Regola della Miseri-cordia di Bergamo, indici non certo di un rapporto diretto tra le due istituzioni, bensì di un co-mune modus operandi da parte dei Domenicani. A Bologna come a Bergamo i primi tre capito-li delle rispettive regole specificano: le caratteristiche di coloro che vengono ammessi all’inter-no della confraternita, i modi e i tempi della predicazione e della raccolta dell’elemosina (a Bo-logna fissata in un denario), il ruolo dei massari (in entrambi i casi quattro: uno per ogni quar-tiere o porta della città) e le modalità per la distribuzione delle elemosine a poveri, infermi,carcerati, orfani e vedove. Circa i contatti tra i monasteri di Bergamo e Bologna si veda quantoesposto da: V. ALCE, op. cit., pp. 16, 24-25; cfr. anche: M. CORTESI, Memorie … cit., p. 30.
48 A. RIGON, Penitenti e laici… cit., p. 54; L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., p. 59;M.T. BROLIS, Confraternite bergamasche … cit., pp. 342-343; M. CORTESI, Pinamonte da Bremba-te … cit., p. 77; ROISIN ANN COSSAR, The work of salvation: civic piety in the Misericordia Mag-giore of Bergamo, 1265-1365, Thesis University of Toronto 1999, p. 23; M.T. BROLIS - G. BREMBIL-LA - M. CORATO, op. cit., p. CXVI; M. CORTESI, Memorie … cit., p. 30.
49 Altro esempio coevo – segnalato dal Little – di consorzio sorretto in modo concorde daPredicatori e Minori fu il Consorzio di Fede e di Pace istituito a Cremona nel 1266, ma le note-voli differenze progettuali e operative di tale esperienza non la rendono accostabile alla Miseri-cordia. Fondato, infatti, per iniziativa dei legati pontifici e approvato direttamente da papa Cle-mente IV con una bolla nel 1267, il consorzio aveva come principale finalità la persecuzionedegli eretici, dando vita a una politica volta al sostegno dei dettami pontifici e in collaborazionecon l’autorità comunale. Il consorzio cremonese ebbe, inoltre, le caratteristiche di un’istituzio-
porto di convivenza e coesistenza tra Ordini Mendicanti e clero secolare. Èin ogni caso notevole che il mondo clericale, spesso aggrappato ai suoi pri-vilegi e ai suoi possedimenti, si fosse rivelato un attento interprete dellenuove aspirazioni che attraversavano la componente laica della chiesa ber-gamasca, incoraggiando forme rinnovate di devozione e assistenza50.L’intervento accanto al vescovo dell’arcidiacono (seconda autorità dell’epi-scopio, suo stretto collaboratore nel governo del clero della diocesi e posto acapo della canonica di S. Vincenzo), del preposito (massimo esponente delcapitolo e legato alla basilica di S. Alessandro), nonché dell’arciprete (sosti-tuto del vescovo in caso di sua assenza), nella costituzione della Misericor-dia è sintomatico del volere unanime di tutte le componenti della chiesa diBergamo e dell’entità delle aspettative riposte nella confraternita51.L’intervento del vescovo nell’atto costitutivo della fondazione sarebbe inol-tre collegato alla natura canonica e alle finalità dell’istituzione, e di conse-guenza al suo specifico compito pastorale e giurisdizionale su tutti gli entidiocesani di interesse pubblico spirituale52. È nella Misericordia e attraver-so di essa che si rinsalda il legame tra la città e il suo vescovo, da un latoeco della ‘simbiosi istituzionale’ tra chiesa vescovile e collettività cittadinadel secolo precedente, dall’altro espressione di una civitas ancora imper-niata sulla chiesa53. Aspetto questo singolare e in controtendenza rispetto alpanorama delle città del XIII secolo, dove le grandi istituzioni ecclesiastiche– vescovado e capitolo – non giocano più il ruolo di centri di raccolta deipartiti e, pur esercitando ancora una certa influenza, si presentano spessocome vittime della volontà del comune di sottomettere ad imposta le loroconsiderevoli proprietà54.
24
G. Cossandi
ne ‘totalitaria’: a coloro che vi aderivano era richiesto per giuramento “quod numquam secun-dum meum posse permittam, quod in civitate vel districtu Cremone fiant alia nova consortiavel societates vel communitates quod solum locum habeat in diocesi et districtu, vel quod no-vum dominum fiat aut detur alicui”. Cfr. U. GUALAZZINI, op. cit., pp. 208-210; JOHN KOENIG, Il“popolo” dell’Italia del Nord nel XIII secolo, Il Mulino, Bologna 1979, pp. 318-319; L.K. LITTLE,Libertà, carità, fraternità … cit., p. 59; MARINA GAZZINI, Il consortium Spiritus Sancti in Emiliafra Due e Trecento, in Il buon fedele… cit., p. 162.
50 M.T. BROLIS, Confraternite bergamasche … cit., p. 343; F. MENANT, Bergamo comunale…cit., p. 63.
51 GABRIEL LE BRAS, Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale, ed. it. a c. diLUIGI PROSDOCIMI e GUERRINO PELLICCIA, SAIE, Torino 1974 (Storia della Chiesa dalle origini aigiorni nostri), XII, 2, pp. 504, 517-522; F. MENANT, Bergamo comunale … cit., p. 63; GIUSEPPINA
VALSECCHI, “Interrogatus … respondit”. Storia di un processo del XII secolo, “Bergomum”, vol.LXXXIV (1989), pp. 62-63; ANDREA ZONCA, “Est una matrix ecclesia”. A proposito di due recentistudi sulla chiesa di Bergamo nel Medioevo, “Archivio Storico Bergamasco”, voll. 1-2 (1990),pp. 282-283; DARIO GALLI, Lanfranco di Bergamo: un vescovo tra due capitoli, in Il difficile me-stiere di vescovo, “Quaderni di storia religiosa”, vol. 7 (2000), Cierre, Verona 2000, pp. 104-105.
52 C. D. FONSECA, op. cit., p. 289.53 MARIA PIA ALBERZONI, Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni, Interlinea, No-
vara 2001, p. 9.54 F. MENANT, Bergamo comunale … cit, p. 31.
Il Bottagisi nella sua Cronaca annota che fu proprio il vescovo Erbordoad attivarsi affinché “s’ergesse la confraternita della Misericordia per sol-lievo della miseria de poveri”, e ancora “meditando di fondare il nobil con-sorzio della veneranda Misericordia a benefitio de poveri cittadini, et ter-razzani per il qual effetto haveva unito grossa somma di contanti, per darprincipio ad opera così pia volle per compagnio nostro buon P. Pinamon-ti”55. La notizia che lo stesso vescovo avesse sostenuto gli esordi della Mi-sericordia con una grossa somma di denaro trova riscontro anche nel Se-roghetti: “Erbordus summam numeratam pecuniae exhibuit expendendamin erectione dicti prius loci ad sublevandam miserorum inopiam”56, men-tre i documenti ricordano soltanto la concessione di indulgenze57. Al di làdella effettiva, o meno, concessione di denaro alla Misericordia, apparechiaro che la posizione di rilievo assegnata nella regola al vescovo Erbordonon sia semplicemente tributaria di un certo formalismo documentario,ma, al contrario, sarebbe indicativa del forte legame con la congregazionee del ruolo di primissimo piano avuto nell’iniziativa che condusse alla suanascita. Il presule, infatti, poté intervenire come elemento di aggregazionee di consenso in un momento in cui risultava essenziale la coesione dellediverse forze ecclesiastiche58. Si consideri che già a partire dalla fine delsecolo XII, in un periodo di convulso proliferare di movimenti spesso sortiai margini delle istituzioni ecclesiastiche, con Lanfranco, l’episcopato si di-mostrò sempre ben disposto ad appoggiare i nuovi impulsi religiosi, salvopoi cercare di subordinarli, pur senza snaturarli, al sistema istituzionalediocesano.
La partecipazione dell’episcopato – sebbene il Meersseman diffidi dal-l’individuare un legame tra una confraternita e una determinata chiesa –spiegherebbe inoltre perché, se fosse stata una confraternita di matriceesclusivamente domenicana, non abbia avuto sede nella chiesa conventualedi S. Stefano, bensì nell’ecclesia mater di S. Vincenzo e nella ecclesia comu-
25
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
55 BASILIO BOTTAGISI, Cronaca dei conventi domenicani di Bergamo, ms. BCBg, SPECOLADOC. 664, ff. 28r, 35v; così anche in: B. DE PEREGRINIS, op. cit., I, cap. 38. Il quale a propositodel vescovo Erbordo ricorda che: “Hic, inter alia a se gesta, consortium Misericordiae insti-tuendum curavit anno Christi 1265 et episcopatus eius 4”.
56 D.M. SEROGHETTI, op. cit., p. 10.57 Nel verso del terzo foglio di guardia della Regola (BCBg, Archivio Mia, n. 937) si legge:
“In nomine Domini amen. Millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione .VIII., de men-se ianuari. Dominus frater Hambordus episcopus Pergamensis, actoritate sibi concessa a do-mino Papa, dedit et inionxit cuique persone congregationis domine sancte Misericordie civita-tis et virtutis Pergami et omnibus aliis personis que venerint ad predicationem illius congrega-tionis Misericordie, quo ipsa predicatio sit, per ipsam congregationem annum unum et diesquadraginta in remissionem animarum eorum”.
58 L. DENTELLA, op. cit., p. 214; LUIGI PELLEGRINI, Vescovi e ordini mendicanti, in Vescovi ediocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo. Atti del VII convegno di storia della chiesa inItalia (Brescia, 21-25 settembre 1987), Herder, Roma 1990, I, p. 198.
59 G.G. MEERSSEMAN, op. cit., p. 932.
nis di S. Maria Maggiore60, quest’ultima divenuta poi col tempo simbolo del-la crescita di una forte coscienza cittadina e di una marcata identità ur ba -na61. Con questo non si vuole cedere il passo a un inutile quanto vacuo gio-co delle parti, nel tentativo di assegnare la paternità esclusiva della Miseri-cordia al vescovo Erbordo piuttosto che al domenicano Pinamonte, quantoriconsiderare il ruolo avuto dal presule e dal capitolo della cattedrale all’in-terno di una storiografia troppo spesso sbilanciata in favore del redattoredella regola62.
La Misericordia fu dunque la mirabile espressione di una religiosità civi-ca e di una identità locale, che in anni di accesi contrasti seppe ergersi, daun lato, a modello positivo e alternativo della dinamica fazionaria, dall’al-tro, a modello unitario all’interno di una pluralità di organismi di governoin concorrenza tra loro, variamente sostenuti dai partiti e dai potentati chesi alternavano nel ruolo di preminenza63. D’alra parte, elemento comune amolte manifestazioni confraternali fu proprio un profondo desiderio di paci-ficazione, richiesto dalle stesse masse di fedeli e meditato in ambienti men-dicanti – come fu per l’Alleluia del 1233 – e clericali. In questo disegno, dal-la sua genesi e dal suo successivo sviluppo, si intuisce chiaramente la deci-sa e determinante volontà del vescovo, che in quel momento ebbe probabil-mente ancora la forza necessaria e la capacità di armonizzare e consolidareattorno a questo istituto le diverse forze ecclesiali della città di Bergamo:Mendicanti, clero secolare e laici.
Il rapporto con il capitolo della cattedrale era altresì rafforzato dal fattoche un suo membro era scelto come patrono della confraternita, “istudsanctum consortium semper habeat unum de prelatis Ecclesie Pergamensisqui sit patronus, protector et defensor huius sancti consortii seu fraternita-tis”, eletto dal ministro e dai consiglieri e confermato nel suo incarico dalvescovo, “et dominus episcopus mittat pro dicto electo si ipse non iverit adepiscopum cum predictis. Et dominus episcopus roget eundem electum etiniurgat ei in remissionem omnium paccatorum quod propter Deum de istafraternitate bonam et sollicitam curam gerat secundum gratiam a Deo sibi
26
G. Cossandi
60 Nel verso del secondo foglio di guardia della regola si trova: “Liber regule consortii Mi-sericordie domine Sancte Marie Maioris de Pergamo” (BCBg, Archivio Mia, n. 937). Poche pa-role che in modo esplicito sembrano confermare, all’atto di origine, l’esistenza di un legametra la confraternita e la chiesa di appartenenza. Meno probabili appaiono per Bergamo i moti-vi ‘polemici’ che accompagnarono altre fondazioni: M. GAZZINI, Il consortium Spiritus Sancti…cit., p. 161.
61 F. MENANT, Bergamo comunale… cit., p. 43; GIUSEPPINA ZIZZO, Santa Maria Maggiore“cappella della città”. La basilica bergamasca nei secoli XII e XIII, “Archivio Storico Bergama-sco”, vol. 3 (1982), pp. 207-229.
62 Spunti per una riconsiderazione del problema sono già stati proposti da Mariarosa Cor-tesi nelle opere più volte citate.
63 DANIEL E. BORNSTEIN, Corporazioni spirituali: proprietà delle confraternite e pietà deilaici, “Ricerche di storia sociale e religiosa”, vol. 48 (1995), pp. 77-78; GIORGIO CHITTOLINI,L’affermazione del comune, in Storia economica e sociale … cit., II, p. 8.
datam”, il cui compito era quello di “habere bonam curam de factis congre-gationis et quando necesse fuerit loqui pro eis et apud antianos populi etetiam in consilio comunis Pergami et ubicumque fuerit oportunum”64.
Numerose sono le attestazioni di lasciti e concessioni al consorzio daparte di membri dello stesso capitolo e delle principali chiese della città diBergamo: altra esplicita manifestazione del rapporto tra l’istituzione e il pa-norama religioso della città in cui opera, nonché del successo riscosso pres-so la comunità. All’anno 1267 il Receptum per ceneparios consortii Miseri-cordie registra due donazioni: una soma di miglio da parte di Alberto Laza-rius, canonico di S. Vincenzo e, il 3 maggio, dieci soldi da parte di Pregacio,prete della chiesa di S. Matteo65. L’importanza della donazione di Pregacio èancora maggiore, in quanto la chiesa di S. Matteo era una collegiata diretta-mente dipendente dalla Santa Sede, che a più riprese aveva preteso di esse-re esentata dalle tasse imposte dal vescovo e dal clero maggiore66. Nel 1272è invece la volta di Bayardo, prete della chiesa di S. Alessandro della Croce,che dona cinque soldi67, e di Giovanni de Verdello, preposito della chiesa diS. Alessandro Maggiore, per venticinque soldi68. Nel 1273 Giovanni de Ver-dello, preposito della chiesa di S. Alessandro, dona alla Misericordia trentasoldi e tre denari e mezzo69, nel 1278 il canonico Alberto de Primollo, su in-carico del suddetto preposito Giovanni de Verdello, dà nove sestari di fru-mento70, mentre nel 1280 Giovanni de Advocatis, preposito di Bergamo edall’anno successivo patrono della confraternita, dona cinque soldi amore
27
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
64 BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 9r-9v; alcune analogie si riscontrano nella situazione ve-neta: GIUSEPPINA DE SANDRE GASPARINI, Per lo studio delle confraternite basso-medievali del ter-ritorio veneto: note su statuti editi e inediti, in Le confraternite in Italia… cit., pp. 37-39.
65 “Item receperunt somam unam milii a domino Alberto Lazario, canonico ecclesie SanctiVincencii, quod millium datum fuit pro remedio anime domini Recuperati de Su(r)sina condamcanonico suprascripte ecclesie”; “Item receperunt solidos decem imperialium a domino Prega-cio presbitero ecclesie Sancti Mathei, die sabato tercio intrante madio, et quod denari fueruntdati pro remedio anime suprascripti domini Recuperati de Sursina” (Receptum per canepariosconsortii Misericordiae ab anno 1267 usque 1308, BCBg, Archivio Mia, n. 724 (d’ora in poiReceptum), f. 1v).
66 G. RONCHETTI, op. cit., II, p. 310.67 “In primis receperunt suprascripti magister Bonumus de Zenate et socii canevari ipsius
Misericordie solidos quinque imperialium a domino pre Bayardo presbitero ecclesie Sancti Ale-xandri de la Cruce civitatis Pergami, de mense aprilis, pro remedio anime sue” (Receptum, f.5v).
68 “Item receperunt solidos viginti quinque imperialium a domino pre Iohanne, prepositoecclesie Sancti Alexandri Mayoris, quos dedit ipsi congregacioni pro remedio anime domini pre[……] de Ghisalba” (Receptum, f. 6v).
69 “Item receperunt solidos treginta et denarios .III. et medium a domino pre Iohanne deVerdello, preposito ecclesie Sancti Alexandri, pro remedio anime alterius domini prepositiBlanci condam qui antecessit eum suprascripte ecclesie Sancti Alexandri” (Receptum, f. 8r).
70 “Item receperunt sextarios novem furmenti ab Alberto de Primollo canonico ecclesiePergamensis, insolutum illorum solidorum viginti quinque imperialium, quos dominus pre Io-hannes de Verdello, prepositus condam ecclesie Pergamensis, iudicavit suprascripto consorciopro rimedio anime eius” (Receptum, f. 19v)
Dei e pro remedio anime di Guala, un tempo vescovo di Brescia71. Nel 1282il clero della chiesa di S. Alessandro dona alla Misericordia cinque soldi peracquistare il pane da distribuire in seguito ai poveri della città diBergamo72. A partire dagli anni ottanta del secolo si rafforza, inoltre, il le-game tra la Misericordia e alcuni membri della famiglia Colleoni presentinel capitolo: il 31 marzo del 1285 Egidio Colleoni, canonico della chiesa diBergamo, stabilisce per testamento che i membri del consorzio della Miseri-cordia “habeant et habere debeant, de hinc ad tregintasex annos, sommasduas furmenti, siliginis, milli, panici equaliter, annuatim, super decima deCaluscho Superiori”73. Nel 1296 Ribaldo de Fara, custode della chiesa diBergamo, dà al Consorzio, per volere di Pasino, un tempo prete della chiesadi S. Maria Rossate, dieci soldi74. Nello stesso anno, Guiscardo Cervonum,canonico della chiesa di Bergamo – già tale nel 1261 e tra i testimoni all’at-to di conferma del consorzio di S. Michele nel 1272 – lascia per testamentoalla Misericordia cento soldi75. Nel 1301, infine, Giacomo, prete della chiesadi Sant’Alessandro Maggiore, a nome del fu Giacomo, prete della chiesa diSanta Grata inter vites, dà alla confraternita cinque soldi76.
Al tempo stesso, non mancano alcune donazioni provenienti dagli Umi-liati, che dal loro arrivo in Bergamo avevano rivestito un ruolo qualitativa-mente rilevante nel campo della carità e dell’assistenza, ma il cui impattosulla popolazione nella seconda metà del secolo era andato progressiva-mente diminuendo a causa dell’ascesa degli Ordini Mendicanti e della Mise-ricordia77. Dopo il concilio Lionese II era, infatti, stato sottratto agli Umiliatiqualsiasi incarico pastorale a vantaggio degli stessi Ordini Mendicanti, men-tre l’evoluzione interna all’ordine in ottemperanza ai dettami conciliari liaveva progressivamente costretti al distacco da ogni impegno esterno alle
28
G. Cossandi
71 “Item recepit solidos quinque imperialium a domino Zoanno de Advocatis, preposito ec-clesie Pergamensis, quos dedit suprascripto consorcio amore Dei et pro remedio anime dominifratris Guale condam episcopi Brixiensis” (Primus liber Misericordiae ab anno 1280 usque1303, BCBg, Archivio Mia, n. 718 (d’ora in poi Primus liber), f. 3v).
72 “Item recepit solidos quinque imperialium a clero Sancti Alexandri Pergamensis, quoddedit suprascripto consorcio pro remedio anime domini magistri Otti de Nagso, quondam ca-nonico suprascripte ecclesie Pergamensis, per emere panes pauperibus” (Primus liber, f. 38r).
73 BCBg, Fondo Mia, n. 646; per quanto riguarda i rapporti con i membri della famigliaColleoni in merito alle decime di Calusco Superiore, cfr. FRANÇOIS MENANT, Lombardia feudale.Studi sull’aristocrazia padana nei secoli X-XIII, Vita e Pensiero, Milano 1994, pp. 172-174;nonché i documenti: BCBg, Fondo Mia, nn. 647, 10475.
74 “Item receperunt solidos decem imperialium a Ribaldo de Fara, custode ecclesie Perga-mensis, quos denarios pre Paxinus, condam presbiter ecclesie Sancte Marie Rossate, iudicavitsuprascripto consorcio amore Dei” (Receptum, f. 63v).
75 BCBg, Fondo Mia, n. 699; AVBg, Archivio Capitolare, n. 4235; mentre indicazioni sullacomposizione del capitolo della chiesa di Bergamo nel 1261 si ricavano da: AVBg, Archivio Ca-pitolare, n. 1162.
76 “Item receperunt solidos quinque imperialium a domino pre Iacobo, presbitero ad Sanc-tum Alexandrum Mayorem, quos dominus pre Iacobus, condam presbiter ecclesie Sancte Grateinter vites, iudicavit suprascripto consorcio” (Receptum, f. 71r).
77 M.T. BROLIS, Gli Umiliati a Bergamo … cit., pp. 111, 192.
domus78. Nel 1269 Crescimbeno, frater della casa degli Umiliati detta do-mus comunis, dona quindici lire imperiali alla Misericordia79; l’anno succes-sivo è la volta di Cresso che pro remedio anime di Bonadeo, suo confratello,consegna sette some e sette sestari di miglio80. Nel 1271 Lanfranco, mini-stro della casa degli Umiliati de la Fontana de Piniollo, dà tre lire imperialia nome di tutti gli altri confratelli e consorelle, che, in vita o in morte, proremedio anime avevano promesso somme al Consorzio81. Nel 1276 è la vol-ta di Giovanni Morlani, frater della casa degli umiliati de Cuniollo, che donadieci lire imperiali, e di Cresio della casa de Bienzano, che a sua volta dà al-la Misericordia quindici lire82. Nel 1284 Crescimbeno frater della domus co-munis dà dieci soldi, promessi al Consorzio da Rogerio83. Infine nel 1286Zambono de Gorne, frater della domus degli umiliati de Raçine, dona cin-que soldi imperiali, promessi pro remedio anime da Algisio, un tempo suoconfratello84. Queste attestazioni testimoniano la straordinaria varietà di le-gami tra la Misericordia e il mondo religioso bergamasco, nonché il ruolounificante che essa rivestì nei confronti del variegato tessuto religioso urba-
29
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
78 M.T. BROLIS, Gli Umiliati a Bergamo … cit., p. 198.79 “In primis enim receperunt suprascripti canevari et ministri libras quindecim iperiales a
fratre Cresimbeno domus humiliatorum domus comunis [...]” (Receptum, f. 2v).80 “Item receperunt somas septem et sextarios .VII. millii a fratre Cresso umiliato pro mer-
cede et remedio anime Bonadei fratris eius, qui iudicavit suprascripte societati Misericordiepro anima sua et de quo millio sint acceptioni libras .IIIor. et solidos .II.” (Receptum, f. 3v).
81 “Item receperunt libras tres imperiales a fratre Lanfranco, ministro de la Fontana do-mus humiliatorum de la Fontana de Piniollo, dante nomine et vice omnium aliorum fratrum etsororum ipius domus et aliorum plurium, tam in vita quam in morte, pro animis eorum et ea-rum que promiserunt dare ipsi congregacioni pro remedio anime eorum et cetera” (Receptum,f. 4v).
82 “Item recepit suprascriptus Filippus canevarius libras viginti quinque imperiales a Io-hanne de Terno calgario et a Petro Guidoti calgario, sindicis et procuratoribus suprascripticonsorcii sancte Marie, videlicet in una parte libras decem imperiales, quas suprascripti sindicireceperant a fratre Iohanni Morlani de domo umiliatorum de Cuniollo per cartam rogatam perIohannem de Redona notarium die .IIIIor. exeunte aprili millesimo .CC.LXXVI, et quas ser Ber-tramus Vitalis Ferarii de Cuniollo iudicaverat suprascripto consorcio congregacionis Misericor-die pro remedio anime eius; et in alia parte libras quindecim imperiales, quas suprascripti sin-dici suprascripto modo et nomine recepera(n)t a fratre Cresio de domo umiliatorum de Bienza-no pro aliquo iudicerio facto per suprascriptum ser Bertramum suprascripto consorcio aliquade causa de aliquibus denariis quos dictus ser Bertramus condam habebat ad suprascriptumdomum umiliatorum, ut de ipsa receptione suprascriptarum librarum .XV. imperialium conti-netur in quadam alia carta rogata per suprascriptum Iohannem de Redona notarium supra-scripto die; et de quibus suprascriptis libris .XXV. imperialibus sic receptis per suprascriptumFilipum canevarium a suprascriptis sindicis suprascriptus Iohannes notarius fecit cartam su-prascripto die” (Receptum, f. 13v).
83 “Item receperunt solidos decem imperialium a fratre Cresimbeno domus umiliatorum dedomo comunis, quos Rogerius, qui condam stabat ad suprascriptam domum umiliatorum, iudi-cavit suprascripto consorcio amore Dei” (Receptum, f. 30v).
84 “Item receperunt solidos quinque imperialium a fratre Zambono de Gorne domus umi-liatorum de Raçine, quos Algisius condam eius frater iudicavit suprascripto consorcio pro re-medio anime eius” (Receptum, f. 35r).
no, divenendo autorevole destinataria della devozione di gran parte deimembri e delle diverse componenti della chiesa di Bergamo, e determinan-do, con il superamento degli ambiti particolari, il raggiungimento dello sta-tus di confraternita della città85.
La Misericordia non fu comunque l’unica confraternita di Bergamo; tra il1266 e il 1329 – anno dell’inizio della signoria viscontea – sorsero, quasi acostituire un vero e proprio reticolo, non meno di otto fraternite parrocchia-li, di cui la metà tra il 1266 e il 1292. La distribuzione di questi consorzi al-l’interno della città si innesta sulla generale suddivisione del contesto urba-no in vicinie e quartieri, facenti capo alle porte, sulla cui logica venne delresto costituita tutta la macchina amministrativa del comune86. Lo scopocomune e primario di tali sodalizi era il vincolo di solidarietà tra i parteci-panti e l’espletamento di forme assistenziali rivolte alla propria vi cinia87.
Nel 1266 un gruppo di laici della vicinia di S. Michele al Pozzo Biancofondò l’omonima confraternita e affidò al notaio Pasino Razini de Poltrinia-no la redazione della regola. Particolarmente stretti erano i rapporti intrat-tenuti da questa confraternita con la Misericordia: per regola si stabilì chetutti i membri del consorzio dovevano essere anche membri della Miseri-cordia, divenendo in questo modo quasi una cellula della più vasta confra-ternita cittadina88. Nel 1272 un gruppo di uomini della vicinia di S. Alessan-dro della Croce, nei pressi della porta di S. Andrea, istituì una propria con-fraternita. Anche in questo caso, dal testo della regola, in parte redatta daun notaio, emerge una indiretta influenza della Misericordia, in particolareper quanto riguarda i requisiti necessari all’ammissione alla confra ter ni -ta89. Qualche anno più tardi, a partire dal 1279, anche nella parrocchia diS. Caterina fu costituito un consorzio, la cui regola nella sua semplicità è
30
G. Cossandi
85 Diversa appare la situazione fiorentina, per la quale si rimanda a: CHARLES M. DE LA RON-CIÈRE, Les confréries à Florence et dans son contado aux XIVe-XVe siècles, in Le mouvementconfraternel au moyen âge … cit., p. 302.
86 MARINA GAZZINI, Confraternite e società cittadina nel medioevo: percorsi di indagine sul-la realtà milanese, “Nuova Rivista Storica”, vol. LXXXI (1997), pp. 380-381.
87 L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., p. 63; M.T. BROLIS, Confraternite bergama-sche… cit., p. 342; M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXX.
88 “Item quod canevarius predicti consorcii teneatur benigne rogare et humiliter exortariomnes fratres qui iam intraverunt ipsum consorcium seu qui intrare || voluerint ut ipsi honoresui et pauperum, inspecta communi utilitate, debeant esse de predicta congregatione Miseri-cordie. Et demum nullus in predicto sancti Michaelis recipiatur consorcio nisi primitus sit deipsa fraternitate et congregatione Misericordie”, L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit.,pp. 60, 133.
89 “Item statuerunt et ordinaverunt quod persone et confratres huius congregationis sint fi-deles et legales et honesti, non lusores, non ebreosi, non basaterii, non infames, sed conve-nientes, et conversationem habentes bonam et honestam, propterea nullus predo, nullus infa-mis, nullus de turpi vitio denotatus, nullus hereticus, vel credens hereticorum, recipiatur in istacongregatione nisi velit redire ad fidem sancte Ecclesie catholice. Item quod nullus publicus us-surarius et infamis qui hoc velit, pro officio seu pro arte sua, non recipiatur omnes vero quale-scumque fuerint viri, quicumque volunt veram facere penitentiam, recipiantur, quando apare-bunt in ipsis probabilia signa”, cfr. L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., pp. 60-61, 146.
modellata su quella della Misericordia. Dall’elenco dei confratelli, riportatodalla matricola allegata agli statuti conservati nell’archivio della parrocchiadi S. Caterina, risulta che questo consorzio annoverava tra gli iscritti – casounico per i consorzi parrocchiali di Bergamo – alcune donne, seppure regi-strate esclusivamente in relazione al marito, in base al principio dell’unitascorporis90. Una pergamena del 1306 riporta due documenti redatti dal no-taio Iohannes de Uria: nel primo il consiglio della confraternita di S. Cateri-na, in data 7 agosto, elegge come proprio ministro Bartolomeo del fu Tom-maso Martinonum ed i quattro canevari, mentre nel secondo il consigliodella Misericordia, in data 20 febbraio, elegge il ministro Giovanni de Ulive-nis e i quattro canevari, a testimonianza del fatto che il bacino di utenzadelle associazioni confraternali per quanto riguardava i notabili e le perso-nalità giuridicamente qualificate non era poi così vasto e diversificato91. Èinfatti ragionevole immaginare l’esistenza di un libero gioco di scambi entroun ambito culturale prevalentemente cittadino. Dovrebbe, invece, risalire al1302, nonostante la stesura della regola dati al 1363, la confraternita di S.Alessandro in Colonna; mentre da alcuni testamenti dei primi decenni delTrecento è attestata l’esistenza in Bergamo dei sodalizi parrocchiali di S.Cassiano, S. Leonardo e S. Lorenzo92.
Nel 1272 morto il vescovo Erbordo, venne allora eletto dai canonici qua-le successore Guiscardo Suardi, arcidiacono dal 1244 – come tale comparenominato nella Regola all’atto di fondazione della Misericordia –, membrodella famiglia di Bergamo più potente a livello cittadino, di parte imperiale eghibellina. Nonostante questo, Guiscardo diede continuazione nei confrontidei Mendicanti a quanto avviato dai suoi predecessori, dimostrandosi altret-tanto attento alle nuove forme della spiritualità popolare93. Nel 1272 appro-vò gli statuti del consorzio parrocchiale di S. Michele al Pozzo Bianco, fon-dato presso l’omonima chiesa nel 126694. Nel 1273 consacrò la chiesa delconvento domenicano di Matris Domini, concedendo quaranta giorni di in-dulgenza a coloro che l’avrebbero visitata il 25 marzo, giorno della dedica-zione, e confermò al monastero di Vall’Alta le donazioni dei suoi predeces-
31
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
90 M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXX.91 BCBg, Fondo Mia, n. 723.92 L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., pp. 62-63; M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M.
CORATO, op. cit., p. XXXI.93 BCBg, Fondo pergamene, n. 4081. G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 259, 317-318; FEDELE SA-
VIO, Gli antichi vescovi d’Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. La Lombardia, Tipo-grafia S. Alessandro, Bergamo 1929, p. 109; L. DENTELLA, op. cit., p. 216; A. PESENTI, op. cit., p.104.
94 “Quod consorcium cum omnibus et singulis statutis et capitulis eiusdem venerabilis pa-ter dominus Guiscardus, divina clemencia Pergamensis episcopus, sub anno currente Domini.M.CC. septuagesimo secundo, quintedecime indictionis, undecimo die octubris, in episcopalipallatio Pergami, in presencia domini Guiscardi Cervonum, Suardi de Robertis et Petralli de Ri-vola, testium rogatorum, auctoritate sua solemniter confirmavit per cartam rogatam per Paxi-num de Poltriniano notarium” cfr. L. K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., p. 125; si vedaanche C. COLLEONI, op. cit., II, pp. 393-394.
sori95. Il 13 gennaio dello stesso anno concesse quaranta giorni di indulgen-za a tutti coloro, uomini e donne, che, facendo parte delle congregazioni as-sistenziali istituite dai Predicatori in onore di Dio e di Maria vergine, contri-ti e confessati, partecipassero alla predicazione tenuta dai frati96. Questoprivilegio dovrebbe aver riguardato anche la confraternita della Misericor-dia, tuttavia nel codice che tramanda il testo della regola si trova annotatasoltanto un’altra concessione del 27 dicembre 127797, di cui non si è con-servato il documento in forma di originale. Risale invece al 9 aprile del1272 una disposizione di Giacomo, priore generale dell’ordine dei frati pre-dicatori della provincia di Lombardia, che intendeva concedere ai laici affi-liati al consorzio o alla congregazione di S. Stefano di partecipare alle vegliee agli altri beni spirituali dei frati predicatori98. Tali disposizioni in favoredei Predicatori e della Misericordia si rivelarono essenziali per dare provadi una solidale coesione, a dimostrazione che l’episcopato di Bergamo, sottola guida di Guiscardo, mantenne un collegamento con la confraternita eseppe ritagliarsi un ruolo importante nella gestione della stessa, accentuan-done gli aspetti caritativi ed assistenziali99. I vescovi infatti si dimostrarono
32
G. Cossandi
95 G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 324-325; A. PESENTI, op. cit., pp. 101, 104; per un’analisipiù approfondita intorno al monastero si rimanda a: LUIGI CHIODI, Origine e primi sviluppi delmonastero, in Il monastero di Matris Domini in Bergamo, Edizioni “Monumenta Bergomen-sia”, Bergamo 1980, II, pp. 237-238.
96 BCBg, Archivio degli Orfanotrofi, n. 1198: “Guiscardus Dei gratia episcopus Pergamen-sis. Ecclesiarum prelatis omnibus et singulis nostre diocesis et universis, tam in civitate quamdiocesi, in Christo fidelibus. Salutem in Domino sempiternam. Intelligentes quod per fratres or-dinis fratrum predicatorum, tam in civitate quam nostra diocesi, quidam laudabiles ac peruti-les congregationes sancte sint et fiant ad honorem Dei et gloriose Virginis Marie laudem, ubinon solum per dictos fratres Dei verbum ad salutem credentium seminatur, verum etiam etelemosine multe in subsidium egenorum et pauperum laudabiliter offeruntur. Ideoque nos, eo-rum commendabili operi favore benivolo annuentes de Dei misericordia confisi, volumus quoddicti fratres, auctoritate nostra, indulgentiam facere possint .XL. dierum quolibet mense, cumin predictis congregationibus eos contigerit predicare sane omnibus de suis peccatis vere con-tritis et confessis, vel si infra octavum diem confitebuntur qui et que ipsas congregationes in-traverunt vel intrabunt pro tempore, vel de suis bonis ipsis congregationibus dederint vel mise-rint in misericordie peribus erogandis. Quam propter inhibemus districtius et precipiendomandamus ne aliquam persona secularis vel ecclesiastica iam dictos fratres in tam pio opereaudeat aliquamtenus impedire vel molestare. Datum .XIII. exeunte ianuario .M.CC.LXXIII.”, giàcitato in: B. BOTTAGISI, op. cit., f. 17r; ora ripreso anche in: M. CORTESI, Memorie … cit., p. 29.
97 Nel verso del terzo foglio di guardia della regola: “In nomine Domini amen. Die quintoexeunte decembri .M.CC. septuagesimo septimo, indictione quinta. Dominus Guiscardus deSuardis, miseratione divina episcopus Pergamensis, dedit et concessit cuique persone societa-tis et consorcii congregationis Misericordie domine Sancte Marie Pergami et omnibus aliis per-sonis que venerint ad predicationem suprascripti consorcii que fiant et porixerint caritatem ibivel noncis ipsius consorcii quinquaginta dies perdonanciae per cartam rogatam per Federicumde Azuellis notario suprascripto die, anno et indictione” (BCBg, Archivio Mia, n. 937).
98 BCBg, Fondo pergamene, n. 4078.99 Diversa appare la situazione fiorentina: ANNA BENVENUTI PAPI, Donne religiose nella Fi-
renze del Due-Trecento; appunti per una ricerca in corso, in Le mouvement confraternel aumoyen âge … cit., p. 81; mentre simile, benché successiva di uno o due secoli, appare quellaveneta: G. DE SANDRE GASPARINI, Il movimento delle confraternite … cit., pp. 364, 383.
generalmente ben disposti nel concedere protezione e privilegi di indulgen-za alle confraternite legate ai conventi, preferite alle case degli Umiliati giàgeneralmente protette dall’esenzione100. Il favore di Guiscardo verso la Mi-sericordia continuò anche dopo la sua morte avvenuta nel 1281: a partiredal 1282 e per sei anni stabilì che il consorzio ricevesse ogni anno una so-ma di miglio e una di segale101.
Alla morte del vescovo la successione alla cattedra episcopale si rivelò as-sai difficile. La divisione tra le famiglie, nel frattempo, si era fatta semprepiù profonda e incerta in quanto i più potenti Suardi non riuscivano da solia tradurre la loro preminenza politica in una signoria istituzionalizzata eaveva trasferito le discordie anche all’interno del capitolo della cattedrale. Il21 marzo del 1281, al momento dell’elezione del nuovo vescovo si creò unaspaccatura tra la maggioranza dei canonici espressasi in favore di RobertoBonghi, e una congrua minoranza, schieratasi con Giovanni Avvocati, che siappellò alla decisione del papa. La questione, per un insieme di cause, siprotrasse per otto anni fino al 1289, quando Niccolò IV confermò vescovo ilBonghi. Sembra inoltre che i responsabili della chiesa di Bergamo non sidiedero particolare cura di ottemperare con sollecitudine agli inviti del pon-tefice e di eseguire gli ordini del loro nuovo vescovo, tanto che il Bonghi potéprendere ufficialmente possesso dell’episcopato, dopo notevoli difficoltà, allafine del 1291102. Questi resse dunque soltanto per un triennio la chiesa diBergamo, ma si dimostrò ben disposto nei confronti degli Ordini Mendicanti:favorì la costruzione e consacrò la nuova chiesa dei Minori, incentivò la pro-secuzione di quella domenicana di S. Stefano e pose la prima pietra perl’edificazione della chiesa di S. Agostino dell’ordine degli Eremitani, terzafamiglia mendicante di Bergamo103. Mirò inoltre a dare un nuovo impulsoalla vita spirituale della diocesi grazie alla riorganizzazione del clero secola-re e regolare, in modo da assicurare la continuità del servizio del culto nellacittà e nel suo territorio104. Sul finire del 1292 anche la Misericordia fu og-
33
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
100 CINZIO VIOLANTE, La chiesa bresciana nel medioevo, in Storia di Brescia, Treccani, Bre-scia 1963, I, p. 1100.
101 “Item receperunt unam somam sicalis et unam somam milii a domino Lanfranco, domi-ni Girardi Suardi civitatis Pergami, quas dominus Guiscardus de Suardis, Dei gratia condamepiscopus Pergamensis, iudicavit suprascripto consorcio quolibet anno usque in capite sex an-norum et que suprascripte due somme sunt pro primo anno” (Receptum, f. 26r).
102 FLAVIO FAGNANI, Roberto Bonghi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enci-clopedia Italiana, Roma 1970, XII, p. 40.
103 G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 335-337, 345, 357; F. SAVIO, op. cit., p. 114; L. DENTELLA,op. cit., pp. 221-224; A. MAZZI, Aspetti di vita religiosa … cit., p. 238; A. MOSCONI e S. LORENZI,op. cit., p. 14; A. PESENTI, op. cit., pp. 104-105; A. SALA, op. cit., p. 332; CORRADO FUMAGALLI, S.Agostino di Bergamo. La storia e l’arte delle chiese e dei conventi agostiniani di Bergamo,Nembro, Almeno, Romano, edizioni Villadiseriane, Villa di Serio (Bg) 1990, pp. 44-47; LELIO PA-GANI, Cattedrale, chiese, struttura urbana, in Chiesa, istituzioni e territorio. Atti del corso.Bergamo, ottobre-dicembre 1988, a c. di LELIO PAGANI e VINCENZO MARCHETTI, Editrice commer-ciale, Bergamo 1991, p. 97.
104 F. FAGNANI, op. cit., pp. 40-41.
getto delle attenzioni del vescovo, il quale, come del resto già i predecessori,intervenne in suo favore con la concessione di indulgenze105.
Gli anni intercorsi tra il 1281 e il 1289, dalla morte del vescovo Guiscar-do Suardi alla conferma papale del successore Roberto Bonghi, condusseroa un mutamento di equilibri nei rapporti, fino ad allora esistenti, tra la Mi-sericordia e la chiesa di Bergamo: con la vacanza della cattedra episcopalee l’insorgere di forti tensioni all’interno del capitolo della cattedrale, venne-ro a mancare alcune di quelle componenti che avevano favorito e garantitol’iniziale sviluppo della confraternita. Venuti dunque meno il fattore aggre-gante del vescovo e la solidarietà di parte della chiesa diocesana, i Mendi-canti si trovarono nella condizione di dover procedere in maggiore autono-mia e assumere in prima persona – probabilmente con la garanzia dell’ap-poggio papale, da sempre loro elemento di forza – la guida della confrater-nita106.
Furono i Domenicani allora ad avocare maggiore spazio nell’iniziativa,anche in virtù del fatto che i Francescani stavano probabilmente attraver-sando alcune difficoltà – come attesta il Primus liber Misericordiae “fue-runt modo in magna indigencia”107 – e il loro maggiore impegno nella dife-sa della fede si riflesse direttamente sull’agire della Misericordia. Coincise,infatti, con gli anni dal 1281 al 1289 la ripresa di una fervida attività in-quisitoriale in Bergamo, i cui proventi, derivanti dalle condanne, furonoversati nelle casse del Consorzio108. Numerose furono le condanne commi-
34
G. Cossandi
105 “Die vigesimo secundo mensis decembris .M.CC. nonagesimo secundo, indictione quin-ta. Dominus Robertus de Bongis, miseratione divina episcopus Pergamensis, dedit et concessitcuique persone porgenti caritatem .XL. dies indulgencie per cartam rogatam per Antonium deParvis notarium, suprascripto die et anno et indictione sive per Bertramum de Brolo notarium”(BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. IIIv).
106 Per quanto riguarda la situazione generale, si vedano: R. MANSELLI, I vescovi italiani …cit., p. 334; A. RIGON, Penitenti e laici … cit., p. 54.
107 Primus liber, f. 14v.108 “Item receperunt libras quatraginta quinque imperiales a fratre Lanfranco de Amiçis
de ordine Predicatorum, potestate et voluntate fratris Guidi de Quochonacho ordinis Predica-torum inquisitoris hereticorum, et quas suprascriptas libras .XLV. imperiales dicuntur esse etfuisse de denariis Martinis Buboy burgi Canallis in quibus condemnatus fuit per suprascrip-tum fratrem Guidum debere dare et consignare canevariis suprascripti consorci per eos dareet distribuere pauperibus et egenis et incarzelatis civitatis et burgorum Pergami” (Receptum,ff. 26v, 27r, 27v); “Item recepit libras decem imperiales a Lanfranco de Mariano burgi sanctiStephani die sabati .XII. exeunte marcio, in quibus ipse Lanfrancus fuit condemnatus per do-minum fratrem Guidonem de Choquonacho de ordine Predicatorum, inquisitorem heretico-rum, debere dare suprascriptis canevariis suprascripti consorci congregacionis sancte Miseri-cordie domine sancte Marie de Pergamo per eos dare et distribuere pauperibus et infirmis etincarzelatis et egenis civitatis et burgorum Pergami”; “Item recepit libras quatraginta quinqueimperiales a fratre Lanfranco de Amicis de ordine Predicatorum, potestate et voluntate fratrisGuidi de Cochonaquo, suprascripti ordinis inquisitoris hereticorum, et quas suprascriptas li-bras .XLV. imperiales dicuntur esse et fuisse de denariis in quibus Martinus Buboy burgi Ca-nalis fuit condemnatus per suprascriptum fratrem Guidum debere dare et consignare caneva-riis suprascripti consorci per eos dare et distribuere pauperibus et egenis civitatis et burgo-rum et vertutis Pergami”; “Item recepit libras tres imperiales a domino Detesalvo de Ambive-
nate a persone che, non essendo in grado di cogliere la differenza tra orto-dossia ed eterodossia sul piano dottrinale, finirono per considerare orto-dosso colui che viveva nella maniera più conforme a quella che nella lorolimitata esperienza ritenevano la vita cristiana109. L’impressione, dunque,dell’esplosione del fenomeno ereticale, che si ricava dai documenti è inparte dovuta all’ampliamento costante della nozione di eresia da parte del-le autorità ecclesiastiche, che tesero a raccogliere nel termine eresia opi-nioni sino a quel momento non apparse veramente pericolose: spesso nonè tanto la deviazione dottrinale a causare l’eresia, quanto il rifiuto di obbe-dire alla gerarchia ecclesiastica110. Le esperienze ereticali vanno infatticollocate nel vivo della società e analizzate nel tessuto culturale e sociale,nella dinamica delle tensioni morali e religiose concretamente indi vi dua -bili111. Talvolta l’eresia si mescola anche alla politica: interessi di fazione,in città e regioni così profondamente divise, entrarono senza dubbio nelledenunce e nelle repressioni, tuttavia rimane abbastanza sicura l’effettivaadesione all’eresia da parte degli inquisiti di cui ci è giunta testimonian-za112. Prova del clima di sospetto e di intolleranza nutrito dalla popolazio-ne di Bergamo verso gli inquisitori e coloro che li affiancavano in tale inca-rico è un documento del 9 agosto del 1302:
Die iovis nono intrante augusto .M°.CCCII. In mercato veteri blave comunisPergami, iuxta domum habit(acionis) heredum domini Iacobi de Bustigallis.Inter vesperas et c(on)pletorium veniebat Albertinus et Paulus de Cumis, fa-miliares dominorum fratris Guidonis de Coconathis et fratris Tomai de Mug-go, inquisitorum hereticorum, ante ipsam habitacionem dicendo de suis ne-gocis et tunc salivit Fachinus de Sorisolle, manu armata, cum una spata nudainferius de uno dascho et voluit ferire ipsum Paulum et ipsum Albertinum, di-centes ipsi: ‘Vade ad viam tuam et dimitte nos ire ad nostram. Non dicimusde te aliquid’. […]113.
35
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
re, solvente nomine et vice Lanfranci qui dicitur Rubeus, filii quondam Aydi de Caleppio, bur-gi sancti Andree, et pro eo in quibus suprascriptis libris tribus imperialibus suprascriptusLanfrancus fuit condemnatus per dominum fratrem Guidum de Choconacho inquisitorem deordine Predicatorum debere dare et consignare suprascriptis de suprascripto consorcio con-gregacionis sancte Misericordie de Pergamo per eos dare et destribuere pauperibus et egeniset incarzelatis” (Primus liber, ff. 33r-34r, 36r, 58r, 59r, 61r, 114r-114v, 134v, 154r-156r); giàoggetto di studio da parte di: A. MAZZI, Aspetti di vita religiosa … cit., pp. 233-246; V. ALCE,op. cit., pp. 26-27; cfr. anche MARIA PIA ALBERZONI, Chiesa e Comuni in Lombardia. Dall’età diInnocenzo III all’affermazione degli ordini mendicanti, in La Lombardia dei comuni, Milano1988, p. 43.
109 R. MANSELLI, La religione popolare … cit., p. 84.110 Storia del cristianesimo. Religione, politica, cultura, VI. Un tempo di prove (1274-
1449), a c. di MICHEL MOLLAT DU JOURDIN e ANDRÉ VAUCHEZ, Borla, Città di Castello 1998, pp.302-304.
111 GRADO GIOVANNI MERLO, Un contributo sulla storia ereticale a Vicenza nel duecento, “Ri-cerche di storia sociale e religiosa”, vol. 39 (1991), p. 203.
112 G. PENCO, op. cit., p. 363.113 BCBg, Fondo Mia, n. 11756.
È inoltre possibile che proprio grazie all’istituzione e all’operato dellaMisericordia i Domenicani riuscirono a radicarsi in modo così forte nellacittà di Bergamo; alcuni documenti restituiscono testimonianza della gestio-ne comune di alcuni affari e di uno scambio piuttosto vivace di personalitàqualificate. Nel 1306 Giovanni de Ulivenis, in qualità di sindaco del conven-to dei frati predicatori e del consorzio della Misericordia, riceve un appez-zamento di terra situato in Nembro114. Nel 1308 il notaio Rivano de Vario,agendo a nome della Misericordia e del convento dei predicatori, riscuotedodici soldi e mezzo quale affitto per un appezzamento di terra situato nellavicinia di S. Alessandro115.
Nello stesso periodo prese avvio quel processo che portò la confraternitaa svincolarsi progressivamente – anche se mai completamente – dalle duechiese diocesane di S. Maria Maggiore e S. Vincenzo, luogo in cui tuttaviacontinuò a tenersi la predicazione116. Infatti, se negli anni 1281117, 1282118
e ancora nel 1292119 e nel 1293120 le riunioni del consiglio si tennero all’in-terno del palazzo episcopale o, più comunemente, nel coro di S. Vincenzo, apartire dallo stesso 1282 e più decisamente dal 1304 si trasferirono a S.Stefano, “ad domum fratrum predicatorum”121.
Il successore del vescovo Roberto Bonghi, morto sul finire del 1292, Gio-
36
G. Cossandi
114 BCBg, Fondo Mia, n. 7177.115 BCBg, Fondo Mia, n. 4477. Si vedano anche: BCBg, Fondo Mia, nn. 4468, 4480, 8913,
8925.116 Il secondo capitolo della Regola (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 3r) stabiliva infatti
“quod ille persone de ista congregatione que bono modo possunt, nisi habeant iusta causam,debeant venire post terciam, facto prandio, bis in quolibet mense, per totum annum ad eccle-siam maiorem beati Vincentii martiris gloriosi, ad audiendam predicationem et ad faciendamelimosinam, secundum quod ipsi sibi sentiunt quod possint facere”; cfr. L. K. LITTLE, Libertà,carità, fraternità … cit., p. 113.
117 “In nomine Domini amen. Die dominico sexto exeunte iullio .M.CC. octuagesimo secun-do, indictione decima. In civitate Pergami, in coro ecclesie domini Sancti Vincencii. In pubblicaconvocacione et in pubblico consilio suprascripti consorci congregacionis Misericordie dominesante Marie, ibi more solito convocato, […]” (Primus liber, f. 14v).
118 “In nomine Domini amen. Die dominico callendis novembris M.CC. octuagesimo secun-do, indictione X. In civitate Pergami, in coro ecclesie domini Sancti Vincencii. In pubblica con-vocatione et in pubblico consilio suprascripti consorci Misericordie domine sancte Marie, ibimore solito convocato et coadunato, […]” (Primus liber, f. 15v).
119 “In nomine Domini amen. Die dominico .XIII. exeunte febrario .MCC. nonagesimo se-cundo, indictione quinta. In comune Pergami, in choro ecclesie domini Sancti Vincencii. In pu-blico et generali consilio consorci congregacionis sancte Misericordie domine sancte Marie Per-gamensis, in quoquidam consilio erunt octo ex credendariis suprascripti consorci et in magniquantitate aliorum bonorum hominum suprascripti consorci […]” (Primus liber, f. 239v).
120 “In nomine Domini amen. Die quinto exeunte ianuario, millesimo ducentesimo nonage-simo tercio, indictione sexta. In civitate Pergami, in coro ecclesie domini Sancti Vincencii. Inpublica et generali credencia consorci et congregacionis sancte Misericordie domine SancteMarie Pergamensis, ibi more solito convocata et coadunata […]” (BCBg, Fondo Mia, n. 6820).
121 BCBg, Fondo Mia, nn. 723, 1385, 6828; G. LOCATELLI, La casa della Misericordia … cit.,pp. 124-125.
vanni da Scanzo, intervenne a razionalizzare il panorama assistenziale diBergamo rafforzando i diversi ospedali e soprattutto unendo, nel 1305, alconsorzio della Misericordia quello più antico del monastero di Astino. Fon-dato accanto al monastero, per iniziativa dell’abate Maifredo, da un’asso-ciazione di maggiorenti della città di Bergamo e amministrato da quattroministri con intenti caritatevoli, tra cui la distribuzione di elemosine ai po-veri e ai carcerati una volta all’anno, nel giorno di s. Lazzaro, il consorziodel monastero di Astino appariva all’inizio del XIV secolo ormai “extenuatoet quasi morte consumpto”122. La Misericordia procedette a una vera e pro-pria acquisizione del consorzio di Astino, al punto da fare redigere un regi-stro in cui vennero annotati tutti i suoi debitori, che da quel momento dove-vano pagare quanto dovuto direttamente alla Misericordia123. Nel frattem-po, rinsaldò i rapporti con il medesimo monastero: nel 1306 la confraterni-ta riceve da Giacomino, camerario del monastero di Astino, sette sestari disegale che il monastero era tenuto a dare quale canone d’affitto per alcuniappezzamenti di terra. Mentre l’anno successivo il canevario del monasterodà alla Misericordia trentacinque soldi quale affitto annuale per sette perti-che di terra124.
Nello stesso periodo si intensificarono i contatti tra la Misericordia e glialtri centri del monachesimo tradizionale, urbani ed extraurbani: sono del-l’inizio del XIV secolo alcuni contatti – solo di natura economica – con il mo-nastero di Pontida, che a partire dal 1281 aveva dato avvio a un processo diinurbamento con l’acquisto di una casa nella vicinia di S. Giacomo125. Nel1303 Pietro, vicario del monastero di Pontida, consegna alla confraternitaventi soldi affinché fossero distribuiti ai poveri nel giorno di Natale. In quel-lo stesso anno Pietro de Pontida e Bartolomeo Giselberti Botti, entrambi vi-
37
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
122 BCBg, Fondo Mia, n. 1684; circa il monastero di Astino, fondato nel 1117 come vero eproprio ‘monastero comunale’ beneficiando della sollecitudine del comune e della liberalitàdella classe dirigente, si rimanda a: L. DENTELLA, op. cit., p. 235; Bergamo nei suoi monasteri.Storia e arte dei cenobi benedettini della Diocesi di Bergamo, a c. di MARIO LOCATELLI e PAOLO
DA RE, Il Conventino, Bergamo 1986, pp. 189-190; FRANCESCA CREMASCHI, Il monastero di S. Se-polcro di Astino (Bergamo) dalle origini sino alla fine del secolo XII, Tesi Università degli Studidi Milano rel. Gigliola Soldi Rondinini, aa. 1991-1992, I, p. 131-132; L.K. LITTLE, Libertà, cari-tà, fraternità … cit., p. 102-106; A. PESENTI, op. cit., p. 107; F. MENANT, Bergamo comunale …cit., p. 64.
123 BCBg, Fondo Mia, n. 1665.124 “Item receperunt solidos quindecim imperialium a fratre dum Iacobino, camarerio mo-
nasterii de Astino, pro solutione sextarium .VIII. sicallis, quam ipsum monasterium dare tene-batur suprascripto consorcio de Astino pro ficto plurium peciarum terre quas tenent a supra-scripto consorcio”; “Item receperunt solidos .XXXV. imperialium a canevario monasterii deAstino, solvente nomine et vice ipsius monasterii, pro ficto unius anni proximi preteriti pertica-rum .VII. terre, que fuit consorcii de Astino et modo spectat suprascripto consorcio Misericor-die” (Receptum, ff. 84v, 87v).
125 MAURO CORTINOVIS, I priori maggiori del monastero di Pontida, Archivio Storico Bremba-tese, Brembate Sopra (Bg) 1978, II, pp. 5-27; Bergamo nei suoi monasteri… cit., pp. 80-81.
cari del monastero di San Giacomo di Pontida, consegnano alla Misericor-dia un carro di vino, che avevano promesso di dare amore Dei durante ilperiodo della vendemmia126.
Il 29 maggio del 1304, infine, il vescovo Giovanni da Scanzo intervennea dirimere una controversia circa le pertinenze di un appezzamento di terraposseduto in comune dal monastero di Vall’Alta con la Misericordia, i fratiPredicatori, Minori ed Eremitani, concedendo al monastero di Vall’Alta dialienare la sua parte127.
Il vescovo si impegnò pure in un’opera di riforma della chiesa e del cle-ro, che lo condusse a indire due sinodi, una nel 1295 e la seconda nel 1304,alla quale parteciparono anche alcune rappresentanze dei frati Domenicanie Francescani128.
Ma un episcopato indebolito da lunghi periodi di vacanza e un capitolo,anch’esso vittima dei bandi che colpirono le famiglie in seguito alle frequen-ti discordie cittadine, non furono più in grado di esprimere la forza neces-saria per mantenersi nei confronti della Misericordia quel polo aggreganteche erano stati in passato. Intervennero allora la ‘neutralità’ del contenitoreconfraternale e l’accresciuta coscienza istituzionale a consentire alla Miseri-cordia di non rimanere irreversibilmente ancorata alle scelte originarie e disaper rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla mutata situazione dellachiesa di Bergamo.
38
G. Cossandi
126 “Item receperunt solidos viginti imperialium a domino dum Petro, vicario monasterii dePontida, dante nomine et vice ipsius monasterii quos voluti debere distribui inter pauperes adfestum Nativitatis Domini”; “Item receperunt solidos viginti a domino dum Petro, vicario dePontida, de denariis dicti monasterii quos voluit debere dari pauperibus ad festum NativitatisDomini amore Dei”; “Item receperunt solidos viginti a domino dum Petro, vicario de Pontida,quos dedit suprascripto consorcio nomine dicti monasterii quos voluit debere dari pauperibusad festum Paschatis”; “Item receperunt carrum unum musti a monasterio de Pontida”; “Itemreceperunt solidos viginti imperialium a domino vicario de Pontida, quos voluit debere daripauperibus ad festum Paschatis de denariis suprascripti monasterii” (Receptum, ff. 80r, 83r,84v, 85v, 90r).
127 “Die vigesimonono mensis maii, millesimo trecentesimo quarto, indictione secunda. Inepiscopali palacio Pergamense. In presentia infrascripti Bartholomei notarii et domini Bona-venture de Longis, Iohannis de Ulivenis et Bonadei de Cultinate, civium Pergami, testium ro-gatorum. Venerabilis patris dominus Iohannes, Dei gratia episcopus Pergamensis, ... <così A>abbatis et conventus monasterii Val(is) Alte Pergamensis diocesis, pretibus inclinatis, conces-sit eisdem licentiam pertinentis ipsi monasterio et conventibus Predicatorum, Minorum, He-remitarum et consorcio Misericordie Pergamensis ex legato eis facto per quondam dominamZevernegam de Bergonzis; et hoc fecit ipse dominus episcopus quia reliqui consortes ipsiuspecie terre intendunt ipsam peciam terre vendere, et quia ipsa comode dividi non potest etconsiderans quod est pro ipso monasterio quod ipsa alienatio dicte sue partis fiat quam etcontra. […]” (BCBg, Fondo Mia, n. 6686); circa gli Eremitani, cfr. anche: BCBg, Fondo Mia, n.4469.
128 G. RONCHETTI, op. cit., II, p. 364; L. DENTELLA, op. cit., pp. 228-229.
La Misericordia e il Comune
In Bergamo le confraternite laiche vennero fondate nella seconda metàdell’età comunale, in un periodo caratterizzato dalla forte influenza dellapars populi e della Società delle Armi di S. Maria Maggiore, da una instabi-lità istituzionale, nonché dalla pressoché costante realtà o minaccia dellaguerra civile, a motivo di una intensa dinamica fazionaria che contrassegnòper tutto il XIII secolo la vita del comune129. La prima avvisaglia dei futuriscontri avvenne nel 1206 quando in città scoppiò il bellum tra i Suardi e iRivola, a causa del rifiuto da parte dei Suardi – interpretato come un tenta-tivo di rovesciare militarmente le istituzioni comunali – di lasciare libera lachiesa di S. Maria Maggiore affinché il podestà vi potesse radunare l’aren -go130. Nel mondo comunale la forza dei partiti, infatti, si misurava non tan-to dal numero degli aderenti, quanto dalla capacità di occupare la piazza, ilpalazzo comunale e di espellere gli avversari dalla città. Mentre il gruppo diparentela funzionava obiettivamente già come strumento politico molto pri-ma che i membri dello stesso gruppo avessero chiara coscienza delle suestrutture e possibilità131. Tuttavia l’insuccesso patito dai Suardi e dal lorotentativo di costituire una signoria derivò in parte dall’incapacità della fa-miglia di svincolarsi dal gioco delle fazioni presenti nella città, centro inizia-le del loro potere132.
39
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
129 G. RONCHETTI, op. cit., II, p. 222; CARLO CAPASSO, Il “Pergaminus” e la prima età comuna-le a Bergamo, “Archivio Storico Lombardo”, vol. XXXIII (1906), p. 289; GIUSEPPE LOCATELLI, Lostatuto della Società delle armi di S. Maria Maggiore di Bergamo, “Bergomum”, vol. XXVIII(1924), p. 2; FLAVIO FAGNANI, Guidotto Bonghi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istitutodell’Enciclopedia Italiana, Roma 1970, XII, p. 37; R. BORDONE, op. cit., p. 203; L.K. LITTLE, Li-bertà, carità, fraternità … cit., p. 25; A. SALA, op. cit., p. 315; SANTE BORTOLAMI, Le forme “so-cietarie” di organizzazione del popolo, in Magnati e popolani nell’Italia comunale. Quindicesi-mo convegno di studi (Pistoia 15-18 maggio 1995), Pistoia 1997, p. 43; G. CHITTOLINI,L’affermazione… cit., p. 7.
130 G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 19-33; ANGELO MAZZI, La pergamena Mantovani, “Atti del-l’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo”, vol. IX (1889), pp. III, X-XIV; ANGELO MAZZI, I“Confines Domi et Palatii” in Bergamo, “Archivio Storico Lombardo”, vol. XXX (1903), p. 17;CARLO CAPASSO, Guelfi e Ghibellini a Bergamo, “Bergomum”, vol. XV (1921), pp. 8-9; J. KOENIG,op. cit., pp. 156-157; ENRICO ARTIFONI, Una società di “popolo”. Modelli istituzionali, parente-le, aggregazioni societarie e territoriali ad Asti nel XIII secolo, “Studi Medievali”, serie III,vol. XXIV (1983), p. 574; GINA FASOLI, Oligarchia e ceti popolari nelle città padane fra il XIII eil XIV secolo, in Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Ger-mania, a c. di REINHARD ELZE e GINA FASOLI, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 33-34; GLORIA
CAMINITI, Problemi di difesa e sicurezza interna a Bergamo alla fine del Duecento, “Nuova Ri-vista Storica”, vol. LXXX (1996), p. 154; MASSIMO VALLERANI, L’affermazione del sistema pode-starile e le trasformazioni degli assetti istituzionali, in Storia d’Italia, UTET, Torino 1998, IV,p. 407.
131 GIOVANNI TABACCO, Il rapporto di parentela come strumento di dominio consortile: alcuniesempi in Piemonte, in Famiglia e parentela nell’Italia medievale, a cura di Georges Duby eJacques Le Goff, Il Mulino, Bologna 1977, p. 83; G. FASOLI, op. cit., pp. 11-12.
132 OVIDIO CAPITANI, Dal comune alla signoria, in Storia d’Italia, UTET, Torino 1981, IV,p. 166.
Ma la dinamica fazionaria estendeva le sue relazioni anche al di fuori delcomune agli altri centri della regione, alle famiglie e ai partiti che in essi do-minavano. A questo proposito assunse un ruolo determinante l’egemonia diMilano, che di fatto si impose come il maggiore ente giurisdizionale dellaregione: nei decenni centrali del XIII secolo il partito ghibellino e i Suardiguardavano proprio ai Visconti come ai loro naturali alleati, mentre i Bon-ghi – alla fine del secolo XIII alla testa della fazione guelfa –, i Rivola e il Po-polo al partito popolare milanese capeggiato dai Della Torre133. Il regimepodestarile comportava, infatti, generalmente la creazione di una rete di re-lazioni sovracittadine, in cui la forza del sistema risiedeva soprattutto nellareciprocità degli scambi di ufficiali e nella formazione di un circuito di po-destà che reggevano contemporaneamente le città di un medesimo schiera-mento134.
È possibile, pur non instaurando meccanici rapporti di causa-effetto traun piano e l’altro, che proprio questa situazione di precarietà e di perma-nente tensione abbia in parte incentivato e favorito la formazione degli or-ganismi associativi confraternali, come è del resto plausibile che lo svilupposuccessivo possa essere stato in parte influenzato da circostanze politiche.Le confraternite apparvero allora come forme di inquadramento sostitutivee di appoggio, ristabilendo sul piano spirituale una solidarietà che era venu-ta meno nel quotidiano, o nascondendo gli effetti di questa disgre ga zio -ne135. In altre parole le confraternite davano ai cittadini un senso di sicu-rezza in un periodo in cui la popolazione, sconvolta dalle continue lotte difazione e dall’incertezza del clima politico, viveva in un profondo senso diprecarietà.
Il XIII secolo a Bergamo, come del resto anche nelle altre città contermi-ni e non solo, è caratterizzato da una positiva spinta a livello demografico eda una serie di evoluzioni politiche: il regime consolare, che aveva segnato
40
G. Cossandi
133 GINO FRANCESCHINI, La vita sociale e politica nel Duecento, in Storia di Milano, Treccani,Milano 1954, IV, p. 117; CLAUDIA STORTI STORCHI, Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune allasignoria, Giuffrè, Milano 1984, p. 276; B. BELOTTI, op. cit., II, p. 144; F. MENANT, Lombardiafeudale … cit., pp. 219-221; ELISA OCCHIPINTI, Milano e il podestariato in età comunale: flussidi esportazione e reclutamento, “Archivio Storico Lombardo”, serie XII, vol. I (1994), pp. 13-14; G. CHITTOLINI, L’affermazione … cit., p. 8.
134 MASSIMO VALLERANI, Cremona nel quadro conflittuale delle città padane nell’età di Fede-rico II, in Cremona città imperiale. Nell’VIII centenario della nascita di Federico II. Atti delConvegno Internazionale di Studi. Cremona 27-28 ottobre 1995, Linograf, Cremona 1996 (An-nali della Biblioteca Statale e Libreria Civica di Cremona, 49), p. 43; GIANLUCA BATTIONI, Osser-vazioni sul reclutamento e la circolazione di podestà bergamaschi in età comunale (inizio sec.XIII - inizio sec. XIV), in I podestà dell’Italia comunale. Parte I - Reclutamento e circolazionedegli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), a c. di JEAN-CLAUDE MAIRE VIGNEUR, Roma2000, II, p. 121.
135 LUCIANO ORIOLI, Le confraternite medievali e il problema della povertà. Lo statuto dellacompagnia di Santa Maria Vergine e di San Zenobio di Firenze nel secolo XIV, Edizioni di sto-ria e letteratura, Roma 1984, p. 73; C.M. DE LA RONCIÈRE, Tra preghiera e rivolta… cit., p. 136;J. HENDERSON, op. cit., p. 71; M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXIX.
per la società urbana una fase di eccezionale indipendenza e di profondaevoluzione interna, cede il passo all’istituzione del podestà straniero, men-tre alla dominazione politica di una larga oligarchia sostituisce la rivalitàtra fazioni appoggiate a organizzazioni armate. Con la crescita della città intutte le sue componenti economiche e sociali si accentuano le tensioni inter-ne, tanto che dopo la crisi del regime consolare la vita comunale è caratte-rizzata dal sovrapporsi e dallo scontrarsi di alcuni tentativi di ricostruire ipresupposti per un nuovo equilibrio136. I partiti in lotta continuano comun-que ad essere organizzati attorno alle principali famiglie della città; in que-sto schema il peso delle ambizioni e degli odi tra persone e tra famiglie gra-va sempre più sulla vita politica137.
Preso atto della rottura dei precedenti equilibri non fu possibile, in se-guito, ricostruire un’oligarchia sul modello di quella che si era imposta allavita politica all’origine del comune138. Emerse, invece, in tutta chiarezzaquella tensione che, raggiungendo ormai livelli intollerabili perl’ordinamento cittadino, portò ad un mutamento dei modi della lotta politi-ca, aprendo a forme di contrapposizione per gruppi sociali armati e auto-nomi139. Se il complesso degli affari era ancora nelle mani delle grandi fa-miglie capitaneali, che avevano atteso alle faccende politiche del secolo pre-cedente, questo ora non avveniva senza vivaci contrasti che lentamente lo-goravano il prestigio e indebolivano l’autorità delle stesse famiglie140. Tantopiù che il conferimento della carica di podestà ad una persona esterna allacittà, che, in quanto tale, fosse destinata a subire meno i condizionamentidelle forze interne, aveva determinato come conseguenza un riassetto delleistituzioni interne e una diminuzione della potenza delle famiglie al verticedel governo comunale141.
Dopo il 1230 si impose, come nuova forza politica, il Popolo:l’inserimento negli statuti del comune di quelli della Società del Popolo san-cì il riconoscimento dell’entrata del populus nel gioco politico – nel 1230 laSocietas populi, la cui struttura era chiaramente imitativa di quella comu-nale, sostenuta dalle compagnie d’armi rionali e progressivamente control-lata e diretta dalle associazioni di mestiere, divenne un organismo ufficiale
41
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
136 SERGIO BERTELLI, Il potere nello stato-città medievale, La Nuova Italia Editrice, Firenze1978, pp. 48-49; O. CAPITANI, op. cit., p. 142.
137 GIOVANNI TABACCO, Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano, Einau-di, Torino 1979, p. 276; GIULIANA ALBINI, La popolazione di Bergamo e del territorio nei secoliXIV e XV, in Storia economica e sociale … cit., II, p. 236; F. MENANT, Bergamo comunale … cit.,pp. 30, 40.
138 O. CAPITANI, op. cit., p. 139.139 La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento, a c. di
GIORGIO CHITTOLINI, Il Mulino, Bologna 1979, p. 13.140 G. FRANCESCHINI, op. cit., p. 116.141 ENRICO ARTIFONI, Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale, in La storia. I grandi
problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea, a c. di NICOLA TRANFAGLIA e MARIO FIRPO, UTET,Torino 1986, II, p. 464.
del comune per quanto continui a rimanere da esso distinto – e affidò al col-legio degli Anziani un ruolo di consiglio e controllo accanto al podestà, ga-rantendo inoltre una più ampia partecipazione degli enti nei quali era orga-nizzato il popolo (paratici e vicinie)142. L’importanza dell’inserimento deglistatuti della Società assume maggiore rilievo se si considera che i cittadinivedevano nello statuto non solo il simbolo dell’antica autonomia, ma ritro-vano in esso strumenti normativi ancora capaci di dare espressione a istan-ze e interessi urbani143. L’istituzione della nuova magistratura degli Anzianicostituisce, inoltre, la prova più chiara dei successi politici ottenuti dal po-polo144.
Nel contempo, la popolazione che si volge contro le oppressioni delle ari-stocrazie al governo ha caratteristiche diverse da quelle precedenti: è in-nanzi tutto più numerosa per l’afflusso in città degli abitanti del contado diogni condizione sociale ed è più vigorosa per una maggiore possibilità di ar-mamento e azione145. Il popolo traeva le proprie forze dalle società d’armirionali, assai idonee nel fornire ad esso il necessario potenziale di aggressi-vità e la capacità di movimento coordinato, richiesti da una competizionepolitica che si esprimeva generalmente sul piano del controllo militare deglispazi urbani146. Il popolo di Bergamo, realtà in sé composita e mutevole,non si presentò comunque mai come organismo politico alternativo o paral-lelo al comune, al contrario assunse assai presto, come mezzo di afferma-zione e di sopravvivenza, un ruolo di sostegno e di protezione dell’istitutopodestarile147. La costituzione della Societas populi non si pone control’ordinamento esistente, bensì a sostegno; il fatto poi che non siano postepreclusioni di ceto o di fazione all’adesione alla società e che ne siano con-siderati membri i paratici e le vicinie, conduce al potenziale coinvolgimentodi tutta la popolazione148. Del resto, l’organizzazione vicinale aveva svoltoda molti anni, lungo tutto il periodo comunale, una validissima funzione or-ganizzatrice, che difficilmente avrebbe potuto essere cancellata. Le vicinie,
42
G. Cossandi
142 G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 222, 225-226; A. MAZZI, La pergamena … cit, p. VII; C. CA-PASSO, Il “Pergaminus”… cit., p. 289; C. CAPASSO, Guelfi e Ghibellini … cit., p. 10; DANIEL
WALEY, Le città-repubblica dell’Italia medievale, Einaudi, Torino 1980, pp. 155, 157; C. STOR-TI STORCHI, op. cit., pp. 278, 293, 297; ANTONIO IVAN PINI, Città, comuni e corporazioni nel me-dioevo italiano, CLUEB, Bologna 1986, pp. 98-99; B. BELOTTI, op. cit., II, pp. 164-167; G. FA-SOLI, op. cit., pp. 18, 34; A. SALA, op. cit., p. 321; S. BORTOLAMI, op. cit., pp. 62, 71; G. CAMINITI,op. cit., p. 150; M. VALLERANI, L’affermazione … cit., p. 408; F. MENANT, Bergamo comunale…cit., pp. 31-32.
143 GIORGIO CHITTOLINI, Statuti e autonomie urbane. Introduzione, in Statuti città territori inItalia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, a c. di GIORGIO CHITTOLINI e DIETMAR WILLOWEIT,Il Mulino, Bologna 1991, p. 8.
144 J. KOENIG, op. cit., p. 293.145 G. TABACCO, Egemonie sociali… cit., p. 229.146 G. FASOLI, op. cit., p. 16; ENRICO ARTIFONI, Corporazioni e società di “popolo”: un proble-
ma della politica comunale nel secolo XIII, “Quaderni Storici”, vol. XXV (1990), p. 390.147 G. FASOLI, op. cit., p. 16; M. VALLERANI, L’affermazione … cit., pp. 407-408.148 D. WALEY, op. cit., p. 157; C. STORTI STORCHI, op. cit., p. 282.
infatti, continuarono a svolgere funzioni precise all’interno dell’istituto co-munale. Proprio le vicinie vanno riconosciute come i luoghi istituzionali piùidonei a garantire un rapporto di solidarietà stabile e in qualche modo me-no permeabile alle contingenti pressioni del mutevole quadro politico edistituzionale149.
Contrariamente alla situazione generale, caratterizzata dal tramonto del-le autonomie locali e dalla riduzione delle loro facoltà organizzative, quelloche connota la situazione di Bergamo è la capacità da parte delle vicinie diritagliarsi uno spazio di gestione autonoma150. Forse furono proprio alcunitentativi del comune, volti a reprimere l’autonomia organizzativa delle cor-porazioni vicinali, che ebbero come risultato quello di provocare la rivoltadel popolo ed animare le rivendicazioni che condussero alla guerra civiledel 1226151.
Nel secolo XIII il precedente modello urbano di una città capace di porsicome libero luogo di incontro politico per ceti sociali vecchi e nuovi mostrasempre più numerosi segni di crisi a causa della trasformazione della societàurbana152. In questo clima il popolo, che approfittando delle divisioni esi-stenti negli ordini dominanti si alleò con le famiglie nobili di minoranza, ri-mase fino alla fine del secolo un elemento centrale dell’attività politica, purnon ottenendo mai posizioni di preminenza assoluta153. La sua affermazionecostituirebbe in ogni caso non tanto la prova dell’ascesa al potere dei ceti po-polari, quanto piuttosto l’affiancarsi o il sostituirsi di una nuova aristocraziaa quella antica, con un allargamento della base politica, senza tuttavia creareuna cesura con la tradizione154. È in gran parte merito dell’influenza del po-polo se, nonostante le divisioni interne e le periodiche violenze, il XIII secoloappare come un’epoca di relativa pace, soprattutto se lo si confronta con ilsecolo successivo, in cui la guerra civile sarà molto più presente155.
Le lotte cittadine della Bergamo del Duecento, al di là delle possibili mo-tivazioni economico-sociali, furono in primo luogo il segno di una grave in-stabilità istituzionale divenuta ad un certo punto endemica, a cui l’ascesadelle nuove forze e dei nuovi ceti non seppe contrapporre un sistema stataleadeguato. L’organismo comunale, incapace di attuare una politica di ampiorespiro, rivelò la sua insufficienza nel rappresentare sul piano politicol’intera cittadinanza, numericamente cresciuta e sempre più differenziata
43
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
149 S. BORTOLAMI, op. cit., p. 61.150 G. CAMINITI, op. cit., pp. 151-153.151 G. LOCATELLI, Lo statuto della Società … cit., p. 2; C. STORTI STORCHI, op. cit., pp. 285,
287-289; G. CAMINITI, op. cit., p. 149.152 La crisi degli ordinamenti comunali … cit., p. 8.153 C. STORTI STORCHI, op. cit., p. 309; B. BELOTTI, op. cit., II, p. 141.154 GIORGIO CHITTOLINI, La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale,
“Rivista Storica Italiana”, vol. LXXXII (1970), p. 102.155 F. MENANT, Bergamo comunale … cit., p. 34.156 G. TABACCO, Egemonie sociali … cit., p. 227; G. ALBINI, La popolazione di Bergamo… cit.,
pp. 254-255.
sul piano economico e sociale156. L’analisi della crisi del comune mostra inmodo evidente l’insufficienza politica degli organismi che la città aveva ela-borato per il governo della propria tumultuosa realtà sociale. Nel corso delDuecento si manifesta chiaramente ciò che di incompiuto e di imperfetto vifosse in un’organizzazione comunale incapace di affermarsi realmente co-me un ente al di sopra della parti in lotta, che non si identifichi con esse mapossa porsi come stabile centro di organizzazione delle forze politiche157. Altempo stesso, le nuove forze che caratterizzarono la vita della città durantetensioni così acute e violente, soltanto in parte riuscirono a superare la dif-ficoltà di porsi come struttura di coordinamento della società, così comenon seppero dare vita a strutture politiche sufficientemente robuste e ingrado di contenere spinte destabilizzatrici158.
Il comune dimostra un’identica difficoltà a presentarsi come stabile pun-to di riferimento nei confronti delle forze politiche che hanno la loro princi-pale base di potere nel contado: l’insuccesso politico del comune di Berga-mo è dato, in misura maggiore, dal mancato completamento del processo diorganizzazione intorno all’istituzione cittadina del territorio attraverso unlucido e coerente disegno politico. Il comune di Bergamo mirò, infatti, quasiesclusivamente ad una forte salvaguardia della sua realtà urbana e si occu-pò in misura minore degli interessi delle località del contado159.
Un altro aspetto centrale della politica di Bergamo, durante il Duecento,consiste nella connotazione imperiale della città, nella fedeltà all’imperatoree alle città che lo sostenevano160. Dopo la morte di Federico II, in Bergamo,come del resto nella maggior parte delle città della Lombardia, si aprì unastagione di profondi mutamenti del quadro politico: predominò l’influenzaguelfa, che trovò il suo apogeo nel 1264 con la podesteria del milanese Fi-lippo Della Torre; mentre sotto l’aspetto istituzionale il comune andò pro-gressivamente affermando la propria autonomia nei confronti dell’impero ecostituì la propria struttura organizzativa su un apparato di governo svinco-lato dall’influenza vescovile161.
Lo sbocco delle lotte vissute non poteva, in ogni caso, che essere trovatoin un governo di parte. Alla fine del 1264 Bergamo, seguendo l’esempio dialtri comuni, tra cui Novara e Lodi, per sottrarsi forse all’influenza di Ober-to Pelavicino, elesse alla carica di podestà Filippo Della Torre, conferendogli
44
G. Cossandi
157 G. CHITTOLINI, La crisi delle libertà comunali… cit., p. 103; R. BORDONE, op. cit., p. 203.158 Sotto questo aspetto il caso bergamasco non presenta sostanziali differenze rispetto al
contesto generale: ALFREDO BOSISIO, Milano e la sua coscienza cittadina nel duecento, in La co-scienza cittadina nei comuni italiani del duecento, Accademia Tudertina, Todi 1972, p. 48; Lacrisi degli ordinamenti comunali… cit., p. 18-19; O. CAPITANI, op. cit., p. 139.
159 G. CHITTOLINI, La crisi delle libertà comunali… cit., p. 105; O. CAPITANI, op. cit., p. 147;G. ALBINI, La popolazione di Bergamo… cit., p. 254.
160 B. BELOTTI, op. cit., II, p. 194; A. SALA, op. cit., p. 319; F. MENANT, Bergamo comunale…cit., p. 33.
161 G. RONCHETTI, op. cit., p. 238; C. STORTI STORCHI, op. cit., p. 309; A.I. PINI, op. cit., p. 96;A. SALA, op. cit., p. 329; F. MENANT, Bergamo comunale … cit., p. 33.
pieni poteri per dieci anni. Durante la sua podesteria sopravvissero in Ber-gamo le precedenti magistrature cittadine, riuscendo ancora ad assicurareil funzionamento dei pubblici poteri, e il comune mantenne il controllo del-l’imposizione fiscale162. Dopo l’improvvisa morte di Filippo, avvenuta sul fi-nire del 1265, successe alla carica di podestà il nipote Napoleone, che diedecontinuazione alla politica guelfa e demagogica del predecessore163.
Della pace sociale che si manifestò in questo periodo nell’ambito del Po-polo, espressione di un pressante bisogno di ordine interno dopo anni diautentica confusione ed esasperazione generale, ne è forse il simbolo la fon-dazione del Consorzio della Misericordia, in cui fino alla metà del XIV seco-lo rimase forte la componente artigiano-popolare164. Fin dagli inizi la Mise-ricordia, in quanto manifestazione delle molteplici componenti della societàlocale, cercò di instaurare un rapporto di collaborazione con i pubblici pote-ri, forse nel tentativo di ottenere una sorta di riconoscimento giuridico neiconfronti dell’autorità laica, pur mantenendo sempre una certa autonomia.L’associazionismo confraternale, infatti, ha come sua peculiarità, almenonella prima fase, l’autogestione e la gelosa amministrazione della sua auto-nomia165.
Nell’ottavo capitolo della regola, definendo i compiti che spettano al pa-trono della confraternita, si afferma che: “istius autem patroni tale erit offi-tium, videlicet habere bonam curam de factis congregationis et quando ne-cesse fuerit loqui et rogare pro eis et apud antianos populi et etiam in consi-lio comunis Pergami et ubicumque fuerit oportunum”; sebbene a questa al-tezza cronologica non sia ancora del tutto possibile precisare le funzionidell’organismo comunale degli Anziani del popolo, tuttavia in linea generalesembra potesse esercitare qualche prerogativa sulla scelta del podestà166.Questi esigui spiragli offerti dallo statuto, di per sé non sufficienti a indivi-duare i rapporti tra la congregazione e l’autorità civile, possono esserechiariti da alcuni altri dati, che emergono dalla documentazione comple-mentare.
Nel 1284 il comune di Bergamo concesse alla Misericordia una casa, in
45
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
162 MATTEO SANFILIPPO, Filippo Della Torre, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istitutodell’Enciclopedia Italiana, Roma 1989, XXXVII, pp. 531-532; G. BATTIONI, Osservazioni sul re-clutamento … cit., p. 125.
163 A. BOSISIO, op. cit., p. 89; CASO, Napoleone della Torre, p. 621.164 MARIA CONSIGLIA DE MATTEIS, Societas christiana e funzionalità ideologica della città in
Italia: linee di uno sviluppo, in La città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istitu-zioni, vita religiosa, a c. di REINHARD ELZE e GINA FASOLI, Il Mulino, Bologna 1981, p. 38; PATRI-ZIA MAINONI, L’economia di Bergamo tra XIII e XV secolo, in Storia economica e sociale … cit.,II, p. 258.
165 LIANA BERTOLDI LENOCI, L’istituzione confraternale: aspetti e problemi, Schena, Fasano(Br) 1996, p. 12.
166 BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 9v-10r; L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., pp.81, 118-119; M. CORTESI, Pinamonte da Brembate … cit., p. 78; JEAN-CLAUDE MAIRE VIGNEUR,Conclusione: flussi, circuiti, profili, in I podestà dell’Italia comunale … cit., II, p. 928; M. T.BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXXV.
cui in precedenza vi dimoravano i giudici, affinché la potesse utilizzare co-me caneva per il vino e il grano in sostituzione di quella in legno fino ad al-lora posseduta all’interno della chiesa di S. Maria Maggiore, forse ormai di-venuta troppo piccola in rapporto al volume degli affari gestiti dalla confra-ternita167. L’uso promiscuo di un edificio che avrebbe dovuto ospitare sol-tanto funzioni pubbliche non rappresenta, nei secoli XIII e XIV, una soluzio-ne isolata168. Anche la nuova caneva dovette però difettare nelle dimensio-ni, tanto che la Misericordia, nel 1286, decise di ampliarla con la parte oc-cupata dai giudici, sostituendo con un arco il muro che le divideva. Per larealizzazione di questi lavori la Misericordia procurò a sue spese settanta-due pietre lavorate, la calce e la sabbia, mentre il comune di Bergamo inter-venne stanziando sette lire imperiali per il pagamento della manod’opera169. Nonostante la funzione principale del nuovo edificio fosse quella
46
G. Cossandi
167 “Et duo instrumenta consiliorum generalium comunis Pergami, unum quorum scriptumfuit per Albertum de Laripa notarium quondam potestatis, in quo continetur ordinatum fuisseet concessum pro comuni Pergami suprascripto consorcio domum comunis Pergami in quomorabatur iudices comunis Pergami, et aliud scriptum per Ottolinum de Reage notarium quon-dam potestatis, die .XV. exeunte augusti .M.CC.LXXXV., suprascripta de causa et una carta perSalvoldum Penchere notarium, die tercio exeunte decembre suprascripto anno, in quo contine-tur dominum Piligerium de Sumpiçalis de Bononia potestatis comunis Pergami, auctoritate su-prascripti consilii, concessisse suprascripto consorcio suprascriptam domum” (Primus liber, ff.93v, 125v); la vicenda trova spazio negli storici locali: G. LOCATELLI, L’istruzione in Bergamo…cit., p. 61; A. RONCALLI, op. cit., p. 42; G. LOCATELLI, La casa della Misericordia… cit., pp. 127-128; G. BARACCHETTI, op. cit., p. 65; L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., p. 58; M.T.BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXXV.
168 LUISA CASTELLANI e CARLO TOSCO, La città comunale e gli spazi del potere. Asti 1188-1312, “Società e Storia”, vol. 76 (1997), p. 254.
169 “Item dicit et notificat ipse Bartolameus se recepisse libras septem imperiales a comuniPergami, auctoritate consilii generalis comunis Pergami, ad faciendum fieri certa laboreria etconzamenta ordinata debere fieri in ipsa domo pro comuni Pergami. Que laboreria data fue-runt ad faciendum magistro Marcho de Antelevo et magistro Spinazolo de Pergamo, finis sola-rium ipsius domus in zossum, pro ipsis libris septem imperialibus, et que laboreria que sic de-bent fieri suprascripto precio sunt ista, videlicet in caneva illic ubi est murus inter canevam iu-dicum et canevam Misericordie debet fieri in ipso muro unum archavoltum de bonis lapidibustresenderis ad multaculcinam cum bonis nembris, super quibus nembris debet sirare ipsumarchavoltum; et postea debet auferri seu alio vehi ipse murus de sub ipso archavolto sic quodipse due canevete continuentur et sint tantum una caneva suprascripti consorci, et lapidescuius muri debent esse suprascriptorum magistrorum et per eos alio vehi. Et debet ipsi magi-stri facere unam pulcram finestram in muro ipsius caneve Misericordie, que est prope viam, inqua debent murare unam grathem ferri, que debet eis dari per illos de Misericordia. Item de-bent ipsi magistri facere unum hostium in muro, qui est sub cochina iudicum in terra propecanevam, que erit ipsius consorci, quod sit in latum per tria brachia et in altum per quatuorbrachia et spanam vel ibi circa in una volta et cum bonis palestrutis ad moltamculcinam cumquatuor policibus et cum bonis asidibus et lammis et clodis et cum bonis muris, et in quo ho-stio debent facere unam fanestram feratam ad dandum diem in ipsa canevata, que ibi conzabi-tur per iudices, et in qua fanestra debet fieri unum balconzelum de intra de aside ad eam clau-dendam si oportuerit. Et per illos de consorcio debet fieri clavatura ipsius hosti et de lapidibus,qua releventur illic ubi fiet ipsum hostium in ipso muro debet murari et claudi de bono muroad multamculzinam per suprascriptos magistros aliud hostium per quod modo intratur a cane-
di fornire un luogo sicuro in cui conservare il grano, il comune, con questaoperazione, riconosceva di fatto l’importanza del ruolo della Misericordia.Si veniva, inoltre, a creare una stretta connessione con la vita civile:l’istituzione pubblica in tal modo era in grado di soddisfare le esigenze pra-tiche e assistenziali, nonché di garantire una riserva di grano alla città, ingrado di prevenire possibili disordini.
Rimane da capire il motivo per cui, se già il capitolo ottavo della regolapresupponeva la possibilità di un rapporto diretto con i pubblici poteri, ilprimo intervento istituzionale del comune in favore della confraternita av-venga a distanza di vent’anni dalla sua costituzione. Pur non trovando almomento alcuna spiegazione all’interno dei documenti conservati, è possi-bile tuttavia avanzare qualche ipotesi. In primo luogo si deve ammettereche nel mondo comunale, sia sotto il regime consolare che sotto quello po-destarile, tutta la vita associata si sviluppò generalmente all’ombra delleistituzioni ecclesiastiche, non solo per quanto riguarda le solennità religio-se, ma anche per l’aspetto socio-economico, all’insegna di un fortissimosenso della giustizia e di una religiosità intesa a tutelare il sentimento gene-rale e le cose sacre170. L’inquadramento ecclesiastico rimane, dunque, pursempre l’elemento portante della struttura confraternale, tanto nelle sue va-lenze politico-istituzionali, quanto nelle sue manifestazioni informali171. An-cor più in una situazione in cui il vescovo, il cui potere politico appare or-mai piuttosto circoscritto dall’affermazione di nuove forze, continua comun-que a conservare, grazie all’appoggio domenicano, un certo potere. D’altrocanto il comune popolare, a cui va ascritto il fatto di aver allargato la basepolitica del potere e di aver dato un’adeguata rappresentanza alle classimedie e produttive, manifestò spesso una certa impreparazione e improvvi-sazione nel governo, tanto che forse non seppe da subito cogliere le poten-zialità e l’importanza a livello urbano della Misericordia. Senza dimenticareche, dal punto di vista istituzionale, il sistema podestarile, la cui forma digoverno fu un regime a maglie larghe, “un sistema assai elastico”, favorì ge-
47
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
va, quam modo tenent iudices in ipsam canevetam, que est sub ipsa cuchina iudicum. Et quecaneveta que est sub ipsa cuchina debet tota per ipsos magistros intonegari et salbari et im-blanchari; et debent facere ipsi magistri unam scaletam de panellis per quam asendatur et de-sendatur ab ipsa caneveta in ipsam cuchinam et ab ipsa cochina in ipsam canevetam pro vinoet lignis accipiendis, que scaleta debet fieri illic ubi utilius et melius videbitur ipsis magistris.Et de quibus suprascriptis libris septem imperialibus suprascriptus Bartolomeus dedit supra-scripto magistro Marcho pro se et socio libras quatuor imperiales, et alias libras tres dedit etconsignavit suprascripto ser Alberico per dare ipsis magistris, quando ipsum laborerium pereos complebitur, ut suprascriptum est. Et predicta dixerunt et confessi fuerunt ipsi Bartolo-meus et magister Marchus ita vera esse et debere fieri et atendi, ut scriptum est […]. Ego Ber-gaminus de Marchisis notarius predictam designationem legi et scripsi et interfui et rogatusscripsi, die dominico tercio intrante marcio millesimo ducentesimo octuagesimo sexto, indicio-ne XIIIIa, parere et voluntate predictorum ministri et canevariorum suprascripti consorci” (Pri-mus liber, ff. 94v-95r); cfr. G. LOCATELLI, La casa della Misericordia ... cit., pp. 128, 140-141.
170 G. PENCO, op. cit., p. 350.171 M. GAZZINI, Confraternite e società cittadina … cit., p. 379.
neralmente quel processo di emersione a livello istituzionale di forze e nu-clei di potere che trovarono valida espressione proprio nello strumento as-sociativo172.
Non va, inoltre, sottovalutata l’evoluzione della Misericordia, che natainizialmente come spazio chiuso, negli anni ottanta del Duecento, appog-giandosi sulla struttura vicinale, si aprì decisamente allo spazio esterno. Laforte presa sociale che ne derivò dovette far nascere nel comune il desideriodi veicolarla, soprattutto in un momento in cui, a seguito della vacanza del-la cattedra episcopale, era venuto meno uno dei maggiori elementi di con-trollo e coordinamento. È forse proprio in questa prospettiva che si collocala concessione del comune di alcuni suoi immobili per ospitare la canevadel consorzio. Appare comunque difficile ritenere che le autorità comunalicercassero in questo modo di regolare le sue attività, piuttosto ne incorag-giarono il doppio ruolo religioso e assistenziale.
Nell’orizzonte economico si inseriscono anche le successive iniziative delcomune, volte ad un riconoscimento pubblico dell’istituto confraternale. Il10 dicembre del 1287 Giacomo de Tresolzo, canevario del comune dà allaMisericordia, secondo quanto stabilito dal consiglio del comune, ventiquat-tro lire imperiali “pro elemosinis faciendis”173. La Misericordia, lontano dal-l’esprimersi come forza politica, operò piuttosto da supporto sia logistico siafunzionale nello svolgimento di una preziosa attività assistenziale, ruolo ap-prezzato e favorito dall’autorità cittadina che, riconoscendone i meriti, cer-cò di porla sotto la propria protezione concedendole privilegi legali ed aiutifinanziari174. In questa prospettiva si colloca un documento redatto il 19marzo del 1288, la cui importanza è testimoniata dal fatto che ci è pervenu-to in tre esemplari, tutti un tempo conservati nell’archivio della confraterni-ta175. In esso il consiglio del comune, radunatosi per volere del podestà Gi-
48
G. Cossandi
172 E. ARTIFONI, Tensioni sociali… cit., p. 471; G. CAMINITI, op. cit., p. 152; ANDREA ZORZI, Ne-goziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell’Italia comunale, in Criminalitàe giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioe-vo ed età moderna, a c. di MARCO BELLABARBA - GERD SCHWERHOFF - ANDREA ZORZI, Il Mulino, Bolo-gna 2001, p. 15.
173 “Item receperunt libras vigintiquatuor imperiales a Iacobo de Tresolzo, canevario co-munis Pergami, nomine comunis Pergami, et de denariis propris comunis Pergami constitutiset ordinatis per consilium generale comunis Pergami scriptum per Petrum de Crema notariumpotestatis, die tercio intrante decembre proximo preterito, debere dari canevarios suprascripticonsorci Misericordie pro elemosinis faciendis. Die mercuri .X. intrante decembre” (Receptum,f. 38v).
174 M. GAZZINI, Confraternite e società cittadina … cit., pp. 388-389; J. HENDERSON, op. cit.,pp. 70, 195; R. A. COSSAR, op. cit., pp. 231-233.
175 “Et tria instrumenta, uno tenore facta, cuiusdem consilii generalis comunis Pergamifacti tempore domini Girardi de Tacullis de Regio, condam potestatis comunis Pergami, etscripti per Iohannem de la Costa notarium tunc potestatis et comunis Pergami, die terciodeci-mo exeunte marcio millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, occasione legatorum et iudica-torum que iudicaverunt suprascripto consortio debere et posse exigi per ipsum consorcium si-ne poreccione alicuius libelli a solidis quinquaginta imperialium in yosum, et quod consiliumest loco decreti” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 19r).
rardo de Tacullis di Reggio, prendendo atto che numerose persone affidava-no alla Misericordia come loro ultime volontà ingenti somme di denaro, chespesso divenivano oggetto di controversie economicamente gravose per lacongregazione, stabilì che nei prossimi cinquant’anni potesse essere avviatauna causa di appello nei confronti del consorzio solo per donazioni superio-ri alle cinquanta lire imperiali176. L’intervento del comune attraverso questaconcessione, indubbia prova dei buoni rapporti che allora intercorrevanotra la confraternita e l’istituzione pubblica, si indirizzò verso la difesa deidiritti e dei beni della Misericordia, in funzione del consolidamento di unpatrimonio in via di formazione, ma la cui disponibilità era sempre più inte-sa come il necessario presupposto allo svolgimento di tutte le attività delconsorzio. La combinazione dell’approvazione comunale e di un program-ma di aiuto ai poveri esteso a tutta la città avrebbe incoraggiato i testatori,tanto che sempre più numerosi appaiono nei decenni successivi i lasciti dis-posti in favore della Misericordia. Queste eredità venivano, comunque,spesso ottenute dopo battaglie legali: l’appoggio ufficiale del comune allaconfraternita intendeva forse progressivamente scoraggiare gli eredi dal ri-correre al giudizio del tribunale177.
I pubblici poteri intervennero in più occasioni a sostegno dell’attività as-sistenziale del consorzio, esplicitando in questo modo il carattere socio-eco-nomico della Misericordia. La messa a punto di questa strategia può essereconsiderata parte della crescente consapevolezza da parte del comune dellanecessità di occuparsi del benessere della popolazione. Tuttavia non sareb-be corretto presentare un’immagine troppo positiva di un comune medieva-le che si occupava dei bisogni della popolazione povera spinto da un sensocristiano di carità. Questa politica muoveva piuttosto dal desiderio di mini-mizzare la paura di possibili disordini: l’organizzazione delle opere di assi-stenza aveva, infatti, un effetto protettivo dell’ordine stabilito. In un conte-sto come questo, la carità era concepita come un mezzo di integrazione so-ciale, come un modo attraverso il quale elementi diversi della società, daipiù poveri fino a quelli ricchi e potenti, erano uniti in un orizzonte solidari-stico178. Se, dunque, la confraternita venne, in qualche occasione, utilizzatacome uno strumento di equilibrio, o di implosione delle tensioni, da parte diun apparato statuale che si affidava ancora agli enti confraternali e ospeda-lieri per risolvere problemi contingenti, quali sanità e povertà, questo atteg-giamento non presuppone comunque direttamente una perdita di autono-mia della confraternita stessa179.
49
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
176 Cfr. APPENDICE, doc. I.177 Numerosi sono i documenti in cui, per il periodo compreso tra gli ultimi vent’anni del
XIII secolo e i primi del successivo, sono testimoniate contese legali tra la Misericordia e alcunieredi di testatori; a titolo di esempio si segnalano: BCBg, Fondo Mia, nn. 2993, 3899, 5675,6619, 8793.
178 OVIDIO CAPITANI, Introduzione, in MICHEL MOLLAT, I poveri nel medioevo, Laterza, Roma-Bari 1982, p. XXV; J. HENDERSON, op. cit., pp. 30, 257.
179 M. GAZZINI, Confraternite e società cittadina … cit., p. 394.
Nel 1291 Richfirmino Lazarius, canevario del comune, dà alla confrater-nita ventiquattro lire imperiali e mezza pro elemosina come deliberato dalconsiglio del comune il 20 dicembre dell’anno precedente180. Nuovamentenel 1291 il consiglio del comune – come testimoniato in un atto deperditoredatto dal notaio Bonaventura de Lixana – stanziò una somma di trecentolire imperiali “pro elimosinis pauperibus civitatis et virtutis Pergami facien-dis” da pagarsi in quote da venticinque lire imperiali ciascuna ad ogni cam-bio di podestà181. Lo stanziamento si concluse nel 1296, tenuto conto delfatto che dal 1193 la carica podestarile era divenuta semestrale, con elezio-ne entro il mese di novembre ed entrata in carica ai primi di gennaio e diluglio, nonostante la frequenza delle discordie interne e le ripercussioni del-le vicende politiche esterne resero spesso irregolare la durata in carica delpodestà182.
Sotto l’aspetto economico, dunque, le autorità comunali ebbero un forteimpatto sulle fortune della confraternita, probabilmente più importante diquello degli stessi vescovi. Una così cospicua donazione appare inoltre comeun indubbio riconoscimento dell’istituzione comunale al lavoro diretto e co-stante esercitato dalla Misericordia verso i poveri, tanto è vero che nel 1292questo denaro venne impiegato dai canevari del consorzio per acquistare delfrumento183. L’importanza di questo cereale nel bilancio familiare spieghe-rebbe, nei secoli successivi, la politica sempre più interventista del comunenel suo acquisto, regolamentazione e distribuzione184.
Nel frattempo le forti tensioni politiche che avevano caratterizzato e con-dizionato i primi decenni del XIII secolo tornarono a manifestarsi nel 1296.Nel marzo di quell’anno, a causa del ferimento di Giacomo Mozzi, un mem-bro della consorteria dei Suardi, ad opera di un Colleoni, si sviluppò unacruenta lotta cittadina che si concluse, grazie all’intervento di Matteo Vi-sconti al fianco dei Suardi, con la cacciata dei Colleoni. I Visconti allora, inaccordo con i Suardi, inviarono a Bergamo come nuovo podestà Ottorino da
50
G. Cossandi
180 “Item receperunt libras vigintiquatuor et mediam imperiales a domino Richfirmino La-zarii, canevario comunis Pergami, nomine comunis Pergami, et de denariis comunis Pergami,qui denari costituti et ordinati fuerunt debere dari pro elemosina canevarios suprascripti con-sorci per consilium generale comunis Pergami, scriptum per Richimburgum Durentum nota-rium potestatis, die .XII. exeunte decembre M.CC.nonagesimo, et quos denarios receptos die.V. exeunte decembre M.CC.nonagesimo primo, indicione quarta” (Receptum, f. 46v).
181 Cfr. APPENDICE, doc. II.182 A. RONCALLI, op. cit., p. 42; A. MAZZI, Aspetti di vita religiosa … cit., pp. 236-237; R.A.
COSSAR, op. cit., p. 217; G. BATTIONI, Osservazioni sul reclutamento … cit., p. 119.183 “<1292> Item dedit et expensit libras vigintiquinque et solidos duos et denarios duos et
medium imperialium in somis vigintisex et sextariis quinque furmenti, empti ipso precio percanevarios suprascripti consorci, quod furmentum est in granario suprascripti consorci; quodfurmentum fuit emptum ex illis et de illis libris vigintiquinque imperialibus quas suprascripticanevarii et minister suprascripti consorci receperunt a magistro Bonaventure de Lascasa, ca-nevario comunis Pergami, de denariis ipsius comunis ex illis libris trecentis imperialibus con-stitutis suprascripto consorcio pro comuni Pergami per plures annos et terminos, ut in receptosuprascripti Alberti de Prato canevario continetur” (Primus liber, f. 203r).
184 J. HENDERSON, op. cit., p. 265.
Mandello, ma già nel mese di giugno si assistette ad un nuovo ribaltamentodella situazione: i Rivola ed i Bonghi, rompendo l’alleanza con i Suardi, uni-tisi ai fuoriusciti Colleoni, costrinsero alla fuga i Suardi e decretarono inquesto modo la sconfitta della parte nobiliare e ghibellina. Durante questelotte non venne risparmiata neppure la chiesa di S. Maria Maggiore – forsein quanto sede della Società delle Armi – e con essa il granaio della Miseri-cordia185. Quest’ultima, probabilmente non direttamente implicata con leistituzioni dal punto di vista politico, dovette fare le spese di quella sovrap-posizione di usi che si accompagnava nel XIII secolo agli edifici con funzionipubbliche. Il granaio della Misericordia venne, dunque, distrutto e dallostesso furono trafugate novantaquattro some e mezza di frumento, lì am-massate in attesa di essere distribuite ai poveri; soltanto un successivo rav-vedimento della popolazione, al termine delle discordie, permise al consor-zio di recuperarne almeno una parte186. Ma l’accanimento nei confronti del-la confraternita si indirizzò anche ai propri documenti, testimoni della suaessenza ed esistenza: venne infatti sottratto dal coro della chiesa di S. Vin-
51
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
185 G. RONCHETTI, op. cit., II, pp. 370-373, 379; A. MAZZI, Aspetti di vita religiosa … cit., pp.247-248; C. STORTI STORCHI, op. cit., p. 313; G. CAMINITI, op. cit., p. 159-160; GIANLUCA BATTIONI,Tra Bergamo e Romano nell’autunno del 1321, in L’età dei Visconti. Il dominio di Milano fraXIII e XV secolo, a c. di LUISA CHIAPPA MAURI - LAURA DE ANGELIS CAPPABIANCA - PATRIZIA MAINONI,La Storia, Milano 1993, p. 366; M. T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXXV.
186 “Item recepit somas octo et sextarios quinque et mina furmenti ab infrascriptis homini-bus et personis, ut inferius continetur, ex illis somis nonaginta quatuor et media furmenti su-prascripti consorci quod erat in granario suprascripti consorci, quod est in ecclesia dominiSancti Vincencii; quod totum furmentum fuit ablatum et derobatum suprascripto consorcio ex-tra ipsum granarium tempore guere et discordie Suardorum et Collionum, videlicet sextariostres furmenti a Bordiga Beccario, et sextarios duos furmenti ab Urico de Collonio, et sextariosquatuor furmenti a Bonaventura qui dicitur Garattus, et sextarios septem et minam a Lanfran-cus qui dicitur Mangarinus de quo habuit solidos duos et medium imperialium, et sextariosduo a dona Duncia Martini Bordigia de quo habuit denarios duos, et sextarium unum a Peter-zino de Ardexio servitor, et unam minam ab Alberto Mansferrati, et sextarium unum a Iohannede Sacho et sextarium unum a Bertrammo qui moratur cum ser Alberto de Foro, et sextariostres a Cammeo, et sextarium unum et minam a Franzeschino qui dicitur Zanathina, et sexta-rios quatuor a Minono Brentatori de quo habuit denarios duodecim imperialium, et sextariumunum ab Imperatore et sextarium unum a domina Deglade qui stat in dommo illorum de Cre-ma, et sextarios septem et minam a Bertrammo de Culcinate de quibus habuit denarios vigintiet sex imperialium et sextarios duo a Lanfranco Brentatori de Voltulina, et habuit denarios sexet unum quartarium a Viniano de la Plazza, et sextarios sex a Mayfredo qui dicitur Bochanonede quo habuit denarios duodecim imperialium, et sextarios duo a Dardo Portasacho, et sexta-rium unum a Baxano de Nimbro, et sextarios quatuor ab Alexandro de Bracha, et sextariumunum et minam ab Albinello, et unum sextarium a Puero condam Porrelie, et sextarios duo aLanfranco Otteboni de Pagazano, et sextarium unum et minam a Rogerio de Crema de quo ha-buit et recepit solidos duos imperialium et quinque quartos a Prenesino Sertorio, et sextariumunum a quondam muliere qui stat prope hospitalem Sancti Antoni, et sextarios duo a Venturi-no Borlanandi, et sextarium unum a Martino Viniani Taruffi” (Primus liber, f. 268r); episodiogià segnalato in: A. MAZZI, Aspetti di vita religiosa … cit., pp. 252-253.
187 “Item notificaverunt omnes suprascripti canevarii suprascripti consorci quod deroba-tum fuit scrineum suprascripti consorci, quod erat in goro ecclesie domini Sancti Vincentii,cum libris et scriptis ipsius consorci et cum soldis vigintisex et denariis duobus imperialium
cenzo lo scrineum in cui erano conservati i libri e gli scritti del consorzio187.Rimane in ogni caso difficile stabilire quali e quanti documenti andaronoperduti in quell’occasione.
I fatti del 1296 dovettero sconvolgere a tal punto la Misericordia, che neimesi successivi vennero per la prima volta registrate tra le uscite del con-sorzio alcune spese per l’organizzazione della sicurezza e tutela del propriopatrimonio. La confraternita versò tre lire e quattordici soldi per custodirela propria caneva, difenderla dal fuoco, dai furti e, in caso di necessità, permettere al sicuro quanto in essa riposto188.
L’alterno e contrastato quadro politico cittadino non arrestò in ogni casol’espansione del consorzio, né fece venire meno l’appoggio dell’istituzionepubblica189.
La legislazione comunale indica che il comune, riconoscendo sempre piùil prezioso contributo della confraternita e rafforzando il legame con essa,la premiò con alcune fonti di guadagno aggiuntive. Il 10 aprile del 1299 ilconsiglio del comune di Bergamo, forse a parziale risarcimento – il docu-mento tace il motivo reale della donazione – dei danni economici subiti dal-la confraternita in occasione degli scontri della primavera del 1296, le con-cesse “omnia bona, iura, res et possessiones banitorum et malesardorumcomunis Pergami, quorum bona pubblicata sunt seu publicabuntur in co-mune Pergami”190.
Nel 1301 il comune favorì nuovamente il consorzio, concedendogli il sa-le – la cui gabella costituiva allora uno dei più consistenti redditi del comu-ne – ad un prezzo di favore, “ipso precio secundum modum et formamcontractus ipsius tellonei”, la cui distribuzione ai poveri rappresentava al-lora una delle priorità, tanto è vero che era divenuta una delle forme, concui si esplicava l’opera di beneficenza191. Notevoli vantaggi ruotavano in-fatti attorno al sale e, di conseguenza, il forte interesse fiscale dei comunicittadini in un commercio di cui si conosceva in anticipo la portata, e che
52
G. Cossandi
qui erant in ipso scrineo de denariis ipsius consorci receptis per Bertolameum canevarium, etquos denarios habuit Smonus, filius Gazzi de Brumano, civis Pergami, ut ipse, in presentia ca-nevarii et plurium aliarum personarum, confessus fuit se habuisse, de quibus ipse Bertolameusrecepit soldos quatuor imperialium a suprascripto Smono” (Primus liber, f. 276r); A. MAZZI,Aspetti di vita religiosa … cit., p. 253; G. LOCATELLI, La casa della Misericordia … cit., p. 138.
188 “Item dedit et expendit libras tres et solidos quatuordecim imperialium pro omnibusexpensis factis ocasione caneve suprascripti consorci et ocasione faciendi custodire ipsam ca-nevam et defendere eam igne, et ne derobaretur ipsa caneva, et faciendi viam portare totumvinum et omnes vegetes et omnia alia bona et res que erant in ipsa caneva, et in faciendo cu-stodire plures vegetes in mercato comunis Pergami, que portate fuerunt ibi extra suprascrip-tam canevam” (Primus liber, f. 276r); G. LOCATELLI, La casa della Misericordia… cit., p. 141.
189 M. T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXXV.190 BCBg, Fondo Mia, n. 6287.191 “Item dedit solidos quatragintaduos imperialium conductoribus tellonei salis pro inte-
gra solutione some unius salis, quem salem ipsi conductores dare tenebantur suprascripto con-sorcio ipso precio secundum modum et formam contractus ipsius tellonei” (Primus liber, f.377v); A. MAZZI, La pergamena … cit., p. XLVI; A. MAZZI, Aspetti di vita religiosa … cit., p. 237;R.A. COSSAR, op. cit., p. 228.
comportava grossi investimenti finanziari da parte del consorzio appaltato-re, fu all’origine della trasformazione della vendita del sale nei primi annidel XIV secolo192.
Nonostante la perdita di parte della documentazione non permetta di ve-rificare ancora più nello specifico in che modo e fino a quale livello si fosseesplicata l’azione di tutela del comune, dal quadro proposto emerge comun-que piuttosto chiaramente che fu nel momento in cui la Misericordia rivestìun ruolo di primo piano nella società cittadina, che finì con lo stringere fortilegami con le istituzioni comunali. La configurazione istituzionale di base,assunta dalla confraternita alla fine del XIII secolo, rimase in ogni caso im-mutata nei secoli immediatamente successivi, continuando a gestire alcuniservizi di pubblica assistenza.
La Misericordia e la sua organizzazione
La confraternita della Misericordia fu, dunque, una delle numerose isti-tuzioni di beneficenza attraverso cui si concretizzò, fra XIII e XIV secolo,quella che è stata definita come ‘rivoluzione della carità’. A questo profondocambiamento sottostanno due ordini di motivazioni: da una parte la cre-scente necessità di fronteggiare la nuova situazione di povertà determinatadalla sempre più differenziata vita sociale delle città, dove compaiono comenuovi poveri coloro che non riuscivano ad inserirsi nell’ordine che la socie-tà si era data e cercavano pertanto di sopravvivere ai suoi margini, dall’al-tra la necessità di individuare uno specifico ambito di azione per quei laici,che rivendicavano un più ampio spazio di partecipazione alla vita dellaChiesa193. È già stato sottolineato come una simile iniziativa fosse in strettocollegamento con l’attività degli Ordini Mendicanti e con la pastorale delclero secolare della città, guidato dal vescovo. Bisogna, altresì, da subitoprecisare che la beneficenza e l’assistenza aperta a tutta la città non fu unaprassi frequente e normalmente espletata dalla maggioranza delle confra-ternite medievali194.
Per sua natura, una confraternita si presentava come una libera associa-zione, che presupponeva da parte dei suoi membri l’adesione a delle normee ad alcuni valori comuni, nonché una partecipazione congiunta a un insie-me di attività poggianti su di una organizzazione codificata195. La confrater-
53
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
192 PATRIZIA MAINONI, Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII eXV secolo, Unicopli, Milano 1997, p. 43.
193 P. BREZZI, op. cit., p. 532; G. PENCO, op. cit., pp. 335, 366; L. ORIOLI, op. cit., p. 11; ANTO-NELLA MORIANI, Assistenza e beneficenza ad Arezzo nel XIV secolo: la Fraternità di Santa Ma-ria della Misericordia, in La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medieva-le, a cura di Giuliano Pinto, Salimbeni, Firenze 1989, pp. 66-69; G. ANDENNA, op. cit., p. 21.
194 L. ORIOLI, op. cit., pp. 66-69.195 CATHERINE VINCENT, La confrérie comme structure d’intégration: l’exemple de la Nor-
mandie, in Le mouvement confraternel au moyen âge … cit., p. 112.
nita era solitamente aperta a quasi tutti i ceti: in essa erano ugualmente af-fratellati uomini ricchi e uomini che si procuravano da vivere grazie al lavo-ro delle proprie mani196. Per una confraternita, che agiva all’interno di uncontesto urbano, più numerosi e differenziati sotto tutti i punti di vista era-no i suoi membri, più forte sarebbe stata l’influenza esercitata sul piano lo-cale197. Sebbene la confraternita rappresentasse per gli associati uno stru-mento di crescita civile, oltre che un punto di incontro tra ceti diversi, tutta-via questa non va intesa come un luogo privilegiato in cui, in nome dellafraternitas, venissero cancellate le disuguaglianze presenti nella società198.All’interno del contenitore confraternale non va infatti sopravvalutata latendenza all’integrazione sociale. Appare invece chiaro come entrare a farparte di una confraternita poteva essere inteso come un mezzo di inseri-mento sociale per quanti fossero consapevoli della precarietà del loro ruolorispetto alle aristocrazie dominanti la scena politica e cercassero una legitti-mazione della propria identità pubblica, attraverso l’appartenenza a unastruttura istituzionalizzata dalle autorità civili ed ecclesiastiche e investita diuna certa dignità pubblica199. La confraternita rimaneva, in ogni caso, so-prattutto un’organizzazione religiosa che permetteva ai laici di usufruiredelle pratiche di devozione e penitenza originariamente concepite dagli or-dini religiosi, nonché di esprimere una propria pietà, fondata sulla caritàverso il prossimo e la devozione verso Dio e la Vergine200.
La documentazione prodotta dalla Misericordia permette di conoscerecon ricchezza di particolari l’intensa attività svolta dal consorzio fin daglianni immediatamente successivi alla sua fondazione, quale espressione del-la religiosità ‘civica’ e della stessa identità storica di Bergamo201.
Il punto di partenza e il cardine attorno a cui ruota l’istituzione è natu-ralmente la regola, redatta, in lingua latina, dal domenicano Pinamonte daBrembate e forse, in analogia a quanto generalmente accadeva nelle confra-ternite di matrice domenicana, votata – ammettendo che a questo atto pos-sa fare riferimento l’espressione: “cum consilio et assensu […] aliorum fide-lium laicorum”202 – dall’assemblea dei confratelli come una costituzione.
Esaminando il contenuto dei dieci capitoli della regola si osserva che ilprimo esige dai nuovi membri, siano essi uomini o donne, un’ortodossia al
54
G. Cossandi
196 P. BREZZI, op. cit., p. 532; G. ANDENNA, op. cit., p. 36.197 C.M. DE LA RONCIÈRE, Tra preghiera e rivolta … cit., p. 109.198 P. BREZZI, op. cit., p. 532; G. DE SANDRE GASPARINI, Il movimento delle confraternite …
cit., p. 381.199 A. MORIANI, op. cit., p. 25; L. GAFFURI, op. cit., p. 55.200 C.M. DE LA RONCIÈRE, Tra preghiera e rivolta … cit., p. 90; D.E. BORNSTEIN, op. cit., p. 77.201 M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXXVIII.202 BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 1v; G. G. MEERSSEMAN, op. cit., p. 581.203 “In primo ordinamus quod persone et fratres huius congregationis sint fideles legali et
honesti, non lusores, non ebriosi, non baratarii, non infames, sed convenientes et conversatio-nem habentem bonam et honestam. Propter quod nullus predo, nullus infamis, nullus de turpivitio donatus, nullus hereticus vel credens hereticorum recipiatur in ista congregatione, nisivelit redire ad fidem Sancte Ecclesie. Item nullus publicus usurarius et infamis qui hoc velit ha-
di sopra di ogni sospetto203. Coloro che, dopo essere caduti in errore, aves-sero fatto penitenza e avessero dimostrato di essersi ravveduti, potevano,comunque, essere riaccolti nella confraternita: questa prescrizione potrebbederivare da una prospettiva associativa maggiormente aperta verso il futuroche verso il passato204. Lo statuto, ad ogni modo, non è in grado da solo dirispondere sul tipo e sulla qualità della partecipazione della società allaconfraternita. Esso si limita a dichiarare i requisiti necessari per l’ingressodei nuovi soci e non offre molte più informazioni di quelle sufficienti a valu-tare il criterio di reclutamento: questo aspetto non aiuta a chiarire il tipo ela qualità della partecipazione all’associazione205. Gli statuti infatti fornisco-no numerosi dettagli sulla spiritualità delle fraternite, ma, in quanto testinormativi, essi stabilivano che cosa dovesse essere fatto e non ci informanoinvece su che cosa effettivamente venisse fatto206. Se tuttavia si guarda al-l’ambiente di reclutamento, si osserva una larga apertura: lo statuto nonfissa mai limiti numerici per gli aspiranti all’iscrizione, né si riscontranoscelte aprioristiche verso determinati ceti sociali207. Nella selezione dei nuo-vi membri la Misericordia si rivolgeva all’intero ambiente cittadino, sul qua-le modellava la sua stessa struttura; tuttavia è assai probabile che non vi fa-cessero parte coloro il cui tenore di vita fosse vicino al livello di sussistenza.
Fin dal primo capitolo appare con chiarezza l’insistenza – come per mol-te altre esperienze religiose – sul carattere ‘misto’ della confraternita. Uomi-ni e donne sono posti su un piano di parità: le donne erano ammesse a tito-lo personale e non in osservanza al principio dell’unitas corporis con il ma-rito. L’unica disposizione che prevedeva un discrimine tra i due sessi eraquella relativa alle modalità di iscrizione208. La regola prescriveva due di-verse modalità di registrazione: mentre le donne venivano da subito accolteall’interno della Misericordia, l’ammissione degli uomini avveniva soltantodopo un anno di prova, che poteva dare modo agli ufficiali di informarsiadeguatamente sulla vita del postulante e sulla sua reale disposizione all’os-servanza della normativa statutaria209. È probabile che le iscrizioni maschi-li fossero molto più selezionate di quelle femminili, benché non meno nu-
55
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
bere pro offitio seu pro arte sua recipiatur. Hoc idem intelligimus de mulieribus, addentes quodsi fuerit meretrix publi||ca vel infamis non recipiatur” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 2r-2v).L’insieme rappresenta un vero e proprio codice morale redatto probabilmente sotto l’impulsodegli Ordini Mendicanti.
204 “Omne vero qualescumque fuerint viri vel mulieres quicumque volunt veram facere pe-nitentiam, recipiantur quando apparebunt in ipsi probabilia signa” (BCBg, Archivio Mia, n.937, f. 2v); GIUSEPPINA DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite religiose di Padova nel Me-dio Evo, “Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana”, vol. VI (1974), p. XXXVII.
205 Si confronti la situazione veneta: G. DE SANDRE GASPARINI, Per lo studio delle confraterni-te … cit., p. 46.
206 D.E. BORNSTEIN, op. cit., pp. 78-79.207 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite… cit., p. XLIX; L. ORIOLI, op. cit., p. 59.208 MARIA TERESA BROLIS, Mille e più donne in confraternita. Il consorcium Misericordiae di
Bergamo, in Il buon fedele … cit., p. 108; M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XL.209 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., p. XXXVIII.
merose, a garanzia del fatto che in seguito agli uomini venivano affidati i li-velli istituzionali e la stessa gestione dell’associazione210. La presenza delladonna sottolinea, comunque, la non emarginazione femminile dalle attivitàdella congregazione, pur nella sua esclusione dalla possibilità di rivestirecariche gestionali al suo interno211.
Il secondo capitolo impone ai membri della confraternita di assistere duevolte al mese, dopo terza, nella chiesa di S. Vincenzo, alla predicazione, altermine della quale venivano raccolte le elemosine212. I confratelli – parreb-be solamente quelli di sesso maschile – in quell’occasione disponevano nellachiesa di S. Vincenzo ventuno lunghe panche di legno, solitamente custoditenella camera del consorzio situata all’interno della stessa chiesa, sulle qualiprendevano posto per assistere alla predica dome nicale213. L’ascolto delsermone poteva talvolta essere accompagnato dalla lettura pubblica del cor-pus normativo che regolava la vita degli associati e che forniva spesso ilquadro generale entro cui si compiva la formazione cristiana214. La predica-zione – affidata generalmente ai Domenicani e talvolta anche ai Francescani– aveva probabilmente come principale obiettivo quello di regolamentare lavita sociale dei confratelli, puntando di continuo ad adeguare le verità reli-
56
G. Cossandi
210 La procedura di iscrizione è descritta con precisione in: M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M.CORATO, op. cit., pp. LI-LII.
211 L. BERTOLDI LENOCI, op. cit., p. 16; ELENA LUCCA, Nascita, regolamentazione e vita inizia-le di un ospedale duecentesco. L’hospitale Sancte Marie Maioris di Mantova nei primi decennidi esistenza, “Archivio Storico Lombardo”, serie XII, vol. III (1996), p. 28. Sulla questione dellapresenza femminile: ANDRÉ VAUCHEZ, Comparsa e affermazione di una religiosità laica (XII se-colo-inizio XIV secolo), in Storia dell’Italia religiosa, I. L’antichità e il medioevo, a c. di ANDRÉ
VAUCHEZ, Laterza, Roma-Bari 1993, pp. 417-420.212 “Secundo ordinamus quod ille persone de ista congregatione que bono modo possunt,
nisi habeant iustam causam, debeant venire post terciam, facto prandio, bis in quolibet mense,per totum annum ad ecclesiam maiorem beati Vincentii martiris gloriosi, ad audiendam predi-cationem et ad faciendam elimosinam” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 3r). Numerose testimo-nianze sulla pratica della predicazione e la conseguente raccolta delle elemosine sono presentianche nel Primus liber, a titolo di esempio si trascrive la prima: “<1280> Item recepit solidosocto et denarios tres imperialium, suprascripto die dominico decimo intrante marcio, qui fue-runt offerti ipse die in ecclesia Sancti Vincencii ad predicationem” (Primus liber, f. 1r). Cfr. an-che: LESTER K. LITTLE, Les techniques de la confession et la confession comme technique, inFaire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe auXVe siècle, École française de Rome, Roma 1981, p. 92.
213 “Et viginti unam banchas longas et novas que sunt in suprascripta camera et que exten-duntur foras per ipsam ecclesiam Sancti Vincencii quando fiunt per predicationes suprascriptoconsorcio congregacionis Misericordie” (Primus liber, f. 13r).
214 “<1281 aprile 14, Bergamo> In publica et generali credencia et societate et universitateconsorcii, congregacionis domine sancte Marie, que apelatur Misericordia de Pergamo, ibi con-vocata et congregata ad requisicionem et ad istanciam ministri ipsi consorcii, more solito, prolegendis capitulis statutorum seu ordinamentorum ipsius consorcii […]” (BCBg, Pergamene co-munali, n. 6263). Forniscono un’ampia trattazione dell’argomento: G. DE SANDRE GASPARINI,Statuti di confraternite … cit., p. XXII; ROBERTO RUSCONI, Pratica cultuale ed istruzione religiosanelle confraternite italiane del tardo Medio Evo: “Libri da compagnia” e libri di pietà, in Lemouvement confraternel au moyen âge … cit., p. 139; L. GAFFURI, op. cit., p. 53.
giose alle condizioni di vita degli uomini e ordinare queste ultime in quelleverità215. Le prediche potevano limitarsi all’esortazione morale, allo sprona-re a una condotta di vita consona all’esempio evangelico e a una pietà atti-va, ma potevano anche ricordare le finalità della congregazione, come la di-fesa della fede e dell’ortodossia. I frati, dunque, attraverso la predicazione ela guida spirituale, esercitavano una certa influenza sulla confraternita216.
Qualsiasi tipo di associazione aveva bisogno di ufficiali, eletti per garan-tire un efficiente funzionamento: il terzo capitolo della regola affronta laquestione degli ufficiali del consorzio, del loro numero e dei loro compiti. Èin questo settore che emerge in modo più chiaro il continuo rapporto traconfraternita e città nelle sue diverse componenti sociali, civili e reli gio -se217. Nella Misericordia i livelli istituzionali erano tutti affidati agli uomini,ai quali erano soggette anche le donne: non vi sono, infatti, per le donne nédifferenziazione organizzativa, né autonomia decisionale. La donna, lonta-no dall’essere considerata un membro attivo, veniva, infatti, interdetta daimomenti più solenni della vita associativa, quali l’elezione degli ufficiali o leadunanze mensili218.
Notevole appare la precisione con cui vengono definiti tutti i meccanismiorganizzativi e amministrativi della Misericordia, talvolta più complessi diquanto si riscontri all’interno di fondazioni analoghe219. In primo luogo, inconformità con le amministrazioni urbane, con quelle corporazioni di arti emestieri che si incontrano nel tessuto cittadino e con un indirizzo generaleriscontrabile anche in confraternite strutturalmente diverse, vi erano quat-tro massari, scelti dal ministro e dai consiglieri possibilmente uno per cia-scuna porta della città – S. Alessandro, S. Stefano, S. Andrea e S. Lorenzo –,che avevano il compito di distribuire le elemosine ai poveri, ai religiosi, agliospedali, agli infermi, alle vedove e agli orfani. Nel giorno dell’adunanzadella congregazione, questi massari, alla presenza del ministro e dei consi-glieri, erano chiamati a rendere conto delle elemosine raccolte e della loro
57
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
215 Prediche alle donne nel secolo XIII, a cura di Carla Casagrande, Bompiani, Milano1978, p. XVII.
216 GIAN PIERO PACINI, La predicazione laicale nelle confraternite, in Le confraternite in Ita-lia… cit., pp. 15-17; L. GAFFURI, op. cit., p. 59. Sull’importanza della predicazione si veda an-che: G. G. MEERSSEMAN, op. cit., p. 538.
217 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., p. LXII.218 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., pp. XL, XLIII.219 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., p. L; M.T. BROLIS - G. BREMBILLA -
M. CORATO, op. cit., p. XLI.220 “Tertio ordinamus quod ista fraternitas habeat quatuor massarios, sive canevarios, […]
qui sint de quatuor portis civitatis Pergami, si fieri potest convenienter. Quos canevarios, sivemassarios, eligent et costituent de communi bona voluntate et communi consilio minister etconsiliarii in prima dominica Quadragesime […]; et isti quatuor massarii permaneant || usquead unum annum et non plus. Isti etiam massarii de consilio ministri et consiliariorum distri-buant pauperibus religiosis et hospitalibus, infirmis, viduis et orfanis ipsam elimosinam. […] etquerant per civitatem et burgos pauperes, verecondos et infirmos et incarceratos et alios ne-cessitatem patientes, et eis fideliter distribuant dictam elimosinam et misericordiam, sicut se-cundum Deum melius videbitur expedire” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 3r-3v).
distribuzione220. Il 13 luglio del 1300, allo scadere del proprio mandato,Yroldo de Cumis, canevario generale del consorzio della Misericordia, su ri-chiesta del ministro Giovanni de Ulivenis, dichiara di aver preso in carico ildenaro registrato per mano del notaio Pietro Adobbi sul registro (quater-num) della confraternita221.
L’ufficiale laico più importante della congregazione era senza dubbio ilministro, suo compito e responsabilità erano quelli di provvedere al fine chele prescrizioni alla base della vita del consorzio ed i servizi facenti ad essocapo si svolgessero nel modo corretto222. Tuttavia al ministro non era con-cesso un potere illimitato. Egli era affiancato e controllato da dodici consi-glieri, che, come lui, rimanevano in carica un anno, a partire dalla primadomenica di quaresima. Ministro e consiglieri fissavano i giorni in cui imembri della confraternita dovevano radunarsi per ascoltare la predicaquindicinale in S. Vincenzo oppure per assolvere l’incarico della distribuzio-ne delle elemosine223. La collegialità dell’esercizio del comando, in partico-lare riguardo alla gestione economica, intendeva con ogni probabilità tute-lare il consorzio dal rischio di iniziative individuali e inconsulte. Sebbenenella regola non vi sia alcun riferimento in proposito, è verosimile pensare– come generalmente accadde – che il controllo ultimo sull’autorità del mi-nistro e sulle sorti della Misericordia potesse essere esercitato dallo stessofondatore Pinamonte da Brembate224. Nell’adunanza del consiglio dellaconfraternita tenutosi il 14 aprile del 1281 “pro legendis capitulis statuto-rum” e per l’elezione dei canevari e dei sindaci, Pinamonte viene registratoal primo posto tra i confratelli partecipanti alla seduta; lo stesso avvienel’anno successivo, il 16 febbraio, in cui in occasione di una nuova adunanzail suo nome segue soltanto quello del patrono Giovanni de Verdello225. Pina-monte ricopriva presumibilmente il ruolo di guida oltre che di guardiano
58
G. Cossandi
221 Cfr. APPENDICE, doc. III.222 BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 4r-4v.223 “Et habeat dictus minister et tota congregatio duodecim consiliarios utiles et bonos,
providos et discretos qui cum ministro provideant et ordinent dies quando debent congregaripersone de congregatione sive pro predicatione que fit apud Sanctum Vincentium et oblationi-bus que ibi offeruntur, sive pro quacumque causa que occurrerit sive etiam velint videre ettractare de omnibus que expediunt fraternitati huius congregationis” (BCBg, Archivio Mia, n.937, f. 4v).
224 Casi simili emergono dall’analisi del contesto fiorentino: J. HENDERSON, op. cit., p. 79.225 BCBg, Fondo Pergamene, n. 6253 (1281 aprile 14, Bergamo): “In palacio episcopalli Per-
gamensis. […] in publica et generali credencia et societate et universitate consorcii, congrega-cionis domine Sancte Marie, que apelatur Misericordia de Pergamo. Ibi convocata et congregataad requisicionem et ad instanciam ministri ipsi consorcii, more solito, pro legendis capitulis sta-tutorum seu ordinamentorum ipsi consorcii, ipso die, more solito, et pro infrascriptis et aliis fa-cendis […] et in qua societate et universitate erant infrascripti de ipso consorcio, videlicet: domi-nus frater Pinamontis de Brembate ordinis fratrum Predicatorum conventi de Pergamo et […]”;BCBg, Fondo Mia, n. 6828 (1282 febbraio 16, Bergamo): “[…] in publica et generalis credenciasocietatis et universitatis consorcii, congregacionis domine Sancte Marie, que apelatur Miseri-cordia de Pergamo, per dominos Iohannem de Verdello, prepositum Pergamensem et patronumet protectorem ipsius congregacionis, et fratrem Pinamontum de Brembate […]”.
degli statuti e consigliere spirituale della confraternita e, a causa del suoruolo di rappresentante dei valori morali e spirituali della Chiesa, era consi-derato ‘al di sopra’ della stessa fraternitas. A lui poteva spettare anche ilcompito di correggere coloro che infrangevano le prescrizioni fondamentalicontenute nella regola, così come probabilmente a lui poteva essere affidatoil giudizio sulla ortodossia dei candidati, in virtù anche dell’autorità che gliderivava dall’aver esercitato in passato l’incarico di inquisitore226. Pina-monte, grazie alla sua imparzialità e al suo status di ‘al di sopra delle par-ti’, potrebbe anche avere rivestito una funzione centrale in occasione delleelezioni del collegio direttivo della Misericordia. In questa direzione andreb-be, dunque, considerata la sua presenza, fino al febbraio del 1282, alle adu-nanze della confraternita. Questi documenti si pongono, quindi, in nettacontrapposizione alle precedenti fonti che collocano la morte del frate do-menicano intorno al 1266227. Alla luce di questi nuovi dati la scomparsa diPinamonte non sarebbe avvenuta nel 1266, ma presumibilmente nell’arcodi tempo che va dal 17 febbraio al 25 luglio del 1282, poiché non risulta an-noverato tra i confratelli presenti alla successiva adunanza del 26 luglio228.
La procedura elettorale, non proprio dettagliatamente delineata dallostatuto, potrebbe essere stata costituita da un semplice sistema di voto, incui la maggioranza veniva raggiunta dai due terzi dei votanti – per poteravere valore giuridico era invece richiesta la presenza all’adunanza di dueterzi dei consiglieri (8 su 12) –, e rifletterebbe da vicino i modelli del comu-ne, delle vicinie e delle arti, con cui condivideva anche la durata annualedelle cariche e il divieto alla rielezione (unica eccezione per la carica di mi-nistro, ma soltanto in caso di parere favorevole dei consiglieri229). Questadisposizione era chiaramente finalizzata a evitare il perpetuarsi di interessipersonali nella gestione della confraternita, oltre che ad adottare un siste-ma il più possibile giusto ed equilibrato, che tenesse lontano dalla Miseri-cordia quella politica di schieramenti e fazioni, che dominava la scena diBergamo. Nello stesso tempo il veloce rinnovo delle cariche obbligava unbuon numero di confratelli ad impregnarsi dello spirito dello statuto in mo-do da poterlo fare osservare; mentre la suddivisione delle responsabilitàcontribuiva a radicare nella coscienza del singolo associato tutti gli obblighicollettivi230. La brevità della ‘vita parlamentare’ della confraternita, che si
59
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
226 J. HENDERSON, op. cit., pp. 79-80; M. CORTESI, Pinamonte da Brembate … cit., p. 75; M.CORTESI, Memorie… cit., pp. 26-32.
227 THOMAS KAEPPELI, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Typis Polyglottis Vatica-nis, Roma 1980, III, pp. 276-277
228 Primus liber, ff. 15r-15v. Lo spostamento verso gli anni ottanta del XIII secolo della datadi morte di Pinamonte era del resto già stato proposto da Mariarosa Cortesi in: M. CORTESI, Pi-namonte da Brembate … cit., pp. 78-80; ora riproposto in: M. CORTESI, Memorie… cit., p. 32.
229 “Et minister similiter in quolibet anno debet mutari, nisi consiliariis videatur quod ad-huc ipsum debeant confirmare” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 5r).
230 C. M. DE LA RONCIÈRE, Tra preghiera e rivolta … cit., pp. 97-98; M. GAZZINI, L’esempio diuna “quasi-città”… cit., p. 190.
esauriva nello spazio di quella seduta, non creava inoltre i presupposti per-ché vi potesse essere, come nella maggior parte dei governi, una tensionetra i poteri, tanto più che la preoccupazione principale continuava a rima-nere la gestione del patrimonio finanziario231. Risultava, in ogni caso, piut-tosto facile per alcuni gruppi famigliari mantenere a lungo una posizionedominante all’interno del direttivo dell’associazione. L’analisi delle liste de-gli ufficiali mostra come già nell’ultimo decennio del XIII secolo e ancor piùall’inizio di quello successivo, nel momento in cui ormai era venuta meno lafunzione di garante esercitata da Pinamonte, si manifesti la tendenza acreare all’interno del gruppo una sorta di aristocrazia, che trovava logicaespressione nella iterazione delle cariche: caso esemplare è rappresentatoda Giovanni de Ulivenis che dal 1300 al 1306 riveste ininterrottamentel’incarico di ministro232. La forte presa della confraternita sullo spazio ur-bano poteva prestarsi, infatti, a essere sfruttata in diverso modo da gruppifamigliari in ascesa o, se già affermati, preoccupati di consolidare il propriopotere. Era del resto impensabile che, a motivo della sua conformazione dicarattere associativo, modelli ed esperienze della società civile non si ripro-ponessero, sia pure in forme e toni diversi, anche all’interno della Miseri-cordia233. Non sembra comunque ipotizzabile una strumentalizzazione dellaconfraternita da parte di questi gruppi; le norme continueranno ancora a ri-spondere alle convinzioni religiose, morali e sociali di tutti coloro che neavevano sancito la validità e promesso obbedienza234.
Il quinto capitolo prescrive che gli uomini e le donne affiliati – permanetuttavia ancora qualche dubbio per quanto riguarda le donne – partecipinoalle messe, alle orazioni, alle preghiere, a tutte le opere spirituali, nonchéalle visite a infermi e carcerati promosse dalla confraternita (dalle quali era-no senza dubbio escluse le donne). L’identità di una confraternita si espri-meva al massimo grado nella vita devozionale e cerimoniale: era in questocontesto che generalmente veniva rafforzata l’identità dei singoli mem -bri235. La messa era sentita come la principale delle devozioni, quella piùmeritoria e maggiormente portatrice di grazia; mentre la prescrizione dipreghiere comuni, imperniate sulla presenza di un confessore, è un aspettotipico della pastorale degli Ordini Mendicanti per i laici.
L’assistenza ai funerali dei confratelli defunti è, invece, prevista dal capi-tolo sesto, il quale stabilisce anche che gli associati si preoccupino di porta-re i candelieri e le torce, e che ognuno reciti sette pater noster e sette ave
60
G. Cossandi
231 G. LE BRAS, op. cit., p. 549.232 R. A. COSSAR, op. cit., pp. 90-91; M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XLV-
XLVI.233 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., p. XLVIII; M. GAZZINI, Confraterni-
te e società cittadina … cit., p. 383.234 L. ORIOLI, op. cit., p. 16.235 LAURA PAMATO, Le confraternite medievali. Studi e tendenze storiografiche, in Il buon
fedele … cit., p. 32.
(le due consuete preghiere che formavano il patrimonio della pietà comune)per l’anima dell’associato236. L’attenzione e la solidarietà tra i confratellinon sembrano, comunque, mai degenerare in chiusura campanilistica237.Per quanto riguarda le pratiche della devozione e del culto, dunque, i capi-toli dello statuto tracciano un quadro non molto difforme da quello che siconosce a proposito delle tendenze devozionali del tempo. La preoccupazio-ne maggiore e costante che generalmente affiora dai testi delle regole è ilsuffragio per i propri defunti. La morte appare spesso come il centro dellameditazione e occupa un largo spazio nell’orizzonte mentale dei membridelle confraternite238. Già in precedenza, nel primo capitolo, lo statuto rac-comandava nel momento in cui un membro della congregazione facesse te-stamento, la presenza di almeno altri due o tre affiliati che lo consi glias se -ro239. Questa disposizione non deve essere intesa come una implicita costri-zione ad operare dei lasciti in favore del consorzio di appartenenza, quantopiuttosto come un simbolo dell’unione che doveva collegare in punto dimorte e anche dopo il trapasso gli iscritti alla confraternita240.
Garante della ricchezza dei rapporti istituzionali della Misericordia, chene ribadivano il carattere cittadino e generale, era il patrono, unico ufficioecclesiastico e senza limite di tempo. Il capitolo ottavo descrive con preci-sione i suoi compiti e le sue caratteristiche241.
Il nono capitolo ammette la possibilità di rivedere la normativa fissata,apportando aggiunte o modifiche al testo, purché, sottolineando in questomodo la priorità dell’aspetto assembleare, tali mutamenti fossero affidati adun collegio di persone composto dal patrono, due frati predicatori e due mi-nori, un prete della chiesa di Bergamo, il ministro della congregazione, i do-
61
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
236 Un’ampia panoramica sulle pratiche devozionali e sulle preghiere è proposta da: G. G.MEERSSEMAN, op. cit., pp. 942-949.
237 C. M. DE LA RONCIÈRE, Tra preghiera e rivolta … cit., p. 100.238 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., pp. CIX-CXI.239 “Et quelibet persona de ista congregatione quando debuerit facere testamentum debeat
et teneatur vocare tres fratres vel duos ad minus de congregatione et cum eorum consilio facere et ordinare secundum gratiam a deo sibi datam” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 2v).
240 L. ORIOLI, op. cit., pp. 63-64.241 “Istius autem patroni tale erit offitium, videlicet habere bonam curam de factis congre-
gationis et quando necesse fuerit loqui et rogare pro eis et apud antianos populi et etiam inconsilio comunis Pergami et ubicumque fuerit oportunum” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 9v);L. K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., p. 81; M. T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op.cit., p. XLI.
242 “Nono ordinamus quod si aliquid mutandum vel addendum vel minuendum fuerit, nondebet cito vel leviter fieri nisi novis supervenientibus causis necessariis. […] Et talis mutatiocirca hoc non possit fieri, nisi de consensu et voluntate predicti patroni et protectoris congre-gationis, et nisi de consensu et voluntate predictorum duorum fratrum Predicatorum et duo-rum fratrum Minorum, et unius discreti de prelatis vel de sacerdotibus Ecclesie Pergamensisquem isti quinque voluerint eligere, et nisi de consensu et voluntate ministri et duodecim con-silialiorum et quatuor massariorum congregationis” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 10r, 11r);M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XLI.
dici consiglieri ed i quattro massari242.Se gli statuti descrivono il momento specifico della loro redazione,
l’aggiunta di rubriche o modifiche al testo originario consente di seguire imutamenti apportati alla normativa con il trascorrere del tempo. Questisuccessivi complementi formano una serie discontinua di testimonianze dicome le confraternite affrontassero i nuovi problemi, in primo luogo, econo-mici243. Il 2 marzo del 1281 si stabilì che potevano essere nominati uno odue sindaci o procuratori generali, che, rimanendo in carica un anno, fosse-ro preposti a ricevere tutto quanto potesse essere concesso alla Misericordiaper mezzo di lasciti testamentari, donazioni o legati244. La vita della confra-ternita, in relazione al volume di affari gestito, pare essersi complicata a talpunto da non poter più essere lasciato al caso il combinarsi delle preoccu-pazioni amministrative con le innovazioni del quadro direttivo.
Il decimo e ultimo capitolo decreta l’obbligo dello statuto, che si impe-gnavano a osservare entrando a far parte della confraternita; tuttavia non sifa alcuna menzione a sanzioni – ammende o preghiere – per la trasgressio-ne di qualche passo. L’insieme delle prescrizioni statutarie potrebbe alloraessere stato considerato, in modo unitario, come un fatto vincolante per iconfratelli, ma soggetto all’autorità del fondatore, nonché guardiano. Talinorme sarebbero state per i membri uno stimolo positivo alla conversioneanche interiore, ma non tassativi precetti che mortificavano la libertà del-l’uomo e, se trasgrediti, non costituivano materia di peccato, ma ci si rimet-teva alle decisioni dello stesso guardiano245.
Viene inoltre a saldarsi con il testo della regola la lettera – il cui originaleera conservato nell’archivio della confraternita246 – di partecipazione ai me-riti dell’ordine protettore: il primo di febbraio del 1288 frate Nicola, dell’Or-dine dei Predicatori e provinciale di Lombardia, ammette alla partecipazio-ne di tutte le opere e i beni spirituali dell’Ordine coloro che fanno parte del-
62
G. Cossandi
243 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., p. LXXVII; D.E. BORNSTEIN, op. cit.,p. 79.
244 BCBg, Archivio Mia, n. 937, ff. 12v-15r.245 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., pp. XXXIII-XXXIV.246 “Et una litera sigillata sigillo domini prioris provincialis Lombardie fratrum, que est in
busta copergata amplia, in qua continetur quod omnes de suprascripto consorcio Misericordiesunt consortes omnium bonorum operum, missarum et oracionum que fiunt per omnes ipsosfratres predicatores suprascripte provincie ut in ipsis literis plenius continetur” (BCBg, Archi-vio Mia, n. 937, f. 19v).
247 “Devotis et in Ieshu Christo dilectis … ministro congregacionis Misericordie Pergamen-sis civitatis, ac universis et singulis congregacionis eiusdem. Frater Nicholaus, fratrum ordinisPredicatorum provincie Lombardie dictus prior, salutem et incrementa continua gracie saluta-ris. Exigente pie devocionis affectu quem ad ordinem nostrum habens vobis presencium teno-re, concedo participacionem in omnibus bonis, videlicet missis, oracionibus, ieiuneis, abstinen-ciis, vigiliis, laboribus predicationibus ceterisque bonis que per fratres nostros cum tota pro-vincia nostra fieri dederit actor bonorum omnium Dei filius Ieshus Christus. Ordinans nichilo-minus et volens ut in capitulo nostro generali post decessum vestrum anime vestre fratrumorationibus devote recomendetur si vestri ibidem obitus fuerint nunciati, et ut tantum fiat afratribus nostre provincie quantum pro uno fratre defuncto communitatis in ordine nostro fieri
la congregazione della Misericordia di Bergamo247. Nell’occasione di questavisita del padre provinciale la Misericordia donò al convento dei frati predi-catori quattro lire imperiali248. L’aggancio con la Chiesa, seppure nella ri-stretta concezione dei meriti del gruppo, non venne, dunque, mai meno e siconfigurò prima di tutto come una ricerca di riconoscimenti e di grazie talida rendere più prezioso il patrimonio spirituale asso cia tivo249.
Più che dallo statuto è dalla dovizia dei particolari della documentazionecomplementare che affiora nella sua concretezza e nella sua corpositàl’attività giornaliera della confraternita. Il Primus liber Misericordie, il Re-ceptum per caneparios consortii Misericordie e gli atti privati prodotti ci re-stituiscono la vita pratica dell’associazione, quella vita che, sebbene mossada intenti spirituali o culturali, si mostra nei fatti ed è spesso dagli stessicondizionata250. Questi testi indicano che la finalità primaria, nonché benpresto prevalente, della confraternita fu l’attività di assistenza rivolta a di-verse categorie di poveri e bisognosi; del resto, si è già osservato come leistituzioni pubbliche e la stessa chiesa furono portate ad accentuare gliaspetti caritativi ed assistenziali della confraternita. Le opere di carità di-vennero anche un fatto di razionalizzazione e di disciplinamento della vitaassociata, secondo i nuovi bisogni suscitati dalla crescita dei complessi ur-bani251.
Nel frattempo, la sempre più profonda cristianizzazione della società occi-dentale portava con sé un cambiamento nel concetto di carità. La devozioneverso l’umanità di Cristo e l’impatto sulle masse delle correnti evangelichecondussero, in misura maggiore nel corso del XIII secolo, a vedere il Cristocome una creatura sofferente e a considerare i poveri come suoi rappresen-tanti tra gli uomini e come intercessori privilegiati nei confronti di Dio. Con-seguenza di questa evoluzione spirituale fu il moltiplicarsi delle fondazioni infavore dei poveri e, soprattutto, l’impegno nel fare coincidere le opere di cari-tà con le varie forme di povertà252. Non si deve comunque escludere che a
63
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
consuevit. In cuius concessionis testimonium sigillum nostrum duxi presentibus apponendum.Datum Pergami, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo octavo, die kal(endarum) fe-bruari” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 24v); si veda anche: L.K. LITTLE, Libertà, carità, frater-nità… cit., p. 97.
248 “<1288> Item dedit libras quatuor imperiales conventuy fratrum Predicatorum de Per-gamo, quando venit Pergamum dominus provincialis conventuy suprascriptorum fratrum Pre-dicatorum de voluntate et consensu et potestate ministri et canevariorum suprascripti consorciet credendariorum suprascripti consorci et aliorum plurium discretorum virorum suprascripticonsorci” (Primus liber, f. 123r).
249 G.G. MEERSSEMAN, op. cit., p. 538; G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite …cit., p. CXVIII.
250 CLAUDIO LEONARDI, Lingua e cultura negli antichi statuti bergamaschi, in Statuti rurali estatuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII. Atti del convegno. Bergamo 5marzo 1983, a c. di MARIAROSA CORTESI, Bergamo 1984 (Fonti per lo studio del territorio berga-masco, 5), p. 116.
251 G. MICCOLI, op. cit., p. 797.252 ANDRÉ VAUCHEZ, Ordini mendicanti e società italiana: XIII-XV secolo, Il Saggiatore, Mila-
no 1990, pp. 222-228.
una prospettiva più strettamente cristiana si affianchi talvolta anche un at-teggiamento più concreto e nella maggior parte dei casi improntato al pensie-ro della povertà come male e miseria253. È possibile, in ogni caso, supporreche i bisogni sempre crescenti della popolazione rendessero l’attività di assi-stenza svolta dai precedenti ospedali esigua e insufficiente, sia per la ristret-tezza degli ambienti di cui disponevano, sia economica per le rendite spessoinadeguate alle nuove esigenze254. Sotto le sollecitazioni della crescita demo-grafica e di una società sempre più mobile e diversificata, nella quale il dena-ro assume un’importanza crescente, il modello caritatevole del secolo prece-dente mostra tutti i suoi limiti255. Ciononostante le concezioni e le motivazio-ni religiose che stanno alla base delle nuove iniziative assistenziali e di pietàdel pieno XIII secolo non presentano grosse diversità rispetto al periodo pre-cedente, ma servizi e fondazioni acquistano ora una stabilità e un’organizza-zione maggiori e le loro forme sono in grado di adattarsi meglio alle condizio-ni della vita sociale, del quadro urbano e dell’economia mone ta ria256.L’influsso diretto degli Ordini Medicanti stimolò, inoltre, il nascere di uno spi-rito di assistenza rivolto a opere di carità più vaste257. Anche se non risultapossibile effettuare una ricerca a livello quantitativo, è lecito credere che nel-l’insieme l’offerta di assistenza ricoprisse gran parte delle necessità258. Glielenchi di poveri beneficiati fatti redigere dalla Misericordia contraddicono,inoltre, in modo palmare la tesi storiografica secondo cui di solito, nel bassoMedioevo, la beneficenza sarebbe stata indiscriminata e non avrebbe tenutoin considerazione i bisogni reali259. La Misericordia attua un cambiamentonell’orientamento di base verso i poveri: si distoglie l’attenzione dal benefi-ciare le istituzioni religiose e assistenziali per concentrarsi direttamente suipoveri, a cui venivano versate la maggior parte delle elemosine.
Nel caso di Bergamo i confratelli della Misericordia raccoglievano, dun-que, elemosine, alimenti, indumenti che in seguito venivano distribuiti dai
64
G. Cossandi
253 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite … cit., p. CXVI.254 E. LUCCA, op. cit., p. 13. Una descrizione dell’assistenza ospedaliera in Bergamo è offer-
to da: L. K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità… cit., p. 89; M. T. BROLIS, All’origine dei primiospedali … cit., pp. 53-77; MARIA TERESA BROLIS, La fondazione dell’ospedale bergamasco di S.Antonio “de Foris” (sec. XIII), “Bergomum”, vol. LXIX (1995), pp. 5-17.
255 GRADO GIOVANNI MERLO, La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV, in Laconversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XIV. Atti del XXVIII Convegno storico interna-zionale. Todi, 14-17 ottobre 1990, CISAM, Spoleto 1991, p. 18.
256 G. MICCOLI, op. cit., p. 798.257 MICHEL MOLLAT, I poveri nel medioevo, Laterza, Roma-Bari 1982, pp. 155, 160.258 A. VAUCHEZ, Ordini mendicanti… cit., p. 228.259 Cfr. APPENDICE, doc. IV. Un ampio inventario di poveri beneficiati nell’anno 1282 è stato
pubblicato in: M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., pp. 81-95; cfr. anche: J. HENDER-SON, op. cit., p. 256.
260 Cfr. APPENDICE, doc. V; Gli atti della visita apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo(1575), I. La città, a c. di ANGELO RONCALLI, Olschki, Firenze 1936, pp. 360-361; M.T. BROLIS - G.BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. XXXV.
261 “Item recepit solidos tredecim et medium imperialium die dominico .XIIIIor. intrante apriliqui fuerunt offerti ipso die in ecclesia Sancti Vincencii ad predicationem” (Primus liber, f. 1r).
ca ne vari260. Le entrate del consorzio erano costituite dal denaro raccolto inoccasione della predicazione261, dalla colletta effettuata nelle vicinie della cit-tà e nei borghi262, dalle rendite provenienti dalla locazione di beni immobili,nonché dalle donazioni e dai lasciti testamentari dei privati. La Misericordiapoté sussistere e operare attivamente proprio grazie anche alle donazioni ot-tenute attraverso i testamenti, nei quali, durante il XIII secolo, cresce pro-gressivamente l’attenzione verso i poveri263. Gli atti testamentari finiscono,inoltre, col diventare – come in precedenza lo fu per i Predicatori – un bancodi prova sul quale misurare la capacità di presa della Misericordia sulla so-cietà urbana264. Al contempo la frequenza dei lasciti creò la necessità di svi-luppare un efficace sistema di amministrazione di tali beni in relazione allaloro distribuzione265. Ben presto acquista, all’interno del gruppo dirigente delconsorzio, un’importanza particolare la figura del notaio-segretario che, in
65
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
262 “Isti sunt denarii recepti ad festum Domini .M°.CC°. octuagesimoquinto. In primis enimrecepti solidos .XLIII. et denarios .II. a vicineis sancti Alexandri de la Cruce et sancti Iohannisde hospitali et sancti Andree.Item recepti solidos .XV. et .II. imperialium a vicinis vicinee sancti Michaelis de Puteo Albo.Item recepti solidos .IIIIor. et medium imperialium a vicinis vicinee sancti Michaelis de Archu.Item recepti solidos .VII. et denarios .XLI. imperialium a vicinis vicinee de Antescolis et sancto-rum Salvatoris et Iohannis Evangeliste.Item recepti solidos novem et denarios .XL. imperialium a vicinis vicinee Burgi Canallis et sancteGrate.Item recepti solidos .XXIII. et denarios .II. et medium imperialium a vicinis vicinee sancti Ale-xandri in Columna et sancti Leonardi.Item recepti denarios .XLIIIIor. a vicinis vicinee sancti Maffei.Item recepti solidos octo et denarios .VII. imperialium a vicinis contrate de Arena et sancte Agate.Item recepti solidos .VII. et denarios octo imperialium a vicinis vicinee sancti Andree.Item recepti solidos tres imperialium a domino Tersevallo de Mariano quos dedit suprascriptoconsorcio amore Dei.Item recepti solidos decem et denarios .II. a vicinis vicinee sancti Pancraci.Item recepti denarios .XII. imperialium a Martino de Oyo vicinee sancti Stephani quos uxorcondam ipsius Martini iudicavit suprascripto consorcio.Item recepti solidos quatuor et denarios .XI. et unum asse a vicinis vicinee sancti Laurenci.Item recepti solidos .XIIIIor. imperialium in nativitate Domini in ecclesia Sancti Vincencii inmane et post prandeum ad predicationem” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 26r).
263 P. BREZZI, op. cit., p. 528; ANTONIO RIGON, I testamenti come atti di religiosità pauperisti-ca, in La conversione alla povertà … cit., p. 403; R.A. COSSAR, op. cit., pp. 130-133.
264 Nei trent’anni circa che vanno dal 1277 al 1310 si contano numerosi testamenti in fa-vore della Misericordia: BCBg, Fondo Mia, nn. 698 (1277), 1237 (1277), 9007 (1278), 1155(1279), 646 (1285), 5675 (1289), 1156 (1290), 2992 (1294), 561 (1296), 699 (1296), 1240(1296), 5333 (1296), 1682 (1297), 647 (1300), 701 (1300), 4338 (1300), 10904 (1300), 4338(1301), 4473 (1301), 4811 (1301), 562 (1302), 702 (1303), 1159 (1305), 724 (1306), 1565(1307), 563 (1309), 4482 (1310), 8793 (sec. XIV); BCBg, Archivio degli Orfanotrofi, n. 1460(1298). Si è indicato tra parentesi l’anno in cui venne redatto il documento.
265 Ne sono testimonianza, tra gli altri, i documenti: BCBg, Fondo Mia, nn. 9007, 6619, 2993,10482; si vedano inoltre: P. BREZZI, op. cit., p. 528; J. HENDERSON, op. cit., pp. 169, 266-267.
266 G. DE SANDRE GASPARINI, Statuti di confraternite… cit., p. LXVII; ANNA ESPOSITO, Ammini-strare la devozione. Note dai libri sociali delle confraternite romane (secc. XV-XVI), in Il buonfedele… cit., p. 196; ATTILIO BARTOLI LANGELI, Il notaio, in Ceti, modelli, comportamenti nella so-cietà medievale (secoli XIII-metà XIV), Pistoia 2001, p. 34.
virtù della sua diretta competenza nella produzione di scritture autentiche,viene incaricato della compilazione dei registri contabili e degli inventari266.
Le disposizioni statutarie prescrivevano che i canevari si recassero, ingruppi di almeno tre persone – qualora questo non potesse avvenire eranoautorizzati a richiedere l’aiuto di altri confratelli –, per le vie della città e deiborghi e procedessero alla distribuzione di pane, vino, panni di lana, flan-donos (forse un tipo di pasta riempita di dolci o qualcos’altro e cotta al fuo-co267), sale ed elemosine. I canevari, tuttavia, non agivano in modo del tuttoautonomo: anche nella beneficenza il modus operandi della Misericordia èsempre collegiale. Infatti nel 1292, a causa della sovrapposizione nella do-menica 17 febbraio dell’andata generale e dell’elezione del nuovo ministroe dei canevari, il canevario generale Giovanni Armani de Redona non deci-de autonomamente di cambiare data, ma sottopone il problema al consigliodella confraternita, il quale, all’unanimità, stabilisce di posticipare al vener-dì successivo la distribuzione delle elemosine268.
La Misericordia attuò un’assistenza tutt’altro che superficiale e sporadica,che, oltrepassando i confini di una solidarietà strettamente confraternale e altempo stesso superando l’impianto vicinale, si rivolgeva a tutta la cittadinan-za e copriva l’intera città269. Ma il raggio dell’azione della beneficenza siestendeva anche al di fuori della mura cittadine, verso i suoi borghi e talvoltaverso le vicine valli: risultano stabilmente interessati dall’opera della confra-ternita Seriate, Paderno, Grassobbio, Orio e Plorzano270. L’orizzonte mentaledell’opera di assistenza è dunque la città con i borghi che le gravitano attor-no, quella città definita dalle proprie mura ma aperta attraverso le porte alsuo circondario. Tuttavia, al di là del mirabile intento caritativo, non va sot-tovalutato un intento pratico e protettivo, che, attraverso la distribuzione del-
66
G. Cossandi
267 A. RONCALLI, op. cit., p. 71.268 “In nomine Domini amen. Die dominico .XIII. exeunte febrario .M°.CC°. nonagesimo se-
cundo, indictione quinta. In comune Pergami, in choro ecclesie domini Sancti Vincencii. In pu-blico et generali consilio consorci congregacionis sancte Misericordie domine sancte Marie Per-gamensis, in quoquidam consilio erunt octo ex credendariis suprascripti consorci et in magniquantitate aliorum bonorum hominum suprascripti consorci.
Ibique dominus Zoannus ser Armani de Redona, canevarius suprascripti consorci, pro seet sociis suis et ipsius consorci, proposuit ibi in ipso consilio et ab eis petit sibi dicto modo etnomine consilium exhiberi super infrascriptis, videlicet cum andata generali suprascripti con-sorci que debet fieri die dominico proximo venturo, quo die debet fieri electio de ministro etcanevariis eligendis, sic quod ipsa andata ipso die non potest comode fieri […]. Unde, reforma-to consilio et factis et revolutis partitis, placuit omnibus, nemine contradicere, quod dicta an-data generale fiat per canevarios suprascripti consorci die veneris proximo veniente, loco ip-sius diei dominico” (Primus liber, f. 239v)
269 A. VAUCHEZ, Comparsa e affermazione… cit., p. 416; R.A. COSSAR, op. cit., pp. 177-183.270 “<1293> Et in andata facta in locis de Seriate et de Paterno et de Gresobio et de Urio
fladones viginti unum et solidos quinque panis et sextarios duodecim imperialium in denariisfactis et solidos duos imperialium in denariis factis” (Primus Liber, f. 220r).
271 In questa direzione si muove la politica messa in atto dai comuni cittadini nel corso delXIII secolo, cfr. ANTONIO IVAN PINI, Dal comune città-stato al comune ente amministrativo, inStoria d’Italia, UTET, Torino 1981, IV, p. 533.
le elemosine ai poveri delle valli e dei borghi contermini, intendeva con ogniprobabilità impedire l’intensificarsi del loro inurbamento271.
Il Primus liber descrive come queste andate, distinte in generali o ‘parti-colari’, rivolte in questo caso ad una determinata categoria di poveri, forsein quel momento più bisognosa, avvenissero di domenica, generalmenteogni quindici giorni272. Un affresco del XIV secolo, che doveva trovarsi sullafacciata della cattedrale, nei pressi della scala che portava al piano superio-re del palazzo del Comune – oggi conservato nel Museo Diocesano di Berga-mo –, a testimonianza di come le fonti iconografiche talvolta possano inte-grare le fonti scritte, restituisce l’immagine di una di queste distribuzioni. Inesso vi è rappresentato un uomo seminudo che tende le braccia per riceve-re da una persona, il canevario della Misericordia, dal cui vestiario si pre-sume di condizione elevata, un pane. Accompagnano il canevario un giova-ne, che sorregge con entrambe le mani un recipiente, in cui probabilmenteera contenuto del vino, e due portatori, di condizione sociale meno elevata,che recano con sé un sacco ed un fiasco segnati con una croce273. Forte-mente sottolineata è la distanza sociale che separa chi dona da colui che ri-ceve: è probabile che i canevari venissero individuati tra persone sufficien-
67
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
272 A titolo di esempio si segnalano: “<1282> Item dedit et expensit solidos triginta quin-que et denarios novem imperialium in andata facta per suprascriptos canevarios per civitatemet burgos Pergami, die dominico ultimo agusti, ad visitandum pauperes, infirmos et incarzela-tos et presonerios et egenos civitatis Pergami et burgorum ultra somas quatuor furmenti et sili-ginis, qui fuerunt cocti in pane et dati et expensi, suprascripto die, in suprascripta andata intusconputatis solidos quinque imperialium, qui dati fuerunt in uno sextario salis quod expensumfuit in suprascripta andata et solidi septem et denarii decem imperialium, qui dati fuerunt infaciendo fieri unum zirco qui ofertus fuit ad Sanctum Alexandrum in festo sancti Alexandri etultra medium quatarium salis, quam dedit Detesalvus de Ambonate pro anima sua et ultra sex-tarium unum salis, quod dedit Paganus Iordene quod expensum fuit in suprascripta andata”;“<1283> Item dedit et expensit suprascriptus Bartolameus <Iohannis Testoris de Lemene>,una cum suprascriptis aliis canevariis sociis suis et ministro suprascripti consorci, libras treset solidos quinque et denarios quatuor imperialium in andata facta per ipsum Bartolameum etsocios eius canevarios, die dominico callendis marci suprascripto anno, per civitatem et burgosPergami ad visitandum pauperes et infirmos et incarzelatos et egenos et presonerios, ultra so-mas quatuor et medium, quid furmenti, quid sicallis, quid milli, silicet in una parte sextarios.VII. furmenti et duo milli quondam receptos a domino Lanfranco Suardi, ut in recepto supra-scripti Bartolamei continetur, et sextarios .XI. furmenti empti per ipsum Bartolameum, ut su-pra continetur, quondam suprascripte some quatuor et medium suprascripte blave, ut supra-scriptum est, fuit cocte in pane et date et expense in suprascripta andata et ultra sextariosduos salis receptos a domino Teutaldo Tavegozi et unum quartum salis receptum a suprascrip-to Zoanno de Solto, quondam canevario suprascripti consorci, quod totum suprascriptum sa-lem similiter fuit expensum in suprascripta andata”; “<1292> Item dedit et expensit solidos vi-ginti et denarios unum et medium imperialium videlicet, solidos tredecim et denarios quinqueet medium imperialium in quodam andata facta tantum ad visitandum infirmos et incarzelatoscivitatis et burgorum Pergami die veneris .XIII. intrante augusti, et solidos sex et denarios octoimperialium in quodam zirco flurito offerto die festi sancte Marie, que fuit dominico .XV. in-trante augusti ad ecclesiam Sancti Franzischi” (Primus Liber, ff. 26r, 41r, 66r); cfr. anche: R.A.COSSAR, op. cit., pp. 177-183.
273 A. RONCALLI, op. cit., pp. 70-71; L.K. LITTLE, Libertà, carità, fraternità … cit., p. 80.
temente ricche, in modo da poter attraversare la città raccogliendo e distri-buendo le elemosine senza suscitare il sospetto di un tornaconto personalee senza essere scambiati per dei poveri274. Fin dall’inizio, dunque, a motivodella necessità che gli amministratori avessero le competenze specifiche persopperire ai nuovi impegni assunti dalla Misericordia, furono chiamati alladirezione della confraternita alcuni rappresentanti della borghesia cittadi-na, alla cosiddetta ‘aristocrazia degli affari’, talvolta gli stessi che ricopriva-no incarichi anche all’interno dell’amministrazione del Comune275.
Ma questi ufficiali percorrevano la città anche per selezionare coloro chesembravano in una situazione di particolare bisogno e verso i quali dovevaindirizzarsi l’opera del consorzio; compito questo che poteva in parte esserecondizionato dai possibili pregiudizi su chi, questi ufficiali, considerasseropiù degno di ricevere l’elemosina276. La beneficenza messa in atto dalla Mi-sericordia era pertanto fondata sulla personalizzazione del rapporto tra uf-ficiali e beneficiati.
Con il passare degli anni nel Primus liber si fanno sempre più accurate leregistrazioni delle andate e delle distribuzioni effettuate, tra le cui righe ap-paiono chiaramente ricostruibili le linee di una lenta ma progressiva evolu-zione del pensiero dei confratelli, che si accompagna ad una sempre piùconvinta accettazione di un compito assistenziale che viene assumendo deicontorni sempre più costanti277. Senza dubbio le registrazioni del Primus li-ber sulla beneficenza restituiscono un’immagine più reale e dettagliata diquella offerta dagli statuti; rimane tuttavia ancora lecito chiedersi in che mi-sura le elemosine offerte dalla compagnia possano essere considerate un ef-ficace sistema di assistenza ai poveri.
Nel frattempo la monetizzazione dell’elemosina aveva costituito una tap-pa evolutiva del concetto stesso di elemosina sotto l’aspetto economico, maanche sociale e morale. La libertà di uso del denaro lasciava al povero be-neficiato una certa possibilità di scelta, reale seppure limitata, per i suoi ac-quisti. In questo modo si intendeva rispettare la dignità personale e ne ri-sultava facilitata la discrezione con cui conveniva soccorrere i poveri vergo-gnosi278. Forse uno dei motivi che in misura maggiore rendono ragione del-la notevole stima goduta dalla Misericordia sta nella sua attività in favoredei poveri vergognosi (pauperes verecundi), di coloro che non desideravano
68
G. Cossandi
274 A. RONCALLI, op. cit., p. 71; A. MORIANI, op. cit., p. 26.275 Yroldo de Cumis, canevario della Misericordia intorno al 1300, rivestì l’incarico di con-
sole del collegio dei notai nel 1283, nonché quello di giudice ordinario nel 1301. Bergamino deMarchisis fu invece console del collegio dei notai nel primo semestre del 1309 e nel 1315 (cfr.GIUSEPPE SCARAZZINI, Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII), Consiglio nazionale del notariato,Roma 1977, pp. 71, 73). Situazioni analoghe sono presentate in: A. MORIANI, op. cit., p. 26. Suinominativi che componevano il gruppo dirigente, si vedano: R. A. COSSAR, op. cit., pp. 52, 105,112-113; M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., pp. XLI-XLVI.
276 J. HENDERSON, op. cit., p. 286.277 L. ORIOLI, op. cit., pp. 92-93.278 M. MOLLAT, op. cit., p. 178.
rivelare pubblicamente la propria condizione di povertà o per senso di pu-dore o perché causa di un decadimento della posizione sociale ed economi-ca. Si tenga presente che, nella seconda metà del XIII secolo, in un contestosociale sempre più urbanizzato, la povertà vergognosa iniziava ad assume-re proporzioni di rilievo, ponendo alla coscienza cittadina interrogativi circai problemi sottesi a tale tipo di povertà e stimolando il nascere di fondazionivolte al sostegno di questi poveri279.
La base economica da cui la Misericordia traeva il sostegno necessarioall’attuazione delle proprie finalità caritative appare costituita dal patrimo-nio fondiario, consolidatosi progressivamente tra la fine del XIII e l’iniziodel XIV secolo, e da un considerevole numero di donazioni e acquisizionivolontarie.
I documenti restituiscono testimonianza di numerosi appezzamenti diterra, acquistati dalla Misericordia, situati non solo all’interno delle muracittadine, ma anche nel contado. Nel 1293 la confraternita entra in possessodi alcune pezze di terra arativa e vitata situate lungo la strada che conducea Seriate280; nel 1304 il ministro Giovanni de Ulivenis riceve due appezza-menti di terra arativa, vitata, prativa, boschiva e con alcune case e degli al-beri siti in Bergamo, nella vicinia di S. Lorenzo281. Nel 1306 ne acquisiscealtri due entrambi in Bergamo, il primo di terra prativa, ortiva e vitata si-tuato nella vicinia di S. Michele al Pozzo Bianco; il secondo con alcune casee alberi nella vicinia di S. Andrea282. A partire dal 1306 si fanno più consi-stenti anche i beni fondiari posseduti in Valle Seriana: nel 1306, 1307, 1308entra in possesso di tre appezzamenti di terra vitata in Nembro283. Infinenel 1309 la Misericordia riceve una pezza di terra arativa e vitata, con unsedime ed alcune case in Torre Bol done284. La confraternita mantiene, dun-que, costante nel tempo, se non addirittura consolida nel corso del XIV se-colo, questa tendenza ad incorporare nuovi terreni ed immobili, segno sen-za dubbio del perdurare di una favorevole situazione economica.
Dalla documentazione relativa al patrimonio, sebbene sotto alcuni aspet-ti lacunosa, sembra, inoltre, possibile constatare che fino all’inizio del XIVsecolo la Misericordia non mise in atto una politica di accorpamento delleproprietà, così come pare che ad alcuni investimenti diretti privilegiasse uncomune affitto – in denaro o in natura – da impegnare nelle distribuzioni aipoveri. Nel 1277 Giovanni de Orio, sindaco della Misericordia, riceve tren-tasei soldi quale affitto di un appezzamento di terra arativa e vitata sito in
69
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
279 Analogo appare il caso dell’ospedale della Colombetta di Milano: ANGELO BORGHINO, Laicie beneficenza a Milano tra XIII e XIV secolo. Il caso della Colombetta, “Archivio Storico Lom-bardo”, serie IX, vol. V (1988), pp. 72-73.
280 BCBg, Fondi Mia, n. 6820.281 BCBg, Fondo Mia, n. 6641.282 BCBg, Fondo Mia, n. 1865.283 BCBg, Fondo Mia, nn. 8913, 8925.284 BCBg, Fondo Mia, n. 3899.285 BCBg, Fondo Mia, n. 10998.
Almenno285. La Misericordia ricorreva, dunque, per la gestione del propriopatrimonio fondiario, alla figura del sindaco già prima del 1281, anno in cuifu ufficializzato questo incarico con l’inserimento di un nuovo capitolo nellostatuto. Nel 1297 Bartolomeo de Cravascho, canevario generale della con-fraternita, riceve da Bonazio de Oxio cinque lire imperiali quale affitto per ilpossesso di un appezzamento di terra con alcune case, situato nel borgo diS. Stefano286. Nel 1298 Bonazio de Oxio riceve cinque lire imperiali qualefitto per l’utilizzo di una casa, di proprietà del consorzio, posta nella viciniadi S. Stefano287. Nel 1301 Giovanni de Ulivenis, ministro della Misericordia,riscuote alcuni sestari di siligine e di miglio, quale affitto per il possesso dialcuni appezzamenti di terra situati nel territorio di Stezzano288. Nel 1308Antonio detto Tirla dà alla confraternita dodici soldi e mezzo quale fitto diun anno per il possesso di un appezzamento di terra in borgo di S. Andrea,nella vicinia di S. Alessandro. Nel 1309 la Misericordia riceve altri dodicisoldi e mezzo per l’affitto di un appezzamento di terra sito nello stesso bor-go di S. Andrea289. Da questi documenti si comprende come uno degli ele-menti chiave delle associazioni definite con il termine di consorzio fosse lagestione di capitali e investimenti, che comportasse anche la ripartizionedegli utili, che potevano talvolta contribuire al sostegno di qualche confra-tello in difficoltà. Il 23 ottobre del 1310 Malgarita, figlia del fu Giovanni Ar-mani de Redona, del borgo di S. Andrea – di cui la madre e il padre vengo-no registrati tra gli iscritti alla Misericordia290 – promette al notaio Gugliel-mo Bergonzi, che agisce a nome della confraternita, di restituire entro ilprossimo mese un prestito di quattro lire imperiali e mezza, concessole dalcanevario generale Alberto Guidoti291.
Il quadro delle proprietà era completato da alcune case possedute dallaMisericordia in Bergamo. Nel 1300 e 1301 risultano appartenere al patri-monio immobiliare della confraternita due case, l’una nella vicinia di S.Alessandro della Croce e l’altra in quella di S. Andrea, ottenute probabil-mente per mezzo di lasciti testamentari292. Sempre nel 1301, alla ricerca diuna sede stabile per i propri uffici, archivio e caneva per il vino, la Miseri-cordia acquistò dai pellicciai Bonaventura de Agraria e suo figlio Giacomo
70
G. Cossandi
286 BCBg, Fondo Mia, n. 5886.287 BCBg, Fondo Mia, n. 5887.288 BCBg, Fondo Mia, n. 6041.289 BCBg, Fondo Mia, n. 4480.290 M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., p. 47.291 BCBg, Fondo Mia, n. 566; cfr. anche: BCBg, Fondo Mia, n. 4471.292 BCBg, Fondo Mia, nn. 4473, 4477, 8794, 8913.293 “Die quartodecimo intrante februario millesimo trecentesimo primo, indictione quarta-
decima. Petrus Bertolamei Adobi notarius tunc suprascripti consorci rogavit cartam aquisti do-mus seu hospicii ipsius consorcii, in qua debent teneri et gubernari bladam et vinum et omniaalia bona ipsius consorcii. In qua carta continetur Bonaventuram, filium quondam Martini deCornu, de Adraria, piliparium civitatis Pergami, et Iacobum, eius filium, fecisse datum et ven-ditionem Iohanni de Uliverio, ministro, domino Iroldo de Cumis, canevario generali, Iohannide Uria et Guillelmo Bonomi Bergonzii, tunc canevariis dicti consorcii nomine ipsius consorciide quadam pecia terre casate qua iacet in vicinia sancte Heufemie, precio librarum trecenta-
al prezzo di trecentosessantadue lire imperiali una casa nella vicinia di S.Eufemia, che rimase fino al 1449 la sede della confraternita293. Sicuramen-te devono aver creato le premesse favorevoli a questo trasferimento i nume-rosi collaboratori provenienti da questa vicinia, che in qualità di canevari eministri, prestarono la loro opera nel periodo dal 1279 al 1300294.
Nel corso del XIV secolo, dunque, la progressiva acquisizione di autono-mia amministrativa e l’estensione dell’impegno caritativo comportarono inparte il mutamento delle strutture della Misericordia fino forse a far veniremeno il carattere originario di organizzazione religiosa, per trasformarla inuna istituzione pubblica con una sede stabile e perfettamente integrata, an-zi collocata in una posizione di primo piano, nella società cittadina.
Dal quadro fino a qui delineato emerge inequivocabilmente lo stretto le-game, già più volte sottolineato, tra la Misericordia e l’area locale. La storiadella Misericordia, così come ci appare dai documenti conservati nel suo ar-chivio, è innanzi tutto un pezzo di storia della sua città, in ogni caso di unospazio socio-politico, le cui vicissitudini e traversie riflettono la dialetticadelle forze sociali, religiose e politiche, la dialettica delle tensioni e dellementalità.
71
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
rum sexagintaduarum imperialium; quam domum suprascriptus Bonaventura aquistavit a do-mino Pagano Iordene, ut plenius continetur in quodam instrumento rogato per Vincentium dePrenda notarium, die duodecimo intrante ienuario .M.CC. nonagesimo quarto, indictione septi-ma” (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 20v); G. LOCATELLI, La casa della Misericordia … cit., pp.128-129, 142.
294 M.T. BROLIS - G. BREMBILLA - M. CORATO, op. cit., pp. CI-CII.
APPENDICE DI DOCUMENTI (*)
IREFORMATIONES CONSILII COMUNIS PERGAMI
1288 marzo 19, Bergamo.
Il Consiglio del Comune, convocato per volere del podestà Girardo de Tacullis diReggio, prendendo atto che numerose persone affidano alla Misericordia come loroultime volontà ingenti somme di denaro, che spesso divengono oggetto di controver-sie economicamente gravose per la congregazione, stabilisce che, nei prossimi cin-quant’anni, possa essere avviata una causa di appello nei confronti del consorzio so-lo per donazioni superiori alle cinquanta lire imperiali.
Originale, BCBg, Archivio Mia, n. 912 (1) [A]. Secondo originale, Archivio Mia, n. 912 (2)[A’]. Copia del sec. XIIIex incompleta, Fondo Mia, n. 5686 [B]. Nel margine superiore del rectodi A, segnatura novecentesca: “MIA 39. 28. 31”. Nel verso di A, di mano del sec. XIII-XIV: “§Hic inter est testamentum Bartolamei Iohannis Testoris”; di altra mano del sec. XIII-XIV, ripas-sata da mano del sec. XVIII: “§ Consilium factum super […] reddenda consorzio usque ad soli-dos quinquaginta imperialium et ultra; di mano del sec. XIV: “Consilio comunis suprascripto”;di mano del sec. XV: “Provisiones consili comunis Pergami in favorem consortii ****** veteritempori”; segnatura novecentesca: “MIA XXXIX – 28 (2)”; altre segnature novecentesche a ma-tita. Nel margine superiore del recto di A’, segnatura novecentesca: “MIA 39. 28. 32”; nel mar-gine inferiore; annotazione di mano del rogatario: “Que omnia suprascripta continencia in su-prascriptum consilio facta fuerunt tempore domini Bonaventure de Mapello, ministri supra-scripti consorci congregationis sancte Misericordie, qui operatus fuit suprascriptum consiliumfieri faci | endum una cum Antonio Merzadio et Cresimbeno de Capriate et Recuperato de Ane-xie et Iohanne Adammi de Tresolzo, calgario, omnibus tunc canevaris suprascripti consorci”.Nel verso di A’, di mano del sec. XVIII: “Pro consorcio Mie privilegia a magna civitate 1288 |sub ministratu de Bonaventura de Mapelo ministri”; segnatura novecentesca: “MIA XXXIX –28 (2); altre segnature novecentesche a matita.
La pergamena di A presenta, oltre a qualche macchia di umidità, una certa consunzione ealcune modeste rosicature lungo il margine destro. I forellini di cucitura, visibili nel margineinferiore, denunziano la congiunzione di questa ad un’altra pergamena (forse A’, come sem-brerebbe confermare l’accostamento fisico dei due manufatti). La pergamena di A’, pur essen-do interessata da diffuse macchie di umidità lungo il margine destro, appare in buono stato diconservazione. Nel margine superiore si osserva la presenza dei forellini di cucitura.
La mutilazione della parte inferiore della pergamena di B interessa l’indicazione delle deci-sioni prese dal consiglio, che nell’originale seguono la proposta del notaio Azuello de Azuellis.Il lasso temporale in cui collacare la redazione della copia ha, ovviamente, come terminus postquem il 1288 marzo 19 – data in cui fu redatto l’originale – e come terminus ante quem il1295, poiché nell’inventario dell’archivio della confraternita, redatto in quell’anno per manodel notaio Bergaminus de Marchesis, è registrata la presenza di tre instrumenta relativi a que-sta decisione consigliare (BCBg, Archivio Mia, n. 937, f. 19r).
72
G. Cossandi
(*) I criteri editoriali adottati si rifanno alle norme approntate da Pratesi nel 1957 (ALESSAN-DRO PRATESI, Una questione di metodo: l’edizione delle fonti documentarie, “Rassegna degli Ar-chivi di Stato”, vol. 17 (1957), pp. 312-333), comunemente impiegate, con poche eccezioni, neilavori di edizione e per l’affinità tipologica di parte della documentazione qui edita a: MARIA TE-RESA BROLIS - GIOVANNI BREMBILLA - MICAELA CORATO, La matricola femminile della Misericordia(1265-1339), Stabilimento Tipografico Pliniana, Selci-Lama 2001.
Si trascrive il primo originale nella colonna di sinistra e il secondo originale nella colonnadi destra.
Nel rispetto inoltre dell’impaginazione effettuata dal notaio, che intendeva dare autonomiaformale alle disposizioni dei singoli notai intervenuti, si è deciso di manetenere l’originariasuddivisione del testo in paragrafi, andando a capo ogni volta che ciò avviene nell’originale.
73
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
In nomine Domini amen. Die veneristerciodecimo exeunte marcio, millesimoducentesimo octuagesimo octavo, indi-tione prima. In palacio comunis Perga-mi. In publico et generali consilio comu-nis Pergami, | more solito convocato etcongregato campanis et voce preconium,nobilis vir dominus Girardus de Ta-cull(is) de Regio, potestas comunis Per-gami, proposuit in ipso consilio et ab il-lis de ipso | consilio petiit sibi pro comu-ni Pergami consilium exiberi super in-frascriptis, videlicet cum per multos etvarios homines et personas sit relictumin suis ultimis voluntatibus | consortiocongregationis Misericordie dominesancte Marie de Pergamo in multis etvariis quantitatibus denariorum et pec-cunie (a) et rerum, sic(ut) quod multepersone civitatis et virtutis Pergami, |que debent et tenentur dare ipsi consor-cio congregationis multa legata seu iudi-ceria in variis quantitatibus, detractantet nolunt ipsa legata seu iudiceria | darenec solvere ipsi congregationi sine lite etcontroversia; et oporteat ipsam congre-gationem facere in multis ex ipsis legatisconsequendis et exigendis mayores | ex-pensas quam ipsa legata essent seu iudi-ceria. Si placet et volunt illi de consilioquod omnes illi, qui debent vel debebuntdare eidem consortio et congregationi |aliquid ex aliquo testamento seu volun-tate alicuius defoncti, possit cogi per po-testatem comunis Pergami, qui modo estvel pro temporibus erit, et per eius iudi-ces seu per aliquem | eorum sumarie etextra ordinem et sine poreccione ali-cuius libelli seu petitionis (b) ad solven-dum et satisfaciendum, realiter et perso-naliter, totum illud quod relictum est vel| erit ipsi congregacioni usque ad quanti-tatem solidorum quinquaginta imperia-lium, pro quolibet testamento vel legato
In nomine Domini amen. Die veneristerciodecimo exeunte marcio, millesimoducentesimo octuagesimo octavo, indic-tione prima. In palacio comunis Perga-mi. In publico et generali consilio comu-nis Pergami, | more solito convocato etcongregato campanis et voce preco-nium, nobilis vir dominus Girardus deTacull(is) de Regio, potestas comunisPergami, proposuit in ipso consilio et abillis de ipso consilio | petiit sibi pro co-muni Pergami consilium exiberi superinfrascriptis, videlicet cum per multos etvarios homines et personas sit relictumin suis ultimis voluntatibus consortiocongregationis | Misericordie dominesancte Marie de Pergamo in multis etvariis quantitatibus denariorum et pec-cunie (a) et rerum, sic quod multe perso-ne civitatis et virtutis Pergami, que de-bent et tenentur dare | ipsi consorciocongregationis multa legata seu iudice-ria in variis quantitatibus, detractant etnolunt ipsa legata seu iudiceria dare necsolvere ipsi congregationi | sine lite etcontroversia; et oporteat ipsam congre-gationem facere in multis ex ipsis legatisconsequendis (b) et exigendis (c) mayoresexpensas quam ipsa legata essent seuiudiceria. | Si placet et volunt illi de con-silio quod omnes illi, qui debent vel de-bebunt dare eidem consortio et congre-gationi aliquid ex aliquo testamento seuvoluntate alicuius defuncti, | possit cogiper potestatem comunis Pergami, quimodo est vel pro temporibus erit, et pereius iudices seu per aliquem eorum su-marie et extra ordinem et sine poreccio-ne alicuius libelli | seu petitionis ad sol-vendum et satisfaciendum, realiter etpersonaliter, totum illud quod relictumest vel erit ipsi congregationi usque adquantitatem solidorum quinquaginta im-perialium, pro | quolibet testamento vel
74
G. Cossandi
vel quid aliud volunt debere fieri in pre-dictis et circa predicta et | eorum occa-sione. Et quod predicta habeant locumtam tempore futurorum rectorum comu-nis Pergami quam huius presentis recto-ris, et predicta requiruntur per mini-strum et canevarios et alios | bonos ho-mines ipsius consorti Misericordie debe-re fieri et ordinari pro comuni Pergami,pro bono et utilitate pauperum civitatiset virtutis Pergami et ad hoc ut Deus def-fendat | comune Pergami ab omni mallo(c) pericullo et ipsum comune in perpe-tua pace et concordia manuteneat.
Quibus lectis et propositis in ipsoconsilio, dominus Iacobus de Zoppo an-zianus populi Pergamensis, pro se et so-ciis suis anzianis, consuluit quod ita fiatet firmetur et servetur et in totum | su-per preposicionem illorum de Misericor-dia, ut in ipsa preposicione continetur,et hoc consuluit pro evidenti voluntatecomunis Pergami aprobata per omnesanzianos populi Pergamensis proope[re] | Misericordie in concordio.
Dominus Zillius de Credario consulitquod fiat (d) et firmitur per presens con-silium pro comuni Pergami et serveturin totum in omnibus et per omnia superfacto preposictionis facte (e) | ocasione il-lorum de consorcio Misericordie, ut inipsa preposicione continetur; et quodquilibet qui se posuerit in lite cum (f)
predictis de ipso consorcio, ocasione eo-rum vel alicuius eorum que | in ipsa pre-positione continentur, si in ipsa lite sub-cumbuerit, conde(m)pnetur in omnibusexpensis restituendis illis de ipso con-sorcio et quod predicta et quodlibet (g) |predictorum locum et vim habeant de-cretorum et servet(ur) per quoslibet rec-tores et offitiales comunis Pergami dehinc ad vigintiquinque annos proximosvenientes; et interim de omnibus supra-scriptis iudiceriis | et legatis ipsi Miseri-cordie factis et faciendis teneatur ille iu-dex sub quo ventilabitur questio eius to-tius quod asenderet ultra solidos quin-quanginta imperialium definitivam sen-tentiam dare | super ipsa questione infra
legato vel quid aliud volunt debere fieriin predictis et circa predicta et eorumoccasione. Et quod predicta habeant lo-cum tam tempore futurorum | rectorumcomunis Pergami quam huius presentisrectoris, et predicta requiruntur per mi-nistrum et canevarios et alios bonos ho-mines ipsius consorti Misericordie debe-re fieri et ordi|nari pro comuni Pergami,pro bono et utilitate pauperum civitatiset virtutis Pergami et ad hoc ut Deusdeffendat comune Pergami ab omnimallo pericullo et ipsum comune in per-petua | pace et concordia manuteneat.
Quibus lectis et propositis in ipsoconsilio, dominus Iacobus de Zoppo an-zianus populi Pergamensis, pro se et so-ciis suis anzianis, consuluit quod ita (d)
fiat et firmetur et servetur et in totum |super prepositionem illorum de Miseri-cordia, ut in ipsa prepositione contine-tur, et hoc consuluit pro evidenti volun-tate comunis Pergami aprobata per om-nes anzianos populi Pergamensis proopere Misericor|die in concordio.
Dominus Zillius de Credario consulitquod fiat et firmitur per presens consi-lium pro comuni Pergami et servetur intotum in omnibus et per omnia superfacto preposictionis facte ocasione | illo-rum de consorcio Misericordie, ut in ip-sa prepositione continetur; et quod qui-libet qui se posuerit in lite cum predictisde ipso consorcio, ocasione eorum velalicuius eorum que in ipsa | prepositionecontinentur, si in ipsa lite subcumbuerit,conde(m)pnetur in omnibus expensis re-stituendis illis de ipso consortio et quodpredicta et quodlibet predictorum locumet vim | habeant decretorum et ser-vet(ur) per quoslibet rectores et offitialescomunis Pergami de hinc ad vigintiquin-que annos proximos venientes; et inte-rim de omnibus suprascriptis iudiceriiset legatis | ipsi Misericordie factis et fa-ciendis teneatur ille iudex sub quo venti-labitur (e) questio eius totius quod asen-deret ultra solidos quinquanginta impe-rialium definitivam sententiam dare |super ipsa questione infra sex menses
75
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
sex menses proximos venientes, ex quolis fuerit iniciata super ipsa questione, etconde(m)pnare similiter teneatur in ex-pensis restituendis ipsi consorcio | illumvel illos qui subcumbuerint in ipsa que-stione vel lite.
Dominus Azuellus de Azuellis consu-luit quod in qualibet causa que agitabi-tur ocasione predictorum legatorum subquocumque iudice vindicet sibi locumlex pro parandum, | videlicet quod vic-tus victori condempn(atus) in expensisarbitrio iudicantis et hoc, quod fiet inhoc consilio super predicta prepositioneMisericordie et eius ocasione, habeanturet | sint pro decreto comunis Pergami,de hinc ad quinquaginta annos proxi-mos venientes pro comuni Pergami, ethabeant locum tempore presentis recto-ris comunis Pergami et futurorum recto-rum usque ad ipsum | terminum.
§ Unde reformato consilio et factis etrevolutis bis partitis, secundum modumet formam statuti comunis Pergami, pla-cuit omnibus quod ita fiat et firmetur etservetur | in totum super prepositionefacta ocasione Misericordie in omnibuset per omnia, ut petitum et requisitumest super ea et ut in ipsa prepositioneplenius continentur.
Item placuit omnibus quod hec lo-cum habeant et vim decretorum et va-leant et teneant tam tempore presentisrectoris quam tempore futurorum recto-rum sic(ut) in prepositione continetur.
Item placuit quasi omnibus quod, sialiquis posuerit se in lite cum illis de ip-sa Misericordia et consorcio pro aliquoiudicerio seu legato quod excedatquan[titat]em solidorum | quinquagintaimperialium, quod ipse potestas et iudexsub quo ipsa causa ventilabitur, teneaturet debeat ipsam causam sentencialiterdefinere infra sex menses ex quo lisin|iciata erit, ut consuluit dominus Zil-lius de Credario.
Item placuit quasi omnibus quodcondempnentur in expensis illi qui sub-cumbuerint illis de ipsa Misericordia, utconsuluit suprascriptus domunis Zillius.
proximos venientes, ex quo lis fuerit ini-ciata super ipsa questione, et con-de(m)pnare similiter teneatur in expen-sis restituendis ipsi | consorcio illum velillos qui subcumbuerint in ipsa questio-ne vel lite.
Dominus Azuellus de Azuellis consu-luit quod in qualibet causa que agitabi-tur ocasione predictorum legatorum subquocumque iudice vindicet sibi locumlex | pro parandum, videlicet quod vic-tus victori condempn(atus) in expensisarbitrio iudicantis et hoc, quod fiet inhoc consilio super predicta prepositioneMisericordie et eius | ocasione, habean-tur et sint pro decreto comunis Pergami,de hinc ad quinquaginta annos proxi-mos venientes pro comuni Pergami, ethabeant locum tempore presentis recto-ris comunis Pergami et | futurorum rec-torum usque ad ipsum terminum.
§ Unde reformato consilio et factis etrevolutis bis partitis, secundum modumet formam statuti comunis Pergami, pla-cuit omnibus quod ita fiat et firmetur et |in totum super prepositione facta oca-sione Misericordie in omnibus et peromnia, ut petitum et requisitum est su-per ea et ut in ipsa prepositione pleniuscontinentur.
Item placuit omnibus quod hec lo-cum habeant et vim decretorum et va-leant et teneant tam tempore presentisrectoris quam tempore futurorum recto-rum | sic(ut) in prepositione continetur.
Item placuit quasi omnibus quod, sialiquis posuerit se in lite cum illis de ip-sa Misericordia et consorcio pro aliquoiudicerio seu legato quod excedat |quantitatem solidorum quinquaginta im-perialium, quod ipse potestas et iudexsub quo ipsa causa ventilabitur, teneaturet debeat ipsam causam sentencialiterdefinire in|fra sex menses ex quo lisin|iciata erit, ut consuluit dominus Zil-lius de Credario.
Item placuit quasi omnibus quodcondempnentur in expensis illi qui sub-cumbuerint illis de ipsa Misericordia, utconsuluit suprascriptus domunis Zillius.
76
G. Cossandi
Item placuit omnibus de predicta re-formata ocasione Misericordie locum etvim habeant et locum et vim obtineantdecretorum, usque ad quinquaginta an-nos proximos venientes, | et habeant lo-cum tempore presentis rectoris et futu-rorum rectorum comunis Pergami us-que ad ipsum terminum.
Lecte fuerunt suprascripte reforma-tiones in suprascripto consilio ante se-paracionem ipsius consilii per infra-scriptum Iohannem de la Costa nota-rium potestatis et comunis Pergami su-prascripto die et anno.
+ Ego Iohannes de la Costa notariustunc potestatis comunis Pergami interfuiet ad confirmandum me subscripsi.
(SN) Ego Bergaminus de Marchesisnotarius et missus regis rogatus supra-scripti Iohannis notarii scripsi.
(a) Così A.(b) Prima i corr. su e.(c) mallo nell’interlineo con segno di inse-
rimento.(d) Segue et (nota tironiana) s(er)vet(ur)
depennato.(e) Segue i (come pare) depennata.(f) Segue d(e) depennato.(g) Segue eo(rum) i(n) ip(s)a p(re)positione
depennato.
Item placuit omnibus de predicta re-formata ocasione Misericordie locum etvim habeant et locum et vim obtineantdecretorum, usque ad quinquaginta |annos proximos venientes, et habeantlocum tempore presentis rectoris et fu-turorum rectorum comunis Pergami us-que ad ipsum terminum.
Lecte fuerunt suprascripte reforma-tiones in suprascripto consilio ante se-paracionem ipsius consilii per infra-scriptum Iohannem de la Costa nota-rium potestatis et comunis Pergami | su-prascripto die et anno.
+ Ego Iohannes de la Costa notariustunc potestatis comunis Pergami interfuiet ad confirmandum me subscripsi.
(SN) Ego Bergaminus de Marchesisnotarius et missus regis rogatus supra-scripti Iohannis notarii scripsi.
(a) Così A.(b) Prima e corr. da lettera principiata,
come pare.(c) et exige(n)dis nell’interlineo.(d) i- corr. su lettera principiata, come pa-
re.(e) A’ ventalibit(ur)
II(1291 – 1296)
MIA 718 (Primus liber MIE), ff. 189v-272v.
Ricevute relative alla donazione di trecento lire imperiali concessa dal comune diBergamo alla Misericordia, in quote da venticinque lire da effettuarsi ad ogni cam-bio di podestà.
Una mano medievale ha disposto lungo il bordo destro dei fogli del Primus Liber una seriedi indicatori (a forma di testa di cane?), con il trasparente significato di segnalare le annotazio-ni riguardanti i versamenti effettuati dal comune.
Le annotazioni, registrate nel Liber dalla mano del notaio Bergaminus de Marchisis, notaiodi fiducia del Consorzio della Misericordia dal 1274 al 1296, si riferiscono alla decisione presadal consiglio del comune di Bergamo, il cui instrumentum era conservato nell’archivio dellaMisericordia (BCBg, Archivio Mia, n. 937. f. 19v).
Tra parentesi si segnala la corrispondenza di tali registrazioni con il Receptum per canepa-rios (BCBg, Archivio Mia, n. 724).
<1291> Item recepit libras viginti quinque imperiales a domino Bonefacio de Gre-deniano, canevario comunis Pergami, nomine comunis Pergami, et de denariis ipsiuscomunis ex illis libris trecentis suprascripto consorcio per plures annos et terminosconstitutis pro comunis Pergami, ut continetur in quodam consilio generali comunisPergami scripto per Bonaventuram de Lixana, notarium potestatis et comunis Perga-mi, die octavo intrante octubre proximo preterito (f. 189v; Receptum, f. 48v).
<1292> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a Iacopo Botti, canivario co-munis Pergami, nomine et vice comunis Pergami, et denariis comunis Pergami ex illistrecentis libris imperialibus suprascripto consorcio per plures annos et terminos con-stitutis pro comuni Pergami, ut continetur in quodam consilio generali comunis Per-gami scriptum per Bonaventuram de Lixana, notarium potestatis et comunis Perga-mi, die octavo intrante octubre proximo preterito; et ut in dispendiis suprascripti do-mini iacet scripto per Quintavallum Gueriene notarium, die tercio intrante hoc pre-sente mense aprile, et de solucione quarum librarum viginti quinque imperialium Pa-xinus Iohannis Boseri notarius fecit cartam ipso die (f. 193r; Receptum, f. 53v).
<1292> Item dedit et expensit libras vigintiquinque et solidos duos et denariosduos et medium (a) imperialium in somis vigintisex et sextariis quinque furmentiempti ipso precio per canevarios suprascripti consorci, quod furmentum est in gra-nario suprascripti consorci quod furmentum fuit emptum ex illis et de illis libris vi-gintiquinque imperialibus quas suprascripti canevarii et minister suprascripti con-sorci receperunt a magistro Bonaventure de Lascasa, canevario comunis Pergami,de denariis ipsius comunis ex illis libris trecentis imperialibus constitutis supra-scripto consorcio pro comuni Pergami per plures annos et terminos, ut in receptosuprascripti Alberti de Prato canevario continetur (f. 203r).
<1292> Item receperunt libras vigintiquinque imperiales a domino magistro Bo-naventura de la Scalla, canevario comunis Pergami, de denariis ipsius comunis ex il-lis libris trecentis imperialibus constitutis suprascripto consorcio per plures annos etterminos pro comuni Pergami pro elemosinis pauperibus, prout continetur in quo-dam consilio generali comunis Pergami scripto per Bonaventuram de Lixana, nota-rium potestatis et comunis Pergami, die octavo intrante octobre M.CC.nonagesimoprimo, ut in dispendio ipsius magistri Bonaventure scripto per Detesalvum de Sola-rio, notarium potestatis et comunis Pergami, die octavo exeunte dicembreM.CC.nonagesimo secundo; et que suprascripte libre .XXV. imperiales date et solutefuerunt per suprascriptum magistrum Bonaventuram suprascripto Alberico de
77
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
Brembate ministro et Alberto canevario suprascrpti consorci, prout in dispendio ip-sius magisteri Bonaventure plenius continetur (Receptum, f. 54r)
<1293> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a domino Gualterio de Bur-co, canevario comunis Pergami, et de denariis ipsius comunis et nomine et vice ipsiuscomunis et pro ipso comuni ex illis libris trecentis imperialibus constitutis suprascrip-to consorcio per plures annos et (b) terminos per suprascriptum comune Pergami proelimosinis faciendis, quas libras .XXV. imperiales suprascriptum consorcium et (c) Mi-sericordia habere debebant a suprascripto comuni pro isto medio anno regiminis do-mini Maffei Curini de Veneçiis, potestatis comunis Pergami, pro ipsa elemosina fa-cienda; et de solucione quorum denariorum suprascriptus Iohannes de Redona mini-ster et suprascripti Bartolameus de Crevascho et ser Albertus (d) de Foro (e) et Guide-bonus, qui dicitur Marazzius, canevarii suprascripti consorci Misericordie, nomine etvice ipsius consorci et Misericordie, fecerunt confessionem solucionis, prout (f) conti-netur in carta rogata per Iohannem domini Lanfranci de la Ripa notarium, die .XI. in-trante hoc presente mense marcio (f. 208v; Receptum, f. 55r).
<1293> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a Guilielmo, qui dicitur Cer-mus, canevario comunis Pergami, et de denariis ipsius comunis, nomine et vice ip-sius comunis et pro ipso comuni, ex illis libris trecentis imperialibus constitutis ipsiconsorcio Misericordie per plures annos et terminos per suprascriptum comune Per-gami pro elimosinis faciendis, quas libras vigintiquinque imperiales suprascriptumconsorcium et ipsi de Misericordia habere debebant a suprascripto comuni Pergamipro isto medio anno regiminis domini Iohannis de Sancto Vitali de Parma, potestatiscomunis Pergami, pro ipsa elemosina facienda; et de solucione quorum denariorumsuprascripti domini Iohannes (g) minister et Bartolameus de Crevascho, canevariusgeneralis, et ser Albertus de Foro et Iacobus ser Petri de la Fontana et Guidebonus,qui dicitur Marazzus, canevarii suprascripti consorci Misericordie, nomine et vicesuprascripti consorci, fecerunt confessionem solucionis, prout continetur in carta ro-gata per me Bergaminum de Marchisis notarium, die callende septembris .M°.CC°.nonagesimo tercio, indictione sexta (f. 212r; Receptum, f. 56v).
<1294> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a Zoanno domini Oberti deRoxiate, canevario comunis Pergami, de denariis ipsius comunis Pergami, nomineipsius comunis et pro ipso comuni (h), ex illis libris trecentis imperialibus constitutissuprascripto consorcio per comune Pergami per plures annos pro elimosinis facien-dis, quas libras .XXV. suprascriptum consorcium et ipsi de Misericordia habere de-bebant a suprascripto comuni pro isto medio anno regiminis domini Frederici Pon-zenium de Cremona, potestatis comunis Pergami, pro ipsa elemosina facienda; et desolutione quorum denariorum omnes suprascripti canevarii, nomine et vice supra-scripti consorci (i), fecerunt confessionem solucionis, prout continetur in carta rogataper Antonium de Bamatis notarium, die mercuri .XIIIIor. intrante aprile .M°.CC°.nonagesimo quarto (ff. 228v-229r; Receptum, f. 58v).
<1294> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a domino Guilielmo de Ali-prandis, civis Pergami, canevario comunis Pergami, nomine et vice comunis Perga-mi et pro ipso comuni, de denariis comunis Pergami ex illis et de illis libris trecentisimperialibus constitutis suprascripto consorcio per comune Pergami per (j) pluresannos pro elimosinis pauperibus civitatis et virtutis Pergami faciendis, quas librasvigintiquinque imperiales suprascriptum consorcium et ipsi de Misericordia haberedebebant a suprascripto comuni pro isto medio anno regiminis domini Bandini Fol-chaneri (k) de Florencia, potestatis comunis Pergami, pro ipsa elemosina facienda (f.233r; Receptum, f. 59v).
<1295> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a Raymondo de Capitaneisiudice, canevario comunis Pergami, nomine et vice comunis Pergami et pro ipso co-
78
G. Cossandi
muni, de propriis denariis comunis Pergami ex illis libris trecentis imperialibus con-stitutis suprascripto consorcio per comune Pergami per plures annos pro elimosinispauperibus civitatis et virtutis Pergami faciendis, quas libras vigintiquinque imperia-les suprascriptum consorcium et ipsi de Misericordia habere debebant a suprascrip-to comuni pro isto medio anno regiminis domini Ungeruçi de Ottis de Perusio, pote-statis comunis Pergami, pro ipsa elemosina facienda; et de solucione quorum dena-riorum omnes suprascripti domini minister et canevarii, nomine et vice suprascripticonsorci, fecerunt confessionem solucionis per cartam rogatam per Guidotum deCurteregia notarium, die (l) (f. 250v; Receptum, f. 61v).
<1295> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a domino Armano de Nico-lis, canevario comunis Pergami, nomine et vice comunis Pergami et pro ipso comu-ni, et de propriis denariis ipsius comunis ex illis libris trecentis imperialibus consti-tutis suprascripto consorcio per comune Pergami per plures annos pro elimosinis fa-ciendis pauperibus civitatis et virtutis Pergami, quas libras .XXV. imperiales ipsi desuprascripto consorcio Misericordie habere debebant a suprascripto comuni pro istomedio anno regiminis domini Nuci de Galfuris **** de Castella, potestatis comunisPergami, pro ipsa elemosina facienda (m); de solutione quorum denariorum fecit car-tam attestatam Henricus Fare Bordonis notarius, die septimo intrante septembresuprascripto anno (f. 253v; Receptum, f. 62r).
<1296> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a domino Petro Lorenzo-num de Vertoa, civis Pergami, canevario comunis Pergami, nomine comunis Perga-mi, et de propriis denariis ipsius comunis, ex illis libris trecentis imperialibus consti-tutis suprascripto consorcio per comune Pergami per plures annos pro elimosinis fa-ciendis pauperibus civitatis et virtutis Pergami, quas libras vigintiquinque imperialesipsi de ipso consorcio habere debebant a suprascripto comuni per isto medio annoregiminis domini [Crevi] de Bonetariis de Bononia, potestatis comunis Pergami; etde solutione quorum denariorum Henricus Terzeno notarius fecit cartam attestatam,die septimo exeunte febrario suprascripto anno (f. 267r; Receptum, f. 63v).
<1296> Item recepit libras vigintiquinque imperiales a domino Bonaventura deGavaçio, canevario comunis Pergami, nomine comunis Pergami, et de propriis dena-riis ipsius comunis ex illis libris trecentis imperialibus, constitutis suprascripto con-sorcio pro comuni Pergami per plures annos, pro elimosinis faciendis pauperibus ci-vitatis et virtutis Pergami, quas suprascriptas libras vigintiquinque imperiales illi desuprascripto consorcio habere debebant a suprascripto comuni pro ultimo medioanno (n) proximo preterito currente .M°CC°. nonagesimo sexto, indictione nona, tem-pore regiminis seu pothesterie | domini Supermantis de Amatis de Cremona, pote-statis comunis Pergami (f. 272v; Receptum, f. 64v).
(a) m- corr. su altra lettera, come pare.(b) Segue an(n)os depennato.(c) Si sottintenda ipsi de(d) A- ripassata con inchiostro più scuro.(e) Su -ro segno abbr. depennato.(f) Segue p(ro) depennato.(g) Ioh(ann)es nell’interlineo.(h) Segue d(e) depennato.(i) c(on)sorci nell’interlineo.(j) Segue co(mun)e depennato.(k) -a- corr. su altra lettera, come pare.(l) Così, senza indicazione della data.(m) fac(ienda) nell’interlineo.(n) Segue m principiata depennata.
79
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
IIIPROTESTATIO
1300 luglio 13, Bergamo.
Yroldo de Cumis, notaio del comune di Bergamo e canevario generale del Con-sorzio della Misericordia, su richiesta di Giovanni de Ulivenis, ministro del Consor-zio, dichiara di aver preso in carico tutto il denaro registrato dal notaio Pietro Adob-bi nei quaderni contabili del Consorzio.
Originale, BCBg, Fondo pergamene, n. 6868 [A]. Nel verso, di mano del sec. XIV: “Protesta-tio facta per Yroldum de Cumis canevarium generalem Consorcii | quondam .CCC°. de supra-scriptis denariis is habebat pene se qui erant Consorcii”; segnatura novecentesca a matita:“Collezione di pergamene 6868”.
La pergamena, complessivamente in buono stato di conservazione, presenta un paio dimodeste abrasioni lungo il margine sinistro – in particolare in corrispondenza delle righe dallaventicinque alla ventisette –, un piccolo foro provocato da rosicature nel quarto superiore equalche macchia di umidità.
Nell’escatocollo non compare la sottoscrizione del notaio Pietro Adobbi, per la quale pareessere stato predisposto l’apposito spazio.
In nomine Domini amen. Yroldus de Cumis, notarius civitatis Pergami, caneva-rius generalis consorcii Misericordie domine | sancte Marie Pergamensis, dixit etprotestatus fuit solempni confessione in hoc publico instrumento | redacta ad postu-lacionem domini Iohannis de Ulivenis, ministri suprascripti consorcii postulantis etrecipientis nomine et vice ipsius consorcii | et pro ipso consorcio, quod ipse Yroldusrecepivit pro ipso consorcio omnes illos denarios et omnes illas res et | omne id to-tum quod et qui et que scripti sunt, manu infrascripti Petri notarii et eciam manu |Bertrami de Casteneta notarii, hoc anno presenti, super quaternis dicti consorcii, se-cundum et eo modo ut | scriptum in ipsis quaternis ipsius consorcii receptum, etquod expensatum est de ipsis denariis pro ipso | consorcio omne id quod totumquod continetur in quaternis dispen(dium) ipsius Yroldi, scriptis per infrascriptum |Petrum notarium et per suprascriptum Bertramum notarium, et quod penes eumerant et esse debebantur | libre trecente undecim et solidi quatuordecim et denariundecim imperialium de denariis suprascripti consorcii, | proventis ad manus ipsiusYroldi et ad huc sunt et esse debent penes eum, secundum | formam scripture facteper infrascriptum Petrum Bartolamey Adobbi notarium, die dominico decimo | in-trante hoc presente mense iullio; de quibus postea expen(savit) libras decem otto etsolidos tredecim | et denarios quatuor imperialium, qui dati fuerunt pro ipso consor-cio in somis decem sallis ab ipsa racione | facta suprascripto die dominico (a) decimointrante (b) iullio citra. Et omnes ille res mobilles que | fuerunt de hereditate dominiBonaventure, filii quondam domini (c) Martini de Cerro de Butanucho, | cui dicebaturBonaventura de Mapello, seu precium earum si vendite sunt alique ex eis | et queconsignate fuerunt ipsi domino Yroldo canevario dicto nomine per Albertum, filium |quondam ser Iohannis de Prato de Brembate civitatis Pergami, quondam caneva-rium suprascripti consorcii, per cartam 1 | illius consignationis rogatam per infra-scriptum Petrum Adobbi notarium die ******** proximo preterito. De | quibus omni-bus denariis sunt et esse debent libre ducent(e) tregintaquinque et solidi decem sep-tem | et denarios octo (d) duo imperialium penes Columbum domini Filippi de Mapel-lo et fratres eius et | libre viginti imperiales penes fratres domus humilliatorum queapellatur domus comunis, | et quod omnes suprascripti denarii sunt proprii supra-
80
G. Cossandi
scripti consorcii et non suprascripti Yroldi, non obstante quod | [sunt] scripti nomineipsius domini Yroldi. Et quod libre treginta septem et solidi quatuor | [et dena]riiquinque imperialium [...] sunt penes ipsum Yroldum de predictis denariis per eum |receptis et ultra suprascriptas duas quantitates denariorum que sunt penes supra-scriptum Columbum et | fratres eius et suprascriptos fratres domus comunis, quaresuprascriptus dominus Yroldus convenit et | per stipulacionem promissit, obligandoomnia sua bona pignori et sub pena omnis dampni, dispendi | et interesse. Et postpenam c(on)positam de sic atendere (e) et observare suprascripto domino Iohanni, |dicto nomine recipiente, dandi et solvendi et restituendi eidem consorcio seu cane-varis | ipsius consorcii pro ipso consorcio suprascriptas libras treginta septem et so-lidos quatuor et denarios | quinque imperialium que sunt penes eum et omnes illasres que consignate fuerunt per suprascriptum | Albertum, quondam canevarium su-prascripti consorcii, suprascripto Yroldo, suprascripto nomine recipiente, seu pre-cium | et valenciam earum de quibus sit mencio in suprascripta carta designationisrogata per in|frascriptum Petrum Bartolamey Adobbi notarium. Protestando et di-cendo eciam | ipse Yroldus ad postulacionem suprascripti domini Iohannis, dicto no-mine postulantis, quod est de | eius bona voluntate (f) quod omnes denarii qui suntpenes suprascriptos Columbum | et fratres eius et penes suprascriptos fratres domuscomunis dentur et designantur per | ipsos fratres de Mapello et fratres domus comu-nis suprascripto domino Iohanni, dicto nomine | recipiente, et canevaris suprascripticonsorcii tanquam (g) denari qui sunt ipsius consorcii tantum et (h) | sic fuerunt con-tenti et confessi, et renonciando exceptione non ei habitorum aput se omnium su-prascriptorum et | cuiusque (i) eorum et omni alii iuri et legi, accioni et racioni qui-bus se dicto nomine de hoc tueri possent. | Actum die terciodecimo intrante iulliomillesimo trecentesimo, indic(tione) terciadecima. In civitate | Pergami, in vic(inea)sancti Cassiani, in domo hab(itationis) suprascripti Yroldi. Testes ibi fuerunt: Alber-tus domini | Aydini (j) de (k) Nocia (l) et Guilielmus Bonummi Bergonzii notarius etBertramus qui dicitur Presbiter | de Carabellis de Stabullo piliparius civitatis Perga-mi.
(SN) Ego Rogerius Petri de Sancto Gervasio notarius rogatus suprascripti Petrinotarii scripsi.
(a) -m- corr. su lettera principiata, come pare.(b) -t- corr. su r(c) -in- corr. su m(d) A octto, con prima t espunta.(e) Così A.(f) v- corr. da c.(g) Così A.(h) Segue all’inizio del rigo successivo et erroneamente ripetuto.(i) -i- corr. da altra lettera, come pare.(j) -in- corr. su m.(k) segue Fa(r)ra depennato.(l) -c- corr. su altra lettera, forse t.1 Non si è reperito il doc. relativo.
81
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
IV(1295 <aprile 3>)
MIA 718 (Primus liber MIE), f. 260v.
Elenco delle uova — in numero di 210 soldate e mezza — distribuite da GiovanniPizenni, canevario del Consorzio della Misericordia, nel giorno di Pasqua del 1295.
L’elenco si trova al f. 260v del Primus liber MIE, scritto di mano del notaio Bergaminus deMarchisis, fa riferimento alla distribuzione effettuata il 3 aprile del 1295. La parte conclusivadell’elenco – “Et residuum […] et medium” – è disposta in una seconda colonna a destra, piùper volontà di occupare un solo foglio che per un reale disegno formale di impaginazione.
Il passaggio da una colonna all’altra è segnalato dalle barre verticali.
Hec sunt ova data et distributa per suprascriptum Iohannem Pizenni canevariumet socios eius et que ipse (a) Iohannes recepit ad suprascriptam Pasce maioris et queova fuerunt numero soldat(arum) ducentum decem (b) et medium ut in recepto ipsiusIohannis canevarii continetur.
§ In primis enim dedit pauperibus vicinee Burgi Canallis et sancte Grathe de in-ter vites soldatas quatuordecim.
Et pauperibus vicinee sanctorum Salvatoris et Iohannis Evangeliste et de Ante-scolis soldatas septem et medium.
Et pauperibus et infirmis vicinee de Arena soldatas quatuor et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancte Agathe soldatas tres et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Maffei soldatas quatuor et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Mich(aelis) de Archu soldatas quatuor.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Laurencii soldatas octo et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Pancraci soldatas sex.Et pauperibus et infirmis vicinee sancte Euffemie soldatas sex et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Andree soldatas sex et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Mich(aelis) de Puteo Albo soldatas decem
et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Alexandri de la Cruce soldatas tredecim
et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Iohannis de hospitali soldatas duodecim
(c) et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Antoni soldatas sex et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Alexandri in Columpna et sancti Leonar-
di soldatas (d) tredecim.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Stephani soldatas decem et medium.Et pauperibus et infirmis vicinee (e) sancti Iacobi de la Porta soldatas sex.Et pauperibus et infirmis vicinee sancti Casiani soldatas tres et medium.§ Et fratribus Predicatoribus soldatas septem.Et fratribus Minoribus soldatas sex.Et fratribus Remitanis soldatas quinque.Et remitis de sancto Pantaleono et de la Zera soldatas sex.Et remitto sancti Salvatoris duas soldatas.Et remito (f) de Calva duas soldatas.
82
G. Cossandi
Et remittis de Morengo soldatas quatuor. ||Et residuum ipsorum ovorum postea dati et distributi fuerunt pluribus infirmis et
egenis per canevarios suprascripti consorci et que omnia ova fuerunt soldat(arum)(g) .CC. decem et medium.
(a) -e in parte coperta da macchia.(b) -e- corr. da altra lettera, forse c (come pare).(c) -c- corr. da altra lettera, come pare.(d) Segue soldat(as) erroneamente ripetuto.(e) -c- corr. da altra lettera, forse e (come pare).(f) Così A.(g) Si sottintenda numero
83
Fermenti religiosi e spinte istituzionali a Bergamo tra XIII e XIV secolo
V(1293 <marzo 29>)
MIA 718 (Primus liber MIE), ff. 209v-210r.
Elenco dei flandoni, delle uova, dei pani e dei denari raccolti da Bartolomeo deCrevasco, canevario del Consorzio della Misericordia, nel giorno di Pasqua del 1293.
L’elenco si trova ai ff. 209v-210r del Primus liber MIE, scritto di mano del notaio Bergami-nus de Marchisis, fa riferimento alla raccolta avvenuta in data 20 marzo 1293. Il passaggio dauna pagina alla successiva è segnalato dalle barre verticali.
In nomine Domini amen. Isti sunt flandoni, panes et ova et denarii recepti perBartolameum de Crevasco canevarium ad festum Pasce Mayoris ut inferius continetur.
In primis enim recepit a vicinis vicinee sancti Mich(aelis) de Archu flandonos vi-ginti octo et ova .XVIII. et denarios sex imperiales.
Item recepit a vicinis vicinee de Arena flandonos .LII. et ova .XII.Item recepit a vicinis vicinee sancti Stephani flandonos nonaginta et soldatos .VI.
ovorum et duos (a) panes.Item recepit a vicinis vicinee sancti Iohannis de hospitali flandonos .CXXVI. et
unam fugazinam.Item recepit a vicinis vicinee sancti Antoni flandonos .XLVII.Item recepit a vicinis vicinee sancte Euffemie flandonos .LVI.Item recepit a vicinis vicinee sanctorum Alexandri in Columpna (b) et Leonardi
flandonos .CXVI. et panes .XLI. et soldatos .LXV. ovorum.Item recepit a vicinis vicinee sancte Agathe flandonos .XXVIIIIor.Item recepit a vicinis vicinee sanctorum Salvatoris et Iohannis Evangeliste et de
Antescollis flandonos (c) .LXXXVIII. et soldatos .IIIIor. ovorum et denarios quinqueimperiales.
Item recepit a vicinis vicinee sancti Iacobi de la Porta flandonos .XLV. et soldatos.VI. et medium ovorum et panes tres.
Item recepit a vicinis vicinee sancti Pancraci flandonos .LXXXVIII. et panes .VII.et soldatos .XV. et medium ovorum et denarios duos imperiales.
Item recepit a vicinis vicinee sancti Alexandri de la Cruce flandonos .CIIIIor. etdenarios duos et unum panem et soldatos duos ovorum.
Item recepit a vicinis vicinee sancti Laurenci flandonos .LVIII. et unum panem etsoldatos .XIIIIor. ovorum.
Item recepit a vicinis vicinee sancti Mich(aelis) de Puteo Albo flandonos .XLV. etsoldatos .XXVI. ovorum (d).
Item recepit a vicinis vicinee sancti Maffei flandonos .XXXV. et panes .V. et.XIIIIor. ovos.
Item recepit a vicinis vicinee Burgi Canalis et sancte Grathe de Inter Vites flando-nos .LXVIII. et soldatos .XVIII. ovorum et panes duos et denarios .IIIIor. imperiales.
Item recepit a vicinis (e) vicinee sancti Andree flandonos .LXVIII. et panes .XIII.et denarium .I. ||
Somma sommarum omnium suprascriptorum flandonum receptorum ad omnibussuprascriptis vicineis est et asendit in .MCLXXXXIII. et somma ovorum est sol da -t(orum) .CLXXI. et somma panis est .C. panes et somma den(ariorum) est solidos duos.
(a) -u- corr. su altra lettera, forse r (come pare).(b) A Colup(n)a.(c) A fla.(d) o- corr. su altre lettere, come pare.(e) Segue s(an)c(t)i depennato.
84
G. Cossandi