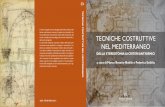La versione di Beda (il Venerabile). MEDIOEVO, n. 187 (agosto 2012), pp. 42-51 (draft)
F. Miraglia, Atlante delle tecniche costruttive di Terra di Lavoro. Murature in tufo grigio...
Transcript of F. Miraglia, Atlante delle tecniche costruttive di Terra di Lavoro. Murature in tufo grigio...
FRANCESCO MIRAGLIA
ATLANTE DELLE TECNICHE
COSTRUTTIVE DI TERRA DI LAVORO
MURATURE IN TUFO GRIGIO (XIII-XV)
agro Falerno, litorale domizio, area del monte Maggiore
Prefazione di
GIUSEPPE FIENGO
ARMANDO CARAMANICA EDITORE
FRANCESCO MIRAGLIA
ATLANTE DELLE TECNICHE
COSTRUTTIVE DI TERRA DI LAVORO
MURATURE IN TUFO GRIGIO (XIII-XV)
agro Falerno, litorale domizio, area del monte Maggiore
Prefazione di GIUSEPPE FIENGO
ARMANDO CARAMANICA EDITORE
Prima edizione: dicembre 2012
Progetto grafico: Antonietta Manco
In copertina: Carinola (CE), castello, evidenze stratigrafiche.
Copyright © ARMANDO CARAMANICA EDITORE
Via Appia, 762 - 04020 Marina di Minturno (LT) - Tel. e Fax 0771.680838
www.caramanicaeditore.it
ISBN 978-88-7425-110-0
Le foto e le tavole, se non diversamente indicato, sono dell’Autore.È vietata la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,anche ad uso interno e didattico, non autorizzata.
Indice
PREFAzIONE p. 7
NOTA INTRODUTTIVA p. 9Criteri metodologici p. 10Esiti della ricerca p. 12Note p. 14
INqUADRAMENTO TERRITORIALE p. 17Lineamenti geolitologici p. 17Distretti di studio: Carinola, Sessa Aurunca, p. 19Castel Volturno, Pontelatone e FormicolaNote p. 26
NOTE SULLE TECNIChE COSTRUTTIVE MURARIE TARDO-MEDIEVALI p. 31IN TERRA DI LAVOROContesto operativo p. 33Magisteri murari ricorrenti nei sub-areali di studio p. 35Note p. 41
CASI SIGNIFICATIVI PER LA DIFFUSIONE NEI SUB-AREALI DI STUDIO p. 47DELLE TECNIChE COSTRUTTIVE MURARIE TARDO-MEDIEVALINote p. 66
TECNIChE DI MURO IN TUFO GRIGIO p. 73NEI SUB-AREALI DI STUDIO (xIII-xV)Setti verticali p. 73Cantonali p. 92Aperture arcate p. 97Prospettive di tutela p. 101Note p. 107
BIBLIOGRAFIA p. 119
INDICE DEI NOMI p. 125
INDICE DELLE LOCALITà p. 129
Prefazione
Il presente contributo è il risultato degli studicompiuti da Francesco Miraglia per il consegui-mento, nel 2010, del titolo di dottore di ricercain Conservazione dei beni architettonici, pressola Seconda Università di Napoli. Il suo interessedipende non soltanto dal valore scientifico deirisultati ottenuti, ma anche dalla non trascurabilecircostanza di concorrere alla realizzazionedell’Atlante delle tecniche costruttive tradizionali dellaCampania (XVI-XIX secolo): ambizioso progettodei docenti di Restauro della Facoltà di Archi-tettura aversana, Giuseppe Fiengo e Luigi Guer-riero, finalizzato all’acquisizione di unindispensabile strumento moderno per il rico-noscimento, la salvaguardia ed il restauro del pa-trimonio edilizio storico della regione.
Di quest’ultimo è già edito, nel 2008, con ilcofinanziamento del Ministero dell’Università edella Ricerca Scientifica e Tecnologica e la par-tecipazione di numerosi studiosi, l’Atlante delletecniche costruttive tradizionali. Napoli, Terra di La-voro (XVI-XIX), organizzato in due tomi, rela-tivi a murature, solai, coperture, infissi,ferramenta e pavimenti. Esso è il frutto di unquindicennio circa di attività di ricerca, duranteil quale sono stati pubblicati i noti volumi: Mu-rature tradizionali napoletane. Cronologia dei paramentitra il XVI ed il XIX secolo (1998); Murature an-gioino-aragonesi in Terra di Lavoro (2001), tesi peril Dottorato in Conservazione dei beni architet-tonici di Marina D’Aprile; Atlante delle tecniche co-struttive tradizionali. Lo stato dell’arte, i protocolli dellaricerca. L’indagine documentaria (2003), anch’essocofinanziato dal Ministero di cui sopra.
In definitiva, attraverso il menzionato la-voro, in gran parte svolto nell’ambito dell’attivitàformativa del Dottorato di ricerca in Conserva-zione dei beni architettonici della Facoltà di Ar-chitettura del Secondo Ateneo napoletano, sonostati approfonditi gli aspetti mensiocronologicidelle tecniche costruttive di età moderna, relati-vamente agli areali napoletano e di Terra di La-voro, pervenendo alla definizione degliindicatori, di ordine formale e dimensionale, utiliper la datazione delle varie componenti edilizie.Cosicché, gli operatori locali dispongono di uno
strumento finalizzato ad agevolare l’analisi stra-tigrafica del costruito, a ridurre considerevol-mente la percentuale delle stratificazionisacrificate per difetto di identificazione ed a mo-tivare la salvaguardia delle coralità edilizie di mi-nore interesse artistico.
Ma, tornando alla monografia di Miraglia,rileviamo che il titolo prescelto, Atlante delle tec-niche costruttive di Terra di Lavoro. Murature in tufogrigio (XIII-XV), segnala sia le particolari strut-ture oggetto della ricerca, sia il materiale con cuisono prevalentemente composte, l’ignimbritecampana, e sia l’arco temporale prescelto, rela-tivamente ai sub-areali dell’agro Falerno, del li-torale domizio e dell’area del monte Maggiore.Rispetto al menzionato Atlante di Napoli e Terradi Lavoro, essa si distingue soprattutto per il di-verso arco temporale prescelto, essendo carat-terizzati i suddetti territori dalla presenza dicomuni, quali Sessa Aurunca, Carinola, Ponte-latone e Formicola, che custodiscono un note-vole patrimonio edilizio tardo-medievale,oggetto finora di attenzione limitatamente ainoti episodi maggiori.
D’altra parte, non è quella in causa la primalettura mensiocronologica del costruito storicotardo-medievale della Campania finora prodotta,potendosi annoverare, tra l’altro, oltre ai già se-gnalati contributi a cura di Fiengo e Guerrierodel 1998, sulle Murature tradizionali napoletane intufo giallo, tufo grigio, piperno e laterizio e diD’Aprile del 2001, attinente alle strutture forti-ficate, il volume di Cesare Crova, del 2005, sulletecniche costruttive medievali del Latium adiec-tum e la Terra Laboris, il saggio di Fiengo, in me-rito alle murature in calcare della costa di Amalfi,nell’Atlante del 2008, e quello di Crova, del 2011,in “Napoli nobilissima”, dal titolo: L’arte di co-struire al tempo di Federico II. Cantieri e tecniche co-struttive in Terra di Lavoro.
quanto alla caratterizzazione delle mura-ture dal xIII al xV secolo dei sub-areali di stu-dio, Miraglia segnala che essa non si discostasignificativamente da quella già accertata me-diante i citati lavori concernenti la Terra di La-voro. ha constatato, cioè, l’assoluta prevalenza
7
del magistero “a cantieri” sia nel settore dell’edi-lizia corale, sia nell’ambito degli edifici ecclesia-stici, dei palazzi dell’aristocrazia e dei complessifortificati, come castelli, torri, cinte murarie, etc.,sebbene in questi ultimi si riscontri abbastanzadi frequente anche il ricorso al magistero a filaridi conci. Inoltre, ha registrato il progressivo au-mento, a partire dalla seconda metà del xIII se-colo, dell’altezza dei “cantieri” da 30-35centimetri ai 40-55 del xIV e xV secolo.
Efficace risulta, in particolare, l’illustrazionedelle tecniche costruttive murarie in tufo grigiodi setti verticali, cantonali e aperture arcate me-diante foto e tavole con disegni di dettaglio. Trai più noti esempi da lui selezionati si annoveranostrutture, mai prima documentate, del palazzoPetrucci e del castello di Carinola, del bastionedifensivo della Terra Murata di Mondragone,della torre Marzano e del palazzo Rotondo diPontelatone, della torre di San Biagio di SessaAurunca. Più numerosi sono, naturalmente, gliapparecchi murari dell’edilizia anonima o quasidi Sessa Aurunca, di Carinola e della sua fra-zione di Nocelleto, di Teano e della frazione Pu-gliano, del borgo San Castrese di CastelVolturno, etc.
Il castello di Carinola, in particolare, consi-derato un caso significativo, unitamente a quellidei vicini complessi della cattedrale e dei palazzi
Marzano e Petrucci, ai fini della diffusione neisub-areali di studio delle tecniche costruttivemurarie riscontrate, gli ha offerto l’occasione pereffettuare, innanzitutto e per la prima volta,un’approfondita lettura delle preziose strutturesuperstiti, purtroppo prive di un’adeguata pro-tezione e fatte oggetto di recente di parziali emalintesi restauri. quindi, ne ha registrato incinque tavole gli apparecchi murari e, infine,avendone individuato le stratificazioni presenti,ha proposto un’articolata datazione delle stessein quattro fasi, comprese tra il xIII ed il xV se-colo.
La ricerca compiuta da Miraglia, dunque,fornisce un interessante quadro delle tecnichecostruttive murarie in tufo grigio, in uso neltardo Medioevo in areali finora poco noti pertali aspetti, nonostante il cospicuo interesse delloro patrimonio edilizio. Il risultato è tanto piùapprezzabile se si riflette sul fatto che quest’ul-timo, come egli ha osservato, localmente è «og-getto del disinteresse pubblico e privato»;disinteresse dipendente da tanti noti fattori, nonultimo la scarsa capacità degli operatori del set-tore di saperne individuare, riconoscere e dimo-strare la qualificazione culturale, indispensabilepremessa per la sua conservazione.
GIUSEPPE FIENGO
8
Nota introduttiva
I moderni metodi di studio delle tecniche co-struttive storiche – condotti tenendo nel dovutoconto le complesse sfaccettature geo-territorialie socio-culturali dei contesti analizzati – hannoconsentito l’acquisizione di competenze e datiscientifici di estremo interesse, ai fini della valo-rizzazione delle istanze connesse alla conserva-zione del patrimonio culturale.
Recenti esperienze di ricerca di respiro na-zionale, ben note in letteratura, fornendo i criteriper la definizione cronologica e, quindi, la qua-lificazione delle tecniche costruttive tradizionali(murature in calcare ed in tufo, solai e coperturein legno, infissi, ferramenta, pavimenti e lastriciin battuto di lapillo) nell’area della provincia diNapoli e dell’antica Terra di Lavoro, in una fasestorico-culturale che va dall’età moderna avan-zata (xVI secolo) al xIx secolo, hanno con-corso a creare le premesse affinché si passifinalmente dalla tutela e restauro della «crea-zione architettonica isolata» a quelli dell’«am-biente urbano e paesistico», come auspicatodalla Carta Internazionale del Restauro di Vene-zia.
Affiancando la lettura storico-critica – que-st’ultima tuttora rivolta soprattutto ai manufattidi rilevante valore storico-architettonico – i sud-detti metodi pongono gli operatori tecnici nellacondizione di poter definire l’età di strutture emembrature, prescindendo dalla loro realtà fi-gurale – generalmente assai poco caratterizzata,trattandosi spesso di stratificazioni parziali, fi-nalizzate ad una pratica utilità – per puntare suquella tecnologica.
Ciò riesce particolarmente utile in generalenel caso dell’edilizia storica – ossia della «lette-ratura architettonica», secondo l’efficace acce-zione di Roberto Pane mutuata dall’esteticacrociana – connotata da caratterizzazioni for-mali assai meno spiccate di quelle delle cosid-dette «creazioni isolate», proprio perchéaderente alle necessità della vita quotidiana e piùspesso opera di maestri fabbricatori che di ar-chitetti; condizioni, queste, che rendono proble-matica, per la sola via estetica, la puntualiz-zazione cronologica degli immobili nel loro
complesso, di singole parti degli stessi, delle nu-merose stratificazioni generalmente non solostrutturali, ma anche sotto forma di finiture, cheusualmente li connotano.
In una siffatta ricerca, ponendosi la neces-sità di analizzare sub-areali omogenei dal puntodi vista culturale, l’attenzione è stata limitata allemurature dell’agro Falerno, del litorale domizioe dell’area del monte Maggiore. quanto all’arcotemporale, quello prescelto va dal xIII al xV se-colo (con riferimenti al periodo storico imme-diatamente successivo), nel corso dei quali, entroi menzionati contesti, si affermarono, diffon-dendosi estesamente, un linguaggio edilizio etecniche costruttive tardo-medievali, persistendoed evolvendo sino alla metà circa del Cinque-cento.
Il presente studio analizza gran parte del-l’antico ager Falernus, corrispondente alla fasciaurbana attualmente occupata dal comune di Ca-rinola – esaminando anche i vicini territori diSessa Aurunca e Castel Volturno – e l’area delmonte Maggiore, nello specifico i comuni diPontelatone e Formicola. Il suddetto locus è statoperimetrato tenendo conto dell’origine dei giaci-menti di ignimbrite campana.
questa evidente affinità nella reperibilitàdella risorsa lapidea ed un destino comune in or-dine alle dinamiche di governo politico, fannodei sub-areali individuati un contesto abbastanzaomogeneo dal punto di vista storico-culturale,che ha visto, nel periodo in esame, l’avvicendarsidi due grandi case regnanti, quella angioina equella aragonese.
Le realtà urbane analizzate hanno fattoparte, in varie fasi storiche, degli estesi possedi-menti della famiglia Marzano, che deteneva, tragli altri, un gran numero di feudi in Terra di La-voro, rappresentando, nei secoli a cavallo tra ladominazione angioina e quella aragonese delregno di Napoli, una delle casate più ramificatee potenti1.
Metodologicamente ed operativamente, in-fine, è stato assunto a modello l’imponente la-voro, coordinato da G. Fiengo e L. Guerriero,per gli areali di Napoli e di Terra di Lavoro2.
9
Va osservato, dunque, che un’attenta rico-gnizione delle caratteristiche geolitologiche delterritorio rappresenta una fase imprescindibileper qualsivoglia analisi, che deve anche tenerconto del litotipo dominante, individuandone,per quanto possibile, le antiche cave dismesse oancora attive; circostanza che concorre a com-prenderne le lavorazioni adottate.
Inoltre, alla ricerca in situ va necessaria-mente affiancato l’esame delle fonti documen-tarie e bibliografiche, anche se spesso questeultime sono poco sviluppate3. ha interesse, per-tanto, ricordare come lo studio delle tecnichecostruttive sia proficuo per comprendere nonsolo le caratteristiche strutturali e tipologiche deimanufatti analizzati, ma anche i caratteri storico-architettonici e socio-economici delle realtà ter-ritoriali nelle quali essi sono localizzati4.
Il patrimonio edilizio tardo-medievale, rife-rito non soltanto ai distretti indagati ma all’interaTerra di Lavoro, ha una notevole importanza,per gli originali esiti – soprattutto dal punto divista architettonico – offerti dal contesto cultu-rale che lo ha generato, distanti dalle istanze delclassicismo rinascimentale che si svilupparono,con nota fortuna, a partire dalle esperienze to-scane.
Ragguardevole è pure la sua estensione, contestimonianze rinvenibili soprattutto nei piccolicentri, ancorché generalmente trascurate o se-gnalate, al più, soltanto attraverso lo studio diepisodi immediatamente identificabili o rimar-chevoli, non attribuendo, in tal modo, il giustovalore – e la doverosa tutela – agli innumerevolicasi di edilizia diffusa proprio perché non facil-mente riconoscibili.
In definitiva, va segnalato, per quanto ri-guarda l’ambito ed il periodo storico in causa,che gli episodi architettonici tre-quattrocente-schi campani non si giovano ancora di una co-noscenza sufficiente, soprattutto in ordine allaloro complessità tipologica ed alle qualità for-mali, ma anzi, «di fatto, l’attenzione generalecontinua ad appuntarsi, unicamente o quasi, suiloro portali, le mostre di porte e finestre, e ciòconcerne soprattutto l’edilizia, ma anche e di fre-
quente gli immobili di più ambizioso pro-gramma, peraltro non sempre – per non direquasi mai – indagati con l’ausilio di accurati ri-lievi, la preventiva osservazione di tutti gli spazi,l’analisi delle singole realtà materiche e la letturadelle stratificazioni di fabbrica»5.
Scopo della presente ricerca, sulla scorta diqueste considerazioni, è un’inversione di ten-denza, mirante a riconoscere il valore degli or-ganismi architettonici attraverso un’analisi con-dotta dal punto di vista delle tecniche costruttivemurarie, cercando di privilegiare la conoscenzadi quelle impiegate su larga scala, così da identi-ficare gli elementi ricorrenti della produzione ar-chitettonica storicizzata, anche se non codificatasecondo parametri aulici.
questo percorso cognitivo è base fondanteper un opportuno programma di tutela, finaliz-zato alla loro protezione ed al loro rispettosoriutilizzo per fini utili alla società, come stabilitodalla richiamata Carta di Venezia.
Criteri metodologici
Il percorso di indagine, in accordo ai richiamatiprotocolli di ricerca, definisce due fasi comple-mentari, volte alla determinazione delle caratte-ristiche delle tecniche costruttive murarie at-traverso l’analisi delle peculiarità di un congruonumero di campioni indagati.
La prima fase, incentrata sull’acquisizionedi informazioni sui materiali da costruzione e leloro lavorazioni, ha mirato a superare la penuriadi fonti bibliografico-archivistiche. La seconda,invece, ha riguardato la redazione di schede de-scrittive delle strutture analizzate, accompagnateda glossari esplicativi, così da addivenire alla de-finizione di un ambito uniforme, comprensibilee soprattutto riproducibile in altre esperienze diricerca6.
Si è proceduto alla classificazione dei cam-pioni murari attraverso rilievi geometrici, foto-grafici e materici, indispensabili per la correttacomprensione del corpus di studio. Per ciascunodi essi si è provveduto, altresì, ad indicare, ove
10
possibile, «la collocazione, la caratterizzazionegeolitica e metrologica del materiale lapideo e lerelative lavorazioni, i componenti elementaridella malta (legante ed aggregati), la tipologiadell’apparecchio murario (tessitura e dimensionidei giunti), i processi di alterazione, gli eventualistrati di protezione e finitura, e, infine, le con-clusioni dell’analisi critico-documentaria»7.
Il metodo di analisi si fonda primariamentesull’incrocio e la comparazione di dati desuntidallo studio delle fonti documentarie e dai rilievidiretti. In ordine alle prime, si è già avuto mododi chiarire che la produzione bibliografica o irinvenimenti d’archivio, per i distretti in parola,non riportano, ai fini della presente ricerca, con-tributi ricchi e metodici; piuttosto, si registranoapporti sparsi e non ancora sviluppati, general-mente frutto dell’impegno di cultori di storia lo-cale.
Non sono stati ritrovati, infatti, documentiche descrivono operazioni di cantiere o tecnichedi muro adottate per l’intervallo temporale con-siderato. Per il caso di Carinola, invece, si è avutomodo di consultare l’apprezzo tardoseicentescodel feudo, rivelatosi utile per la comprensionedelle caratteristiche tipologiche di alcuni edificiallo stato di rudere e, dunque, non più leggibilinella loro completezza.
L’attività “sul campo”, come accennato, siè giovata dell’analisi diretta delle varie compo-nenti dei manufatti, attraverso rilievi geometrici,fotografici e materici. A tal proposito, è agevoleaffermare che lo studio diretto delle tecnichemurarie tradizionali diviene un ulteriore tasselloper la consapevole – e mirata – concretizzazionedell’intervento di conservazione, originata, an-zitutto, dalla conoscenza, cui fa seguito l’analisi cri-tica. In tale direzione, scaturisce l’esigenza di«conoscere i modi di costruire, di vedere comestoricamente si siano trasformati e come regio-nalmente si siano più o meno differenziati, par-tendo solo dalla realtà dei manufatti esistenti»8.
Il rilievo geometrico si è dimostrato utileper l’acquisizione di dati riguardanti le caratteri-stiche metriche e tipologiche dei manufatti in-dagati, allo scopo di meglio definirne le
peculiarità. Il rilievo fotografico, complementodel primo per quanto riguarda la corretta edesaustiva configurazione del successivo rilievomaterico, è stato condotto avendo cura di foto-grafare sempre i campioni murari con l’ausiliodi un preciso riferimento metrico. Infine, lo stu-dio delle caratteristiche materiche dei campionimurari è stato predisposto secondo uno schemaordinato attraverso “lemmi descrittivi”, cheprincipia con l’inquadramento planimetrico dellastruttura oggetto di analisi, cui sono affiancati,a seconda dei casi, il prospetto o la sezione del-l’alzato.
Il rilievo materico, condotto per un’esten-sione tale da considerare un’opportuna quantitàdi dati, è affiancato dalle sezioni dei muri, dalladescrizione dei nuclei, se visibili, da indicazionisulle dimensioni prevalenti degli elementi litoidie da eventuali schemi di realizzazione e partico-lari costruttivi. quando necessario, in accordoalla complessità del campione, lo si è esaminatoper un’estensione maggiore. In sede di scelta deicampioni murari sono state preferite le muratureche disponessero di almeno un paramento fac-ciavista e del nucleo ispezionabile. Laddove nonpossibile, sono stati considerati campioni checonsentivano la lettura di almeno un paramento.
È stato, altresì, seguito l’approccio stratigra-fico, che, ampiamente sperimentato negli ultimianni, rappresenta, affiancato da sistemi di data-zione come quello mensiocronologico, uno stru-mento utile per lo studio delle caratterizzazionistrutturali di un manufatto. Come è noto, neldetto tipo di analisi occorre, individuate le “unitàstratigrafiche” positive (ancora esistenti) o negative(segnalate in genere da crolli o demolizioni, inquanto non più esistenti), condurre un’oppor-tuna osservazione dei rapporti temporali che siinstaurano tra loro.
questa indagine, di tipo relativo, ancorchénecessitante di informazioni iniziali per la data-zione di almeno una parte della fabbrica che siintende analizzare, consente di evidenziarne leeventuali stratificazioni, in ossequio al suo carat-tere di “palinsesto”.
Per ogni scheda è stato, infine, redatto un
11
ampio testo di commento, esplicitando ulterior-mente le caratterizzazioni indicate nelle analisigrafiche.
La base di dati così ottenuta ha consentitodi raffrontare un numero quantitativamente si-gnificativo di campioni murari, di organizzareun discorso compiuto sulla loro cronotipologiae di configurare, per tal via, un’analisi accuratadel contesto costruttivo che li caratterizza.
Il rilievo materico ha rappresentato la fasepiù complessa dell’esperienza di ricerca, a causadelle differenti condizioni di conservazione e lo-calizzazione dei vari campioni. Per quanto ri-guarda le murature a ricorsi orizzontali periodici(“cantieri”), le altezze sono state rilevate, nellamaggioranza dei casi, dalle partizioni murarieterranee, misurando, ove possibile, anche quellesuperiori. Nel caso di “cantieri” apparecchiati afascia, il rilievo è stato effettuato tenendo contodello strato di pareggiamento; quelli conformatiad incastro, invece, sono stati rilevati in almenotre punti diversi, così da seguirne l’articolazionenella maniera più precisa possibile.
Anche le altezze dei corsi con zeppe sonostate rilevate tenendo conto dello strato di pa-reggiamento degli stessi. Per i filari di concisquadrati, invece, sono stati presi in considera-zione l’allineamento dei filari – registrando even-tuali particolarità discostanti dalle caratteristichegenerali del magistero murario – e le dimensionidei conci, ossia l’altezza, la lunghezza e, quandopossibile, la profondità, indagandone anche ladisposizione e lavorazione della facciavista, nellanecessità di descrivere il grado di accuratezza edi individuare gli strumenti utilizzati per effet-tuare la sagomatura.
I cantonali si sono giovati di un rilievo ef-fettuato tenendo conto delle due facce a vista,comprendendo, se visibile, parte del brano mu-rario adiacente. Si è tenuto anche conto delle ca-ratteristiche metriche degli elementi litoidi utiliz-zati: nella stragrande maggioranza dei casi conciben squadrati.
La stessa metodologia, pur nella differenzia-zione delle caratteristiche dei campioni murari, hariguardato l’analisi delle aperture arcate e dei pilastri.
Esiti della ricerca
I risultati raggiunti hanno portato all’individua-zione delle serie cronotipologiche presenti neisub-areali analizzati ed all’esplicitazione di inte-ressanti invarianti nella loro caratterizzazione.
Le analisi poc’anzi descritte, infatti, hannoconsegnato preziose informazioni che desi-gnano la netta prevalenza, tra i magisteri muraririscontrati, di quello “a cantieri”, presente mas-sicciamente sia su base territoriale sia in ordineal periodo considerato. Non fanno eccezione lestrutture castellate o quelle auliche, come si puòagilmente verificare nel castello o nel palazzoPetrucci a Carinola, nella torre dei Cappuccini aSessa Aurunca o nella torre Marzano a Pontela-tone. Come è noto, discriminanti per la diversi-ficazione cronotipologica di siffatte muraturesono l’altezza dei ricorsi, la dimensione e laforma degli elementi costituenti, nonché le mo-dalità di apprestamento degli stessi.
Nei casi individuati si è assistito ad un pro-gressivo aumento dell’altezza dei “cantieri”, da40-55 cm, con un range di 45-52 cm (xIV-xVsecolo, corrispondente all’ultima fase della do-minazione angioina ed alla dominazione arago-nese), a 60-65 cm (xVI secolo, nella prima fasedel viceregno spagnolo). In alcuni casi – soprat-tutto nel complesso programma costruttivo delcastello di Carinola, che si è giovato, in questasede, di un’accurata analisi stratigrafica – sonostati riscontrati “cantieri” di altezza più conte-nuta (30-35 cm), contraddistinti da costituentigeneralmente impilati, di più antica derivazione,coincidente verosimilmente con il primo pe-riodo della dominazione angioina (seconda metàdel xIII secolo).
Anche la lavorazione dei costituenti subisceun progressivo raffinamento, divenendo menoapprossimativa e pervenendo alla produzione,oltre che di pietrame spaccato di varie forme edimensioni, anche di pietre rustiche con confi-gurazioni assimilabili al quadrato, al triangolo oal trapezio.
In ordine alle dimensioni dei suddetti nonsi registrano, tra il xIV ed il xV secolo, sensibili
12
variazioni, trattandosi perlopiù di pietre spaccateconfiguranti, in genere, due allineamenti più omeno regolari, pareggiati da materiale minuto.Invece, nel xVI secolo – del quale sono statianalizzati campioni murari riferibili alla primafase del viceregno spagnolo, utili a chiarire, comepoc’anzi accennato, la sostanziale permanenzadelle tecniche costruttive dei secoli precedenti –gli elementi litoidi assumono dimensioni legger-mente maggiori, soprattutto in altezza, che in-fluiscono, unitamente alla più precisalavorazione ed alla realizzazione di sezioni mu-rarie contenute, anche sull’aumento dell’altezzadei “cantieri”.
Le modalità di apprestamento, grazie allamaggiore versatilità degli elementi litoidi, neces-sitano di un minore impilaggio e, di conse-guenza, della presenza meno estesa di elementidi pareggiamento (le cosiddette “asche”), chetuttavia permangono – talvolta anche nelle con-fezioni murarie riferibili al xVI secolo – per pa-reggiare i ricorsi, i quali, per tale motivo,tendono ad una maggiore linearità.
L’ulteriore magistero murario significativa-mente ritrovato, sebbene in minore quantità ri-spetto al primo e riguardante perlopiù icantonali, è quello a filari di conci, che annoveracome discriminanti per la diversificazione cro-notipologica, oltre che le dimensioni degli stessi,anche la lavorazione della facciavista e la carat-terizzazione dei giunti di malta.
Si è potuto accertare, a tal proposito, so-prattutto nel corso del xV secolo, il ricorso aconci squadrati o, in misura meno frequente,pseudo-regolari, collocati, in genere, alternativa-mente in lungo e in largo, nelle soluzioni ango-lari delle scatole murarie apprestate a “cantieri”,con la doppia funzione di irrobustire le parti piùdelicate della struttura e favorire la linearità deiricorsi orizzontali. Il repertorio di casi di studio,a tal proposito, è ampio e ricorrente in quasi tuttii distretti analizzati.
In altri casi, come in alcune porzioni del pa-lazzo Petrucci a Carinola, l’apparecchio a filariconcerne anche parte della muratura, o, comenel mastio e nella base scarpata del castello, sem-
pre a Carinola, i conci hanno configurato, permotivi difensivi, robuste fodere per le frontiesterne, ricoprendole senza soluzione di conti-nuità.
Le dimensioni ricorrenti dei conci sono, perquanto riguarda l’altezza, generalmente tendentiad un palmo napoletano (25-28 cm), con rareoscillazioni verso i 30-35 cm (1,25 palmi circa)e, per la larghezza, 27-40 cm. In ordine alla pro-fondità, si registrano valori tendenti ai due palmi(52-55 cm), con oscillazioni verso i 65-70 cm.
Giova anche ricordare che l’altezza dei“cantieri”, in presenza di cantonali con concisquadrati, è in genere confinata entro un rangecaratterizzato da valori tendenti a due palmi, ot-tenuta dalla sovrapposizione di due conci.
In definitiva, durante le dominazioni an-gioina ed aragonese, nei distretti analizzati i“cantieri” erano caratterizzati da un’altezza che,muovendo da 1,5 palmi, in genere non superavai due palmi, scanditi da costituenti di dimensioniperlopiù irregolari, in genere impilati, frutto dellavoro di spaccatura eseguito in cava.
Sebbene solo a partire dagli ultimi anni delladominazione aragonese l’altezza dei “cantieri”si fosse giovata della codificazione del palmo na-poletano, voluta da Ferrante d’Aragona (1480),si è rilevato agilmente come anche le maestranzeoperanti in precedenza si fossero riferite, sostan-zialmente, agli stessi valori, pur con qualche mi-nima differenziazione, perché già ampiamenteutilizzati e, dunque, acquisiti nel loro bagaglio diesperienze. Anche la lavorazione dei costituenti,nell’arco temporale scandito dalla presenza delledue case regnanti, è similare, segno della conti-nuità di una prassi costruttiva caratterizzata, sindalla dominazione angioina, dalla presenza dimaestranze più esperte, come i noti maestri dimuro cavesi e lombardi.
Negli anni del primo viceregno spagnolo,per i quali nei distretti analizzati è stata riscon-trata una minore quantità di campioni murari ri-spetto a quelli individuati per i secoli precedenti,invece, l’altezza dei “cantieri” in alcuni casi au-menta, seppure di poco, e le pezzature comin-ciano ad avvicinarsi a valori maggiormente
13
standardizzati, senza dubbio giovandosi anchedelle istanze di regolamentazione dell’attivitàedilizia culminate con le prescrizioni della notaprammatica del viceré Pedro Afan de Riberaduca di Alcalà (1564).
queste variazioni hanno condizionato, so-prattutto nel distretto napoletano, anche le di-mensioni dei costituenti angolari, perl’apprestamento dei quali in questo periodo nonvenivano utilizzati conci squadrati, ma perlopiù“spaccatoni”, elementi litoidi alti ½ palmo e lun-ghi due palmi, e “spaccatelle”, di dimensioni piùproporzionate (35 x 26 x 13 cm), posti, rispetti-vamente, in lungo e in largo.
Nei distretti indagati, invece, è general-mente permaso il ricorso diffuso a tecniche co-struttive murarie tramandate dai secoliprecedenti; per tale motivo, sono stati ritrovaticantonali in gran parte confezionati utilizzandoconci squadrati o elementi di spoglio, come co-lonne.
Note:1 I Marzano furono molto influenti durante il regno
di Roberto d’Angiò, cominciando a perdere potere soloal volgere del xIV secolo, sotto Ladislao di Durazzo. Spo-sarono la causa degli Aragonesi, risorgendo ed ulterior-mente espandendosi con l’avvento di Alfonso ilMagnanimo, ma, a seguito dei cruenti scontri tra MarinoMarzano e Ferrante d’Aragona, che portarono alla mortedel primo, scomparvero del tutto.
2 Cfr. G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Muraturetradizionali napoletane. Cronologia dei paramenti tra il XVI ed ilXIX secolo, Napoli 1998, G. FIENGO, L. GUERRIERO (acura di), Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo statodell’arte, i protocolli della ricerca. L’indagine documentaria (Attidel I e del II Seminario Nazionale), Napoli 2003 e G.FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Atlante delle tecniche co-struttive tradizionali. Napoli, Terra di Lavoro (XVI-XIX), 2tt., Napoli 2008. Gli studi sulle tecniche costruttive tradi-zionali condotti dall’unità di ricerca della Seconda Univer-sità degli Studi di Napoli, che hanno portato alla redazionedel ponderoso Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Na-poli, Terra di Lavoro (XVI-XIX), sono inquadrati nel Pro-gramma di Ricerca di Interesse Nazionale “Conoscenzadelle tecniche costruttive storiche: protocolli e strumentiinnovativi per la diffusione e l’applicabilità al processo diconservazione”, cofinanziato dal Ministero dell’Universitàe della Ricerca Scientifica e Tecnologica (annualità 2006-
2007). L’importante percorso di ricerca è stato coordinatodal prof. Stefano Della Torre del Politecnico di Milano edha visto la partecipazione, oltre a quest’ultimo ed alla Se-conda Università degli Studi di Napoli, delle Università diFerrara, Pescara, Roma “La Sapienza” e L’Aquila. L’unitàdi ricerca napoletana è stata coordinata dai proff. Giu-seppe Fiengo e Luigi Guerriero ed ha registrato la parte-cipazione dei ricercatori Saverio Carillo, Marina D’Aprile(Seconda Università degli Studi di Napoli) e CaterinaGiannattasio (Università di Cagliari), nonché degli archi-tetti Margaret Bicco, Stefania Cavallaccio, Cristina Cerullo,Giuseppe Cecere, Claudia De Marco, Luca Ferri, LuigiD’Orta e Manlio Montuori.
3 «Per l’edilizia residenziale dei numerosi centri sto-rici leborini di fondazione medievale, la letteratura storio-grafica si limita a menzionare elementi isolati (portali,finestre, logge) caratterizzati stilisticamente, trascurandoindagini tipologiche e storico-costruttive volte alla com-prensione degli organismi edilizi nella loro totalità mate-rico-figurale e della relativa stratificazione. A ciò siaggiunga la scarsità di informazioni circa le soluzioni di-stributive e costruttive delle residenze medievali leborinerinvenibili nelle fonti archivistiche note». L. GUERRIERO,F. MIRAGLIA, Materiali del Roccamonfina nell’architettura medie-vale di Terra di Lavoro: Pontelatone, Formicola, Castel Volturno,in A. PANARELLO (a cura di), Conoscere il Roccamonfina. 2.L’architettura (Atti del convegno e catalogo della mostra,Roccamonfina, 11 settembre 2010), San Nicola La Strada2010, pp. 107-108.
4 «Misurare murature, solai, coperture, infissi, ferra-menta, pavimenti, elementi di decoro e di finitura è unostrumento per cercare attraverso nuovi sentieri, inevita-bilmente interrotti, la bellezza del mondo, che non risiedeesclusivamente negli irripetibili capi d’opera, ma si rivelanella sostanza vitale degli uomini che hanno vissuto nellecase che noi misuriamo, segnate dalla loro esistenza, la cuiesperienza è essenziale per la comprensione dei processistorici». L. GUERRIERO, Panorami mensiocronologici post-medie-vali campani, in C. VARAGNOLI (a cura di), Muri parlanti.Prospettive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia storica (Attidel convegno, Pescara 26-27 Settembre 2008), Firenze2009, p. 109.
5 G. FIENGO, Prefazione a h. ROTOLO, Restauri antichie nuovi nel palazzo di Antonello Petrucci in Napoli, “quadernidel Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Archi-tettura e dell’Ambiente”, 3, Napoli 2003, p. 8.
6 «I dati identificativi assicurano la riproducibilitàdell’esperienza (la controllabilità delle osservazioni) e, alcontempo, forniscono indicatori (estensione del contestoomogeneo oggetto del rilievo; eventuale presenza di alte-razioni) utili per la stima della “credibilità” delle risultanzearcheometriche, ovvero per la determinazione del gradodi tipicità del tessuto esaminato. Come si comprende,
14
brani indisturbati e di notevole ampiezza vantano una rap-presentatività maggiore di quella attribuibile ad unità stra-tigrafiche molto ridotte». L. GUERRIERO, Classificazione delleunità stratigrafiche, in G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di),Murature tradizionali napoletane…, cit., p. 61.
7 L. GUERRIERO, Lo stato dell’arte in Campania, in G.FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Atlante delle tecniche co-struttive tradizionali. Lo stato dell’arte…, cit., p. 80.
8 T. MANNONI, Cronotipologia, in IDEM, Caratteri co-struttivi dell’edilizia storica, Genova 1994, p. 77.
15
Inquadramento territoriale
La provincia di Terra di Lavoro, di antica originee notevole estensione, come è noto, ha assuntodinamiche storico-territoriali molto varie nelcorso dei secoli, ampiamente approfondite inletteratura1.
L’appellativo Terra Laboris le giunse, conmolta probabilità, dalla presenza di un’antica po-polazione italica, quella dei Leborini, o Liburi. GiàPlinio il Vecchio, operante nel I secolo, docu-mentò la locuzione “Leboriae”, ma in epoca ro-mana gran parte della sua superficie eradenominata anche Campania Felix, per indicarela grande feracità della terra. Nella suddivisioneoperata in età augustea, infine, fu annessa allaRegio I.
Realtà amministrativa che arrivò a detenerefasce territoriali appartenenti attualmente a treregioni (Campania, Lazio e Molise) e ad ottoprovince (Caserta, Napoli, Avellino, Benevento,Salerno, Latina, Frosinone ed Isernia), feceparte, nel periodo delle dominazioni longobardae normanna, del potente Principato di Capua;inoltre fu, sin dal 1231, a seguito della promul-gazione delle Costituzioni di Melfi, Giustizie-rato.
quest’ultimo appellativo le permase sino al1806. L’accostamento del toponimo leborinoalla “Campania Felix”, all’attualità non più ricor-rente, ritornò a partire dal xVI secolo, qualeprodotto delle diverse elaborazioni geograficheche ritraevano la provincia, in molte delle qualiquesta era definita Terra di Lavoro olim CampaniaFelix.
Dipartimento del regno delle Due Siciliedopo la restaurazione, suddivisa in distretti e cir-condari, Terra di Lavoro si attestò, dopo l’Unitàd’Italia, come una delle province più estese dellaPenisola. Sino al 1818 ebbe come capoluogoCapua, sostituita poi da Caserta.
Infine, fu sciolta nel 1927 da Benito Mus-solini – con la volontà di sopprimere le forticontrapposizioni nate tra i maggiorenti del fa-scismo casertano – per essere ricostruita nel1945, fortemente ridimensionata in termini ter-ritoriali e con l’appellativo di “Provincia di Ca-serta”, che tuttora le permane.
I distretti oggetto del presente studio, qua-lificanti ben conformati sub-areali, sono statisempre ricompresi nell’area centro-settentrio-nale del suo vasto territorio (Figg. 1-2).
Lineamenti geolitologici
I distretti in parola (Fig. 3) fanno parte in pre-valenza delle aree falerna, domizia e del monteMaggiore e corrispondono ai territori di Cari-nola, Sessa Aurunca, Castel Volturno, Pontela-tone e Formicola. Si configurano, inoltre,secondo un assetto caratterizzato dalla diffusapresenza del tufo grigio campano – come peral-tro accade in gran parte del territorio casertano– ricoperto appunto dal conglomerato di originevulcanica, di varia consistenza, facente capo, inbuona parte, all’apparato del Roccamonfina.
L’eruzione del detto vulcano si è estesa, in-fatti, sino ai monti Ausoni, al monte Maggioreed all’area massicana, venendo a contatto anchecon i locali calcari mesozoici2. Il legame del mas-siccio massicano con fenomeni vulcanici ha im-pegnato – e tuttora impegna – le valutazioniscientifiche di molti geologi.
Invero, dopo anni di approfondite ricerche,è stata adottata una teoria “di mediazione”, cheascrive all’area, sebbene puntellata da giacimenticalcarei consistenti, una peculiarità materica ca-ratterizzata dalla notevole presenza di tufo grigiocampano. Circa l’origine di quest’ultimo nell’areamassicana è stato rilevato che «questa pirocla-stite è stata considerata proveniente dal vulcanodi Roccamonfina o dai Campi Flegrei, ma, se-condo studi recenti, per il tufo dell’Agro Falernonon è troppo verosimile né l’una né l’altra pro-venienza; l’Agro Falerno geograficamente è in-fatti estraneo alla regione aurunca e nonappartiene ai Campi Flegrei, ma è zona tipica di“tufo campano”»3.
queste considerazioni, in linea con studicoevi, ancora oggi largamente accreditati, infor-mano di un’origine del tufo grigio campano inquest’area dovuta perlopiù all’azione di più cen-tri eruttivi, localmente diffusi4.
17
Fig. 1. Principali distretti geografici della Campania (daGALASSO, ROMEO 1986).
Il termine “tufo”5 è alquanto generico –quantunque massicciamente utilizzato – e iden-tifica una grande quantità di rocce di matrice pi-roclastica, costituite fondamentalmente da ma-teriali solidi o semisolidi, emessi nel corso dieruzioni, soprattutto di carattere esplosivo, sottoforma di cenere, lapilli e frammenti di grosso-lana foggia.
Dopo la sedimentazione di questi ultimi in-terviene, in ambiente subacqueo o subaereo, unprocesso di “cementazione”. Se il detto pro-cesso non ha avuto luogo, i sedimenti si presen-tano sciolti, sotto forma di tufi incoerenti, comela nota pozzolana6. Se invece, come più spessoè accaduto, si formano letti consistenti di mate-riale in base ad un criterio di ordine granulome-trico, si rinvengono cinerazzi, lapilli e brecce.
Nello specifico, l’ignimbrite campana è ori-ginata «dalla precipitazione di nubi ardenti adalta temperatura, dove, al momento della depo-sizione, a motivo del forte calore, i bordi deiframmenti si saldano gli uni con gli altri, dandoluogo a tufi (…) principalmente composti dabande ben marcate e strati di materiale tufitico(pomici, lapilli, cristalli, etc.). queste qualità pi-roclastiche derivano, esclusivamente, da attivitàvulcaniche sub-aeree»7.
Relativamente all’area di studio, è utile se-gnalare che «il tufo grigio campano, emergentenell’area falerna e in quella casertana, assume,dall’alto in basso, la seguente nomenclatura: ci-nerazzo (piroclastite allo stato incoerente), se-mitufo (abbastanza coerente, di colore grigiocon scorie nere, pur non essendo molto resi-stente è stato largamente usato come materialeda costruzione in Terra di Lavoro), tufo piper-noide e piperno (materiali più resistenti grazieall’avanzato processo di sanidizzazione)»8.
Le facies inferiori possono generalmente in-dicare depositi più antichi, con caratteristiche fi-sico-meccaniche che ne decretano maggioretenacità. Nel tufo grigio campano, ad ognimodo, raramente la serie giunge a completezzapervenendo al piperno, disponibile in passato aNapoli, nell’area della collina dei Camaldoli.
quest’ultimo è una «roccia di aspetto e con-sistenza lapidea, che per il passato era conside-rata una lava, ma che oggi è classificata cometufo vulcanico, di natura trachitica. Malgrado irinvenimenti nell’area cittadina, è ancora preva-lente l’opinione che esso sia stato generato dalsolo vulcano di Soccavo, ai piedi della collina deiCamaldoli, ove il relativo giacimento è copertoda una formazione piroclastica grossolana, detta“breccia museo”, oltre che da banchi di tufo epozzolana. La sua caratteristica massa fonda-mentale grigia, disseminata di “fiamme” piùscure, lo ha reso, sin dai tempi antichi, moltogradito agli architetti napoletani, che ne hannofatto largo uso, sin alla fine del secolo scorso,per configurare gradini, cornici, stipiti, archi-travi, mensole, piedritti, zoccolature, etc.»9.
L’ignimbrite campana deve il massiccio uti-lizzo, oltre che all’agevole reperibilità (l’ediliziaha sfruttato le risorse locali soprattutto per mo-tivi economici) ed all’ottima lavorabilità, ancheal basso peso specifico, combinato ad una di-screta resistenza a compressione10 e ad un bassocoefficiente di trasmissione termica. L’altra suavariante, il tufo giallo stratificato, o casertano,deve invece la sua origine alla trasformazionedell’ignimbrite campana attraverso un processonoto come “zeolitizzazione”11.
18
Distretti di studio: Carinola, Sessa Aurunca, CastelVolturno, Pontelatone e Formicola
Il percorso di conoscenza principia con la de-scrizione di Carinola, posta nel cuore dell’anticoager Falernus e densa di episodi ascrivibili all’arcotemporale analizzato – dunque oggetto di mag-giore attenzione – il cui nucleo urbano è situatosu un esteso banco tufaceo12, circondato da duepiccoli torrenti, Pozzano e Malerba, sulla basedella collina confinata tra i monti Pecoraro, TreCroci, Massico, Petrino e Cicoli.
L’articolato contesto territoriale, compren-dente il centro e sette frazioni (Casanova,Casale, Nocelleto, Ventaroli, S. Donato, S. Crocee S. Ruosi) a guisa di satelliti, che puntellanol’esteso territorio di pertinenza, trova nella cit-tadella capoluogo un elemento di fortecaratterizzazione storica, che attraversa tutto ilMedioevo, giungendo all’età moderna con dif-fusi e qualificanti episodi architettonici, fruttosoprattutto della cultura catalana, comprendentisia le fabbriche militari sia l’edilizia civile, nobi-liare e popolare13.
Senza dubbio «la particolare e peculiareconfigurazione geo-morfologica ed orograficadel sito, una collina a 74 metri s.l.m. posta tra icorsi d’acqua Pozzano e Malerba, che si con-giungono a sud dell’abitato, ha favorito notevol-mente la nascita di quell’insediamento che,nell’Alto Medioevo, doveva essere Carinulum»14.
Ci si trova, dunque, dinanzi ad un insedia-mento di chiara matrice medievale, che, durantela dominazione aragonese, caratterizzata tuttaviada una forte presenza baronale autoctona, ha su-bito una ramificata ricodificazione della formaurbis, pertanto anche del tessuto edilizio, assu-mendo, in tal modo, caratteri distintivi ed origi-nali.
Infatti, sebbene permanga l’ossatura del-l’impianto planimetrico a fuso e sviluppo li-neare15, che segue l’andamento topografico delsito naturale, questo è stato impreziosito da unaserie di interventi durante il periodo aragonese,che hanno, in maggior quota, rappresentato l’ad-duzione di membrature, la “regolarizzazione” di
episodi edilizi preesistenti, il potenziamento o laridefinizione dell’edilizia civile signorile e diquella militare16.
Esempi tipici sono il castello, i palazzi Pe-trucci e Marzano e, in definitiva, l’intero qua-drante che da nord penetra nel distretto diorigine medievale17.
questo interessante patrimonio architetto-nico rivela una serie di episodi, perlopiù di edi-lizia diffusa, sinora mai analizzati dal punto divista delle tecniche costruttive murarie, ma sol-tanto in ordine alle caratteristiche immediata-mente “visibili”, ancorché fortemente limitative,legate alla presenza catalana, quali finestre, por-tali o particolari elementi di finitura.
Evidente sinora è stato, pertanto, il “pre-concetto ideologico” a causa del quale mai sonostate istruite problematiche di datazione, nean-che nei confronti di manufatti maggiormentenoti, come il palazzo Petrucci ed il castello, suiquali cogente poteva essere la necessità di evi-denza filologica.
Soprattutto sul castello, il cui stato di rudereha permesso di indagare una grande quantità dibrani murari e di elementi architettonici, il pre-sente studio ha potuto lumeggiare le caratteriz-zazioni costruttive tre-quattrocentesche ed irapporti con l’edilizia residenziale collocatanell’area dell’espansione angioino-aragonese del-la città.
Come oltre un trentennio addietro affermòacutamente Roberto Pane, riprendendo un’os-servazione di Adolfo Venturi a proposito di Ca-rinola “Pompei del quattrocento”, questadefinizione ha rappresentato «solo la scopertadella nostra ignoranza. Fu infatti la sorpresa pro-curatagli dalla vista di un ambiente tardogoticoche nessuno aveva documentato a suggerire alVenturi il senso della scoperta totale, e cioè ap-punto quella che si fa asportando il terreno chericopre le spoglie più antiche»18.
C’è purtroppo da rilevare che, all’attualità,quel che in passato era un manto di diffuso di-sinteresse, si è trasformato in un mero interesseparziale, mirante al semplicistico riconoscimentodegli episodi noti e visibili e scartando ogni ipo-
19
tesi di ricerca più accurata, estesa alle tecnichecostruttive, che invece favorirebbe la correttadelineazione, con dovuto rigore, dell’evoluzionestorico-architettonica della Carinola tre-quattro-centesca.
Tendenza che ha persistito anche negli studimiranti, da varie lateralità e con alterni risultati,ad approfondire gli aspetti dell’architettura ca-talana19. L’essersi soffermati sull’esclusiva analisidi membrature spiccatamente riconducibili aglistilemi catalani – al più concentrandosi sullo stu-dio di qualche struttura peraltro già largamentedocumentata secondo i canoni classici di studiostorico-architettonico – ha di fatto precluso laconoscenza di decine di casi interessanti, oggiampiamente intonacati o disturbati – se non ad-dirittura vulnerati – da interventi spesso oltre-modo invasivi, quindi non più analizzabili concompletezza o, peggio, null’affatto analizzabili.
Dopo l’epoca aragonese, l’espansione ur-bana di Carinola subì una fase di arresto, tantoche la città conserva, complessivamente, la ca-ratterizzazione quattrocentesca, se si eccettuanoalcuni interventi condotti nel corso dell’Otto-cento per favorire la viabilità, come lo sventra-mento che ha dato origine al corso Umberto,arteria che collega il centro ai flussi di trafficoverso Capua ed il litorale domizio20.
In questo contesto di indefinitezza ha bengiovato la consultazione di un documento fon-damentale per comprendere le specificità archi-tettoniche ed urbanistiche della città tra il xVIIed il xVIII secolo, in questa sede più volte ri-chiamato per le descrizioni di alcuni manufattianalizzati: l’apprezzo dei beni dell’Università ba-ronale di Carinola, redatto nel 1690 in occasionedella vendita del feudo, proprietà del defuntoNicola Carafa Guzmàn principe di Stigliano che
20
Fig. 2. Francesco Cassiano De Silva, Terra di Lavoro, inG.B. PACIChELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in do-dici provincie, v. I, 1702-1703 (da CARDI 2006). Si noti l’ac-curata delineazione dei confini della provincia leborina edelle realtà urbane di Carinola e Sessa.
non lasciò eredi, dai “regi ingegneri e tavolari”Antonio Galluccio e Lorenzo Ruggiano, inte-gralmente pubblicato ed ampiamente commen-tato in un recente contributo a stampa21.
Nell’apprezzo, sulla scorta delle accuratedescrizioni dei tavolari, si comprende come Ca-rinola (il cui feudo, unitamente a quello della vi-cina Mondragone, fu acquistato, tramite l’in-tervento di un intermediario, da Marc’AntonioGrillo de Mari marchese di Clarafuentes) fosserimasta pressoché identica nel corso dei secoli.
I tavolari così la descrivono: «la Città di Ca-rinola stà posta in q.ta Provincia di Terra di La-voro prossima alla strada di Roma situata in unopiano circondata da valloni murata attorno,parte con recinto di mura, et parte dalle med.me
abitazioni, le quali sono buona parte cascate, etparte di monte seù tufo naturale tagliati a forza.In detta città ci sono tre Porte, una detta la Porta
della Mad.na, che tira per la Strada di Capua,un’altra detta la Porta del Castello, che tira perla strada di Sessa, et l’altra detta la Porta di S.Andrea che tira verso la Rocca di Montedra-gone. Con la suddetta città ci sono quattro Ca-sali, di Casale di Casanova, Casale di Falciano, diCasale et Nocellete, con molte massarie habitateda cittadini e forastieri».
Un ulteriore documento, coevo all’ap-prezzo e dunque con lo stesso largamente raf-frontabile, è la veduta di Carinola illustrata daFrancesco Cassiano de Silva, contenuta nell’al-bum noto come Regno Napolitano Anotomizzato(1705)22.
L’opera (Fig. 4), che ritrae la città e parte delsuo territorio – ricorrendo alla tipica rappresen-tazione “in prospettiva” – in un assetto simile aquello più puntualmente descritto dai tavolari –e che sconta alcune indubitabili imprecisioni de-
21
Fig. 3. Gli areali geolitologici campani (elab.: L. D’Orta;da FIENGO, GUERRIERO 2008).
Fig. 4. Francesco Cassiano de Silva, Carinola. Regno Napo-litano Anotomizzato, 1705, Österreichische Nationalbiblio-thek, Wien, Kartensammlung, Alb. 161a (da AMIRANTE,PESSOLANO 2005).
rivanti probabilmente da esigenze artistiche23 –offre anche una breve descrizione epistolare chene esplicita alcune caratterizzazioni storiche esocio-culturali24, in gran parte mutuata da quellacontenuta nel noto testo dell’abate Pacichelli25 –che non riporta, però, alcuna veduta di Carinola– ma in uno stile più fluente.
A nord-ovest, a pochi chilometri dal terri-torio carinolese, si trova un altro distretto moltointeressante ai fini del presente studio, rappre-sentato dalla città di Sessa Aurunca, che sorgesu un pianoro tufaceo ed occupa un territoriomolto vasto, esteso sino alle falde dell’apparatovulcanico del Roccamonfina a nord ed al martirreno ad ovest, coprendo una superficie di 150km2 circa e rappresentando, dal versante occi-dentale, l’ultima propaggine della Campania, aiconfini con il basso Lazio.
Il territorio che ha originato questa com-plessa realtà urbana è molto antico. Colonia didiritto latino, fondata nel 312 a.C. circa, Suessapervenne allo status amministrativo di municipiumnel 90 a.C. Il ruolo di grande importanza chevisse nel periodo imperiale la portò ad espan-dere l’area abitata. Con il declino dell’impero ro-mano, però, cominciò a subire una lentadecadenza.
Divenne una delle prime diocesi del Cristia-nesimo in Campania settentrionale (secolo VI)e non fu abbandonata perché importante nodourbano dell’arteria di comunicazione tra Roma,Capua e Napoli.
Al volgere del Ix secolo ospitò un gastal-dato longobardo, dando origine, nel x secolo,ad un castrum, sotto la signoria di Pandolfo Ca-podiferro26 e per suo volere fu edificata unatorre, a lui dedicata e oggi non più esistente,posta a guardia del fiume Garigliano. Nellostesso periodo, la città divenne nuovamente sedevescovile.
Con la dominazione normanna, Sessa rico-minciò a crescere sensibilmente di importanza;con l’avvento di Federico II di hohenstaufen fucondotto un articolato piano di ristrutturazioneurbana, che favorì la sistemazione della cintamuraria turrita e l’ingrandimento del castello.
La presenza angioina fu caratterizzata, in-vece, da un visibile aumento della popolazione,concentratosi soprattutto nel borgo superiore,posto nel quadrante settentrionale dell’insedia-mento urbano. I governanti francesi favorironol’impianto di nuovi edifici religiosi, fatti realiz-zare soprattutto da Francescani, Domenicani edAgostiniani.
Nel 1200 fu eretto un monastero di clau-sura femminile, intitolato a S. Germano, mentre,quarant’anni dopo, nel borgo inferiore, dunqueall’esterno della primigenia cinta muraria, fu fon-dato dalle clarisse il monastero di S. Stefano. Allaparentesi angioina si deve anche l’edificazionedella torre di S. Biagio (1276) e dell’attiguo pic-colo edificio, quest’ultimo completamente tra-sformato da interventi risalenti al volgere delxIx secolo.
Perché la città ottenga un ruolo di granderespiro territoriale, ad ogni modo, bisognerà at-tendere il xIV secolo, con la venuta dei Mar-zano27, una delle più potenti famiglie del regnodi Napoli, che fece di Sessa il capoluogo dei pro-pri ingenti possedimenti feudali.
Il destino della città, infatti, incrociò la co-rona aragonese attraverso l’azione di questa im-portante casata, che vide in Giovanni Antonio,
22
padre del più tristemente noto Marino, l’arteficedella più importante trasformazione urbana edel potenziamento della cinta muraria, con la co-struzione di un secondo tratto che collegava laporta dei Cappuccini con quella dei Ferreri,quindi il borgo inferiore al superiore, serrando,in tal modo, l’asse di penetrazione a nord-ovest.
Ai Marzano è anche ascritto il profondo ri-maneggiamento del castello, con l’introduzionedi elementi di stilema catalano, soprattuttomembrature, nella rigida struttura fridericiana.Testimonianze della cultura costruttiva catalanasono riscontrabili anche in diversi punti dellacittà, sopravvissute limitatamente a portali e fi-nestre28.
Caduti i Marzano nel 1464 e volto al ter-mine, pochi decenni più tardi, il dominio arago-nese29, la città fu tenuta, dal 1507, da ConsalvoFerrando de Cordoba, noto come Gran Capi-tano, popolare condottiero spagnolo, tra gli ar-tefici della conquista del regno di Napoli daparte di Ferdinando il Cattolico30, nonché primoviceré della città partenopea.
quando i Carafa della Stadera acquistarono,verso la metà del xVI secolo, dal nipote di Con-salvo, Consalvo II, il feudo della vicina Carinola,che quest’ultimo fu costretto a cedere a causadella sua vita dispendiosa31, i Sessani provvideroall’autotassazione per non cadere nelle mani deinuovi feudatari, mostrando una forte propen-sione all’autonomia, perdurata nei secoli.
Non sono noti, purtroppo, apprezzi deibeni del feudo, che avrebbero consentito dicomprenderne con accuratezza l’articolazioneurbana e la consistenza edilizia tra il xVII ed ilxVIII secolo, come nel caso di centri vicini, chehanno vissuto vicende politiche comuni, qualiMondragone o Carinola32.
Anche Sessa fu ritratta da Francesco Cas-siano de Silva nel Regno Napolitano Anotomizzato33.La veduta sessana (Fig. 5) rappresenta, pur se li-mitata anch’essa da lampanti imprecisioni e dallarichiamata impossibilità di confrontarla con unapprezzo, un documento comunque utile per lostudio della città in una fase di grandi rivolgi-menti socio-politici.
Anche un’altra veduta (Fig. 6), attribuita alCassiano e di sua mano certamente, contenutanel Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici pro-vincie34, descrive la città, ma in maniera più pun-tuale, contenendo anche l’indicazione dei luoghirimarchevoli35. Nella parte inferiore di questa,infatti, sono individuati, tra gli altri edifici, il ca-stello, la porta della Maddalena e la torre di S.Biagio. In entrambe le delineazioni è accurata-mente rappresentata la robusta murazione checinge la città.
Dopo alterne vicende, non ultima l’aperturanel 1571 del “Real Camino”, che isolò il centrourbano dai collegamenti preferenziali in dire-zione Roma-Napoli, all’inizio del xIx secolo lacittà visse una fase di lento declino, orfana, tral’altro, delle influenti famiglie e dei tanti ordinireligiosi che, sin dal Medioevo, ne avevano for-temente caratterizzato l’assetto socio-culturale36.
Contrariamente a Carinola, che offre dif-fuse testimonianze legate in gran parte all’archi-tettura tardo-medievale, essendo rimasta persecoli cristallizzata all’assetto impressole dalladominazione aragonese, Sessa Aurunca ha su-bito un’evoluzione più dinamica, offrendo stra-tificazioni maggiormente complesse.
23
Fig. 5. Francesco Cassiano de Silva, Sessa. Regno NapolitanoAnotomizzato, 1705, Österreichische Nationalbibliothek,Wien, Kartensammlung, Alb. 161a (da AMIRANTE, PES-SOLANO 2005).
In recenti studi sulle tecniche costruttivetradizionali sessane tra il xV ed il xVI secolo simette in enfasi la presenza, sin dal Medioevo,del magistero murario “a cantieri”, in particolarmodo nel castello e nelle strutture ad esso an-nesse. questa tecnica di muro, che riguarda latotalità dei distretti indagati e sulla quale in que-sta sede saranno condotti ampi approfondi-menti, è stata massicciamente utilizzata in cittàanche nei periodi angioino ed aragonese37.
Muovendo a sud-ovest, a distanza di circa30 chilometri, si individua l’esteso territorio oc-cupato da Castel Volturno, che si dipana, senzasoluzione di continuità, sino ai confini con laprovincia napoletana, attraverso un litorale chesi estende per ben 27 chilometri. L’insediamentoche ne caratterizza il centro storico comprendel’area del fortilizio longobardo ed il borgo de-nominato S. Castrese (Fig. 7).
Dopo l’abbandono della colonia romana diVolturnum, al volgere dell’VIII secolo, Grimo-aldo, duca di Benevento, donò all’abate Teodo-maro di Montecassino il porto di Traetto equello volturnense, segno dell’importanza stra-tegica del sito per i possedimenti dell’abbazia.
A qualche centinaio di metri, infatti, fu fon-dato ad opera dei Longobardi, un castrum, la cuiprima fase costruttiva data al Ix secolo e la se-conda, consistente in un intervento di fortifica-zione, al x-xI secolo. La distanza del castrumdalla colonia romana manifesterebbe, secondoalcuni, una voluta discontinuità tra quest’ultimae l’insediamento alto-medievale, che, di formarettangolare, un tempo totalmente murato, so-stanzialmente conserva ancora il primigenio as-setto urbano.
Attiguo al borgo è il castello, realizzato suparte del preesistente spazio occupato da un
24
Fig. 6. Francesco Cassiano de Silva (attrib.), Sessa (da PA-CIChELLI 1702-1703).
ponte romano che traguardava le sponde delVolturno, inglobandone un’arcata scampata alladistruzione38; per la creazione del castello fufatto larghissimo ricorso a spolia provenienti dalsito e dalla strada romani39.
I Longobardi realizzarono una poderosastruttura difensiva laddove maggiore era il peri-colo di incursioni nemiche, la cui localizzazionenon seguiva logiche di difesa naturale ma piut-tosto rappresentava la necessità di tenere sottocontrollo un territorio di complessa articola-zione, che aveva nel porto fluviale il suo fulcroeconomico.
Il sito pervenne, dopo la parentesi nor-manno-sveva, alla dominazione angioina conrinnovata rilevanza commerciale e difensiva.Con l’avvento degli Aragonesi, il castrum ed il ca-stello furono annessi al novero degli ingenti pos-sedimenti della genìa dei Marzano, portati indote a Marino dalla moglie Eleonora.
Ben presto, però, dopo la disfatta di Marinoad opera di re Ferrante, quest’ultimo, mentre di-stribuì ai vari feudatari le terre confiscate al co-gnato, trattenne per qualche tempo in suopossesso l’insediamento volturnense, ben con-siderandone la valenza strategica. Valenza che,seppur perdurata nei secoli successivi, non haconsentito un ulteriore sviluppo del borgo40, né,in definitiva, la sua necessaria salvaguardia.
Vicende contemporanee, scandite, dallametà del Novecento, da un’aggressione sistema-tica del territorio, con la realizzazione, in variearee, di centinaia di migliaia di metri cubi senzaregole né controllo, non hanno infatti rispar-miato il borgo di S. Castrese. Ormai disabitato,presenta quasi tutti gli edifici – in gran parte af-flitti da piccoli e grandi abusi edilizi – allo statodi rudere.
Raggiungendo l’area del monte Maggiore,alle pendici di quest’ultimo, in direzione nord-est si trova Pontelatone, sito urbano anticamentedenominato Pontelatrone o Ponteladrone, riferen-dosi al ponte che i cittadini utilizzavano per tra-sportare la merce, sovente assalito dai briganti.Molto simile, per impianto urbanistico e carat-teristiche orografiche, a Carinola, dunque carat-
terizzato da un tessuto urbano a fuso e sviluppolineare ed attestato su un banco di tufo lieve-mente sopraelevato dalla quota di campagna, ilpiccolo e compatto abitato si erge a 120 m s.l.m.,circondato da due torrenti (ancora similmente aCarinola), San Giovanni e Pisciariello, e difesodalle caratteristiche orografiche del sito naturale.
Le sue origini, sulle quali non è purtroppodisponibile una robusta letteratura, sono ascritteda alcuni al x secolo, ad opera dei Longobardi41.Nel 1306 fu appannaggio di Tommaso Marzano,noto per le notevoli capacità strategiche e per laperizia nel far realizzare fortificazioni. Con l’av-vicendarsi della dominazione aragonese e dopola rovina dei Marzano, Ferrante d’Aragona creò,nel 1465, la baronia, affidandola a Diomede ICarafa, raffinato umanista ed esperto uomod’armi, che la impreziosì con l’adduzione di ele-menti di stilema gotico-catalano.
Il peso politico della famiglia Carafa in que-sto territorio persistette sino all’eversione delfeudalesimo. Al volgere del xVIII secolo, acausa di malsane condizioni ambientali, i suoiabitanti discesero a 35042.
Dalla lettura degli assetti architettonici è fa-cile arguire come Pontelatone, analogamente aCarinola, abbia vissuto il periodo di maggiorefloridezza in età aragonese. Ne sono vivida te-stimonianza soprattutto edifici civili con tipolo-gia palatiale, tra i quali si ricordano i palazziRotondo, Galpiati, Scirocco ed Affinito. Interes-sante, a tal proposito, è anche gran parte dellacortina muraria che si snoda sulla centrale via IVnovembre e che ospita altre testimonianze quat-trocentesche e brani facciavista.
Desta interesse anche il monastero dome-nicano, risalente al xVI secolo e articolato inuna complessa insula, realizzata intorno ad unagrande corte di forma leggermente trapezoidale.Degna di nota per le finalità della ricerca è latorre Marzano, a pianta circolare, che si ritienefacesse parte di un sistema difensivo più artico-lato.
Uno studio sull’argomento riferisce che «lafortezza era stata probabilmente costruita nelcorso del xIII secolo, ma cominciò ad avere una
25
particolare rilevanza solo dopo l’intervento diTommaso Marzano dei duchi di Sessa, del qualela città era divenuta possedimento agli inizi delxIV secolo (…) Tommaso Marzano, infatti for-tificò il castello preesistente, costruendo sul latooccidentale di questo una torre cilindrica per mi-gliorare la difesa di una zona più facilmente at-taccabile delle altre a causa dell’assenza delfossato»43.
quest’ultima considerazione, a propositodel rafforzamento di un fortilizio preesistente,ricorre anche nelle altre, sparute pubblicazioniche trattano del patrimonio storico-architetto-nico di Pontelatone.
A poche centinaia di metri, muovendo anord-ovest, si staglia il piccolo centro di Formi-cola, adagiato in una pittoresca valle racchiusadai monti Callicola, Serrone e Maggiore, an-ch’esso caratterizzato dalla diffusa presenza ditufo grigio.
Insieme al capoluogo, la realtà amministra-tiva conta tre frazioni, di modesta estensione:Lautoni, Cavallari e Fondola. Appena oltre que-st’ultima frazione, tramite un sentiero si rag-giunge Pizzo S. Salvatore (1037 m s.l.m.), la vettapiù alta del massiccio del monte Maggiore.
Scarsissime sono, purtroppo, le fonti sullastoria del sito, che ne ascrivono perlopiù la fon-
dazione al xII secolo, anche se alcuni riferi-scono la presenza in zona di una turris Feniculi,che avrebbe dato origine all’insediamento già nelcorso dell’xI secolo44.
Notizie più dettagliate, ad ogni modo, sonoreperibili a partire dal xIV secolo, quando For-micola, come la vicina Pontelatone, era annove-rata tra i possedimenti di Tommaso Marzano.Dopo la disfatta della potente famiglia, nel 1465Ferrante d’Aragona donò a Diomede I Carafa ilfeudo, che comprendeva anche i centri di Pon-telatone, Sasso, Sesto e Roccapiperozzi.
Il Carafa vi fece edificare un sontuoso pa-lazzo, tuttora esistente. Nel xVIII secolo, unodei suoi successori, Francesco II Carafa, lo in-grandì e lo rese sede di una prestigiosa accade-mia araldica.
Con la riforma murattiana Formicola di-venne capoluogo della circoscrizione che com-prendeva anche i comuni di Pontelatone, Schiavi(divenuto in seguito Liberi) e Baia. La circoscri-zione decadde, alfine, con la soppressione dellaprovincia di Terra di Lavoro ad opera del regimefascista.
Note:1 Ampi ragguagli sulle dinamiche evolutive di Terra
di Lavoro sono in A. LEPRE, Terra di Lavoro, in G. GA-LASSO, R. ROMEO (a cura di), Storia del Mezzogiorno, v. V,Roma 1986 e in A. GENTILE, Da Leboriae a Terra di Lavoro,in AA.VV., Ritratto di Terra di Lavoro, Caserta 2005.
2 «Il centro eruttivo di Roccamonfina (…) costitui-sce un vulcano a recinto con un cono interno (M. S.Croce, m. 1003 sul mare) ed un vasto cono esterno, cheva ad adagiarsi fino a contatto con i calcari mesozoici deiM. Ausonî, del M. Maggiore e M. Massico». F. PENTA, Imateriali da costruzione dell’Italia meridionale, v. I, Napoli 1935,p. 203. Le eruzioni del Roccamonfina datano da 630.000a 50.000 anni fa, impegnando, dunque, un ampio lasso ditempo. Ragguagli sull’utilizzo del materiale originato dal-l’apparato vulcanico del Roccamonfina in alcuni comunidi Terra di Lavoro – Pontelatone, Formicola e Castel Vol-turno – nel periodo medievale sono in L. GUERRIERO, F.MIRAGLIA, op. cit., pp. 107-124. È utile, a tal proposito,ricordare che «sia dal punto di vista chimico che da quelloevolutivo, il Roccamonfina presenta caratteristiche che nonsono paragonabili a nessuno dei vulcani vicini, sia a nordche a sud. Sebbene la causa del magmatismo sia la mede-
26
Fig. 7. Castel Volturno (CE), inquadramento planimetricodel borgo di S. Castrese con, ad ovest, il castello (daGUERRIERO, MIRAGLIA 2010).
sima, il chimismo delle rocce vulcaniche affioranti variamoltissimo, a causa della diversa composizione delle rocceoriginarie, da cui si formò il magma». L. SANTELLO, Evo-luzione del Complesso Vulcanico del Roccamonfina, in A. PANA-RELLO (a cura di), Conoscere il Roccamonfina. 1. Il geosito (Attidel convegno – Roccamonfina, 11 luglio 2009, Volumeprimo – Relazioni), Formia 2009, p. 2.
3 A. PETRONE zOLFO, Considerazioni geografiche sullapiana di Mondragone, Sant’Arpino 1979, p. 26. Per una de-scrizione dell’ignimbrite campana cfr. F. PENTA, op. cit.,pp. 203-204. Altri studi ascrivono la formazione del-l’ignimbrite campana, considerata il deposito piroclasticopiù esteso dell’area (150 km3 circa), al secondo ciclo vul-canico dei Campi Flegrei, avvenuto circa 37.000 anni fa,a causa del quale gran parte della regione fu seppellitasotto una spessa coltre tufacea. Il tufo giallo caotico, o na-poletano, che si rinviene nell’area napoletano-flegrea enella piana campana sino ai rilievi appenninici, si sarebbeinvece originato in seguito, circa 12.000 anni fa, nel corsodel quarto ciclo vulcanico dei Campi Flegrei, configuran-dosi, per estensione (50 km3 circa), come il secondo de-posito piroclastico.
4 Cfr. L. GUERRIERO, G. CECERE, Strutture in tufo gialloe in tufo grigio a Napoli e in Terra di Lavoro, in G. FIENGO, L.GUERRIERO (a cura di), Atlante delle tecniche costruttive tradi-zionali. Napoli, Terra di Lavoro…, cit., t. I, p. 117, che attin-gono i dati da P. DI GIROLAMO, Petrografia dei tufi campani,in “Rendiconti dell’Accademia di Scienze Fisiche e Mate-matiche”, xxxV (1968), pp. 5-70 e da F. ORTOLANI, F.APRILE, Principali caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei de-positi superficiali della piana campana, in “Bollettino SocietàGeologica Italiana”, 1985, pp. 195-206.
5 «Le rocce piroclastiche sono spesso associate alle igneepoiché risultano formate da ceneri, lapilli e altri materialiprovenienti dalle fasi esplosive dei vulcani, ma depositatisecondo modalità caratteristiche delle rocce sedimentarie.Sono caratterizzate da modesta compattezza, se non in-coerenza, e sono spesso associate a materiali lavici. Al-l’estremo inferiore della scala di cementazione stanno lepozzolane, a quello superiore i tufi porfirici. Le famiglie piùdiffuse sono i tufi, formati da frammenti di vetro vulca-nico, minerali, femici ed elementi di varia natura depositatiin ambiente subaereo o subacqueo. Secondo il magma dacui provengono possono dividersi in porfirici, andesitici,trachitici, basaltici, leucitici ecc. Grazie alla loro facilità diestrazione e alla loro lavorabilità, e malgrado la scarsa re-sistenza, sono molto apprezzati nell’edilizia, specialmentenella costruzione di ossature murarie non in vista». C. VA-RAGNOLI, La materia degli antichi edifici. La pietra, in G. CAR-BONARA (a cura di), Trattato di restauro architettonico, v. I,Torino 2004, p. 305.
6 La puteolana pulvis è un prodotto vulcanico di scarsacoerenza, di colore rosso scuro, con granulometria gene-
ralmente sabbiosa, rinvenibile nel Lazio, in Sicilia e, ap-punto, a Pozzuoli, in Campania. La pozzolana è utilizzataper confezionare malte cosiddette “pozzolaniche”, adattein particolare per opere marine o subacquee. I primi acomprenderne le particolari proprietà in ambiente subac-queo furono i Romani, che utilizzavano le malte pozzola-niche per i piloni dei ponti. Cfr. Dizionario di Architettura,Milano 2001, pp. 672-673.
7 M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi in Terra diLavoro, Napoli 2001, p. 30, n. 33, che attinge i dati da Voce:«Piroclastiche rocce» in D.G.A. WhITTEN, J.R.V. BROOKS, Di-zionario di geologia (ed. it.), Milano 1978, pp. 249 ss.
8 L. GUERRIERO, G. CECERE, op. cit., p. 222, n. 7. Ilprocesso di sanidizzazione è determinato dalla presenzadel sanidino, un minerale feldspato alcalino che si presentasotto forma di cristalli prismatici o tabulari, spesso gemi-nati e che si ritrova in una grande quantità di rocce vulca-niche. Può essere biancastro o incolore, con striaturabianca e lucentezza vitrea sulle facce del cristallo. Insolu-bile in quasi tutti gli acidi, il sanidino si può rinvenire dopole eruzioni vulcaniche.
9 G. FIENGO, Organizzazione e produzione edilizia a Na-poli all’avvento di Carlo di Borbone, Napoli 1983, p. 37.
10 Giova ricordare che le diverse facies del tufo grigiocampano presentano compattezza e peso generalmentesuperiori al tufo giallo, stratificato o caotico, in funzionedella zona di estrazione e della profondità del deposito,con valori crescenti verso il basso. La resistenza a com-pressione del tufo grigio campano, invece, «è minore diquella del tufo giallo: la tensione di rottura a schiaccia-mento varia tra i 25 e i 60 kg/mq». A. AVETA, Materiali etecniche tradizionali nel napoletano. Note per il restauro architetto-nico, Napoli 1987, p. 9.
11 «Il tufo giallo stratificato è il prodotto di eruzionianteriori a quelle che hanno dato luogo al tufo giallo cao-tico dei vulcani di Capo Miseno, Bacoli, Nisida, Coroglio,Trentaremi; contiene una grande quantità di pomici e sco-rie, per lo più piccole, e presenta una massa fortementestratificata, nella quale si evidenziano sensibili differenzenella granulometria e nel colore dei vari strati». Ivi, p. 11.questo tipo di tufo, «che secondo alcuni costituirebbe unaspecifica facies del tufo grigio, ben connotato sul piano pe-trografico, [è] costituito da una matrice grossolana di co-lore ocra, con diffusi inclusi scuri di dimensionimedio-piccole, di buona resistenza». L. GUERRIERO, G.CECERE, op. cit., p. 117. Il processo di zeolitizzazione sideve alla presenza della zeolite, un minerale con strutturacristallina regolare e microporosa, caratterizzato da grandequantità di volumi vuoti e da un’intelaiatura strutturale abase di alluminosilicato con ioni con carica positiva in-trappolati in cavità a “tunnel” o a “gabbia”.
12 Nel ponderoso Dizionario geografico-ragionato, incen-trato sulla descrizione dei comuni del regno di Napoli, Lo-
27
renzo Giustiniani afferma: «io non dubito affatto, che que-sta città, cogli altri paesi del di lei stato fossero edificati inun suolo tutto vulcanico, non potendosi altrimenti carat-terizzare il Massico, che per un’esplosione vulcanica. I la-pilli, le pietre abbruciate, le ceneri, vi si veggonopalpabilmente dappertutto». L. GIUSTINIANI, Dizionariogeografico-ragionato del Regno di Napoli, t. III, Sala Bolognese1984. Ripr. facs. dell’ed.: Napoli, 1804, pp. 175-176.
13 «L’architettura di influenza catalana si sviluppò, inalcuni centri minori, con una maggiore diffusione che nonnella stessa Napoli; il primato della capitale si contrappo-neva ancora a quello dei feudi, alcuni dei quali vantavanoun passato e un’estensione territoriale di grande impor-tanza. Inoltre i feudatari e funzionari aragonesi, preferi-vano forme tradizionali a loro familiari e più consone allaloro cultura, che non forme di importazione, come quelletoscane; quest’orientamento di gusto è confermato dalfatto che l’influenza toscana diminuisce, man mano checi allontaniamo dalla capitale». M. ROSI, Architettura meri-dionale del Rinascimento, Napoli 1983, p. 67.
14 F. MIRAGLIA, Tracce di storia urbanistica, in F. MIRA-GLIA, R. NOCCO, C. VALENTE, Carinola. Viaggio nel dominiodella memoria, Napoli 2000, p. 11.
15 questo tipo di insediamento, risalente all’alto Me-dioevo, ha una morfologia alquanto elementare «costituitada un tessuto edilizio formato da abitazioni disposte inserie parallele ed allineate, secondo la direzione di pene-trazione all’interno del villaggio, fino a coprire l’intero spa-zio disponibile sull’alto della zona più piana delpromontorio sul quale il villaggio era stato fondato origi-nariamente». P.M. LUGLI, Storia e cultura della città italiana,Bari 1967, pp. 130-131.
16 Che gli interventi condotti dagli Aragonesi fosseroinseriti nel tessuto urbano preesistente senza stravolgerneparticolarmente le articolazioni formali, è confermatoanche «dal fatto che la quattrocentesca chiesa dell’Annun-ziata fosse stata edificata in posizione fortemente decen-trata rispetto all’originario nucleo urbano medioevale,quindi extra moenia, per preservare la funzione peculiaredella Cattedrale; gli stessi palazzi Marzano e Novelli (…)prospettano sulla generatrice viaria dell’insediamento, ri-spettando perfettamente i limiti delle piccole insulae me-dioevali che la intersecano». F. MIRAGLIA, Tracce di storia...,cit., p. 12.
17 Massimo Rosi, che si è occupato di Carinola e delsuo patrimonio di architettura catalana per diversi anni,descrivendolo in occasione di svariati contributi a stampa,ha constatato che essa, «esempio sempre citato come epi-sodio singolare, mostra invece la sua appartenenza ad unvasto patrimonio, comune a tutto il Sud, ancora in granparte ignorato, trascurato, non studiato in modo ade-guato». M. ROSI, L’altro Rinascimento. Architettura meridionalenel ‘400, Napoli 2007, p. 71.
18 Cfr. R. PANE, Il Rinascimento nell’Italia Meridionale,Milano 1975, pp. 205-225.
19 In un volume incentrato sulle problematiche del-l’ambiente campano, Lucio Santoro rileva che «mentresono abbastanza noti i preziosi particolari di una finestrao di un portale (Capua, Fondi o Carinola), si ignorano,tuttora, le strutture degli edifici nel loro insieme. questainformazione, ancora sommaria, ha portato all’errore,piuttosto frequente, di valutare l’opera dei maestri catalaniquale quella “di virtuosi lapicidi che non di architetti ca-paci di realizzare complesse opere murarie”». L. SANTORO,Aspetti e problemi dell’ambiente campano, Napoli 1979, p. 61.In un altro suo contributo a stampa, che tratta dei castelliangioini ed aragonesi nel regno di Napoli, lo studioso in-vece afferma che «la produzione dei maestri catalani inprovincia dove questi lavorarono per i nobili di corte, rap-presenta un aspetto di minore importanza rispetto al-l’opera napoletana. Infatti, le espressioni catalane deicastelli di Carinola, Sessa Aurunca e Fondi, in maggiorparte finestre, pur se notevoli come elementi singoli, nonpossono essere considerate come veri organismi architet-tonici». L. SANTORO, Castelli angioini e aragonesi nel Regno diNapoli, Segrate 1982, p. 136. Tali osservazioni denotanolo scarso interesse, al tempo, per un’analisi più approfon-dita dei manufatti architettonici, che fosse orientata allacomprensione delle loro tecniche costruttive e non sol-tanto al riconoscimento delle membrature o delle finiture.
20 Il Giustiniani indica, nel Dizionario, per Carinolauna popolazione di «500 individui, esclusa quella de’ suoicasali, e villaggi», informando che la città «nel 1532 tuttainsieme fu tassata per fuochi 890, nel 1545 per 978, nel1561 per 961, nel 1595 per 486, nel 1648 per 440; e nel1669 per 292», confermandone il graduale spopolamento.L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico…, cit., t. III, p. 176.
21 Cfr. C. VALENTE, L’Università Baronale di Carinolanell’Apprezzo dei Beni anno 1690, Marina di Minturno 2008.Le successive citazioni del documento, ove non diversa-mente indicato, sono tratte dalla stessa fonte.
22 La veduta di Carinola è contenuta, con quella diAirola, nel foglio 280 dell’album, custodito presso l’Öster-reichische Nationalbibliothek di Vienna, composto di 285fogli e dedicato al maresciallo austriaco von Daun, con-quistatore del regno di Napoli. La rappresentazione è de-lineata con inchiostro seppia, campita con acquerellocolor ambra e inquadrata in un medaglione. Ampi raggua-gli sulla veduta sono in F. MIRAGLIA, Note sulla rappresenta-zione della città e del territorio di Carinola tra il XVII ed ilXVIII secolo. La veduta tardoseicentesca di Francesco Cassiano deSilva, in “Civiltà Aurunca. Rivista trimestrale di cultura”,75-76 (2009), pp. 71-77. Un accurato studio sulla raccoltaviennese del Cassiano è in G. AMIRANTE, M.R. PESSO-LANO, Immagini di Napoli e del Regno. Le raccolte di FrancescoCassiano de Silva, Napoli 2005. Ulteriori descrizioni della
28
veduta in parola, dal taglio sintetico, sono nel saggio di V.VALERIO, Carinola e il suo territorio, in Carinola. Arte, storia enatura, Napoli 2003, pp. 27-35, in cui è pubblicata per laprima volta in Italia, e nella scheda contenuta in C. DE
SETA, A. BUCCARO (a cura di), Iconografia delle città in Cam-pania. Le province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Na-poli 2007, pp. 239-240.
23 «Il punto di vista della veduta, orientata a nord,con il massiccio massicano a far da cornice naturale allacittà, è un promontorio posto a sud, in linea con la ma-niera di rappresentazione dell’autore. Nel caso in esame,però, questa postazione non trova facile conferma, essen-dovi da quel lato assenza di rilievi significativi per diversichilometri. Carinola si presenta come un agglomerato rac-colto, con impianto a fuso e sviluppo lineare, circondatoda robusta murazione, il cui tratto irregolare somiglia aquello reale, ad eccezione della porzione a sud-est e delgran numero di torri d’angolo. queste imprecisioni, cui siunisce l’errata illustrazione delle caratteristiche orografichedel sito, nella realtà lievemente sopraelevato rispetto alpiano di campagna, fanno pensare che il Cassiano, eviden-temente impossibilitato ad uno sguardo complessivo dellacittà, sia ricorso ad una delineazione ex post della veduta,probabilmente stilata sulla scorta di dati attinti da una po-stazione all’interno del perimetro urbano, come il mastiodel castello o il campanile della cattedrale, in seguito rie-laborati e tratteggiati senza curarsi della distorsione pro-spettica né delle inesattezze altimetriche». F. MIRAGLIA,Note sulla rappresentazione della città e del territorio di Carinola…, cit., p. 75.
24 Cfr. G. AMIRANTE, M.R. PESSOLANO, op. cit., p. 88.25 Cfr. G.B. PACIChELLI, Il Regno di Napoli in prospettiva
diviso in dodici provincie, v. I, Sala Bolognese 1979. Ripr. facs.dell’ed.: Napoli, 1702-1703, pp. 103-104.
26 Pandolfo I, detto “Capodiferro” (? - 981), fu prin-cipe di Benevento e Capua (943-981) e di Salerno (dal978). Fondamentale fu il suo ruolo nella guerra contro Bi-zantini e Musulmani per il controllo delle terre del Mez-zogiorno nei secoli appena successivi alla caduta deiLongobardi e dei Carolingi in Italia.
27 La famiglia Marzano era venuta in possesso diSessa nel 1374, «con Tommaso, conte di Alife e di Squil-lace, a seguito della vendita della città da parte della reginaGiovanna I che gli conferì il titolo di duca (…) Nella lottatra angioini e aragonesi per la conquista del regno [Gio-vanni Antonio Marzano, nipote di Tommaso] si schieròal fianco di Alfonso d’Aragona ottenendo onori e gloria,tanto che il figlio Marino non soltanto ebbe in sposa Eleo-nora d’Aragona (che portò in dote Rossano e gran partedella Calabria) ma divenne nel 1453 – alla morte del padre– duca di Sessa e grande ammiraglio». M. VENDITTI, Pre-senze architettoniche tardo-gotiche e catalane in Terra di Lavoro,in C. CUNDARI (a cura di), Verso un repertorio dell’architettura
catalana. Architettura catalana in Campania. Province di Bene-vento, Caserta, Napoli, Subiaco 2005, p. 224.
28 Un’esaustiva trattazione degli elementi architetto-nici di matrice catalana a Sessa Aurunca è in E. CARELLI,Elementi architettonici durazzeschi e catalani a Sessa Aurunca, in“Napoli nobilissima”, III s., xI (1972), pp. 33-45.
29 Ferrante d’Aragona aveva così a cuore il governodi Sessa da raccomandare, il 12 marzo 1493, a Luigi dePaladinis, suo ambasciatore a Roma, di distogliere il papadalla volontà di conquistare la città: «Si che si da sua S.tase li mettesse troppo la fantasia: siate accorti à desviare lacosa: et da tollercela delo animo: che voi ad cio che questecose possano venire ad effecto, essendo in ragionamenti:et domandandose cose notabile, come e dicta cita: et im-possibile ad noi e bene che le desviate: et che sua S.ta vo-glia mettere lanimo ad cosa conveniente: et ragionevole:et dè quelle che noi possiamo fare, et questo tenerite ap-presso voi: che solum ve lo havemo scripto per vostra in-formatione: et ad cioche possate dirizare la mira: et leparole per lo camino che queste practiche possano haverequillo effecto, che se desidera: perche de cose honeste: etconvenibile noi non simo per tornarce in deretro». F.TRINChERA (a cura di), Codice aragonese o sia lettere regie, or-dinamenti ed altri atti governativi de’ sovrani aragonesi in Napoliriguardanti l’amministrazione interna del reame e le relazioni al-l’estero, v. II, p. I, Napoli 1868, p. 324.
30 Tra i territori leborini ottenuti dal Gran Capitano,con privilegio dell’1 gennaio 1507, vi era anche il feudodi Carinola. Per un’organica descrizione degli eventi chehanno caratterizzato la storia di Sessa Aurunca tra il Me-dioevo e l’età moderna cfr. G. DI MARCO, Sessa e il suo ter-ritorio tra medioevo ed età moderna, Marina di Minturno 1995.
31 «Consalvo ha venduto anche la città di Sessa e lavicenda della vendita del feudo, nel 1570, a Luigi Carafadella Marra, principe di Stigliano, al quale aveva già ven-duto Carinola, avrà una ripercussione sulle finanze dellacittà». Ivi, pp. 72-73.
32 I due comuni furono oggetto dell’attenzione deglistessi tavolari, i citati Antonio Galluccio e Lorenzo Rug-giano, operanti tra l’ultimo quarto del Seicento ed il primodel Settecento, i cui apprezzi, molto simili nell’imposta-zione e redatti a pochi mesi di distanza, furono annotatidal notaio Paolo Colacino. I due regi ingegneri furono im-pegnati, insieme, singolarmente o con altri colleghi, anchenegli apprezzi di Alianello, Ardore, Calvello, Campagna,Campolataro, Castelforte, Castelgrande, Caulonia, Ce-lenza, Città Sant’Angelo, Colletorto, Crecchio, Ferrazzano,Fondi (con Itri e Sperlonga), Grottacastagnara, Laviano,Malvito, Monasterace, Montecorice, Montefusco, Monte-malo, Monteverde, Rapone, Riardo, Ripacandida, Rocca-nova, Roccella, Sant’Arcangelo, Sessano, Stigliano, Tito,Torella, Torre a Mare (masseria) e Traetto, dimostrandositra i più attivi del regno e non soltanto limitatamente alla
29
provincia di Terra di Lavoro. Un accurato elenco degli ap-prezzi di svariate università è in G. LABROT, Quand l’histoiremurmure. Villages et campagnes du royaume de Naples (XVI-XVIII siècle), Roma 1995, pp. 585-634.
33 La veduta, contenuta nel foglio 271, è, come quellache raffigura Carinola, inquadrata in un medaglione, ri-tratta accanto a quella di Teano. Caratterizzata dalla tipicarappresentazione “a volo d’uccello”, è delineata con in-chiostro seppia e campita con acquerello color azzurro.«La città viene disegnata all’interno della cornice circolare;quindi lo stesso autore che fornì l’immagine per il testodel Pacichelli dovette, come per tutti i casi simili, ridurreil disegno e renderlo più semplice per adattarlo al RegnoNapolitano Anotomizzato». C. DE SETA, A. BUCCARO (a curadi), op. cit., p. 242.
34 È stato osservato che «il Cassiano ritrae l’insedia-mento da ovest accennando ad una leggera altura ove sa-rebbe sorta Sessa. Nessun riferimento al primitivoimpianto romano; le emergenze indicate sono quasi esclu-sivamente religiose, ad eccezione delle due porte civiche,della torre di San Biagio e del fortilizio». Ivi, p. 243.
35 Per un’analisi comparata delle due vedute, si vedaF. MIRAGLIA, La raffigurazione di Sessa nelle vedute tardoseicen-tesche di Francesco Cassiano de Silva, in “Civiltà Aurunca. Ri-vista trimestrale di cultura”, 81 (2011), pp. 57-65.
36 Cfr. A.M. VILLUCCI, Sessa Aurunca: un itinerario cul-turale, in “Civiltà Aurunca. Rivista trimestrale di cultura”,28 (1994), pp. 15-26.
37 Cfr. C. GIANNATTASIO, Strutture protomoderne in tufonell’area di Sessa Aurunca, in G. FIENGO, L. GUERRIERO,Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Napoli, Terra di La-voro…, cit., t. I, pp. 261-268 e, della stessa autrice, La co-struzione in tufo tra XV e XVI secolo in Terra di Lavoro: SessaAurunca in C. VARAGNOLI (a cura di), Muri parlanti. Prospet-tive…, cit., pp. 111-120.
38 Cfr. L. CRIMACO, Volturnum, Roma 1991 e C. ITE-RAR, Centri di fondazione e di influenza benedettina in Campaniatra IX e XII secolo, in A. CASAMENTO, E. GUIDONI (a curadi), Le città medievali dell’Italia meridionale e insulare (Atti delconvegno, Palermo, 28-29 novembre 2002), Roma 2004,pp. 174-181. Ampi ragguagli sulla storia della città sonoin A. CAPRIO, Castel Volturno. La storia, la cultura, i monu-menti, le famiglie, Napoli 1997, pp. 43-148.
39 «Il castello longobardo fu eretto utilizzando inlarga misura materiali di spoglio (grossi blocchi di tufogiallo stratificato provenienti con tutta evidenza daun’opera quadrata romana; basoli di lava divelti dal lastricodella via Domiziana; frammenti di cocciopesto, mattonispezzati, massi di opera cementizia)». L. GUERRIERO, F.MIRAGLIA, op. cit., p. 114.
40 Nel Dizionario, il Giustiniani riporta i fuochi di Ca-stel Volturno dal xVI al xVIII secolo, riferendo di un’evi-dente riduzione degli stessi sino al 1732: «Vedesi edificatain luogo piano, di aria niente buona, perché dalla parte delMazzone, ed i suoi abitatori ascendono al numero di 370.Nella situazione del 1532 la tassa de’ fuochi fu di 229, del1545 di 276, del 1561 di 224, del 1595 di 253, del 1648 di90, e del 1669 di 84. In quella del 1732 di 92». L. GIUSTI-NIANI, Dizionario geografico…, cit., t. III, p. 368.
41 Cfr. M. RUMOLO, Tipologie edilizie a Pontelatone cometestimonianza storica e culturale, in M. ROSI, Pontelatone e l’areadi Montemaggiore, Napoli 1995, pp. 37-38.
42 Nel Dizionario, il Giustiniani scrive, a proposito diPontelatone, che «negli scorsi tempi era molto popolata,e cinta di mura, avendo nel suo giro un profondo vallone,e vi si entrava per due ponti, ove vedeansi diverse porte,e torri (…) In oggi per la cattiv’aria è ridotta ad averepochi abitanti al numero di 350, insieme col casalottodetto de’ Funari, ch’è a mezzogiorno della medesima. Latassa del 1532 fu di fuochi 60, del 1545 di 66, del 1561 di62, del 1595 di 39, del 1648 di 25, e del 1669 di 55. Si ap-partiene alla famiglia Caraffa de’ principi di Colobrano [siriferisce ai Carafa della Stadera, che detenevano il feudodi Colobraro dalla seconda metà del xVI secolo]». L. GIU-STINIANI, Dizionario geografico…, cit., t. VII, pp. 246-247.
43 M. RUMOLO, Tipologie edilizie a Pontelatone…, cit.,pp. 49-50.
44 Nel Dizionario, a proposito dell’origine di Formi-cola, il Giustiniani scrive: «io non saprei indicare quandofosse mancata la città di Trebola, e incominciata a sorgerenelle sue vicinanze Formicola, e i suoi casali. Non ignorosoltanto, che fin da’ tempi di Guglielmo II [dunque nel xIIsecolo] ella era una baronia, e diceasi baronia feniculi», nonchiarendo il rapporto tra il sito e le preesistenze territoriali.L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico…, cit., t. IV, p. 344.
30
Note sulle tecniche costruttive murarietardo-medievali in Terra di Lavoro
31
Tra il xIV ed il xVI secolo, nel regno di Napoli– in particolar modo per le commesse più im-portanti – si sviluppò, soprattutto durante labreve permanenza dei governanti aragonesi, lapresenza di maestranze riferibili alla cultura co-struttiva di Cava dei Tirreni. Provenienti dalPrincipato Citerior e richiamate dalle fonti stori-che sin dall’xI secolo, erano ben note per la lorogrande esperienza e specializzazione.
Già presenti durante la dominazione an-gioina, spesso in collaborazione con maestranzefrancesi che lavoravano in Italia al seguito deigovernanti d’Oltralpe, finirono poi con l’appog-giare gli Aragonesi, attratte soprattutto dalle si-gnificative esenzioni fiscali che i nuovi signorigarantivano1.
Operarono con metodi allora decisamenteinsoliti, gestendo le commesse al pari di una mo-derna impresa, che anticipava i capitali occor-renti all’acquisto del materiale e delleattrezzature di cantiere, nonché per la manodo-pera, configurando, in tal modo, un vero e pro-prio “rischio d’impresa”. questo metodo,certamente temerario per i tempi, in contestiproduttivi in cui gli operatori agivano ancora insubordine alla committenza, gli consentiva di ot-tenere con maggiore facilità appalti di grandeimportanza.
Ciononostante mantennero, «sino al Cin-quecento inoltrato, taluni elementi dell’organiz-zazione professionale medievale; vale a dire:l’introduzione al mestiere mediante rapporti didiscepolato, istituiti tra elementi affermati e ap-prendisti preadolescenti, con il conferimento daparte dei primi del vitto, dell’alloggio e, a finerapporto, dello “stiglio” degli utensili necessariper l’esercizio dell’arte; la dimora nella casa delmaestro degli allievi e dei dipendenti salariati; laformazione omogenea di muratori e tecnici, conla conseguente diffusione della figura dell’archi-tetto-intraprenditore»2.
Ampiamente citato in letteratura, è l’inte-ressante caso dell’edificazione dell’abbazia di Re-alvalle (Fig. 8), presso Scafati, che vide im-pegnati, al volgere del xIII secolo, artefici pro-venienti da diversi paesi, diretti da protomaestri
francesi. Ai “fabricatores” campani fu affidatala realizzazione dei setti murari, apparecchiati “acantieri”3.
questa diversificazione dei compiti, con larelativa subordinazione cui erano destinate lemaestranze autoctone, era dovuta alla precisavolontà, da parte dei governanti d’Oltralpe, difornirsi di professionalità francesi (provenientiin genere dalla Provenza e, nella gran parte deicasi, protomaestri o incisori) per ricoprire com-piti e funzioni apicali nelle intraprese ediliziereali, utilizzando le presenze del luogo per lavoridi minore difficoltà esecutiva, quali, appunto, larealizzazione degli apparecchi murari.
Insomma, alle maestranze francesi eranoaffidati il controllo del cantiere e l’esecuzionedegli aspetti più complessi dello stesso, mentrei maestri di muro italiani (pugliesi, abruzzesi,lombardi e campani) si occupavano della confe-zione delle opere murarie4.
L’inversione di tendenza avvenuta nell’arcodella dominazione aragonese, oltre che con le ci-tate esenzioni fiscali soprattutto con i grandi ap-palti concessi dalla corte, consentì ai Cavesi diestendere in maniera significativa la propria at-tività.
A tal proposito, è utile ricordare che, tra lafine del xV e gli albori del xVI secolo, propriograzie all’incremento delle commesse favoritodagli Aragonesi, fondamentale nel Mezzogiornofu il ruolo delle corporazioni di fabbricatori, ri-costruite allo scopo di creare un articolato di re-gole che consentisse alle maestranze di muoversipiù agilmente e con maggiori garanzie in unmercato divenuto ormai florido ma anche sog-getto ad una forte pressione della concorrenza.
Tra le ragioni fondanti delle nuove corpo-razioni vi era, pertanto, anche la necessità di nonconsentire l’immissione nel mercato di mae-stranze di provenienza estera.
La Corporazione di Arti e Mestieri diCapua, nata nel 1487, contava la partecipazionedi 29 maestri di muro, tra i quali sei cavesi; inegual misura erano rappresentati i maestri lom-bardi, mentre quelli capuani contavano setteunità. quella di Napoli, nata nel 1508, su 26 ade-
Fig. 8. Scafati (SA), località S. Pietro, abbazia di Realvalle.Si notino gli apparecchi murari “a cantieri” (FIENGO,GUERRIERO, Maestri di muro nella Campania angioina e arago-nese, da DELLA TORRE, MANNONI, PRACChI 1997).
renti, invece, evidenziava la partecipazione diben 22 elementi provenienti dal Principato Cite-rior, tra i quali vi erano certamente cavesi5. que-sto dimostra la loro significativa presenza neiruoli-chiave della classe edile del regno di Na-poli, anche durante il periodo vicereale6.
Un’ulteriore presenza, registrata soprattuttoa Carinola nel xV secolo durante la permanenzaaragonese, favorita senza dubbio dall’interventodi Marino Marzano, che ha lasciato tracce con-sistenti anche a Sessa Aurunca e Pontelatone, èquella di artefici di provenienza catalana, che,come i Francesi nel richiamato caso di Realvalle,certamente impressero la loro cultura costruttivaalle maestranze locali, con le quali si confronta-vano quotidianamente.
Per quanto riguarda l’ampiamente citata –ancorché non compiutamente dimostrata – par-tecipazione diretta di architetti del rango di Guil-lermo Sagrera nelle intraprese costruttive aCarinola (soprattutto per la realizzazione del pa-lazzo Marzano) e, in seguito, di Matteo Forci-manya e di Gil de Luna (questi ultimi riguardola realizzazione del palazzo Petrucci), molto pro-babilmente si trattava di loro pur dotati epigoni,che, mutuando gli insegnamenti dei maestri, neperpetuarono in chiave locale le buone prassi,
come ricordato anche dal Filangieri di Candidain un contributo sul palazzo Marzano, che af-fermava, a proposito delle caratteristiche archi-tettoniche del manufatto, come «il disegnodell’opera debba assegnarsi a lui [il Sagrera],anche se l’esecuzione fu opera di suoi aiutanti econtinuatori»7.
Un altro studioso soffermatosi sulla figuradel Sagrera, lo spagnolo Gabriel Alomar – cheal tempo era commissario generale del patrimo-nio artistico nazionale spagnolo e partecipò nel1964 al II Congresso degli architetti e dei tecnicidei monumenti dal quale scaturì la Carta del Re-stauro di Venezia – attribuisce a Jaume, figlio delmaestro catalano e suo attento seguace, annove-rato tra i continuatori della sua opera presso ilcantiere di Castel Nuovo, l’ideazione, tra le altreopere “minori”, del palazzo “Marzano y Para-scandolo”, erroneamente accorpando, inun’unica struttura, due edifici distinti: il primo,edificato per volontà di Marino Marzano; l’altro,su interessamento di Alfonso V, che pare lo uti-lizzasse come casino di caccia8.
Nei primi decenni del viceregno spagnolo(xVI-xVII secolo), si assiste anche al sensibilesviluppo della trattatistica tecnica. I trattati, verie propri manuali redatti prendendo a modellol’opera vitruviana, furono dapprima diretti «aidotti umanisti committenti, desiderosi di di-sporre di un “catalogo” per le imprese costrut-tive [e, in seguito] ai colleghi progettisti (…) perfornire loro cognizioni teoriche sempre piùcomplesse, da opporre alla semplice capacitàpratica delle maestranze»9.
Oltre ai noti contributi ad opera di LeonBattista Alberti (De re aedificatoria, scritto intornoal 1450 in latino ed edito in italiano nel 1546) edi Palladio (I quattro libri dell’architettura, 1570),cui si aggiunse il trattato di Sebastiano Serlio (Isette libri dell’architettura, 1537-1575), giova in que-sta sede ricordare anche l’opera di VincenzoScamozzi (La idea dell’architettura universale, 1615),nella quale ampie sono le considerazioni sui ma-teriali napoletani e leborini, comprese le varietàdi tufo rinvenibili nei distretti indagati.
Ritornando al xVI secolo, si unì, alle pre-
32
scrizioni vicereali estese con la volontà di rego-lamentare la pratica edilizia (ad opera soprattuttodei viceré Pedro de Toledo e Pedro Afan de Ri-bera), un interessante contributo, scritto dal-l’abate di origini albanesi Giorgio Lapazzaia (oLapizzaia) e titolato Opera d’Arithmetica et Geome-tria con l’usitata prattica Napolitana Nominata il La-pizzaya (1542), che suscitò grande interesse daparte di Pedro de Toledo, che ne patrocinò lapubblicazione, e fu più volte ristampato ed am-pliato, tenendo conto, nelle successive edizioni,anche delle prescrizioni formulate dalla pram-matica di Pedro Afan de Ribera.
L’opera, «partendo da cognizioni elemen-tari di aritmetica e geometria, si fa gradualmentepiù complessa ed è completata dalla proposi-zione di problemi di difficoltà crescente, finoall’applicazione delle nozioni alla misura di“terre, piani e monti”, aree edificabili e fabbrichecittadine (…) Il fine è di insegnare a valutare, intutte le sue componenti, un edificio esistente oda realizzare, prevedendo, in quest’ultimo caso,la quantità di materiale necessaria ed i costi daaffrontare»10.
Ampi i riferimenti anche ai maestri di murocavesi, considerati dall’abate operatori ben inse-riti nell’industria edilizia del regno napoletano.
Dopo la ricostruzione delle corporazioni,dunque, sempre più impellente divenne la ne-cessità di dotarsi di un sistema di regole condi-visibili, sia con lo scopo di limitare al massimoil rischio di frodi nella gestione della filiera edi-lizia sia, soprattutto, con la volontà di standar-dizzare l’uso di buone pratiche nellarealizzazione degli edifici.
Contesto operativo
Nei sub-areali analizzati, includenti i territori ur-bani o di pertinenza dei comuni di Carinola,Sessa Aurunca, Castel Volturno, Pontelatone eFormicola, si è fatto ricorso, durante i secoli dalxIII al xV, ad alcune ben definite tecniche co-struttive murarie, caratterizzate dal preponde-rante utilizzo dell’ignimbrite in facies grigia.
questo litotipo era prelevato, nella stra-grande maggioranza dei casi, essenzialmente dascavi nel sottosuolo a profondità modeste(esempio paradigmatico è la città di Napoli),lungo i fianchi dei rilievi montuosi (come è ac-caduto nell’agro Falerno, nei pressi del massicciomassicano, e nell’area del monte Maggiore) o, inrare occasioni, da cave a cielo aperto, dalle qualiaffiorava e tuttora affiora in grossi banchi (sipensi, a tal proposito, a Carinola, costruita col-tivando un massiccio sperone tufaceo).
La sua agevole reperibilità in situ consentivaun indubitabile risparmio sui costi di trasporto11
e lo sottraeva alle tassazioni cui erano sottopostii prodotti provenienti dai territori limitrofi.
Sempre per ragioni economiche, l’industriaedilizia ne privilegiava l’utilizzo in forme spac-cate e non sagomate, con la sola eccezione –nella gran parte dei casi – dei cantonali, per l’ap-prestamento dei quali erano in genere impiegaticonci ben squadrati.
L’assenza di profilatura, ad ogni modo, ri-guarda prevalentemente il calcare, poiché l’ot-tima lavorabilità dell’ignimbrite campana haconsentito, col tempo, l’instaurarsi ed il perpe-tuarsi di metodologie estrattive sempre più raf-finate, capaci di offrire elementi litoidiaccuratamente sagomati mediante l’uso del-l’ascia o, più frequentemente, della sega12.
Nei distretti analizzati è stata rilevata la pre-senza soprattutto di pietre di tufo grigio cam-pano (ed in piccola quota della variante tufogiallo stratificato) spaccate o rustiche e, in su-bordine, di conci più o meno squadrati. Ciò evi-denzia il ricorso più frequente agli strumenti perla spaccatura della pietra, come la mannara13, piùche alla sega.
Per tale motivo, «nei casi in cui non si feceuso della sega, anche il tufo poté essere soggettoalle operazioni di sbozzo, servendosi dell’asciaoppure della martellina ed operando diretta-mente in cantiere»14.
Per citare qualche esempio, ha interesse se-gnalare che i conci sono stati adoperati, in quan-tità significativa: nell’apparecchio murarioesterno del mastio del castello di Carinola, alle-
33
stito con magistero a filari; in parte della mura-zione carinolese; nella realizzazione di grossi erobusti cantonali, come nel caso del palazzo Pe-trucci, sempre a Carinola; nei palazzi Rotondo,Galpiati e Scirocco a Pontelatone; in episodi rin-venibili a Sessa Aurunca, anche in questo casoporzioni della murazione urbana.
Non è raro ritrovare, altresì, in vari distrettidi Terra di Lavoro, cantonali di tufo grigio cam-pano collocati in strutture realizzate con pietracalcarea, a conferma del prevalente utilizzo deltufo grigio come pietra da sagomare, preferibil-mente collocata nelle angolate come guida perl’iniziale regolarizzazione dell’assetto delle altrepietre.
questa peculiarità si manifesta maggior-mente, per ovvie ragioni costruttive, negli appa-recchi murari “a cantieri”, dei quali si tratterà inseguito.
L’analisi delle tecniche costruttive murarierelative all’arco temporale che va dal xIII al xVsecolo, ricorrenti nei sub-areali di studio, con-dotta sia sugli edifici di ambizioso programma(perlopiù castelli e palazzi nobiliari) sia, soprat-tutto, in ordine all’edilizia “diffusa” (palazzetti,case e masserie), ha dato luogo all’individua-zione di tre magisteri murari – presenti, seppurtalvolta con leggere diversificazioni, anche inaltre aree, riferibili appunto al periodo tardo-me-dievale – ossia: a ricorsi orizzontali periodici (“acantieri”), a corsi più o meno inzeppati e a filaridi conci.
qui giova ricordare il fatto che una delle piùricorrenti alterazioni dei paramenti murari è rap-presentata dalla discutibile iniziativa, all’attualitàsempre più diffusa, anche da parte degli archi-tetti delle soprintendenze, di intonacare, nelcorso dei restauri, ad esempio i paramenti “acantieri” (originariamente a facciavista ovverostoricizzati come tali), lasciando a vista, il piùdelle volte, soltanto i conci squadrati dei canto-nali.
questa pratica, oltre ad alterare o, meglio,a falsare gravemente l’immagine figurale del pa-ramento, gli conferisce anche una fastidiosa in-determinatezza, peraltro cancellando del tutto –o, nei casi meno gravi, obnubilando fortemente– il ritmo dell’apparecchio “a cantieri” ed asse-gnando ai conci dei cantonali – gli unici ancorain vista – soltanto un vago quanto inadeguatoruolo decorativo.
Un’altra frequente azione che causa l’alte-razione degli apparecchi murari storici facciavi-sta è rappresentata dall’utilizzo di malta finecementizia nella ristilatura dei giunti, verticali edorizzontali.
L’intervento in questione, praticato – senzacurarsi di circoscriverlo alle zone murarie real-mente ammalorate – coprendo con abbondantemalta gran parte del materiale, minuto e non, co-stituente il magistero murario “a cantieri”, rendeilleggibile il documento anche a chi sarebbe ingrado di leggerlo.
Provvedimenti di tal genere sono stati os-servati, ad esempio, su brani murari dei castelli
34
Fig. 9. Sinossi e prima classificazione delle tipologie mu-rarie tardo-medievali in Terra di Lavoro (xIII-xV sec.).1) a filari: 1a) in conci; 1b) in bozze e rari conci; 2) a corsicon zeppe: 2a) con prevalenza di bozze; 2b) con preva-lenza di pietre rustiche; 3) irregolare con ricorsi orizzontaliperiodici (“a cantieri”): 3a) con disposizione per fasce; 3b)con disposizione ad incastro (da D’APRILE 2001).
di Sessa Aurunca e Carinola, sul limitato para-mento murario esterno lasciato facciavista delpalazzo Galpiati a Pontelatone e sull’intero pa-ramento esterno delle torri Marzano a Pontela-tone e dei Cappuccini a Sessa Aurunca.
Magisteri murari ricorrenti nei sub-areali di studio
Si è già ricordato che le murature in tufo rinve-nibili nei distretti analizzati rimandano essenzial-mente a tre tipologie fondamentali: a ricorsiorizzontali periodici (“a cantieri”), a corsi conzeppe e a filari di conci (Fig. 9).
La prima, detta appunto in letteratura “acantieri”15 (Fig. 10), è caratterizzata dalla pre-senza, sugli opposti paramenti e «ad intervallivariabili, di evidenti cesure orizzontali nell’appa-recchio murario, segnalate dal materiale minutodi pareggiamento e dal doppio strato di maltautilizzato per regolare l’assisa inferiore ed allet-tare il pietrame di quella successiva. Vi si os-serva, inoltre, l’impilaggio degli elementi ap-partenenti alla medesima partita di muro (…)l’altezza dei ricorsi, le modalità di lavorazione el’assortimento volumetrico del pietrame e il ma-gistero sono correlati alla dimensione trasversaledei setti»16.
Negli apparecchi murari “a cantieri” bendefiniti, quando non alterati da rinzaffi di maltafine cementizia frutto di discutibili interventicontemporanei di cui si è poc’anzi fatto cenno,è possibile ancora agilmente notare i due stratidi malta sovrapposti, a distanze più o meno re-golari, presenti tra un ripianamento e l’altro.
questo magistero murario, diffuso nell’in-tera regione campana, «ha dato luogo a para-menti ad opera irregolare, con orizzontamentidistanziati da poco più di trenta centimetri a ses-santa ed oltre. Per la sua realizzazione, il maestromuratore allestiva contemporaneamente due otre ricorsi di pietre di tufo, di solito sbozzatenelle facce esterne e di appoggio. Ne derivavaun apparecchio disomogeneo, con conci impilatiin verticale, giunti non sfalsati, letti di maltagrossi e ricchi di asche di pareggiamento»17.
Sulla scorta di queste informazioni si puòaffermare, dunque, che ciascun cantiere «è unagrossa partita di fabbrica (…) solitamente costi-tuita da due o tre ricorsi di pezzi irregolari, as-semblati senza eccessiva preoccupazione per laloro giacitura orizzontale e, soprattutto, per glisfalsamenti dei giunti verticali»18.
Le murature “a cantieri” «recano, in media,i volumi maggiori in corrispondenza delle partiinferiori della fabbrica, utilizzando, man manoche si procede verso l’alto, quelli più piccoli»19.
Nel comporle, il maestro di muro «appron-tava contemporaneamente l’intero spessore delsetto, senza sostanziali disomogeneità costrut-tive tra i paramenti ed il masso interno, pur col-locando in quest’ultimo il materiale più piccoloed irregolare»20.
In base alla disposizione del materiale li-toide21 si possono realisticamente distingueredue tipi di magisteri “a cantieri”: a fascia e ad in-castro. Nel primo caso, le pietre sono apparec-chiate seguendo un andamento orizzontalequanto più accurato possibile, che spesso nondipende dalla configurazione del nucleo mura-rio, quest’ultimo apprestato in maniera meno re-golare, tramite l’utilizzo di materiale di diversafoggia. Nel secondo caso, gli elementi litoidisono sistemati secondo un assetto non precisa-mente allineato, dovuto, anche e soprattutto, allenecessità di incastro con i componenti delmasso interno22.
L’altezza dei “cantieri” dipendeva da varifattori, riguardanti principalmente: la predispo-sizione delle buche pontaie, in generale ubicatein corrispondenza degli orizzontamenti; le di-mensioni dei blocchi dei cantonali, spesso inta-gliati a spigolo vivo; la forma e la dimensione,dunque la collocazione, dei costituenti.
ha interesse rilevare, a tal proposito, che larealizzazione del tipo strutturale in causa, so-prattutto se di spessore cospicuo, impegnava«due squadre di artefici (ciascuna costituita daun maestro di muro e da almeno due manovali),che lavoravano contestualmente sugli oppostiparamenti, disponendo opportunamente il pie-trame di ingranaggio»23.
35
In definitiva, la concomitanza di tutti questifattori ha dato luogo, nei sub-areali di studio, a“cantieri” – apparecchiati generalmente con dueo al massimo tre allineamenti di elementi litoidi,ai quali è sovrapposto materiale minuto di pa-reggiamento – di altezza non uniforme, purnell’ambito di periodi storicamente determinati,ad ogni modo rientranti in tipologie costruttiveconsimili e realizzati, nella stragrande maggio-ranza dei casi, secondo multipli del palmo na-poletano codificato nel periodo della domina-zione aragonese (0,263676 m)24.
Attuando la suddetta tecnica si poteva uti-lizzare – a differenza di quanto accadeva nelcaso di altri magisteri murari, che esigevano l’uti-lizzo di elementi scaturiti da più accurata lavo-razione – tutto il materiale disponibile, conevidente risparmio di risorse e di tempo.
La possibilità di non dover procedere a co-stose e meticolose operazioni di sagomaturadella risorsa lapidea, infatti, e quindi di non ge-nerare consistenti avanzi di lavorazione, rendevail lavoro delle maestranze sensibilmente più age-vole. Tanto più che, non essendo necessario ri-spettare il corretto sfalsamento dei giuntiverticali, si potevano utilizzare, senza particolariaccorgimenti, anche materiali di foggia irrego-lare.
Per tali motivi, il magistero “a cantieri” harappresentato, almeno sino all’età modernaavanzata25, sia nei sub-areali de quo sia nell’interoregno di Napoli e, in definitiva, in diverse altrearee della Penisola, la tecnica costruttiva larga-mente preferita da maestranze e committenza,persino in manufatti aulici, come quelli analizzatiin questa sede26.
36
Fig. 10. Ricostruzione delle fasi di realizzazione di unamuratura “a cantieri” con scheggioni calcarei di dimen-sioni medie e piccole. Lo schema illustra l’allestimento didue ricorsi sovrapposti (elab.: A. Manco; da Scala nel Me-dioevo 1996).
L’apparecchio murario “a cantieri”, a se-guito di recenti sperimentazioni in laboratorioeffettuate su costituenti di tufo giallo, ha dimo-strato, tra l’altro, una resistenza a compressionemaggiore rispetto a due diversi apparecchi mu-rari, realizzati con “bozzette” e “blocchetti”,dunque con l’utilizzo di elementi litoidi frutto diuna più accurata lavorazione, apprestati anchecurando lo sfalsamento dei giunti verticali. Perle verifiche sono stati creati opportuni macro-modelli.
Per le murature “a cantieri” e con “boz-zette” sono stati utilizzati elementi di tufo giallonapoletano estratti e lavorati nel xVII secolo,provenienti da una cava sotterranea situata nelborgo dei Vergini a Napoli, al disotto del can-tiere vanvitelliano della chiesa dei padri dellaMissione, a suo tempo accatastati, e non più uti-lizzati, per l’ampliamento settecentesco del com-plesso; per quelle con “blocchetti”, invece,costituenti di tufo giallo provenienti dalla cavadi qualiano, resi disponibili dalla demolizione diun muro realizzato nel 1891 nel complesso mo-nasteriale di S. Lorenzo ad Septimum in Aversa.
Per l’apprestamento dei “cantieri” sonostate utilizzate, dopo accurata selezione, “pietrerustiche”, “spaccate”, “spaccatelle” ed “asche”,mentre per la muratura con “bozzette”, “spac-catelle” e “pezzi”.
La resistenza a compressione dei “cantieri”ha raggiunto un valore di 3,97 N/mm2, quelladella muratura con “bozzette” di 3,09 e, infine,quella della muratura con “blocchetti” di 2,65. Irisultati dimostrano, come si può agilmente con-statare, un’evidente primazia dell’apparecchiomurario “a cantieri”27.
Le murature del secondo tipo, a corsi conzeppe, invece, sono caratterizzate, in corrispon-denza dei paramenti, da corsi di pietre perlopiùsbozzate, a loro volta generalmente suddivise indue tipologie principali: a corsi sub-orizzontalio sdoppiati e convergenti.
La prima tipologia presenta tessiture conandamento massimamente tendente all’orizzon-talità, nelle quali si registra una scarsa presenza– o la completa assenza – di elementi di foggia
irregolare. Il filare così composto è regolarizzatoda allettamenti di malta e con l’utilizzo di “in-zeppature” di materiale minuto, scaglie e fram-menti vari, ma anche di diverse qualità dielementi fittili.
La seconda, invece, realizza apparecchi mu-rari con una diffusa presenza di pietre irregolari,periodicamente orizzontati dal massiccio inseri-mento di zeppe. In questa tipologia, general-mente ricorrente solo in sezioni murarie limitate,i corsi si sdoppiano per poi convergere in ununico elemento lapideo.
Le due tipologie succitate possono ritro-varsi anche concomitanti nelle murature, in virtùdi particolari necessità costruttive, e intessonotra loro strette relazioni28.
I corsi possono, altresì, presentarsi sottoforma di porzioni di ricorsi periodici, con i qualicondividono gran parte delle peculiarità costrut-tive, dando vita ad un magistero murario chepuò definirsi “misto”, nel quale i ricorsi, solita-mente di altezza contenuta entro i 50-52 cm,contengono corsi intermedi, perlopiù sub-oriz-zontali.
A tal proposito, è doveroso precisare cherari sono stati, nei sub-areali di studio, i ritrova-menti di apparecchi murari a corsi sovrappostidi bozze; nella maggioranza dei casi riferiti aquesto tipo di murature, invece, ci si è trovati di-nanzi a “cantieri” apprestati mediante l’utilizzodi bozze con zeppe.
Infine, le murature afferenti al terzo tipo,ossia quelle a filari di conci, che configuranoogni orizzontamento alto quanto un solo costi-tuente, contemplano l’uso di conci di tufo bensquadrati, in genere con spigoli tendenzialmentevivi e con cinque delle sei facce spianate. Lasesta faccia è quella posta a contatto con il nu-cleo murario, di solito costituito da elementi solosbozzati, rustici o spaccati, unitamente ad ab-bondante quantità di malta.
La decisione di non spianare quest’ultimafaccia, come è ben noto, non è originata da mo-tivi di ordine economico, bensì da ragioni co-struttive: una superficie scabra, infatti, favoriscel’adesione della malta all’elemento litoide, ren-
37
dendo più resistente il muro. Altro accorgi-mento, non presente nelle murature “a cantieri”né in quelle a corsi per via delle loro particolaricaratterizzazioni costruttive, è la grande atten-zione allo sfalsamento dei giunti verticali, neces-sario a garantire una corretta distribuzione deicarichi.
La lavorazione dei conci da squadrare eraoperazione impegnativa ed onerosa, consistendoin un lavoro lungo e preciso, che necessitava delcoinvolgimento di maestranze qualificate, a dif-ferenza di quanto avveniva nell’allestimento dimateriale spaccato o sbozzato29.
Dopo aver analizzato la caratterizzazionedei magisteri murari tardo-medievali riscontrati,nell’ambito dell’edilizia, nell’area di studio, ha in-teresse anatomizzare con attenzione gli elementilapidei che li compongono.
Dalla forma e dalle dimensioni di questi ul-timi, infatti, è possibile condurre un’agile diver-sificazione dei materiali utilizzati per larealizzazione dei manufatti. È utile considerare,a tal proposito, che la preparazione preventivadelle pietre, che fosse fatta in cava o in cantiere,aveva significative ripercussioni anche sulle mo-dalità di esecuzione.
Iniziamo con l’osservare, dunque, che lepietre di tufo, destinate alle costruzioni edestratte dalle cave generalmente urbane, ossia le“spaccate”, secondo antiche consuetudini napo-
letane, erano classificate in categorie dimensio-nali codificate dalla nota prammatica del 27 ago-sto 1564, la prima della serie De Tabulariorumcollegio, promulgata dal viceré Pedro Afan de Ri-bera, al fine di disciplinare, attraverso un nuovomodo di riformare le misure, l’attività di maestri fab-bricatori, pipernieri, mastri d’ascia, calcari e ta-gliamonti30.
Le due categorie di base includevano, ri-spettivamente, la “pietra spaccata” (52 cm dilunghezza – pari a due palmi napoletani, 35 dilarghezza e 13 circa di altezza – pari a ½ palmo)e il “pezzo” (39 x 35 x 13 cm circa). Da questi,a seguito di ulteriori spacchi, erano ricavati: gli“spaccatoni”, ossia pezzi speciali, utilizzati inparticolar modo nei cantonali, di altezza limitata(circa 13 cm), con rapporto tra base ed altezzadi circa 1:4, quindi assimilabili alle “pietre spac-cate”; le “spaccatelle” (35 x 26 – pari ad unpalmo – x 13 cm), prodotte dal frazionamentodelle “spaccate” di cava, di uso corrente nell’edi-lizia, grossolanamente profilate nelle facceesterna e di appoggio; le “pietre rustiche”, com-plessivamente irregolari, comunque nella faccia-vista tendenti al quadrato (con altezza pari a18-20 cm) o a forme poligonali (in genere trian-golari o trapezoidali), spesso provenienti dallospacco di cava.
Infine, vanno ricordate le “asche”, elementiminuti risultanti dal recupero di scarti ottenuti
38
Fig. 12. Principali attrezzi dello scalpellino: a-b) subbia apunta fine e grossa; c) scalpello accapezzatore; d)-e) scal-pelli a taglio stretto e largo; f) calcagnolo o dente di cane;g) gradina; h) ugnetto; i) gorbia o ferro tondo (da MENI-CALI 1992).
Fig. 11. Principali strumenti a manico per la lavorazionedella pietra: a-b) mazze; c) mazzuolo di ferro dolce perscalpellare; d) maglio; e-f) martelli a due punte; g) mazzaa testa concava per squadrare; h) testa per sbozzare gli spi-goli; i) martello a taglio dritto per pietre tenere; l) martelloa taglio dentellato per pietre dure; m) martello a tagliomisto; n) martellina; o) martellina dentata; p) bocciarda atesta piana; q) bocciarda a testa convessa (da MENICALI
1992).
dalla cavatura e sgrossatura del pietrame piùgrosso, a cui si conferiva una sagoma vagamentecuneiforme, utilizzate per colmare i vuoti trapietra e pietra nell’apparecchio murario31.
Viceversa i conci erano il risultato di un ac-curato lavoro di sagomatura, cui faceva seguitouna meticolosa azione per “allisciarne” le super-fici a vista, così da renderli il più possibile rego-lari, di forma cubica o a parallelepipedo, ingrado quindi di dar vita a paramenti organizzatiper filari, quanto più possibile paralleli e lineari.
Gli attrezzi di cantiere (Figg. 11-12) per lalavorazione dei conci erano: lo scalpello, perasportare le parti di materiale superfluo, utile so-prattutto per la realizzazione degli spigoli delconcio; il mazzuolo, di legno o di ferro, per la bat-titura dello scalpello sull’elemento litoide; lasquadra, per assicurarne la perpendicolarità tra lefacce; la riga, per definirne i contorni.
Un ulteriore intervento era necessario perassicurare la spianatura della facciavista del con-cio. In tal caso, si utilizzavano generalmente lapunta (o subbia), per levigare grossolanamente, ela gradina, con punta a forma di forchetta, per ri-finire la superficie.
Nel caso del tufo, più lavorabile del calcaree per tale motivo da sempre qualificato come ot-tima pietra da taglio, frequente era anche l’uti-lizzo di strumenti per l’abrasione, quali la citatasega, per tagliare la pietra secondo piani ben de-finiti.
L’apparecchio murario così lavorato potevaavere una configurazione “allisciata” o “ad esal-tazione”; nel primo caso, i giunti di malta eranoportati a filo del paramento, così da ottenere l’ef-fetto di una superficie senza soluzioni di conti-nuità e ben spianata; nel secondo, invece, erapreferito l’utilizzo di conci a bugnato, così daesaltare il rapporto tra pietra e malta, offrendouna visione tridimensionale dell’insieme.
Al riguardo, è stato osservato che in Terradi Lavoro, nella totalità dei muri «che utilizzanoquesto apparecchio, anche quando in calcare, iparamenti realizzano, inoltre, delle semplici fo-dere, mediamente ad una o due “teste”, conspessore compreso tra circa 20 cm, invero assai
raro, e 50-55 cm. La solidarietà al nucleo è assi-curata da un numero piuttosto variabile di morse,in ragione della qualità della confezione. Le im-morsature sono realizzate con pietre di fabbricacorrenti, inserite di punta al paramento, talvolta,probabilmente anche con lunghezze maggioridelle corrispondenti misure comuni»32.
Ciononostante, questo accorgimento nonha impedito, in un largo numero di casi, il di-stacco tra il paramento in conci ed il nucleo mu-rario.
Con tali premesse risulta evidente che laforma e le dimensioni delle pietre impiegate po-tevano variare in maniera sostanziale, in virtù deltipo di magistero murario adottato, per ragionidi ordine soprattutto strutturale.
In particolare, nei distretti di studio, ri-guardo l’arco temporale prescelto si ritrova, nelcaso dei magisteri “a cantieri”, essenzialmentepezzame spaccato e rustico, cui si aggiungonovarie componenti minute, utilizzate per rendereorizzontale il piano superiore di ciascun “can-tiere”, quali “asche”, elementi fittili, etc. Si regi-stra anche la presenza, in quantità contenuta, dimateriale erratico, di piccola dimensione.
Nel caso dei magisteri murari a corsi conzeppe, invece, si riscontrano in prevalenza pietresbozzate, perlopiù assimilabili a quelle rustiche.
Infine, in quelli a filari di conci, questi sonoben squadrati; sovente la loro faccia esterna èanche allisciata, mentre le altre sono sufficiente-mente preparate così da potersi inserire con pre-cisione nell’ordito murario. La faccia a contattocon il paramento interno, per ovvi motivi legatial corretto ingranaggio dei costituenti, è invecegrossolanamente sbozzata.
Altra indagine necessaria, dal punto di vistacostruttivo, riguarda le caratteristiche dei nucleimurari (Fig. 13). Purtroppo, non è frequente lapossibilità di poter esaminare brecce murarie.Comunque, i ruderi tardo-medievali individuatihanno rivelato, relativamente ai nuclei dellestrutture, tre diverse confezioni: a sacco; incastrata;costipata.
Nella prima produzione, senza dubbio lapiù celere dal punto di vista costruttivo, la malta
39
Fig. 13. Classificazione dei nuclei murari delle strutturetardo-medievali in Terra di Lavoro. a) a sacco; b) inca-strato; c) costipato (da D’APRILE 2001).
è abbondante ed il materiale litoide non è sem-pre adeguatamente ammorsato. In questo tipodi lavorazione, infatti, il nucleo viene realizzatoin maniera indipendente dai due paramenti, de-notando in ciò un’evidente fragilità della confe-zione, in genere priva di ammorsature.
La seconda, maggiormente impegnativa ecostosa, perché prevede il lavoro di più maestridi muro e manovali contemporaneamente, madotata di maggiore resistenza, si rinviene in mu-rature di spessore contenuto (in genere 50-60cm) ed è confezionata con elementi litoidi,molto semplicemente sbozzati, sistemati, neidue paramenti, tra loro sfalsati ed includenti pe-riodici pezzi collocati di punta33, così da superarela metà dello spessore della sezione muraria, cre-ando un robusto ammorsamento con il ridottonucleo. questo tipo è certamente il più resi-stente, anche se sconta la citata restrizione in or-dine allo spessore murario.
La terza, ricorrente in tutta la Terra di La-voro, preferita nel caso di spessori murari con-sistenti, è invece ottenuta sistemando, in maltaabbondante, elementi lapidei di forma irrego-lare, compattati «ad altezza periodica, in media,corrispondentemente agli allettamenti presentisui paramenti»34. L’ammorsamento tra i para-menti ed il nucleo avviene tramite sporadici ele-menti collocati di punta, ben compattati insieme
alle pietre, di varia forma e dimensioni, sistematinel nucleo, definito “costipato” perché soggettoa battitura affinché la malta penetri nei vari in-terstizi presenti tra le pietre.
Nell’area di studio, invero, è stata rinvenuta,a causa degli spessori significativi delle muraturepresenti, una consistente quantità di nuclei mu-rari “costipati”, a fronte di uno scarso numerodegli altri due tipi di confezione.
Per un corretto ed agevole apprestamentodelle murature era essenziale, oltre che – comepoc’anzi accennato – una congerie di utensili,adatti ai vari scopi ed alle diverse risorse lapidee,anche e soprattutto una struttura di sostegno pergli operai impegnati nel cantiere: l’impalcatura,la quale, similmente a quanto avviene all’attua-lità, consentiva di velocizzare i lavori e garantivamargini accettabili di sicurezza per gli interventicondotti ad altezze significative.
Nel cantiere medievale le tipologie ricor-renti per l’allestimento di impalcature, mutuateda tecniche già ampiamente sperimentate inepoche precedenti e perfezionate in relazione alcontesto operativo, erano sostanzialmente didue tipi, entrambi realizzati facendo ricorso adelementi lignei: indipendenti e dipendenti (o in-castrati).
Il primo tipo, autonomo dall’organismoedilizio che si intendeva fabbricare, era utilizzato
40
per le intraprese costruttive più delicate, in par-ticolar modo quelle riguardanti l’intonacatura ola tinteggiatura. Le impalcature indipendenti di-sponevano di elementi verticali, i montanti, edorizzontali, i tavolati, sostenuti da correnti e tra-vicelli, ed erano irrobustite facendo ricorso adelementi obliqui, le saette.
Il secondo tipo era invece addossato al ma-nufatto da erigere e, via via che questo venivaedificato, era approntato ad un’altezza sempremaggiore. Più robusto del precedente, consen-tiva, cosa di non poco conto, anche un facile riu-tilizzo, con evidente risparmio sui costi diproduzione. L’impalcatura dipendente, in mag-giore misura pertinente ai fini del presente stu-dio, era largamente utilizzata nei sub-arealianalizzati, come conferma la presenza di molte-plici fori d’andito, le cosiddette buche pontaie,praticati per assicurarla all’organismo edilizio.
Le buche pontaie erano ottenute lasciando,durante le fasi di allestimento del muro, un foro– tondo o quadrato in virtù della forma deglielementi lignei di cui si aveva disponibilità – tragli elementi lapidei, di profondità necessaria al-l’alloggiamento dei travicelli (generalmente paria 40 cm circa), sui quali veniva poi montato il ta-volato per consentire alle maestranze il correttosvolgimento dei propri compiti.
Le buche pontaie dovevano essere impian-tate a distanze, orizzontali e verticali, quanto piùsimmetriche possibile, per rendere più agevolel’installazione dell’impalcatura; nei sub-areali distudio questa precisione nella loro collocazione,invero, è abbastanza rara, a dimostrazione delfatto che diversi manufatti indagati sono stati,evidentemente, oggetto di più interventi costrut-tivi, che hanno necessitato l’impegno di diffe-renti maestranze e la collocazione di nuoviponteggi, posti ad altezze e distanze diverse daquelli precedenti.
Altrettanto rara è la presenza di fori conforme e dimensioni tra loro identiche, a con-ferma del riutilizzo degli elementi lignei, costi-tuenti l’incastellatura, in altri cantieri.
In talune circostanze, soprattutto nel casodi manufatti a destinazione militare, nei quali
prioritarie erano le necessità difensive, le buchepontaie venivano celate con opportuni riempi-menti di materiale litoide e malta o realizzate adaltezze elevate, per evitare che, in caso di attacco,i nemici potessero utilizzarle come facile appog-gio per risalire il muro35.
Nei distretti analizzati, grazie all’esame dellacollocazione delle buche pontaie, si è potuto de-terminare che i ponteggi erano generalmenterealizzati in due forme distinte: a singola fila dimontanti e a sbalzo (Fig. 14).
Nel primo caso, veniva approntata un’unicafila di costituenti verticali, spesso irrobustita daun elemento obliquo conficcato nel terreno, ag-ganciata poi al muro con l’ausilio di componentiorizzontali, i travicelli. questo tipo di impalca-tura, per ovvie ragioni statiche, non era preferitaquando si doveva lavorare ad altezze elevate.
Nel secondo caso, i travicelli erano ancorati,ad un’estremità, alla muratura, e all’altra, ad unelemento obliquo, la saetta, così da scaricare sulmuro il peso del tavolato superiore. quest’ul-tima soluzione era largamente preferita dallemaestranze, perché consentiva di lavorare, in di-screte condizioni di sicurezza, soprattutto neicasi in cui era necessario operare ad altezze mag-giori. I vari livelli delle impalcature erano colle-gati tra loro da scale verticali o inclinate o dasuperfici inclinate.
Note:1 «Le condizioni economiche del centro cavese al-
l’affermarsi della corona aragonese rappresentarono, dicerto, un fattore di slancio per l’attività edilizia locale e perl’ulteriore espansione del relativo mercato. La regione sitrovò, di fatto, in una situazione di semi-autonomia am-ministrativa, dal momento che, sebbene vassalli dellaBadia filoangioina, i Cavesi parteggiarono, invece, per inuovi dominatori, appoggiandone concretamente l’azionedi conquista». M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…,cit., p. 154.
2 G. FIENGO, L. GUERRIERO, Maestri di muro nellaCampania angioina e aragonese, in S. DELLA TORRE, T. MAN-NONI, V. PRACChI (a cura di), Magistri d’Europa. Eventi, re-lazioni, strutture della migrazione di artisti e costruttori dai laghilombardi (Atti del convegno internazionale, Como 1996),Como 1997, p. 183. Il testo (pp. 177-192) contiene ampi
41
ragguagli sui magistri cavesi. Si vedano anche P. PEDUTO,Nascita di un mestiere. Lapicidi, ingegneri, architetti di Cava deiTirreni (secc. XI-XVI), Cava dei Tirreni 1983 e G. FIENGO,Cronologia dei paramenti murari napoletani moderni, in G.FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Murature tradizionali na-poletane…, cit., pp. 9-68, in particolare i paragrafi: La tra-dizione costruttiva napoletana e l’ambiente angioino; Dal cantiereangioino al cantiere aragonese di Castelnuovo; I maestri cavesi e l’in-dustria edilizia meridionale moderna.
3 Cfr. G. FIENGO, L. GUERRIERO, Maestri di muro…,cit., p. 182.
4 Cfr. M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…, cit.,pp. 148-150.
5 Cfr. G. FIENGO, L. GUERRIERO, Maestri di muro…,cit., p. 187.
6 Si veda F. STRAzzULLO, Edilizia e urbanistica a Napolidal ‘500 al ‘700, Napoli 1995, specificamente il paragrafo:La corporazione dei fabbricatori, pp. 61-76.
7 R. FILANGIERI DI CANDIDA, La casa di Marino Mar-zano Principe di Rossano in Carinola, in AA.VV., Miscellaneain onore di J. Puig y Cadafalch, Barcelona 1947-1951, p. 40.Sulla figura del Sagrera si veda anche G.E. STREET, Some
account of Gothic architecture in Spain, London 1865, pp. 324,337, 456-458, 514, 516.
8 G. ALOMAR, Los discipulos de Guillermo Sagrera en Ma-llorca Napoles y Sicilia (I), in “Napoli nobilissima”, III s., III(1963-64), p. 89. Come ricordato in altra sede, «la foto acommento del testo (p. 88, Fig. 6) non ritrae il palazzoMarzano, bensì il palazzo Petrucci, denotando, oltre al-l’errata denominazione, un’ulteriore svista da parte del-l’autore, che, probabilmente, non visitò Carinola e le suearchitetture catalane, utilizzando documenti e foto di altristudiosi». F. MIRAGLIA, Palazzo Marzano a Carinola: i restauridegli anni Trenta del Novecento, in “Civiltà Aurunca. Rivistatrimestrale di cultura”, 84 (2011), p. 45, n. 4.
9 M. RUSSO, Aspetti della cultura costruttiva napoletanatra XVI e XVII secolo, in “Napoli nobilissima”, IV s.,xxxVII (1998), p. 215.
10 IVI, pp. 223-224.11 Il cantiere medievale è generalmente «povero, con-
traddistinto dalla difficoltà di trasporto di materiali e mae-stranze, dalla forte presenza di manodopera pocospecializzata, dalla “lunga durata” di modalità e tradizionioperative. Solo alcune eccezioni, soprattutto costituite
42
Fig. 14. 1) impalcatura a incastro; 2) impalcatura a sbalzo(da ADAM 1988).
dalle grandi fabbriche monastiche e dai principali edificireligiosi e civili, presentano accorgimenti tecnici partico-lari, indicativi di sofisticati intenti estetici oltre che costrut-tivi, della presenza di maestranze itineranti e specializzate,di “eventi” che in qualche modo interrompono e stravol-gono il flusso di tradizioni ed esperienze specifico d’undeterminato ambiente. questi due ambiti non vivono se-parati tra loro, ma, al contrario, presentano una sensibileosmosi di persone e di tecniche, creano “ibridi”, lascianotracce e contaminazioni rilevabili, a un’attenta lettura, sullostesso tessuto murario». D. FIORANI, Le tecniche costruttivemurarie medievali del basso Lazio, in S. DELLA TORRE (a curadi), Storia delle tecniche murarie e tutela del costruito. Esperienzee questioni di metodo (Atti del Convegno, Brescia 1995), Mi-lano 1996, p. 98.
12 «Largamente utilizzata già dai Romani, la segatura,adottata sia per le pietre tenere sia per le dure, impiegavauno strumento con lama, liscia o dentata, montata su untelaio ligneo provvisto, alle estremità, di due manici, sì daconsentire l’impugnazione contemporanea da parte di dueoperai. Rispetto alla spaccatura, tale procedura risultamolto più vantaggiosa in quanto, anche se in tempi piùlunghi, permette di ricavare i blocchi agendo lungo qual-siasi direzione, garantendo, dunque, il massimo rendi-mento possibile, riducendo vieppiù gli scarti dilavorazione». M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…,cit., p. 172.
13 La mannara o mannaja era conformata «a testa qua-drata ed a scure, con taglio diritto, destinata tanto allospacco quanto allo sbozzo». Ivi, p. 173.
14 Ivi, p. 174.15 La particolare denominazione deriva dal fatto che,
generalmente, l’apprestamento di una partita muraria cor-rispondeva ad un’unità lavorativa, probabilmente a ca-denza giornaliera, nel cantiere dei lavori. Terminata labancata, il giorno successivo si partiva da questa, dopoaver provveduto ad assicurare un ulteriore allettamento dimalta per la posa delle pietre, così da realizzare la succes-siva. La definizione degli apparecchi murari “a cantieri”origina dagli studi di: E. BURATTINI, G. FIENGO, L. GUER-RIERO, Murature tradizionali napoletane: problemi di datazionee formazione di una “base di conoscenza”, in A. GISOLFI (a curadi), Multimedia. Beni culturali e formazione (Atti del ConvegnoNazionale “Sistemi multimediali intelligenti. Multimediae beni culturali. Multimedia e formazione”, Ravello 1994),CUEBC, Salerno 1994, pp. 186-194; E. BURATTINI, G.FIENGO, L. GUERRIERO, Expert systems in the building conser-vation process, in M. MORONI, P. SARTORI (a cura di), Procee-dings of the International Symposium “Dealing with defects inbuilding”, Varenna 1994, pp. 303-312. La definizione hatrovato, altresì, una compiuta sistemazione in L. GUER-RIERO, Note sugli apparecchi murari della costiera amalfitana: ilcaso di Pontone, in Scala nel Medioevo (Atti delle Giornate In-
ternazionali di Studio, Scala 1995), Amalfi 1996, pp. 231-249. Ampi ragguagli sull’argomento sono in M. RUSSO,Apparecchi murari “a cantieri” del XVI secolo in Napoli, in S.DELLA TORRE, op. cit., pp. 83-96, G. FIENGO, L. GUER-RIERO, Maestri di muro…, cit., pp. 177-192, M. RUSSO, Ma-gisteri murari “a cantieri” nell’età del viceregno spagnolo, in G.FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Murature tradizionalinapoletane…, cit., pp. 71-151 e G. FIENGO, L. GUERRIERO,Mensiocronologia delle murature napoletane in tufo giallo (XVI-XIX), in S. D’AVINO, M. SALVATORI (a cura di), Metrologiae tecniche costruttive (Atti della Giornata di Studio, Pescara1998), Roma 1999, pp. 29-36.
16 L. GUERRIERO, G. CECERE, op. cit., pp. 127-128.17 G. FIENGO, Cronologia dei paramenti murari napoletani
moderni, in G. FIENGO, L. GUERRIERO, Murature tradizionalinapoletane…, cit., p. 67.
18 M. RUSSO, Magisteri murari “a cantieri”…, cit., pp.126, 128.
19 M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…, cit., p.267.
20 L. GUERRIERO, Note sugli apparecchi murari della Co-stiera amalfitana…, cit., p. 235.
21 «Un’accentuata eterogeneità volumetrica e, quindi,dimensionale degli elementi litici – tale da associare, adesempio, masse medie e medio-grandi a pietrame minuto,utilizzato non soltanto come zeppe ma anche come ma-teriale costituente – comporta, in generale, un allesti-mento più irregolare, nel quale, quasi a mò di puzzle, lesuperfici lapidee adiacenti, diversamente inclinate, sonopredisposte, cioè, in modo da realizzare il maggior con-tatto possibile. Viceversa, il ricorso a volumetrie tenden-zialmente omogenee facilita la messa a punto didisposizioni di geometria appena più regolare, nelle qualiè frequente l’allineamento orizzontale e verticale dei co-stituenti». M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…, cit.,p. 268.
22 Cfr. Ivi, p. 271. Un recente studio sulle muraturein calcare di Terra di Lavoro informa come «la tendenzaall’impilamento delle pietre rustiche, l’adozione generaliz-zata di nuclei in materiale grezzo (…) – eterogeneo pervolumi e qualità, associato ad impasti di granulometriatendenzialmente medio-grande – confezionati spesso se-paratamente ma costipati ogni due ricorsi rappresentanole più tipiche connotazioni degli apparecchi datati alla finedel xIII ed al xIV secolo», ribadendo che «molti degliesemplari in calcare del xV secolo (…) hanno rivelatoquindi partiti murari complessi in pietre rustiche apparec-chiate “a cantieri” – secondo allineamenti sdoppiati e,quando di volumi eterogenei, anche tendenzialmente im-pilati – orizzontate ogni due, tre o anche quattro file, incoincidenza della posizione assunta da eventuali concisulle angolate o da altri elementi squadrati, determinantiper l’apprestamento delle giaciture orizzontali. In questi
43
casi, gli allestimenti descritti non divergono, allora, inmodo sostanziale dalle modalità realizzative già indicateper le tessiture trecentesche». M. D’APRILE, Murature tar-domedievali in calcare di Terra di Lavoro, in G. FIENGO, L.GUERRIERO (a cura di), Atlante delle tecniche costruttive tradi-zionali. Napoli, Terra di Lavoro…, cit., t. I, pp. 73, 75. que-ste considerazioni trovano larga conferma anche perquanto riguarda gli apparecchi murari “a cantieri” in tufogrigio campano riferibili ai periodi poc’anzi citati, i quali,sebbene costituiti da un diverso litotipo, mostrano carat-teristiche ben similari, attestando, in generale, una conver-genza tra le tecniche costruttive trecentesche e quellequattrocentesche.
23 L. GUERRIERO, P. LENzA, Le murature storiche napo-letane. Prospettive e problemi delle indagini diagnostiche, in A. CA-TALANO, G. FRUNzIO (a cura di), Diagnostica per la tutela deimateriali e del costruito (Atti del convegno, 4 dicembre 2003,sito reale di San Leucio), Napoli 2004, p. 347.
24 Il palmo napoletano ha assunto nel tempo due va-lori codificati. Il primo, pari a 0,263676 m, dal 1480 al1840, come regolamentato il 6 aprile 1480 dall’editto diFerrante d’Aragona; il secondo, pari a 0,264550 m, a se-guito della legge del 6 aprile 1840, promulgata da Ferdi-nando II di Borbone. quest’ultimo valore ha avuto vitabreve, poiché dopo qualche anno si è passati al sistemametrico decimale. Cfr. C. AFAN DE RIVERA, Tavole di ridu-zione dei pesi e delle misure delle Due Sicilie, Napoli 1841.
25 A Napoli, «dopo la parentesi angioina e dellaprima età aragonese, durante le quali le grandi realizza-zioni sono improntate a finezza e a precisione di lavora-zione, si ripropone su un largo orizzonte l’antica tecnicamuraria incerta, già consolidatasi, fin dall’età romana, nonsolo localmente, ma in buona parte dell’Italia meridio-nale». M. RUSSO, Apparecchi murari “a cantieri”…, cit., p. 84.queste considerazioni possono essere agilmente assunteanche nei riguardi dei distretti periferici del regno, com-presi quelli oggetto del presente studio, dove le intrapreseedilizie erano certamente meno ambiziose.
26 Nonostante gli sforzi di Pedro Afan de Ribera, vi-ceré di Napoli dal 1559 al 1571, per regolamentare l’atti-vità edilizia, che impose l’abbandono del magistero “acantieri”, le maestranze continuarono ad utilizzare questatecnica, ormai da tempo acquisita nel loro bagaglio espe-rienziale. Dovette passare oltre un secolo perché la si ab-bandonasse: con il terremoto del 5 giugno 1688, che ebbecome epicentro il Sannio, radendo quasi al suolo Bene-vento e provocando ingenti danni anche a Napoli, si poseil problema di ridefinire le dinamiche costruttive in favoredel magistero a filari, che prevedeva l’utilizzo di costituentilapidei regolari, ritenuti più idonei dal punto di vista sta-tico. Nelle aree periferiche del regno, però, il magistero “acantieri” perdurò per decenni, per motivi legati a contin-genze socio-culturali e tecnologiche.
27 Per ulteriori approfondimenti si vedano B. CAL-DERONI, E.A. CORDASCO, L. GUERRIERO, P. LENzA, G.MANFREDI, Experimental tests on post-medieval and modern tuffmasonry walls, in Conference proceedings, The Tenth North Ame-rican Masonry Conference (St. Louis, Missuori, June 3-6,2007), Omnipress 2007, pp. 921-932, B. CALDERONI, E.A.CORDASCO, L. GUERRIERO, P. LENzA, Prove a compressionesu murature storiche napoletane, in G. FIENGO, L. GUERRIERO
(a cura di), Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Napoli,Terra di Lavoro…, cit., t. I, pp. 269-280, B. CALDERONI,E.A. CORDASCO, L. GUERRIERO, P. LENzA, G. MANFREDI,Mechanical behaviour of post-medieval tuff masonry of the Naplesarea, in “Masonry International. Journal of the Interna-tional Masonry Society”, v. 21, n. 3 (2009), pp. 85-96 e B.CALDERONI, G. CECERE, E.A. CORDASCO, L. GUERRIERO,P. LENzA, G. MANFREDI, Metrological definition and evaluationof some mechanical properties of post-medieval Neapolitan yellowtuff masonry, in “Journal of Cultural heritage”, v. 11, n. 2(2010), pp. 163-171.
28 Cfr. M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…,cit., pp. 242-243.
29 «Elemento discriminante principale, nella sempli-cità costruttiva di questo litotipo, è il variare delle gran-dezze degli elementi di fabbrica, in cui il tempo dilavorazione si ripercuote su quello del cantiere stesso esegue delle regole rigorose (…) L’attenzione che si rivolgenell’apparecchiatura di questa tipologia costruttiva sta nelcercare di realizzare sempre corsi con direzioni orizzon-tali, per ovviare alla possibile formazione di carichi nonverticali nel momento in cui si avessero contatti obliqui».C. CROVA, Insediamenti e tecniche costruttive medievali. Il Latiumadiectum e la Terra Laboris, Montecassino 2005, pp. 130-131.
30 Con l’intento di eliminare le cattive pratiche dal-l’edilizia, perseguito anche dal predecessore Pedro de To-ledo, Pedro Afan de Ribera decretò «che il primario deitavolari, alla presenza di un regio ingegnere, dovesse sot-toporre ad esame i capimastri, iscrivendoli, una volta su-perata la prova, in una sorta di albo, che li abilitava. Tra lesanzioni comminate ai trasgressori, fu inclusa la sospen-sione di coloro che lasciavano incompiute le opere e l’af-fidamento del completamento delle stesse, a loro spese,ad altri operai». G. FIENGO, Organizzazione e produzione edi-lizia a Napoli…, cit., pp. 17-18. Ragguagli sulla prammaticadel de Ribera sono in M. RUSSO, Magisteri murari “a can-tieri”…, cit., pp. 71-151, specificamente nel paragrafo: Glistatuti della corporazione dei fabbricatori e le normative vicerealidel 1545 e del 1564. Ulteriori approfondimenti sull’attivitàpolitica e culturale del viceré sono in F. STRAzzULLO, Edi-lizia e urbanistica…, cit., in particolare nel paragrafo: Leprammatiche del ‘500, pp. 79-88. È stato giustamente notatoche «la ‘prammatica’ del de Ribera ci tramanda quindi,dalla seconda metà del xVI secolo, una «costumanza»della città relativa al dimensionamento dei blocchi lapidei
44
che senz’altro aveva origini anteriori e comunque modulidissimili da quelli d’epoca tardomedioevale, ad ulterioretestimonianza delle continue modifiche, avvenute colfluire del tempo, riguardo l’applicazione di moduli prede-terminati alla confezione delle pietre da paramento, no-nostante le continue azioni di normalizzazione tentate nelsettore da parte dei governi centrali». R. ChIOVELLI, Tec-niche costruttive murarie medievali: la Tuscia, Roma 2007, p. 388.
31 A tal proposito, cfr. M. RUSSO, Apparecchi murari“a cantieri”…, cit., pp. 83-96, IDEM, Magisteri murari “a can-tieri”…, cit., pp. 124, 126, L. GUERRIERO, Lo stato dell’artein Campania, in G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di),Atlante delle tecniche costruttive tradizionali. Lo stato dell’arte…,cit., p. 86, n. 22 e L. GUERRIERO, G. CECERE, op. cit., pp.123-127. Si vedano anche L. GIUSTINIANI, Nuova collezionedelle prammatiche del Regno di Napoli, t. xIV, Napoli 1805, p.218, § 20, L. RAGUCCI, Principj di pratica di architettura, IIed., Napoli 1859, p. 471 e F. DE CESARE, La scienza dell’ar-chitettura applicata alla costruzione, alla distribuzione, alla deco-razione dell’architettura civile, I, Napoli 1855, p. 137.
32 M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…, cit., pp.206-207.
33 I costituenti così collocati avevano una funzionesimile a quella dei diatoni, elementi di consistente lun-ghezza, utilizzati sin dall’antichità per ammorsare le mu-rature, con lo scopo di migliorarne la resistenzameccanica. I diatoni, in genere, arrivavano però ad occu-pare l’intero spessore del muro, presentando entrambe lefacce a vista. Cfr. J.P. ADAM, L’arte di costruire presso i Ro-mani. Materiali e tecniche, Milano 1988, pp. 117-118.
34 Cfr. M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…,cit., p. 197.
35 «questi fori – lasciati in situ, evidentemente, pereventuali successivi lavori – rappresentarono, infatti, unrischio importante, giacché poterono così agevolarsi lescalate e gli assalti delle forze nemiche. Per questo motivo,il riscontro delle cavità è comune soltanto a determinatealtezze, all’incirca a 3-4.5 m dal suolo, sicché è agevolesupporre che questi cantieri usufruirono dell’utilizzo com-binato di entrambe le tipologie d’impalcati, fissati a terrao, meglio ancora, con scale e ponteggi mobili su cavallettifino al livello descritto e con strutture a sbalzo nelle por-zioni superiori». Ivi, pp. 181-182.
45
Casi significativi per la diffusione nei sub-areali di studiodelle tecniche costruttive murarie tardo-medievali
Il percorso di analisi di seguito esplicitato, chedescrive alcuni manufatti, le cui strutture mura-rie sono risultate importanti per la definizionedelle premesse analitiche della presente ricerca,principia con il castello di Carinola1.
Il fortilizio, di notevole interesse storico-ar-chitettonico – ovvero ciò che ormai rimane diesso – è una delle architetture carinolesi mag-giormente stratificate e, al pari della complessainsula di palazzo Petrucci, più rappresentativedella locale cultura costruttiva tre-quattrocente-sca. In gran parte diruto, reca ancora tracce si-gnificative di un cospicuo volume su due livellicoperti con volte, del muro che dava origine allasala di rappresentanza e, infine, del mastio.
Di forma compatta, si articolava intorno adun ampio corpo centrale, sino al secondo con-flitto mondiale, quando, a causa dei bombarda-menti delle forze alleate, subì notevoli danni,divenuti irreversibili a seguito del sommariosgombro delle macerie, della demolizione distrutture allo stato di rudere e dell’apertura diuna strada che lo lambisce, la quale, a sua volta,ha comportato il sacrificio di un tratto dellemura urbane che si saldavano ad esso.
In alcune foto dei primi del Novecento sipresentava come un consistente edificio residen-ziale, su due livelli fuori terra (Figg. 15-16) e conuna scala esterna posta ad ovest, avente conno-tazioni tipicamente quattrocentesche e che, peril “passamano” e per i gradini pensili, ricorda lascala d’accesso alla gran sala di Castel Nuovo2
(Fig. 17).Rimasto fortunosamente intero, sebbene
molto degradato perché non soggetto ad operedi conservazione da molto tempo, è il possentemastio quadrangolare, articolato su tre livellifuori terra, che svetta sul sito dell’antica portadell’Annunziata, a sud-est del fortilizio, a presi-dio del salto di quota che ricorda la presenza diun fossato scavato per ragioni difensive.
La realizzazione, in epoca recente, sull’areaun tempo occupata dalle strutture distrutte delcastello, di un masso pavimentale in conglome-rato cementizio, ha purtroppo coperto le super-stiti tracce delle antiche murature basamentali; a
questa discutibile azione si è aggiunta, come si ègià detto, l’acritica rimozione delle macerie,senza nulla documentare e nulla recuperare, cheimpedisce un’accurata ricognizione delle strut-ture.
Scarse e lacunose, altresì, sono le notizie fi-lologico-documentarie, che ne ascrivono la fon-dazione al periodo normanno, non suffragataperò da alcun riscontro analitico3, se non dallaforma quadrangolare del mastio, peraltro nonesclusiva della cultura costruttiva normanna; ol-tretutto, come riferiscono più approfondita-mente diverse fonti, lo stesso è statoampiamente ristrutturato in epoche successive.
Ulteriore elemento di cui tener conto, a talproposito, è che quello di Carinola non era com-preso tra i castelli campani di pertinenza del de-manio svevo; segno che quanto a quel tempoesisteva in situ non era così rilevante da rientrarenell’organizzazione difensiva fridericiana, a dif-ferenza di strutture militari prossime, quali larocca di Mondragone, classificata nei castra ex-tempta, o i castelli di Sessa Aurunca, Teano e Ca-iazzo4.
D’altra parte, i castelli svevi «presentano nelloro impianto una regolarità matematica e unachiarezza di linee rette con volumi che si artico-lano su pianta quadrangolare o rettangolare, conquattro ali munite di torri quadrate, cilindricheo poligonali in corrispondenza degli angoli»5; ca-ratteristiche non riscontrabili nel fortilizio cari-nolese.
Interventi di riparazione del “castrum” diCarinola, condotti in contemporenea anche suquelli di Alife e Mondragone (possedimenti diFilippo, re di Tessaglia, figlio di Baldovino II diCostantinopoli)6 risultano nel 1272, ordinati daCarlo I d’Angiò7. Nei registri della Cancelleriadei sovrani francesi il richiamo ai castra fa rite-nere plausibile che i lavori si riferissero pure alfortilizio, riguardando – come si approfondiràin seguito – anche la realizzazione del mastio,eretto al disopra di un basamento realizzato inepoca anteriore, forse di impianto normanno.
Un riferimento più preciso alla torre del ca-stello, poco noto, è rinvenibile nel diario del pel-
47
Fig. 15. Carinola (CE), la fronte ovest del castello in unafoto degli anni trenta del Novecento. In evidenza, lo sca-lone esterno, non più esistente (da CIRCOLO LEGAM-BIENTE NUOVA CALENUM 1997).
legrinaggio in Oriente del notaio Nicola DeMartoni, che partì nel 13948 dalla natia Carinolaper arrivare a Gerusalemme, dopo aver toccatodecine di località, e fece ritorno, un anno dopo,alla sua città. A circa metà del viaggio, giunto aFanari, nei pressi di Corfù, a proposito di un ca-stello che colpì la sua attenzione, annotò cheesso si trovava «su una montagna e sopra un altotumulo, come se fosse tre volte la torre del ca-stello di Carinola, inespugnabile da parte dichiunque»9. Ciò a dimostrazione che castello etorre, nella tarda fase angioina, erano attivi e benidentificati nell’immaginario collettivo dei cari-nolesi.
Nella seconda metà del quattrocento lastruttura fu impreziosita di membrature di sti-lema catalano e ristrutturata secondo le nuoveesigenze di difesa. D’altronde, come ampia-
mente noto, l’adeguamento delle strutture difen-sive in epoca aragonese avvenne ovunque nelregno di Napoli. Infatti «l’architettura militarearagonese ostenta una produzione ingentissima,sovrapponendosi in pratica a tutte le precedentirealizzazioni, vuoi normanno-sveve, vuoi an-gioine. In definitiva la totalità dei castelli ancorastrategicamente validi sostenne tale adegua-mento»10.
Una testimonianza sull’utilizzo del castelloda parte di Giovan Francesco Petrucci, figlio diAntonello, segretario di Ferrante d’Aragona, èriportata nella voluminosa opera di Camillo Por-zio11 scritta nella seconda metà del xVI secolo:La Congiura de’ Baroni del Regno di Napoli contra ilre Ferdinando I12.
Del castello, nel xVII secolo, danno descri-zione anche i due tavolari Galluccio e Ruggiano,
48
incaricati di stimare il feudo carinolese. Essi ri-feriscono puntualmente anche del sistema mu-rario di difesa e delle porte urbane: «Segue lastrada larga, tra le mura di d.a Città, et per quantocontiene il fronte della cortina tra li due torrionilaterali del Castello, in testa si trova l’altra portadi d.a Città, che tira verso Sessa, et contiguo àdetto Seggio, si trova l’altra porta detta del Seg-gio, à mano destra dopo la porta, sono le muradel Castello, et à sinistra molte case dirute, segueapp. si trova la strada, che tira alla piazza, et se-guitando la strada, à mano destra si trova ilponte di fabrica, che passa per sopra il fosso did.o Castello, in testa si trova la porta, che dà l’in-gresso al cortile di d.o Castello murato triango-lare scoperto, dove vi è il deritto del pozzosorgente, il quale Castello consiste in moltestanze inferiori, et superiori, con Torre detta la
Castellina, alle stanze superiori si ascende perscala larga con grada di pietra di taglio, qualisono quasi tutte dirute, et cascati tutti l’astrachià cielo, et parte delle mura, le stanze inferioritutte à lamia, che possono servire per uso distalla, carceri, et altro, le quali tutte piovono, cheper renderle di servizio, sarebbe necessario co-prirle à tetti».
Acquistato negli anni trenta del secoloscorso dal Comune di Carinola13, l’edificio, giàutilizzato come canapificio, era allora sede dellecarceri mandamentali del Regime14. Alla penuriadi documenti si aggiunge l’assenza di una letturadiretta della fabbrica, che possa contribuire allaformulazione di ipotesi di datazione15; lacunaestendibile ad altre strutture, sia del sito carino-lese sia di territori urbani circonvicini, che hannocondiviso un destino simile.
49
Fig. 16. Carinola (CE), la fronte sud del castello in unafoto degli anni trenta del Novecento. A destra si erge ilmastio, al tempo coperto, come il fortilizio, con tetto adoppia falda (da CUNDARI, CARNEVALI 2003).
L’analisi odierna del manufatto, condottaapplicando i noti protocolli mensiocronologici,registra, relativamente alle strutture murarie,l’uso ricorrente dell’apparecchio “a cantieri”,con altezza assimilabile al palmo napoletano o amultipli di esso e, in minor misura, di quello afilari, anch’esso con altezza prossima al palmo ecostituenti di lunghezza oscillante, mediamente,da 1,5 a 2,5 palmi.
Ulteriore dato di facile rilevazione è rappre-sentato dalle lavorazioni meno accurate caratte-rizzanti i paramenti murari interni rispetto aquelli esterni16. Partendo da quanto rimane diquesta complessa struttura è possibile indivi-duare almeno quattro fasi costruttive, ricondu-cibili ad un arco temporale compreso tra il xIIIed il xV secolo (Tav. 1).
La prima fase (“A”, xIII secolo) è riferibileal mastio, il cui paramento esterno è costituitoda filari di conci squadrati di tufo grigio, con al-tezze di 39,5~40 cm circa (pari a 1,5 palmi) elunghezze tra 40 e 70 cm (1,5-2,5 palmi), al
muro della fronte est del fortilizio (apparec-chiato con “cantieri” alti 35-45 cm, caratterizzatida ricorsi perlopiù irregolari) (Fig. 18) e a quelloposto a sud, limitatamente al primo livello, oggicoperto da una robusta fodera di conci di tufogrigio, frutto di interventi più recenti.
L’interno del mastio, al secondo livello –l’unico praticabile – al quale si accede da piazzacastello, è coperto con una volta a crociera ogi-vale in buone condizioni di conservazione, chesi eleva dal piano di calpestio per un’altezza al-l’intradosso di 3,80 m17.
Un’analoga volta copre il primo livello,come si può constatare da un foro praticatonella stessa, attraverso il quale nell’ambiente,privo di aperture, è stato versato materiale pro-veniente da demolizioni, colmandolo. È proba-bile che il suddetto vano accogliesse unacisterna.
Sempre all’interno del mastio, dall’analisi diun’apertura posta sulla fronte nord è agevolecomprendere che i filari visibili sul paramentoesterno ed i “cantieri” con i quali è apprestato ilmuro, hanno la stessa altezza (mediamente 40cm); sono il risultato cioè di un unico pro-gramma costruttivo. Un agevole parallelo puòeffettuarsi con i conci di tufo grigio riscontrabilinel Castel Nuovo e riferibili ad intraprese co-struttive del xIII secolo18.
La seconda fase (“B”, xIV secolo) riguardail corpo di fabbrica addossato alla fronte sud-ovest del mastio. In particolare, il muro sul latonord dello stesso è organizzato, per quanto ri-guarda il paramento esterno, in “cantieri” di pie-tre spaccate, con altezza di 35-40 cm. Peraltro,esso mostra la traccia ben visibile di un’apertura,della quale si riconosce ancora parte dell’origi-naria cornice a sesto leggermente acuto, conghiera in conci di tufo grigio, murata per inne-starvi un grande arco ad ogiva, all’attualità quasidel tutto diruto, parte integrante di una volta acrociera ogivale non più esistente.
Sull’opposta fronte del medesimo volume,ossia quella sud del castello, poi, è ancora possi-bile osservare, per gran parte del muro delprimo e del secondo livello, un ampio quadrante
50
Fig. 17. Napoli, Castel Nuovo, corte interna. In evidenza,la scala d’accesso alla gran sala (da SANTORO 1982).
Tav. 1. Carinola (CE), castello, individuazione delle fasicostruttive.
XIII secolo (1272)Costruzione del mastio su preesi-stenza e sopraelevazione del trattonord-est delle mura urbane. Mastio:apparecchio murario a filari di concidi tufo grigio alti 39,5~40 cm e lunghi40-70 cm. Tratto nord-est delle muraurbane: apparecchio murario “a can-tieri” di tufo grigio alti 35-45 cm.
XIV secolo Realizzazione del corpo di fabbrica asud-ovest, addossato al secondo ed alterzo livello del mastio, in parte costi-tuente sopraelevazione delle mura ur-bane. Corpo di fabbrica a sud-ovest:apparecchio murario “a cantieri” ditufo grigio alti 35-40 cm.
XV secolo, prima metàRealizzazione di un’ampia sala, co-perta con volte a crociera ogivali e diuna sovrapposta (forse coperta concapriate), di una scala esterna e di am-bienti di servizio al primo piano,frutto di una ristrutturazione delcorpo di fabbrica a sud. Apparecchiomurario “a cantieri” di tufo grigio alti45-54 cm.
XV secolo, seconda metàRealizzazione, in luogo delle volte acrociera crollate forse a seguito delterremoto del 1456, di una volta abotte a sesto acuto e ricostruzionedella sala del livello superiore. Realiz-zazione della scarpa a ridosso dellemura urbane del lato est. Scarpa: ap-parecchio murario a filari di conci ditufo grigio alti 27 cm.
51
del paramento esterno, caratterizzato da un ap-parecchio murario del tutto simile a quello di cuisopra.
Il brano murario in questione, ancorché al-terato da pesanti rinzaffi di malta fine cementiziaed in gran parte occultato da lastre di tufo grigiodi recente fattura, frutto di un intervento dellasoprintendenza, risulta ancora discretamenteidentificabile e corrobora la lettura della secondafase costruttiva, offrendo contezza circa l’uti-lizzo contemporaneo su entrambi i muri di ununico magistero murario, quello “a cantieri”, ap-parecchiati con frequenze rientranti in valori as-similabili ad 1,5 palmi napoletani (Fig. 19).
In entrambi vi è la presenza di una discretaquantità di materiale minuto di varia prove-nienza – anche fittile – utilizzato come pareg-giamento dei ricorsi e con funzione di
riempimento delle soluzioni di continuità tra glielementi litici, presenti a causa della loro formairregolare.
È agevole, a tal proposito, individuareun’analogia delle tessiture murarie della fase co-struttiva in parola con quelle del paramento mu-rario esterno, in direzione ovest, che dà sulfossato, di palazzo Petrucci (Fig. 20). questa re-lazione conferma una netta affinità tra le due in-traprese costruttive, all’interno di un signi-ficativo settore della città, coincidente conl’espansione angioino-aragonese e gravitante at-torno a quattro manufatti-chiave: i citati castelloe palazzo Petrucci ed i palazzi Marzano e Para-scandolo, quest’ultimo probabile residenza diAlfonso il Magnanimo, distrutto nel corso delsecondo conflitto mondiale.
La terza fase (“C”, prima metà del xV se-
52
Fig. 18. Carinola (CE), castello, fronte est, paramento in-terno, primo livello, apparecchio murario “a cantieri” ditufo grigio alti 35-45 cm, corrispondenti alla parte più an-tica del complesso architettonico.
colo) informa della realizzazione dell’ampio am-biente nord-est del castello. Una lunga sala, pres-soché distrutta nel corso degli ultimi eventibellici, con tracce visibili di quattro volte a cro-ciera a sesto acuto – delle quali all’attualità per-mangono soltanto i peducci del lato est – e diun altro ambiente ad essa sovrapposto, dellastessa estensione, probabilmente provvisto dicopertura a capriate. Sulla porzione superstitedella crociera attigua all’ambiente a sud, si ri-trova un muro, spesso 40 cm circa, realizzato infalso, apparecchiato “a cantieri” di tufo grigioalti 45-54 cm, che introduce ad uno spazio-filtrotra gli ambienti ovest ed est del fortilizio.
Gli elementi litici, annoverabili nella faciesdel semi-tufo e con le stesse caratteristiche geo-litologiche di quelli conformanti le strutture ri-ferite alle fasi “A” e “B”, presentano colore
tendenzialmente chiaro, consistenza tenera eduna serie di piccole inclusioni lenticolari tendential grigio scuro.
I peducci che un tempo sostenevano le cro-ciere, invece, sono conformati in pietra “accon-ciata”, tendente alla regolarità dei profili, conelementi alti 18-27 cm e lunghi 43 cm, simili perfoggia e caratteristiche metriche a quelli checompongono la volta a crociera del mastio, que-sti ultimi leggermente più alti (27-36 cm), daiquali sono stati evidentemente mutuati. Rag-giunta un’altezza di 2,00 m circa, i conci lascianoil posto a pietre rustiche, di forma tendenzial-mente quadrangolare.
questa fase descrive l’esigenza di edificareun ambiente altisonante, ancorché struttural-mente legato al corpo di fabbrica preesistente.
Un’ulteriore fase (“D”, seconda metà del
53
Fig. 19. Carinola (CE), castello, fronte sud, paramentoesterno, primo e secondo livello. In evidenza, l’apparec-chio murario “a cantieri” (xIV sec.) con altezza di 40 cmcirca, simile a quella riscontrata sull’opposta parete. Ilmuro, all’attualità fortemente turbato da recenti ristilaturedi malta fine cementizia e dall’installazione di lastre di tufogrigio, fu affiancato in un secondo tempo al mastio.
xV secolo), che non è stato possibile anatomiz-zare con maggiore accuratezza vista l’esiguità deicampioni murari a disposizione, può individuarsinella realizzazione di una copertura a botte asesto ogivale lungo l’intera sala nord, innestatasulla fascia muraria delle fronti est ed ovest (que-st’ultima non più esistente), che precedente-mente ospitavano le quattro volte a crociera,anch’essa crollata.
Con buona probabilità, la realizzazionedella copertura a botte – la cui imposta, ancoraindividuabile sulla fronte est, attestata a 2,40 m,è testimoniata dai resti di evidenti aggetti delmuro – si rese necessaria per sostituire le cro-ciere ormai danneggiate (Fig. 21), verosimil-mente, dal terremoto del 1456, che colpì laCampania e le regioni circostanti con grandeforza.
Dalle foto di inizio Novecento poc’anzianalizzate si evince con chiarezza la presenza delsecondo livello del fortilizio, ospitante la citatasala, di cui non si è purtroppo ritrovata alcunatraccia.
Proseguendo verso sud, sul versante ovestdella strada che conduce al centro del sito cari-nolese, si trova il palazzo Marzano19. Denomi-nato anche “casa Martullo” in riferimento agliultimi proprietari, è impreziosito da una loggiae da uno scalone che collega il piano terra alprimo. Citato dalle fonti storiche come edificioresidenziale, in origine era significativamente piùesteso20.
La tipologia della casa a corte caratterizzadiffusamente il patrimonio edilizio carinolese,presente in diverse configurazioni. Sistema-basedella formazione dei centri agricoli dell’Europa
54
Fig. 20. Carinola (CE), palazzo Petrucci, fronte ovest,primo livello. Si noti il paramento esterno apparecchiato“a cantieri”, in organica ricorrenza con quello della frontesud del castello (archivio M.A. Russo).
mediterranea, caratterizzati da abitazioni posteserialmente e prospicienti la strada principale, aCarinola offre testimonianze negli episodi piùrilevanti, come appunto il palazzo Marzano o inmisura minore il palazzo Petrucci, ed in quellimeno noti, non per questo meno interessanti dalpunto di vista tipologico e formale.
L’articolazione della corte – in genere con-divisa da più nuclei familiari – sfruttava l’orien-tamento, l’effetto-cortile, la massa termica dellestrutture e la disposizione delle aperture, per as-sociare buone condizioni di abitabilità. Si basavasu uno schema minimo, che comprendeva anchel’androne ed una scala su di un lato, per l’accessoal piano superiore.
Maggiore era l’importanza dell’edificio, piùarticolato era il sistema tipologico. Per il caso inparola, si registra che Alfonso d’Aragona inviòal genero Marino Marzano, nel 1449, maestranzecatalane impegnate nella realizzazione di CastelNuovo (Fig. 22)21.
Il palazzo, non descritto nell’apprezzo tar-doseicentesco di Carinola forse perché non rien-trante tra i beni oggetto di vendita, ha subito nelcorso del Novecento diversi danni, causati per-lopiù dalle distruzioni belliche e da eventi natu-rali, nonché da diversi restauri, primo tra tuttiquello condotto negli anni trenta, non guidati dauna corretta logica di preservazione delle strati-ficazioni della fabbrica, ma, anzi, dalla discutibileesigenza del ripristino “in stile”22.
Non ultimo, negli anni ottanta si è regi-strato un intervento di consolidamento che hainteressato lo scalone e le strutture murarie su-perstiti. I restauri, protrattisi nel corso degli anni,hanno quasi cancellato ogni traccia delle tecni-che costruttive murarie.
L’uso generalizzato, nei vari interventi, dilastre di tufo grigio collocate sulla muratura aguisa di rivestimento, e di intonaco, di norma ce-mentizio, ha reso difficoltosa la lettura dei para-menti, cosa che non ha comunque impedito dirinvenire, visionando una vecchia foto, un appa-recchio murario “a cantieri” (Fig. 23).
Attiguo alla corte quattrocentesca è un cor-tile minore, posto nel quadrante ovest dell’insula,
con una loggia, anch’essa su due livelli, ascrivi-bile al xVIII-xIx secolo, in passato parte inte-grante del complesso immobiliare (Figg. 24-25).
La realizzazione di manufatti come palazzoMarzano e di altri edifici coevi nelle sue vici-nanze, coincise con l’unione tra Marino Mar-zano ed Eleonora d’Aragona, figlia naturale delMagnanimo, avvenuta nel 1449. Essa fu basata,essenzialmente, sull’emulazione e sulla rappre-sentazione in chiave sociopolitica – sebbene at-tenuata e caratterizzata da un contesto mar-catamente autoctono – di istanze provenientidalla cultura aragonese. In definitiva, il matrimo-nio tra gli esponenti delle due genìe fu l’occa-sione per Carinola e Sessa di impreziosirsi didiffuse testimonianze di gusto catalano.
Le vicende successive, che videro MarinoMarzano scagliarsi vibratamente contro il co-
55
Fig. 21. Carinola (CE), castello, fronte est, primo livello.Si noti, sulla sinistra, l’imposta della volta a botte ogivalecrollata, segnalata dalla muratura in aggetto.
gnato Ferrante, subendo ben presto la perditadei beni (1464) e la morte, pochi anni dopo lacomunanza con gli Aragonesi23, non fecero co-munque perdere al sito il carattere acquisito,perdurante, seppure non più nelle raffinatemembrature (in primis le finestre a bilanciere edi portali a sesto ribassato inquadrati in una cor-nice rettangolare), di certo attraverso il raffor-zamento e l’evoluzione delle note tecnichemurarie, in questa sede analizzate.
Nei decenni successivi i nuovi feudatari, iPetrucci, resero Carinola ancor più ricca di in-traprese costruttive di matrice catalana, a tut-t’oggi sopravvissute perlopiù in episodi singolio, purtroppo, turbate da discutibili interventicontemporanei.
A poche decine di metri a sud del palazzoMarzano si trova l’antica residenza dei Petrucci,
fatta realizzare nel xV secolo dal segretario diFerrante d’Aragona, Antonello Petrucci24. L’edi-ficio, che ha portato il suo nome sino a quandoè stato acquistato dalla famiglia Novelli nel xIxsecolo, si articola, similmente al palazzo Mar-zano, attraverso un sistema tipologico propriodelle residenze della Spagna orientale, che metteal centro della fruizione degli spazi la corte, sullaquale affacciano gli ambienti funzionali della re-sidenza, e la scala, organizzata con un loggiato.
Come risulta da uno studio sulle sue strati-ficazioni, il palazzo «si pone tra gli esempi piùsignificativi dell’importazione del linguaggio ar-chitettonico “catalano” nella Campania setten-trionale (…) [si ipotizza che] l’edificio abbiainglobato, nell’assetto conferitogli nel xV se-colo, strutture certamente di epoca prece-dente»25. questa tesi è avvalorata dalla
56
Fig. 22. Carinola (CE), palazzo Marzano, scorcio dellacorte quattrocentesca. Si noti il raffinato scalone che col-lega i piani terra e primo.
Fig. 23. Carinola (CE), palazzo Marzano, scorcio dellacorte dall’ingresso in una foto degli anni settanta del se-colo scorso. Si scorge, sul muro a sinistra che ospitaun’apertura arcata occlusa, l’apparecchio murario “a can-tieri” (da ROSI 1979: Il palazzo Marzano di Carinola).
complessa, a tratti disorganica, configurazioneplanimetrica dell’edificio, non scandita da unoschema coerente.
Evidenti stratificazioni costruttive sono rin-venibili, d’altra parte, anche nel palazzo dei Pe-trucci eretto a Napoli, nel quale «alla stessamaniera di quanto avveniva in altri cantieri dellacapitale, erano compresenti, accanto alle vecchiestrutture angioine, i modi, formali e costruttivi,del tardo gotico quattrocentesco, interpretatidagli artefici spagnoli e cavesi, e quelli rinasci-mentali»26.
Per anni il palazzo è stato abitato da diversinuclei familiari, i quali, nel disinteresse delle isti-tuzioni, non hanno esitato ad “adattarlo” forzo-samente alle proprie esigenze, edificando volumiabusivi che ne hanno alterato forma e distribu-zione interna, quando non ne hanno addirittura
provocato la distruzione di intere parti (Fig. 26).Il citato apprezzo tardoseicentesco ne dà
ampia e precisa descrizione: «à mano destra sitrova il Palazzo di detta Principal Corte, con suaporta di pietra di taglio, lavorati, con entrata co-perta à lamia, et à sinistra vi è una stanza à lamia,et à destra vi è l’altra stanza simile, et di testa viè il cortile scoverto, in testa vi è la bocca dellacisterna, et à sinistra di detto cortile vi sono duealtre stanze grande à lamia per uso di stalla, etaltro, à destra vi è la grada mag.a parte coverta,et parte scoverta, à tetti, et appresso si trova ilcoverto à lamia, capace per tre stanze, et in testasi trovano due altre stanze anco à lamia, et se-guitando detta grada si trova una loggia covertaà tetti con paliaro, et due archi, verso detto cor-tile, et a destra vi è la porta della sala grande co-verta à tetti con soffitto di tonoli sotto con suoi
57
Fig. 24. Carinola (CE), palazzo Marzano, cortile minore,scorcio della loggia, articolata su due livelli (xVIII-xIxsec.).
quadri all’antica, et due finestre in detta strada,et una in detto cortile, in mezzo vi è focolarocon una cappa di ciminera; a sinistra di detta salasi trova un’altra stanza con intempiatura similecon focolaro in angolo. In detta stanza appressosi trova un’altra stanza simile, con porta che dàingresso ad un’altra stanza lunga, et stretta co-verta à tetti, et da essa con grada scoverta si calaad uno vacuo murato, dove sono più piedi di ce-trangole, et uno di fico, et vi è l’aria per scognarele vittuvaglie, et porta ch’esce alla strada accostodetto palazzo, et d.a stanza stà situata v. unalamia, che copre la strada vicinale, et appressola sud.a stanza si trova la cucina coverta à tetticon un’altra stanza per uso di dispensa covertasimile con porta, che esce in detta loggia de-scritta, dov’è il forno, et accosto un’altra stanzacoverta à travi con tetto sopra, et à destra di
detta sala si trovano tre altre stanze, una grande,et due altre ord.ie tutte coverte à tetti con soffittidi tonole, sotto in d.a casa vi è la servitù delle fi-nestre della Torre, che si possiede dal Mon.riodella Università di Sessa, affacciatore, con spira-colo tonno, et una saettera, confina detta casacon li beni di detto Monasterio della Trinità diSessa».
I recenti interventi di restauro, risalenti al200227, di cui è stato oggetto il palazzo, rendonoimpraticabile un’analisi approfondita delle tec-niche costruttive che ne hanno consentito la na-scita e favorito lo sviluppo.
questo perché il manufatto è stato quasicompletamente rivestito con intonaco cementi-zio, senza che l’apparecchio murario messo anudo fosse documentato con foto o disegni, im-pedendo agli studiosi di poterlo analizzare, ec-
59
Fig. 25. Carinola (CE), palazzo Marzano, cortile minore,fianco orientale, loggia a due livelli in tufo grigio, databileal xVIII-xIx secolo (ril.: F. Miraglia; da FIENGO, GUER-RIERO 2008).
Fig. 26. Carinola (CE), palazzo Petrucci, scorcio dellacorte in una foto risalente agli anni ottanta del secoloscorso (coll. privata). Si noti l’invasiva presenza di un vo-lume abusivo che copre quasi del tutto le arcate del pianoterra. In evidenza, anche il caratteristico sistema di rac-colta delle acque piovane, poggiante su mensole di tufogrigio che descrivono una curva parabolica, oggi in granparte rimosso.
Fig. 27. Carinola (CE), edificio in piazza Vescovado. Sinoti il piedritto con pulvino caratterizzato da motivi geo-metrico-floreali.
cezion fatta per i cantonali in conci squadrati ditufo grigio – la cui isolata presenza, risparmiatadall’intonaco, può dar luogo ad un’errata letturadella tessitura muraria – e per il muro sullafronte ovest, di seguito descritto.
Un elemento compiutamente analizzabile èanche il pilastro su cui si erge il primo livello delloggiato interno, sulla fronte nord della corte,che presenta conci squadrati alti 28-32 cm, lun-ghi 50-56 cm e larghi 24-28 cm; valori tendential palmo napoletano o a suoi multipli.
Interessanti, inoltre, sono due manufatti, untempo con tutta evidenza appartenenti al com-plesso architettonico. Il primo, in direzione sud,è sito in piazza Vescovado, quasi di fronte allacattedrale. Il secondo, a nord, ormai vicino allostato di rudere, attiguo al giardino del palazzo, èarticolato su due livelli fuori terra e coperto contetto ligneo a doppia falda.
L’edificio di piazza Vescovado è adiacenteall’ala sud di palazzo Petrucci ed ospita una fa-
legnameria. Contiguo agli ambienti restaurati epiù noti del palazzo, offre all’esame critico unospazio molto interessante, un tempo copertocon una grande volta a crociera a sesto acuto cheimpostava su peducci di notevole dimensione,scaricanti sul piano di calpestio.
All’attualità, della copertura sono rimastisoltanto i peducci e, in luogo della parte som-mitale della volta, vi è un solaio in legno. L’affi-nità di forme e dimensioni dei conci costituentii peducci con quelli della volta superstite del ma-stio e delle volte un tempo presenti nell’am-biente nord-est del castello, consentono diaccomunarne lo spirito costruttivo.
questa analogia porta a chiarire, insiemealle affinità già dimostrate tra il paramento suddel castello e quello ovest di palazzo Petrucci,come le due strutture siano da ritenersi coeve,frutto di una cultura costruttiva operante sin dalxIII-xIV secolo, in epoca angioina, mutuatadalle successive maestranze, presenti nel periodo
60
Fig. 28. Carinola (CE), cattedrale, pianta, 1971 (ril.: F.Sarno). Archivio Soprintendenza per i Beni Architettonici,Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici perle province di Caserta e Benevento (ASBA-CE), B. 196(immagine pubblicata su concessione del Ministero per iBeni e le Attività Culturali – Soprintendenza BAPSAE diCaserta, con nota prot. n. 19595 del 12.9.2012).Il rilievofu approntato in occasione dei lavori di restauro condottidall’architetto Margherita Asso (1966-72).
della dominazione aragonese, che ne hanno, adogni modo, rielaborato lo stile.
Nell’edificio in parola, tra l’altro, si ritrovaun piedritto in pietra calcarea con un pulvinoche contiene motivi geometrico-floreali, certa-mente più antico della volta a crociera (Fig. 27).Testimonianze simili sono rinvenibili anche nellavicina cattedrale.
L’edificio nelle adiacenze di palazzo Pe-trucci, invece, versa in un preoccupante stato di
abbandono, ma è fortunatamente scampato al-l’intervento di restauro architettonico che loavrebbe – al pari di quest’ultimo – sicuramentecoperto con intonaco. Pertanto, sebbene non sigiovi ancora di auspicabili interventi di manu-tenzione, conserva, ben visibili, le tracce del pro-prio assetto costruttivo. La facciata est,prospiciente il piccolo giardino del palazzo, pre-senta un interessante apparecchio murario “acantieri” alti circa due palmi.
61
Pochi metri a sud, nella piazza omonima, sistaglia la cattedrale (Figg. 28-31), fabbrica reli-giosa di grande importanza storico-architetto-nica. Rinviando, per la trattazione delle suecomplesse stratificazioni, alla bibliografia dispo-nibile28, se ne riportano di seguito gli aspetti co-struttivi essenziali.
Il primo impianto, suddiviso in tre navate,fu realizzato al volgere dell’xI secolo, per voleredel vescovo Bernardo, in un’area sacra nellaquale permaneva un sacello paleocristiano.Completata la struttura, Bernardo vi si trasferì,lasciando la vicina cattedra di Foro Claudio.Poco dopo la morte del presule, la chiesa subìdiversi interventi di ampliamento, per ospitarela sepoltura del fondatore. Riferibile a questo pe-riodo è anche la facciata, che custodisce un in-teressante portale architravato sormontato da unarco a tutto sesto, di raffinata fattura.
A sud della navata destra fu inglobato unospazio che conduceva al sacello, che, con moltaprobabilità, aveva originaria funzione di porti-cato. Nei pressi di quest’ultimo è un pavimento
in tessellato marmoreo policromo, in buonecondizioni di conservazione, risalente al IV-Vsecolo, con ampi inserti di gusto cosmatesco.
L’espansione più significativa, ad ognimodo, va riferita al xIV secolo, con l’allarga-mento dello spazio presbiteriale, l’impianto diun nuovo sistema absidale pentagonale ed unacaratterizzazione spaziale in accordo allo stilemadel gotico d’Oltralpe. L’intervento, certamentefinanziato in gran parte dai Marzano, è con tuttaevidenza contemporaneo all’ampliamento tre-centesco del vicino castello, denotando in ciòl’esistenza di un programma di intraprese co-struttive da parte degli importanti feudatari, cheriguardò sia il polo religioso sia quello politicodella terra carinolese.
Riferibile al gusto catalano, invece, è l’arcotrionfale che separa la navata centrale dal tran-setto, realizzato realisticamente sempre sotto iMarzano, ma nel periodo in cui la potente fami-glia era ormai legata ai governanti aragonesi. Ul-teriori interventi hanno interessato la chiesa neisecoli successivi, quali la realizzazione di una
62
Fig. 29. Carinola (CE), cattedrale, sezione del transetto indirezione delle absidi, 1971 (ril.: F. Sarno). ASBA-CE, B.196 (immagine pubblicata su concessione del Ministeroper i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza BAP-SAE di Caserta, con nota prot. n. 19595 del 12.9.2012).
serie di cappelle affiancate alla navata sinistra,del pronao cinquecentesco e l’erezione di un se-condo campanile, collocato sulla piazza anti-stante, in sostituzione dell’originario, di cuirimane solo la base, costituita da grossi blocchiisodomi di tufo grigio, posto nei pressi delle ab-sidi e crollato29.
All’attualità la struttura avrebbe bisogno disignificativi interventi di conservazione dellamateria, soprattutto per il risanamento dagli evi-denti fenomeni di umidità di risalita capillare,causa di diverse manifestazioni di degrado.
Spostandosi a Nocelleto, una delle frazionipiù estese di Carinola, posta a sud-est del capo-luogo, si ritrova un esempio molto interessantedi struttura tardo-medievale, denominata casaDi Cresce, un tempo non certamente episodioisolato nel settore urbano di matrice tre-quattro-centesca della frazione. Ampiamente disturbatoda interventi di ristrutturazione, l’edificio con-serva, fortunatamente, caratterizzazioni struttu-rali utili ad un’organica analisi delle sue tecnichecostruttive murarie.
Casa Di Cresce è inserita sull’asse di pene-trazione verso ovest di via Stefano Ceca, che,dall’arteria principale di Nocelleto, si dipana sinoa raggiungere, su una piccola altura, un’altrastruttura degna di attenzione: la chiesa dell’An-nunziata. quest’ultima, con nucleo originario diprobabile matrice paleocristiana, ha subito pe-santi stratificazioni nel corso dei secoli, tra lequali si segnala l’insolito spostamento, dalla fac-ciata principale a vantaggio di quella posteriore,del portale durazzesco, che ne ha imposto unnuovo asse di fruizione, opposto a quello origi-nario in direzione est-ovest (Fig. 32).
Sulla stessa strada si individua anche unconsistente banco tufaceo emergente, in alcunitratti confinato da un muro a scarpa in bloc-chetti di tufo grigio, che fa comprendere comeanche Nocelleto – parimenti a Carinola – abbiabeneficiato, per la realizzazione delle struttureedilizie, di uno sperone di tufo opportunamentecoltivato.
Ritornando all’edificio oggetto della nostraattenzione (Tav. 2), ha interesse ricordare che
63
Fig. 30. Carinola (CE), cattedrale, sezione sulla sacrestia,1971 (ril.: F. Sarno). ASBA-CE, B. 196 (immagine pubbli-cata su concessione del Ministero per i Beni e le AttivitàCulturali – Soprintendenza BAPSAE di Caserta, con notaprot. n. 19595 del 12.9.2012). Si noti l’arco trionfale di sti-lema catalano.
Tav. 2. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, casa Di Cresce, ca-ratterizzazioni strutturali. Si noti, sulla facciata prospet-tante via Stefano Ceca, la quota di calpestio originaria, piùalta rispetto a quella attuale.
65
esso presenta un interessante portale (Fig. 33),riconducibile allo stilema catalano, in conci squa-drati di tufo grigio – colpiti da forte erosione –con arco a tutto sesto inquadrato in una cornicerettangolare, che introduce all’ingresso, non cen-trale, alla corte interna, molto ampia e circondatada una serie di ambienti con originaria destina-zione di ricovero per animali da lavoro.
Un portale quasi identico si trova nell’edi-ficio posto proprio di fronte a quello in causa,segno dello sviluppo, al tempo, di un’economiaalquanto florida, tanto da permettere ai proprie-tari delle abitazioni di fregiarsi di un così impor-tante elemento decorativo.
Il primo livello della casa è scandito da unesteso spazio rettangolare, frazionato in epocarecente per ospitare alloggi di fortuna, general-mente con altezza al colmo di appena 2,30 m. Ilsecondo livello, pesantemente rimaneggiato, èdestinato a residenza.
Gran parte della muratura è stata integrataattraverso due grevi interventi di sarcitura con-dotti con l’utilizzo di blocchetti di tufo giallo na-poletano, con buona probabilità risalenti,rispettivamente, agli inizi ed alla seconda metàdel secolo scorso.
Sul prospetto su via Stefano Ceca, in corri-spondenza del secondo livello, si osserva unbrano murario apparecchiato “a cantieri” alti 45cm circa, scandito da una serie di buche pontaie.Un altro apparecchio murario è visibile nellospazio andronale e presenta “cantieri” di altezzaminore (35-40 cm) (Fig. 34).
L’altezza di questi ultimi può essere agil-mente confrontata con le murature caratteriz-zanti la fase costruttiva “B” del castello diCarinola, ascrivendo con buona probabilità lamatrice dell’edificio ad un’intrapresa costruttivatardo-angioina, ristrutturata, sopraelevata ed im-preziosita attraverso la realizzazione del portalee di modanature in stile catalano durante il do-minio aragonese.
Sempre a Nocelleto, in vico Aurora, apoche decine di metri da casa Di Cresce, in unospazio urbano introdotto da un grande portalecatalano ad arco ribassato inquadrato in una cor-
nice rettangolare (Fig. 35), si ritrova una piccolaabitazione ascrivibile al xV secolo (Fig. 36), checonsente di ottenere utili ragguagli sull’articola-zione spaziale dell’edilizia tardo-medievale neldistretto in causa.
Il fabbricato è caratterizzato da una loggiasu due livelli che si apre su una corte comune eda una scala laterale; al piano terra, in uno spaziooggi chiuso, un tempo parte della loggia, si con-serva un solaio ligneo – l’unico superstite – in di-screte condizioni di conservazione (Fig. 37), contutta evidenza coevo all’impianto originario dellacasa; un portale ogivale (Fig. 38) introduce invecead uno dei due attuali ingressi su vico Aurora.
Anche in questo caso interventi invasivi –come la sostituzione di quasi tutti gli originariorizzontamenti in legno con solai in putrelle etavelloni – impediscono una lettura esaurientedell’edificio, la cui iniziale analisi, ad ogni modo,consente di comprenderne la partizione degliambienti abitativi, organizzati in due moduli:l’uno in direzione della corte interna, l’altro conaccesso diretto dalla strada.
Nel distretto di Pontelatone, infine, si evi-denzia la torre Marzano. Realizzata con buonaprobabilità entro il primo quarto del xIV secolo,ad opera di Tommaso Marzano, esponente dellapotente genìa che dal 1306 annoverava tra i suoipossedimenti anche il piccolo centro del monteMaggiore, la struttura segue i canoni architetto-nici d’Oltralpe.
Fig. 31. Carinola (CE), cattedrale, cappella est della navatasinistra. Si noti l’apparecchio murario “a cantieri” di tufogrigio, alti 50 cm circa, confezionati con tre allineamentidi materiale spaccato di dimensioni eterogenee e pareg-giati da un discreto numero di “asche”, anch’esse di tufogrigio.
Alta 20 m circa, si staglia su uno spazio ca-ratterizzato da una cortina edilizia e da un estesocampo incolto, che offre, a pochi metri di di-stanza in direzione sud-ovest, un consistentebanco di tufo grigio campano emergente.
La torre, la cui forma è data dall’interse-zione di un elemento tronco-conico con uno ci-lindrico, si articola su tre livelli, accessibili da uningresso sospeso a 8,50 m, raggiunto da unascala in acciaio frutto di un recente interventodi restauro. Al livello terraneo corre un cammi-namento che cinge completamente la base scar-pata per un’altezza media di 1,80 m e conduceal livello ipogeo, che un tempo aveva la funzionedi cisterna.
Sulla sommità sono ancora visibili le men-sole per la difesa piombante ed il redondone, an-ch’esso di tufo grigio, che cinge quasi per intero
la circonferenza della base scarpata, subendo so-luzione di continuità solo per far posto al vanod’ingresso, di forma rettangolare30 (Fig. 39).
La torre Marzano è apparecchiata con“cantieri” di pietrame spaccato e rustico di tufogrigio alti 50-55 cm, con valori ricorrenti assi-milabili ai due palmi; similmente riscontrabili inun’altra struttura militare di Terra di Lavoro,sempre riferibile al xIV secolo, apparecchiataperò con l’utilizzo di materiale calcareo: la torrecilindrica del fortilizio di Pietravairano31 (Fig.40). Stesso discorso non può effettuarsi per ilcastello di Carinola, che, come chiarito, offre –in riferimento alle intraprese del periodo incausa – apparecchi “a cantieri” alti generalmentenon più di 40 cm, dunque tendenti ad 1,5 palmi.
Note:1 Le acquisizioni riportate in questa sede a proposito
del castello di Carinola sono state in parte anticipate in F.MIRAGLIA, La mensiocronologia come strumento di analisi delletecniche costruttive murarie tardomedioevali campane. Indagine stra-tigrafica sul Castello di Carinola, in S. D’AGOSTINO (a curadi), Storia dell’Ingegneria (Atti del 4° Convegno Nazionale.Napoli, 16-17-18 aprile 2012), t. II, Santa Maria a Vico2012, pp. 1139-1150.
2 «Lo scalone d’angolo, col motivo lineare spezzato,è un classico elemento catalano che si trova realizzato innumerosi esempi, dal cortile del palazzo Bellomo a Sira-cusa a quello della deputazione di Barcellona». L. SAN-TORO, Castelli angioini e aragonesi…, cit., p. 142.
3 A dimostrazione della confusione delle fonti sulmanufatto, appare utile ricordare come un castello di “Ca-rinola” sia fugacemente citato da Giuseppe Del Re nel vo-lume che raccoglie gli scritti di cronisti e scrittori sincroninapoletani al tempo della dominazione normanna nelregno di Puglia e Sicilia, nella Storia di Ugone Falcando,riferita al periodo 1146-1169. Il Falcando, storiografo ope-rante nella seconda metà del xII secolo, di probabile ori-gine transalpina, sulla cui vera identità poco si conosce,tratta delle vicende del regno normanno di Sicilia e cita“Carinola”, riportando che: «i famigliari della Corte ritor-nati al Campanile, cavaron fuori il Conte di Mellento, e glialtri Francesi; e temendo gl’impeti sediziosi della plebe el’arrivo de’ Messinesi, fecero quelli tra tanto dimorare ne’due castelli di Partenico e di Carinola, finchè non si fosserapprestati i navigli per imbarcarsi». Nel testo originale inlatino la città è indicata come “Carinula”. Strano apparel’accostamento del castello carinolese a quello di Partinico,
66
Fig. 32. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, chiesa dell’Annun-ziata. In evidenza, il portale a cuspide dentellato, di ma-trice durazzesca, in origine collocato sulla fronte opposta.
città siciliana sita nella provincia palermitana: più realisti-camente, si tratta del castello di Carini, centro posto aduna trentina di chilometri da Palermo, che ospita un for-tilizio di fondazione normanna, in alcune fonti indicatoproprio con il toponimo “Carinula”. G. DEL RE, Cronistie scrittori sincroni della dominazione normanna nel Regno di Pugliae Sicilia, in IDEM, Cronisti e scrittori sincroni napoletani editi edinediti ordinati per serie e pubblicati. Storia della monarchia. Nor-manni, v. I, Napoli 1845, p. 388.
4 I castelli di pertinenza del demanio svevo in Cam-pania (xIII secolo) erano quelli di Napoli (Castelca-puano), Avellino, Aversa, Caserta, Maddaloni,Mondragone, Caiazzo, Gaeta, Sessa Aurunca, Teano,Alife, Rocca D’Evandro, Fondi, Rocca D’Arce, Atina eSora. Cfr. L. SANTORO, Insediamenti svevi in Campania, inM.S. CALò MARIANI, R. CASSANO (a cura di), Federico II.Immagine e potere, Venezia 1995, pp. 335-341 e P.F. PISTILLI,Castelli normanni e svevi in Terra di Lavoro. Insediamenti fortificatiin un territorio di confine, San Casciano V.P. 2003, tavola fuoritesto [Castelli svevi in Terra di Lavoro (1220-1250)].
5 L. SANTORO, Insediamenti svevi…, cit., p. 338.6 Baldovino II (1217-1273) fu l’ultimo imperatore
latino di Costantinopoli, dal 1228 al 1261, anno della ri-conquista della città da parte dei Bizantini. Alterne furonole vicende del suo regno e contrassegnate da continuelotte, tanto che fu costretto a recarsi spesso in Occidentea chiedere aiuto per fronteggiare i numerosi attacchi bi-zantini. Nel 1267 si recò presso la corte di Carlo I d’An-giò, che l’accolse con l’intento di appoggiarlo nellariconquista di Costantinopoli; ciononostante, la missionenon partì mai. Dopo aver lasciato definitivamente le terred’Oriente, con il figlio Filippo, visse stabilmente presso lacorte angioina gli anni che lo separavano dalla morte.
7 «(Mandat ut reparentur castra Alifie, Montisdra-gonis et Carinole. “Item castrum Caleni, de quo ab unaparte paries muri cecidit et indiget in omnibus reparari,reparari potest per nomine ipsius terre et casalium. Suntetiam sibi vicini nomine Calvi, qui bene possunt ad ean-dem reparationem venire, vid. a strata superius”). Dat.Rome, IV maii xV ind. (Reg. 13, f. 203)». C. MINIERI RIC-
67
Fig. 33. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, casa Di Cresce,fronte su via Stefano Ceca, piano terra. Si noti l’interes-sante portale catalano.
CIO, Il regno di Carlo I d’Angiò negli anni 1271 e 1272, Napoli1875, p. 63; IDEM, I Registri della Cancelleria Angioina (a curadi J. Donsì Gentile), v. VIII, Napoli 1967, p. 110. Uno stu-dio sullo sviluppo dell’architettura catalana a Carinola in-forma che del castello, «intorno al 1272, le mura cadentifurono riparate in tutte le loro parti dagli uomini del luogoe dei casali ed ulteriormente ampliate e rafforzate durantela dominazione della monarchia catalano-aragonese nelcontesto di un più ampio programma di sistema difensivodel territorio del regno contro i nemici interni ed esterni».C. ROBOTTI, Architettura catalana in Carinola, in M. ROSI,Carinola Pompei quattrocentesca, Napoli 1979, p. 96.
8 Al tempo, detentore del regno di Napoli era Ladi-slao di Durazzo, ultimo discendente maschio del ramoprincipale della dinastia degli Angioini, che lo tenne sinoal 1414, anno della sua morte.
9 Il testo originale, in latino vulgaris, recita «quod ca-strum est supra quemdam montem et deinde supra unumtartarectum, sicut esset tribus vicibus turris magna castriCaleni, inexpugnabile contra totum mundum». La tradu-zione è di padre Michele Piccirillo, noto archeologo, na-tivo di Carinola, per decenni impegnato a condurre scaviin Terra Santa, che ha ritrovato il manoscritto nella biblio-teca nazionale di Parigi, ampiamente commentandolo inuna recente pubblicazione. Nel testo è possibile ritrovareriferimenti ad altri edifici presenti a Carinola, tra i quali lacattedrale, e considerazioni sul massiccio massicano esull’attuale lago di Falciano. Cfr. M. PICCIRILLO (a cura di),Io notaio Nicola De Martoni. Il pellegrinaggio ai Luoghi Santi daCarinola a Gerusalemme 1394-1395, Gorle 2003, pp. 4, 162-163.
10 F. RUSSO, Trenta secoli di fortificazioni in Campania,Piedimonte Matese 1999, p. 202.
11 Camillo Porzio operò nel xVI secolo. Scrisse lastoria della congiura dei baroni, che inizialmente pensò diredigere in latino, in volgare: «e così, in tersa favella to-
scana la diede egli alla luce nel 1565 a Roma in un volu-metto in 4». C. MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittorinati nel Regno di Napoli, Sala Bolognese 1990, pp. 283-284.Ripr. facs. dell’ed.: Napoli, 1844.
12 Il Porzio, a proposito di un soggiorno del conteGiovan Francesco Petrucci presso la corte aragonese, ne-cessario per motivi diplomatici, scrive che quest’ultimo:«giunto a Corte ed umanamente inteso e con simulate pa-role ricevuto, ivi alquanto si fermò, più per attendere larovina del Re e goderne, che perché avesse voglia di gio-vargli. La quale cosa da molti della Corte conosciuta, in-vidiando la fortuna sua, ed agli stati e rendite sueaspirando, il diffamarono essere rivenuto a spiare gli an-damenti del Re: ed ispaventandolo che come traditorel’avrebbe punito, furono cagione che mandate prima lesue più care cose nel castello di Carinola, egli anche na-scostamente di notte, vi si rifuggisse». C. PORzIO, La con-giura de’ Baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando I,ristampa a cura di S. D’Aloe, Napoli 1859, p. 108.
13 Il 21 settembre 1934, l’allora soprintendente al-l’Arte medioevale e moderna, Armando Venè, inviò unamissiva al Ministero dell’Educazione Nazionale, nellaquale informava che il podestà di Carinola aveva stabilitodi acquistare dai proprietari, i fratelli Enrico e Luigi Ver-rengia, il castello. Il soprintendente propose al suddettoMinistero di autorizzare l’alienazione pubblica dell’edifi-cio, «purché nell’atto di cessione venga inserita la clausolache sull’immobile anzidetto nessun lavoro potrà essereeseguito senza la debita preventiva approvazione di questaSoprintendenza». Il Ministero, con missiva dell’1 ottobre1934, ne autorizzò l’alienazione nelle forme e nei modiprevisti dalla soprintendenza campana. Archivio Centraledello Stato (ACS), Ministero P.I., Dir. Gen. AA.BB.AA.,div. II, 1934-40, Napoli Provincia A-M, B. 259, class. 6,monumenti, f. “Carinola. Castello medioevale”.
14 Che il castello non fosse più adatto ad ospitare lecarceri, era ben chiaro al Caravita di Torritto, che, pur uti-lizzando un accorto e riverente linguaggio per non susci-tare le ire del Regime, pose enfasi sull’inadeguatezza delladestinazione d’uso: «il Commissario Prefettizio, dott. Gio-vanni De Stasio (…) ha acquistato pel Comune l’anticoCastello Ducale attualmente sede delle Carceri Manda-mentali. questo Castello, che ricorda Giov. Antonio Pe-trucci, Conte di Carinola, non è sotto tutti i punti di vista,la sede più adatta per le attuali carceri». B. CARAVITA DI
TORRITTO (a cura di), Una minuscola città del Quattrocento,Aversa 1936, pp. 23-24.
15 Prima del presente studio e del citato saggio del-l’A. sull’analisi stratigrafica della struttura, il supporto bi-bliografico sul castello di Carinola era limitato ad alcunitesti locali ed a saggi di più ampio respiro territoriale, che,per tale motivo, lo descrivono in maniera approssimativao riferendolo a vicende storico-architettoniche più gene-
68
Fig. 34. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, casa Di Cresce,piano terra, androne, lato ovest, muratura “a cantieri” ditufo grigio alti 35-40 cm.
rali. Un contributo sull’analisi delle tecniche costruttivedel fortilizio, che tratta dei paramenti esterni del mastio edella fronte sud del castello, è in M. D’APRILE, Muratureangioino-aragonesi…, cit., p. 234, n. 59. Si vedano anche C.ROBOTTI, Architettura catalana..., cit., p. 96 e C. CUNDARI,L. CARNEVALI, Il patrimonio architettonico di Carinola. I temianalizzati e le architetture rilevate, in C. CUNDARI, L. CARNE-VALI (a cura di), Carinola e il suo territorio. Rassegna dei beniarchitettonici, Roma 2003, pp. 67-69. In quest’ultimo con-tributo si afferma che la sua conoscenza «attende ulterioriindagini “in corpore” oltre ad una più esauriente letturadella sua stratificazione e della sua funzione nel tempo».Riferimenti al castello di Carinola sono anche in C. CROVA,op. cit., p. 43, n. 83 e pp. 113-114, dove si traccia un pa-rallelo tra il paramento esterno a filari di conci del mastioe la seconda cinta muraria di Sessa Aurunca (xIII-xIVsecolo), «realizzata in conci di tufo grigio a spigoli sbozzati(…) apparecchiata su filari orizzontali e regolari». In or-dine al castello, si afferma: «maggior raffinatezza si ritrova,invece, nella rocca di Carinola, il cui paramento dovrebbe
essere riconducibile agli interventi di ampliamento e raf-forzamento quattrocenteschi, realizzati in conci».
16 I paramenti interno ed esterno di un edificio dif-feriscono, nella gran parte dei casi, soltanto per motivi eco-nomici e di ordine funzionale. Infatti, «all’esterno del muroviene sempre impiegato il paramento tecnicamente mi-gliore, sia per ragioni estetiche sia funzionali di resistenzaagli agenti atmosferici e antropici; all’interno, dove il para-mento murario è più protetto dalle intemperie e dall’usurae dove frequentemente le superfici sono destinate a esserescialbate o intonacate, appare evidente come sia sufficienteuna tecnica di minore pezzatura, limitatamente squadratae scarsamente ripianata, con giunti e letti maggiormenteevidenti, in sostanza più corsiva e quindi più economica».F. REDI, Le strutture storiche come archivio di saperi empirici sumateriali, tecniche costruttive e organizzazione del cantiere nel Me-dioevo: diagnostica archeologica e metodi di datazione, in C. VARA-GNOLI (a cura di ), Muri parlanti. Prospettive…, cit., p. 47.
17 In letteratura è stata condotta un’analisi degli ap-parecchi murari angioini ed aragonesi di Terra di Lavoro,
69
Fig. 35. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, ingresso urbano alvico Aurora. In evidenza, il possente portale catalano in-castonato tra due edifici.
nella quale il mastio e la scarpata del castello di Carinolasono inseriti in una sottoclasse tipologica che presenta«tessiture in tufo giallo o grigio di qualità fine, in concisquadrati in 5 piani con faccia vista spianata e spigoli ten-denzialmente vivi, apparecchiati per filari orizzontali». Ilcontributo in questione informa che i filari hanno altezzavariabile tra 30 (rara) e 34 cm, segnalando anche picchi(come nel caso in parola) di 35-42 cm e lunghezza varia-bile tra 39 e 54 cm. Ancora, l’analisi conferma la presenzadi malta dalla granulometria fine, di giunti arretrati e di fi-niture dei conci allisciate. Ulteriori notizie pervengonocirca il nucleo murario, che, nella sottoclasse evidenziata,è generalmente costipato. Cfr. M. D’APRILE, Murature an-gioino-aragonesi…, cit., pp. 232-234.
18 A Napoli «le cortine tardomedievali in tufo grigiocampano e in piperno sono allestite con conci squadratie spianati con cura negli assetti orizzontali e verticali enelle facce esterne e solo sbozzati verso l’interno, di di-mensioni analoghe a quelle dei contemporanei elementiin tufo giallo. In particolare, si riscontrano altezze com-prese tra 20 e 39 cm (tra tre quarti di palmo e un palmo emezzo circa), con notevole frequenza di quelle tra 26 e 34cm. Le lunghezze sono generalmente di poco superiori,con un rapporto h:l pari a 1:1.5 (alle altezze maggiori cor-rispondono le lunghezze più marcate) o, meno diffusa-mente, a 1:1. Più raro è il caso di blocchi con rapporto trai lati di 1:2, mentre sono assenti, tranne sporadici casi,quelli ancor più snelli (...) Dunque, le cortine in tufo grigiocampano o in piperno erano messe in opera, in genere,contestualmente ai massi murari in tufo giallo, confezio-nati, di solito, a cantieri, con ricorsi di orizzontamento pariall’altezza dei blocchi in pietra da taglio», similmente almastio del castello di Carinola. L. GUERRIERO, A. MANCO,Paramenti in tufo grigio e in piperno dell’età moderna, in G.FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Murature tradizionali na-poletane…, cit., pp. 390, 392, 394.
19 L’importante struttura è stata oggetto di una rela-zione dell’A. al convegno internazionale del CITTAM Su-stainable Environment in the Mediterranean Region: from Housingto Urban and Land Scale Construction (Napoli, 12-14 febbraio2012), incentrata sulle sue caratterizzazioni costruttivequattrocentesche e sette-ottocentesche. Le acqusizioni ri-portate in questa sede sono in parte in corso di pubblica-zione nel saggio F. MIRAGLIA, New acquisitions on palazzoMarzano in Carinola, redatto in occasione del citato conve-gno.
20 «È lecito ipotizzare che il palazzo impegnasse l’in-tera insula, estendendosi quindi a quella che oggi è divisafra due proprietà eredi Ceraldi, e Bove». G. TORRIERO,Casa Marzano a Carinola, in C. CUNDARI (a cura di), Versoun repertorio…, cit., p. 124. A dimostrazione della veridicitàdi tale considerazione appare utile ricordare che, in un am-biente posto al secondo livello del palazzo, si trova una fi-nestra che affaccia nella piccola corte della proprietàattigua; quest’ultima, in origine, era verosimilmente l’ulte-riore cortile di un unico edificio.
21 Cfr. R. FILANGIERI DI CANDIDA, La casa di MarinoMarzano…, cit. e M. ROSI, Il palazzo Marzano di Carinola,Napoli 1979.
22 Il 14 ottobre 1938, il soprintendente all’Arte me-dioevale e moderna della Campania, Armando Venè, inviòal ministro dell’Educazione Nazionale una missiva sul re-stauro in corso alla “casa Martullo”, nella quale annun-ciava con enfasi che «dall’esame delle annesse fotografie,prese così, alla buona, durante il corso dei lavori, salvo atrarne un sufficiente numero ed in maniera più perfetta,ad opera compiuta, codesto On.le Ministero può già ren-dersi conto dell’importanza del restauro il cui risultato saràcertamente quello di restituire all’ammirazione degli estetie degli studiosi una delle più belle espressioni di architet-tura catalana, importate dagli Aragonesi nella Campanianel Sec. xV». ACS, Ministero P.I., Dir. Gen. AA.BB.AA.,
70
Fig. 36. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, edificio in vico Au-rora 1, fronte sud, piano primo, scorcio della loggia.
Fig. 37. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, edificio in vico Au-rora 1, fronte sud, piano terra, deposito, particolare delsolaio ligneo (xV sec.).
div. II, 1934-40, Napoli Provincia A-M, B. 259, class. 6,monumenti, f. “Carinola. Casa Martullo”. In ordine ai re-stauri condotti negli anni trenta del secolo scorso sul pa-lazzo, in particolar modo grazie all’impegno profuso daisoprintendenti Gino Chierici e Armando Venè e dal diret-tore di prima classe Oreste Siviero, si veda F. MIRAGLIA, Pa-lazzo Marzano a Carinola: i restauri..., cit. Il contributo inquestione si giova, oltre che di cospicui documenti di ar-chivio, anche di immagini illustranti gli interventi eseguiti.
23 I contrasti tra Marino Marzano e Ferrante d’Ara-gona, già latenti, esplosero in seguito alla morte del Ma-gnanimo (1458) ed alla conseguente ascesa al trono delfiglio naturale. Il Filangieri, a tal proposito, fissa proprionel 1458 il limite estremo dei lavori condotti dalle mae-stranze catalane sul palazzo Marzano. Cfr. C. PORzIO, op.cit., R. FILANGIERI, Architettura e scultura catalana in Campa-nia nel secolo XV, in “Boletin de la Sociedad Castellonensede cultura”, xI, Castellon, s.n., 1930, pp. 15 ss. e IDEM (il-lustrato da), Il codice miniato della confraternita di Santa Martain Napoli, Firenze 1950.
24 Nonostante l’ambito ruolo che ricopriva nellecomplesse e delicate maglie del potere aragonese, il Pe-trucci fu uno degli artefici della “congiura dei Baroni”, at-tuata insieme a due suoi figli e ad altri notabili – quali iCoppola e i Del Balzo – e mirante a rovesciare dal tronoFerrante, considerato un ostacolo al rafforzamento delpotere baronale.
25 V. RUSSO, Palazzo Novelli “casa catalana” a Carinola,in C. CUNDARI (a cura di), Palazzo Novelli a Carinola. La sto-ria, il rilievo, il restauro, Roma 2003, p. 71.
26 G. FIENGO, Prefazione a h. ROTOLO, op. cit., p. 10.27 Il restauro di palazzo Petrucci, finanziato con
fondi dell’Unione Europea e del Comune di Carinola, èampiamente descritto in C. CUNDARI (a cura di), PalazzoNovelli a Carinola..., cit. ha interesse constatare, a tal pro-posito, che alcuni interventi che lo hanno caratterizzatosono rispondenti perlopiù a logiche di sostituzione edili-zia, e, pertanto, non sono certamente ascrivibili ad unacompiuta prospettiva di conservazione.
28 Al riguardo cfr. M. D’ONOFRIO, V. PACE, Italia Ro-manica. La Campania, Milano 1981, pp. 96-108, M. ROSI,Carinola..., cit., F. MIRAGLIA, R. NOCCO, C. VALENTE, Ca-rinola. Viaggio…, cit., C. CUNDARI, L. CARNEVALI (a curadi), op. cit., A. BRODELLA, Storia della Diocesi di Carinola,Marina di Minturno 2005, IDEM, Appendice alla storia dellaDiocesi di Carinola, Marina di Minturno 2005 e C. VALENTE,L’Università Baronale di Carinola…, cit.
29 L’architetto Margherita Asso, negli anni sessantae settanta del Novecento funzionario della Soprinten-denza ai Monumenti della Campania, che ne curò il re-stauro, riconobbe alla cattedrale il carattere di «palinsesto»,impressionata dalle sue stratificazioni, che datavano dalIV al xVIII secolo. Cfr. M. ASSO, Carinola (Caserta). Chiesa
di S. Giovanni Apostolo (ex Cattedrale), in “Bollettino d’Arte”,s. V, a. LII (1967), f. II, aprile-giugno, p. 118. Ampi rag-guagli, a tal proposito, sono in G. LEVA, F. MIRAGLIA, Ilrestauro della cattedrale di Carinola (1966-72), in G. FIENGO,L. GUERRIERO (a cura di), Monumenti e documenti. Restauri erestauratori del secondo Novecento (Atti del seminario nazio-nale), Napoli 2011, pp. 427-438.
30 Cfr. C. RAUCCI, La Torre Angioina, in AA.VV., Pon-telatone dall’età aragonese all’eversione della feudalità, Curti 2009,pp. 19-21.
31 «Il mastio della fortezza di Pietravairano è costi-tuito da un’alta torre cilindrica, in posizione prominente,su base troncoconica e con cornice di separazione in bloc-chi di tufo grigio, con ingresso sopraelevato, affine al-l’esemplare, di volume però minore, della vicina Pon-telatone. Il basamento è apparecchiato per cantieri, alti45-50 cm, di pietre rustiche nella varietà calcarea locale,miste a rari ciottoli, disposte per fasce, con ingranaggioserrato e assortimento omogeneo (…) Nel corpo cilin-drico superiore (…) pur mantenendo i cantieri un’altezzamedia di 40-45 cm, gli elementi lapidei fanno registrareun’eterogeneità più pronunciata per quanto concerne pez-zature e dimensioni». M. D’APRILE, Murature angioino-ara-gonesi..., cit., p. 270, n. 101.
71
Fig. 38. Carinola (CE), fraz. Nocelleto, edificio in vico Au-rora 1, fronte sud, portale d’ingresso ad arco ogivale (xVsec.).
Fig. 39. Pontelatone (CE), la torre Marzano in una fotodegli anni ottanta del Novecento. Dalla struttura – qui ri-tratta prima dell’intervento di restauro – si poteva agevol-mente leggere la presenza dell’apparecchio murario “acantieri”, con questi ultimi ben riconoscibili perché nonancora obnubilati dalle ristilature in malta fine cementizia(da AA.VV., 1989: Pontelatone dall’età longobarda all’età ara-gonese).
72
Fig. 40. Pietravairano (CE), torre cilindrica. Si notino lepalesi affinità con la torre Marzano: la base di formatronco-conica, l’ingresso sopraelevato ed il redondone checirconda il corpo cilindrico superiore (Foto S. Merola, S.Palmieri).
Tecniche di muro in tufo grigio nei sub-areali di studio (xIII-xV)
Setti verticali
Le tecniche di muro riscontrate nei sub-arealianalizzati in questa sede, tra il xIII ed il xV se-colo, quindi nell’arco temporale che va dalla do-minazione angioina a quella aragonese, palesanoil preponderante ricorso al magistero “a can-tieri”, sia nelle fabbriche di più complessa fatturao fortificate sia, a maggior ragione, mercé l’eco-nomicità di realizzazione, nell’edilizia.
Più rare, invece, sono risultate essere lestrutture erette con magisteri a filari, tecnica so-vente esperita per la realizzazione di fodere suiparamenti murari esterni – soprattutto per mo-tivi difensivi – e per la configurazione dei can-tonali.
In ordine alla lavorazione dei materiali lapi-dei dei menzionati “cantieri”, il tufo grigio cam-pano e la sua variante tufo giallo stratificato,sulla scorta di quanto sinora approfondito, risul-tano apprestati di solito con l’utilizzo di pie-trame spaccato, congiuntamente ad elementiminuti, più o meno diffusi, quali “asche” ezeppe, per pareggiare i ricorsi orizzontali.
L’altezza dei “cantieri”, indicatore cronoti-pologico rilevante ai fini della datazione deglistessi, nei manufatti ascrivibili al periodo che vadall’inizio del xIV sino a tutto il xV secolo, cor-rispondente alla fase conclusiva della domina-zione angioina, a quella durazzesca ed alla brevepresenza della corona aragonese, assume valorioscillanti tra 40 e 56 cm.
La relativa tipologia è perlopiù “ad inca-stro”, ossia con ricorsi orizzontali conformatida elementi lapidei apparecchiati tridimensional-mente, tenendo, in tal modo, in massimo contoil corretto ingranaggio tra il nucleo murario ed idue paramenti. Ciò ha permesso anche la realiz-zazione di sezioni murarie di ragguardevolespessore.
Non mancano, ad ogni modo, “cantieri”apparecchiati “a fascia”, soprattutto in presenzadi costituenti di pezzatura più omogenea, o conaltezza minore (35 cm circa), di produzione an-tecedente, riferibile, come confermano soprat-tutto i dati desunti dall’analisi stratigrafica delle
murature del castello di Carinola, alla prima fasedella dominazione angioina (xIII secolo).
La generale assonanza nelle altezze dei“cantieri”, cui non fanno certamente eccezionele strutture militari o quelle di più ambiziosoprogramma, dimostra che, nonostante il mutaredelle dominazioni e del gusto costruttivo, es-sendo esiguo il lasso temporale considerato, letecniche di muro non hanno subito sostanzialivariazioni. Al riguardo, si può far cenno, ancorauna volta, ad alcune murature del castello di Ca-rinola per una prima classificazione della tecnicacostruttiva muraria “a cantieri”, della quale ilfortilizio offre ampie testimonianze, a partire dalmuro della fronte est (Tavv. 3-4).
Il paramento interno di quest’ultimo, fruttodi più intraprese costruttive, come poc’anzi ap-purato a seguito dell’analisi stratigrafica, è appa-recchiato con “cantieri” di pietre spaccate alti35-45 cm, regolarizzati con l’utilizzo di materialeminuto e di elementi fittili, in gran parte pezzidi coppi. Nel settore più a nord della parete, l’ap-parecchio murario presenta allineamenti di ele-menti litoidi diffusamente impilati, più che neglialtri settori, dove invece questi risultano appre-stati in modo maggiormente omogeneo. I costi-tuenti hanno generalmente dimensionimedio-grandi e allungate (alti 22 cm, lunghi 42cm, con un rapporto h:l pari a 1:2).
Spostandosi sul lato est del muro è possibileanalizzarne il paramento esterno, apparecchiato“a cantieri”, conformante la parte sommitaledella scarpa contigua al mastio, con costituentiche offrono, mercé la più accurata lavorazione,dimensioni più equilibrate, con altezza e lar-ghezza tendenti ad un palmo e lunghezza pari a34-54 cm (1,25-2 palmi) (Fig. 41).
Un altro campione murario che ha interesseanalizzare riguarda il paramento interno del ma-stio (Tav. 5), riferibile, come chiarito in prece-denza, al xIII secolo e apparecchiato con“cantieri” di pietrame spaccato che seguono, perquanto riguarda l’altezza, valori simili al prece-dente (40 cm circa). Gli elementi litoidi che locompongono hanno dimensioni leggermenteminori (alti 21 cm circa e lunghi 32-38 cm).
73
Fig. 41. Carinola (CE), castello, fronte est, paramentoesterno. Si noti il differente apparecchio del muro sopra-stante, confezionato “a cantieri”, rispetto a quello dellabase scarpata, realizzato facendo ricorso a filari di concisquadrati alti 27 cm circa. I costituenti di entrambe le mu-rature sono di tufo grigio.
Sul paramento esterno del mastio, invece,si ritrovano conci squadrati con altezza di 40 cmcirca, confermando, come accennato poc’anzi,una realizzazione sostanzialmente coeva dei dueparamenti. Accanto a quest’ultimo, in direzioneovest, inoltre, è possibile analizzare l’apparec-chio murario del corpo di fabbrica attiguo, chepresenta “cantieri” alti 35-40 cm (si faccia rife-rimento, per l’analisi di entrambi i campioni mu-rari, alla Tav. 6).
Ritornando alla fronte sud del castello, sullato interno, nel punto immediatamente conti-guo al grande arco ogivale superstite, si possonorilevare utili informazioni anche in ordine allacomposizione dei nuclei murari. Infatti, l’analisidi un’alta e consistente breccia (Tav. 7), untempo parte del muro posto ad ovest che chiu-deva la grande sala del fortilizio, riferibile alla
prima metà del xV secolo, ha consentito di evi-denziare la presenza di un nucleo murario co-siddetto “costipato”.
questa tipologia di nucleo, come in prece-denza enunciato, è largamente diffusa nel pe-riodo tardo-medievale in Terra di Lavoro, sia neimanufatti realizzati in tufo sia in quelli nei qualiè stato utilizzato il calcare. L’apparecchio mura-rio che si desume dal campione analizzato pre-senta registri “a cantieri”, con altezza di 49-54cm, dunque tendente a due palmi, costituiti datre allineamenti di pietre spaccate mediamenteinzeppate, disposte ad incastro.
Dalla sezione muraria si può anche dedurrela qualità della malta, a base di calce, con aggre-gati di sabbia di fiume, che presenta granulome-tria grossolana e letti di posa di altezzageneralmente pari a 2-3 cm.
74
Tav. 3. Carinola (CE), castello, fronte est, paramento in-terno, primo livello, muratura in tufo grigio (xIII sec.).Apparecchio “a cantieri” alti 40-44 cm, con due allinea-menti di pezzame spaccato, che, diffusamente impilati, re-gistrano una modesta presenza di elementi minuti dipareggiamento, di tufo e fittili. Il muro, che sulla fronteesterna ha un paramento a filari di conci alti 27 cm, è co-struito con perizia. È probabile che il paramento internosia stato realizzato, in parte, con i blocchi utilizzati per ap-prestare quello esterno non lavorati, ma soltanto sbozzati.
Tav. 4. Carinola (CE), castello, fronte est, paramento in-terno, primo livello, muratura in tufo grigio (xIII sec.). Inevidenza, l’assetto delle buche pontaie e gli apparecchimurari a “cantieri” ancora visibili, con altezza variabile da35 a 45 cm, separati da una soluzione di continuità evi-denziata dalla presenza di orizzontamenti non complanari(rielab. da rilievo di V. Dell’Aversano, F. Di Simone, C.Fusco).
76
Va segnalato, infine, che la notevole sezionedei setti murari, in alcuni casi superiore ai duemetri, ha indotto alla realizzazione, evidente-mente per motivi di ordine costruttivo, di “can-tieri” con altezze che a stento superano i 50 cm,in ossequio alla prassi che indica la sussistenzadi un rapporto inversamente proporzionale tral’altezza di questi ultimi e lo spessore murario1.
Anche il paramento esterno della frontesud del castello, come accennato riferibile adun’intrapresa costruttiva del xIV secolo, di-spone di un apparecchio murario “a cantieri” dialtezza assimilabile a quelli sinora riportati.
Ulteriori indicazioni sono fornite dall’analisidel paramento interno sulla fronte ovest del for-tilizio (Tav. 8), che presenta “cantieri” di tufo
Tav. 5. Carinola (CE), castello, mastio, fronte nord, para-mento interno, secondo livello, muratura in tufo grigio(xIII sec.). Il campione murario indagato presenta un ap-parecchio “a cantieri” con altezza grossomodo costante(40 cm circa). I costituenti, composti da due allineamentidi pezzame spaccato, registrano una discreta presenza dielementi minuti di pareggiamento di tufo grigio.
77
grigio alti 52 cm circa, pareggiati da una discretaquantità di elementi minuti – anch’essi di tufogrigio – e di altre porzioni murarie rinvenibili sugran parte della struttura, come il paramento in-terno della fronte sud, con “cantieri” che, ecce-zion fatta per quelli basamentali (alti 56 cmcirca) presentano mediamente un’altezza di 35-40 cm (Fig. 42).
Simili caratterizzazioni strutturali, come ac-cennato, sono estesamente visibili sul paramentoesterno della fronte ovest del palazzo Petrucci(Tav. 9), riferibile al xIV-xV secolo, sormontatoda una monofora ogivale dentellata ed apparec-chiato con corsi sdoppiati di bozze di tufo gri-gio, contenuti in “cantieri” di altezzagrossomodo costante, pari a 40 cm circa, ana-
Tav. 6. Carinola (CE), mastio e castello. CM1: mastio, fronte nord, paramento esterno, secondo livello, muratura in tufogrigio (xIII sec.). Il campione murario indagato presenta un apparecchio a filari di conci con altezza di 39 cm circa. Glielementi litoidi utilizzati sono di forma regolare, con facciavista allisciata e spigoli tendenzialmente vivi. I giunti di maltasono perlopiù arretrati e presentano granulometria grossolana. CM2: castello, fronte sud, paramento esterno successi-vamente inglobato nell’ampliamento della struttura, lato nord, primo livello, muratura in tufo grigio (xIV sec.). Il cam-pione murario indagato è allestito con un apparecchio “a cantieri” alti 35-40 cm. Gli elementi litoidi utilizzati sono inpezzame spaccato, registrando la presenza diffusa di scaglie e scapoli. I giunti di malta sono arretrati e sulla superficiedel paramento sono visibili lacerti d’intonaco.
78
Fig. 42. Carinola (CE), castello, fronte sud, paramento in-terno, primo livello, muratura in tufo grigio “a cantieri”(xIV sec.). I primi due ricorsi, alti due palmi circa, sonosovrastati da ricorsi più bassi, con altezza di 35-40 cm.
logo nell’impostazione alla fronte sud del ca-stello, nella quale è rinvenibile, tra le altre pre-senti, una monofora di foggia affine.
Inoltre, è chiaramente osservabile una saet-tiera, a conferma della destinazione difensiva diquesta fronte, che, pur congiungendosi al ma-nufatto a destinazione residenziale, costituivauna porzione della cinta muraria.
questo tipo di feritoia, composta da dueconci di ragguardevoli dimensioni (60 x 20 x 20cm) posti con il lato lungo in verticale e da altridue collocati di punta per l’ammorsamento conil nucleo murario, si ritrova anche in una torrettanei pressi del castello (Tav. 10), che offre analo-ghe caratteristiche costruttive e “cantieri” dagliallineamenti non regolari, alti da 30 a 45 cm.
Il piccolo manufatto, non facilmente indi-viduabile perché purtroppo pesantemente ri-
strutturato e mutato in abitazione, offre la frontenord-est a facciavista, la qual cosa consente diverificare con precisione almeno altezza e lun-ghezza dei conci costituenti le due feritoie (75 x27-30 cm).
Muovendosi in direzione nord-ovest, invico del Sole si ritrova, invece, un possente murodi contenimento (Tav. 11), eretto per delimitarelo spazio occupato dal giardino del palazzo Pe-trucci, che scandisce tutta la lunghezza dellastrada, offrendo ampie porzioni a facciavista.Anche in questo caso ci si trova dinanzi ad unapparecchio murario “a cantieri”, con due alli-neamenti, a tratti irregolari, di pietre spaccate ditufo grigio, che presentano dimensioni marcata-mente eterogenee.
Oltrepassando il muro, nell’ampio giardinodel palazzo, la già citata abitazione posta nelle
79
Tav. 7. Carinola (CE), castello, fronte sud, piano terra, mu-ratura in tufo grigio (xV sec.). Il campione murario inda-gato è allestito con apparecchio “a cantieri” alti 49-54 cm.Ogni “cantiere” è apprestato con tre allineamenti di pietrespaccate di varie dimensioni e contiene una discreta quan-tità di elementi minuti, di tufo grigio e fittili. Il campionemurario informa, altresì, sulla composizione del nucleo,che si presenta “costipato”, realizzato con grande quantitàdi malta di granulometria grossolana e inerti costituiti dapietrame di provenienza fluviale.
sue adiacenze, articolata su due livelli fuori terra,mostra un apparecchio murario “a cantieri” conaltezza oscillante dai 41 cm della porzione ter-ranea ai 51 delle altre bancate, caratterizzati dadue allineamenti di pietre spaccate di tufo grigio,che, giovandosi di profili maggiormente regolari,registrano una scarsa presenza di elementi mi-nuti utilizzati per il pareggiamento dei ricorsi(Tav. 12).
Sempre a Carinola, spostandosi ad est, nelvico Macello è possibile osservare un edificiocon un apparecchio murario “a cantieri” (Tav.13) alti 36-49 cm, dal profilo alquanto irregolare.Il quadrante urbano, posto negli immediatipressi del sedile quattrocentesco (Fig. 43), delquale oggi purtroppo ben poco rimane – avendolo stesso subito vari interventi di ristrutturazionenel corso degli anni – offre diversi episodi rife-ribili al xIV-xV secolo, sfortunatamente di dif-ficile lettura, a causa di operazioni condottesenza perseguire la doverosa istanza di salva-guardia delle originarie caratterizzazioni struttu-rali e figurali (Figg. 44-45).
Ancora più ad est, negli immediati pressidella chiesa dell’Annunziata (Fig. 46) è possibilerinvenire un consistente tratto della murazioneurbana dell’insediamento, con buona probabilitàrealizzata dopo la costruzione dell’edificio sacroe dell’ospedale ad esso attiguo – del quale ogginon vi è più traccia – e, pertanto, riferibile ad in-traprese del xV secolo. In questo episodio èagevole rilevare la presenza di un apparecchiomurario “a cantieri” di tufo grigio, alti 39-44 cm,ai quali sono affiancati filari di conci che presen-tano costituenti alti mediamente 40 cm (Fig. 47).
Un apparecchio murario “a cantieri”, simileper impostazione a quello sopra descritto, sitrova a Mondragone – realtà urbana non moltodistante da Carinola, situata sulla fascia litoraneacasertana – al civico 51 della centrale via Vene-zia. Si tratta del bastione sud-ovest della “Terradi Mondragone”, insediamento fortificato diorigine quattrocentesca ma sviluppatosi appienonel corso del xVI secolo, rappresentando il nu-cleo dal quale si è originata la città contempora-nea (Fig. 48).
Anche in questo caso, le altezze dei “can-tieri”, conformati da tre allineamenti di pezzamespaccato di tufo grigio, sono assimilabili a duepalmi napoletani2.
Ampie informazioni sul magistero murario“a cantieri” sono riscontrabili anche nel distrettodi Pontelatone, posto nell’area del monte Mag-giore. In particolar modo, la base scarpata dellacitata torre Marzano (Tav. 14), ascrivibile – comechiarito – al xIV secolo, dispone di ricorsi oriz-zontali di pietrame spaccato di tufo grigio, con-formati da due allineamenti di altezza pari a50-55 cm, con costituenti alti 18-22 cm e lunghi35-54 cm, pareggiati da un discreto numero dielementi minuti. Il corpo superiore presenta“cantieri” più omogenei, alti circa 52 cm, pareg-giati facendo ampio ricorso a zeppe e ad abbon-dante malta.
In corrispondenza della sommità della basescarpata l’altezza dei ricorsi aumenta (60-70 cm)per raggiungere l’imposta della volta dell’am-biente interno. A questi dati vanno aggiuntiquelli inerenti alle dimensioni dei conci squadratiche coronano il vano d’ingresso. questi ultimi,anch’essi di tufo grigio, collocati in lungo e inlargo, con facciavista allisciata e sagomati inopera con grande precisione, hanno altezza va-riabile (28-56 cm, con una media di 35 cm), euna profondità ragguardevole, pari a 50 cm circa(Fig. 49). Il possente redondone, infine, ha undiametro di 30 cm3.
Sempre a Pontelatone, lungo via IV novem-bre si trova un ampio brano murario che pre-senta “cantieri” alti 40-54 cm (Fig. 50), riferibilead intraprese del xV secolo, dunque coevo aquelli che caratterizzano il centro storico del sito,apprestati in genere con due allineamenti di co-stituenti di dimensioni eterogenee, impilati e so-vrastati da elementi più piccoli per ilpareggiamento dei ricorsi orizzontali. L’analisiqualitativa della malta restituisce un conglome-rato, di granulometria grossolana e mediocrequalità, in gran parte soggetto a fenomeni di di-stacco.
ha interesse ribadire, tra l’altro, che le inda-gini sinora condotte, soprattutto nel distretto di
81
Fig. 43. Carinola (CE), via Annunziata, scorcio del sedile(xV sec.). In evidenza, i resti di un arco a sesto acuto, oc-cluso per creare un vano abitativo.
Carinola, evidenziano la chiara interdipendenzatra il magistero murario “a cantieri” e quello afilari, spesso rinvenibili nella stessa struttura,come nel caso del castello o di palazzo Petrucci.questa contiguità si spiega con il fatto che, inoccasione della dominazione aragonese, i dueedifici furono ampiamente ristrutturati. In par-ticolare, il castello, si giovò dell’impianto di pa-ramenti esterni a filari di conci squadrati, confunzione di irrobustimento delle facciate più fre-quentemente esposte agli attacchi dei nemici.
Ampie informazioni, in tal senso, sono of-ferte dal paramento esterno del mastio, sulla
fronte sud, e dal basamento della scarpata delfortilizio ad est, poc’anzi citato. I conci del ma-stio, alti 27-39 cm, con un range di 28-30 cm, lun-ghi 70 cm e larghi 40 cm (Fig. 51), presentanogiunti di malta non analizzabili compiutamente,perché oggetto di una recente ristilatura conmalta fine cementizia, mentre quelli della scarpa,di dimensioni similari (alti 27 cm, lunghi 70 cme larghi 38 cm), scampati per ora ad interventiinvasivi, sono caratterizzati da giunti arretratisino ad 8-10 cm.
Ritornando al magistero murario prepon-derante, ossia quello “a cantieri”, utile è anche
82
Fig. 44. Carinola (CE), vico Macello, supportico. Diffuseristilature di malta fine cementizia hanno alterato pesan-temente il ritmo originario della muratura facciavista, ren-dendone difficile la lettura.
l’esame di altre strutture fortificate, riferibili allaseconda metà del xV secolo, ad ulteriore dimo-strazione, sulla scorta dei casi in precedenza ana-lizzati, di come l’altezza dei ricorsi fosse, ingenere, sostanzialmente omogenea, anche al va-riare delle tipologie strutturali4, dimostrando inciò l’acquisizione e l’utilizzo seriale delle mede-sime prassi costruttive.
La cinta muraria di Sessa Aurunca (Fig. 52),sul tratto nord-est, è realizzata con “cantieri” dipezzame spaccato di tufo grigio alti 43-49 cm.Sempre nel centro sessano, si può fare riferi-mento alla torre dei Cappuccini (Fig. 53), postaal culmine meridionale della città, che presentaun apparecchio “a cantieri” di tufo giallo, di al-tezza tendenzialmente pari a 52 cm circa, quindia due palmi, ed alla torre ad ovest di quest’ultima(Fig. 54), confezionata con “cantieri” di tufogiallo alti 42-50 cm.
Infine, la base scarpata della torre di S. Bia-gio (Fig. 55), realizzata nel xV secolo attorno alcorpo quadrangolare di matrice angioina, è ap-parecchiata con “cantieri” di tufo giallo di al-tezza pari a 52 cm circa.
Ritornando alle abitazioni, ha interesse se-gnalare che lo studio del quadrante urbano diSessa Aurunca ampiamente caratterizzato da in-terventi legati alla cultura durazzesco-catalana,che si dipana negli immediati pressi del duomo
in una serie di strade strette e tortuose, offreun’interessante campionatura di murature, utiliper assicurare ulteriore conferma delle caratte-rizzazioni delle tecniche di muro annoverabili alxIV-xV secolo.
All’angolo tra vico Ugolino e via S. Antonioè una muratura “a cantieri” di tufo giallo alti 48cm circa, caratterizzati da costituenti di dimen-sioni generalmente medie, pareggiati con ele-menti fittili e “asche” di tufo grigio. Elementi didimensioni maggiori, di reimpiego, sono inseritinel muro in maniera episodica.
Al civico 30 di via Scanzati (Fig. 56), invece,si trova un edificio articolato su tre livelli, chepresenta una muratura “a cantieri” anch’essa ap-parecchiata con costituenti di tufo giallo. Gliorizzontamenti, formati da due allineamenti dipezzame spaccato di dimensioni eterogenee,sono alti 40-45 cm e presentano elementi minutidi pareggiamento di tufo grigio e frammenti dicocciopesto.
Giova soffermarsi anche su un immobile dimatrice catalana sito in via Spine al civico 14(strada che costeggia l’area occupata dalduomo), nel quale, sebbene ampiamente trasfor-mato da interventi spesso lesivi, è stato possibileanalizzare, nello spazio andronale, due apparec-chi murari di fattura similare, realizzati in tufogrigio e giallo, rientranti nella classificazione stu-
Fig. 46. Carinola (CE), scorcio della chiesa dell’Annun-ziata. Si noti l’evidente stato di degrado dell’edificio sacro– segnalato, in particolare, dalle preoccupanti condizionistatiche del campanile – da anni abbandonato dalle istitu-zioni.
83
Fig. 45. Carinola (CE), edificio in vico Macello 10, para-mento esterno, evidenze stratigrafiche.
diata nella presente ricerca. Il muro posto sullato sud-ovest (Fig. 57), conformato da due alli-neamenti di pezzame spaccato di tufo giallo,presenta “cantieri” alti 45-52 cm, pareggiati da“asche”, anch’esse di tufo giallo. I costituentihanno pezzatura alquanto eterogenea.
quello posto sul lato sud-est (Fig. 58), alcontrario, presenta “cantieri” di tufo grigio, ap-parecchiati con pezzame spaccato e rustico diforma perlopiù assimilabile al rettangolo ed altrapezio5. Come nel caso precedente, l’altezzadei “cantieri”, pareggiati con “asche” di tufo gri-gio e giallo, è pari a 45-52 cm, range sinora am-piamente riscontrato. D’altra parte, “cantieri”alti mediamente 45 cm sono presenti al secondolivello della citata casa Di Cresce a Nocelleto diCarinola, ascrivibili ad intraprese catalane e rien-tranti, anch’essi, in valori compresi tra 1,5 e duepalmi.
Ritornando al palazzo di via Spine, nel cor-tile si nota, vulnerata da interventi scellerati chel’hanno quasi distrutta, una finestra di stilema
catalano (Fig. 59)6. Lo stesso discorso può esten-dersi al palazzo noto per aver ospitato il GranCapitano Consalvo Ferrando de Cordoba neiprimi anni del viceregno spagnolo. Articolato sutre livelli fuori terra, l’edificio ha subito pesantiinterventi di ristrutturazione e sopraelevazione,favoriti da una notevole parcellizzazione dellaproprietà e condotti nel colpevole disinteressedelle istituzioni (Fig. 60).
Continuando il percorso di conoscenzadelle tecniche di muro che caratterizzano, perl’arco temporale individuato, l’edilizia del terri-torio in esame, nel borgo di Pugliano, frazionedel comune di Teano ma prossimo al distrettocarinolese, si può osservare un apprezzabile re-pertorio di edifici tardo-medievali, a partire dauna piccola abitazione in via Casa Licciardi, ri-feribile, come attesta la data contenuta in unadelle due insegne presenti sulla facciata princi-pale, al 14567, dunque agli albori della domina-zione aragonese, quando la genìa dei Marzanoera ancora una delle più potenti della Terra La-
Tav. 8. Carinola (CE), castello, fronte ovest, paramentointerno, primo livello, muratura in tufo grigio (xV sec.).Il campione murario indagato presenta un apparecchio “acantieri” con altezza grossomodo costante (50-52 cm). Icostituenti sono organizzati in due allineamenti di pez-zame spaccato di grandi dimensioni. Gli orizzontamentisono pareggiati da una discreta quantità di elementi mi-nuti, anch’essi di tufo grigio.
84
Fig. 48 - Mondragone (CE), bastione difensivo della“Terra di Mondragone” (xV-xVI sec.), fronte ovest. Èben evidente l’apparecchio murario “a cantieri”.
Fig. 47. Carinola (CE), murazione urbana, versante est. Inevidenza, uno sperone esterno, che presenta un apparec-chio “a cantieri” di tufo grigio (xV sec.) alti 39-44 cm,fortunatamente non ancora alterato da interventi di risti-latura dei giunti di malta.
85
Fig. 49. Pontelatone (CE), torre Marzano, particolare delvano d’ingresso. In evidenza, i conci squadrati di tufo gri-gio che lo coronano e i giunti di malta scampati alla risti-latura con malta fine cementizia, operata nel recenteintervento di restauro, perlopiù arretrati.
Fig. 50. Pontelatone (CE), via IV novembre, muratura “acantieri” di tufo grigio (xV sec.) alti 40-54 cm, organizzatafacendo ricorso a costituenti di foggia eterogenea.
boris ed era già legata, attraverso il matrimoniotra Marino Marzano ed Eleonora d’Aragona, allacorte del Magnanimo.
Di semplice fattura, costruito con materialidi raccolta, l’edificio è impreziosito da una fine-stra con forme ben assimilabili a quelle di alcunepresenti nel più noto palazzo Petrucci di Cari-nola (Fig. 61).
Il paramento esterno che affaccia sullacorte retrostante (Fig. 62) offre utili informa-zioni sull’apparecchio murario, realizzato con“cantieri” di tufo giallo e grigio alti 40-45 cm.Cantonali apprestati con elementi di tufo giallogrossolanamente squadrati ne definiscono gli al-lineamenti.
Sempre a Pugliano, in via S. Maria degli An-geli, si staglia un’alta casa – non analizzabilecompiutamente a causa dell’impossibilità di ac-
cedervi (Fig. 63) – dall’apparecchio murario “acantieri” di tufo grigio, linearizzati da cantonaliin conci squadrati dello stesso materiale. Neipressi di quest’abitazione abbandonata si trovaun altro edificio, che offre il paramento esternodella fronte laterale a facciavista, organizzato incorsi sub-orizzontali di pietrame rustico conzeppe, alti mediamente 27 cm (Fig. 64).
Anche un manufatto a destinazione abita-tiva, sito a Formicola in una traversa di via S.Cristina (Tav. 15), dispone di muratura “a can-tieri”, con altezza di 43-50 cm, confermante ivalori richiamati nei distretti sinora analizzati.
Nella frazione Cavallari dello stesso co-mune, altresì, è possibile notare, in via Cavallari17, un interessante edificio a corte interna conloggia arcata (Figg. 65-66). Su un pilastro otta-gonale di foggia quattrocentesca, con il corona-
86
Tav. 9. Carinola (CE), palazzo Petrucci, fronte ovest, pa-ramento esterno, piano terra, muratura in tufo grigio(xIV-xV sec.). Il campione murario indagato presenta unapparecchio a corsi sdoppiati di bozze contenuti in bassi“cantieri” alti 40 cm circa, con un discreto impilaggio deicostituenti. Gli elementi litoidi registrano la presenza dipietrame rustico e una scarsa quantità di materiale minuto.Una saettiera, realizzata con pietre grossolanamente ac-conciate sovrastate da un elemento triangolare, inter-rompe la continuità della tessitura muraria.
Tav. 10. Carinola (CE), edificio in via Annunziata, frontenord-est, paramento esterno, piano primo, muratura intufo grigio (xIV-xV sec.). Il campione murario indagatopresenta un apparecchio “a cantieri” alquanto irregolari,alti da 30 a 45 cm. Gli elementi litoidi sono organizzati indue allineamenti di pezzame spaccato di grandi dimen-sioni e forma eterogenea. Gli orizzontamenti, alcuni deiquali linearizzati da conci squadrati di tufo grigio, sonopareggiati con l’utilizzo di un’elevata quantità di elementiminuti dello stesso materiale.
88
Fig. 51. Carinola (CE), mastio, fronte sud, paramentoesterno, primo livello, apparecchio murario a filari di concidi tufo grigio. Si notino la forte erosione dei costituenti ele improvvide ristilature con malta fine cementizia.
mento del capitello identico alle cornici lapideeadiacenti, sono impostate voltine seriori inbozze di tufo grigio, riferibili alla tarda età mo-derna.
Ad eccezione del pilastro, il manufatto èrealizzato con costituenti di tufo grigio e ripete,anche se in piccola scala, la tipologia della casapalatiata di matrice catalana, disponendo di unapiccola corte e di una loggia articolata su due li-velli, con una scala laterale che consente l’ac-cesso ai locali posti alla quota superiore.
Lo spazio analizzato è agilmente compara-bile con il loggiato sette-ottocentesco posto nelcortile minore di palazzo Marzano a Carinola,per quanto riguarda l’articolazione planimetricae la forma degli elementi litoidi – bozzette – checompongono le voltine a tutto sesto, con la soladifferenza che l’episodio carinolese non pre-
senta preesistenze riferibili ad intraprese tardo-medievali.
Il palazzo Rotondo nella vicina Pontela-tone, ascrivibile al xV secolo, presenta, sullafronte nord-est, un apparecchio murario “a can-tieri” (Tav. 16), costituiti da due allineamenti dipietre spaccate di tufo grigio, con altezza pari a27-30 cm, dunque tendente ad un palmo, of-frendo ricorsi orizzontali caratterizzati da valoritendenzialmente pari alla metà di quelli riscon-trati con maggior ricorrenza per il periodo incausa, pareggiati da un elevato numero di mate-riale minuto (in preponderanza “asche”), an-ch’esso di tufo grigio.
La realizzazione di “cantieri” così bassi si èresa evidentemente necessaria a causa della di-sponibilità in loco di enormi quantità di materialeminuto, che non ha consentito – per motivi di
89
Tav. 11. Carinola (CE), muro in vico del sole, fronte nord,paramento esterno, piano terra, muratura in tufo grigio(xIV-xV sec.). Il campione murario indagato presenta unapparecchio “a cantieri” piuttosto irregolari, alti 35-45 cm.Il materiale lapideo utilizzato, organizzato in due allinea-menti di pezzame spaccato, ha dimensioni eterogenee, re-gistrando una discreta quantità di elementi minuti per ilpareggiamento dei ricorsi orizzontali.
ordine strutturale – la confezione di ricorsi oriz-zontali più alti.
Articolato su due livelli fuori terra, l’edificioconserva, complessivamente, la caratterizza-zione spazio-funzionale del palatium quattrocen-tesco, dal tratto distintivo catalano, dimostratoanche attraverso la realizzazione di interessantimembrature e sotto forma di una scala scoperta,poggiante su un’arcata a cuspide.
Di questo interessante manufatto merita at-tenzione anche il cantonale, presente sulla stessafronte e visibile per un’altezza di 1,50 m circa,composto da elementi di tufo grigio grossolana-mente “acconciati”, alti 10-16 cm, posti alterna-tivamente in lungo e in largo. Oltre ad assicurareun sufficiente allineamento per la composizionedei “cantieri”, l’angolata ne determina chiara-mente l’altezza.
Ulteriori episodi edilizi, utili a confermarele invarianti sinora riscontrate, sono rinvenibilinel suggestivo borgo di S. Castrese, centro sto-
rico di Castel Volturno, come già ricordato diorigine alto-medievale ma con consistenti carat-terizzazioni risalenti al xIV-xV secolo. L’edifi-cio al civico 2 di vico V S. Castrese (Tav. 17) –uno dei pochi accessibili – ad esempio, presentaun apparecchio murario “a cantieri” alti 40-45cm, conformato da pietre spaccate di tufo grigioe giallo.
All’esterno dello stesso si osserva un para-mento “a cantieri” configurato con identici lito-tipi, caratterizzato però da un’ingente presenzadi frammenti di cotto e cocciopesto, nonché dispolia di origine romana, con buona probabilitàrecuperate dalle macerie dell’antico ponte (Fig.67) realizzato per attraversare il fiume Volturno.
Nel sito in parola è possibile analizzareanche alcune sezioni murarie, grazie alla pre-senza di brecce, che evidenziano un nucleo “in-castrato” che configura, sovente, ricorsiorizzontali periodici alti 40-45 cm e denota alsuo interno la presenza di una gran quantità di
90
Fig. 52. Sessa Aurunca (CE), cinta muraria, fronte nord-est, paramento esterno, piano terra, muratura “a cantieri”di tufo grigio (xV sec.) alti 43-49 cm (da FIENGO, GUER-RIERO 2008).
malta (Fig. 68). Nonostante la condizione digrave degrado in cui versa da anni, il borgo con-serva ancora elementi quattrocenteschi, comeuna serie di interessanti mensole realizzate intufo grigio (Fig. 69), anch’esse purtroppo forte-mente lesionate.
Nella vicina Mondragone, invece, il con-vento francescano (Fig. 70), conferma, in via ul-teriore, come in Terra di Lavoro, in linea conaltre province del regno napoletano, nel pienoperiodo rinascimentale ancora persistessero lo-giche costruttive e stilistiche legate alla culturamedievale.
Riferibile con certezza al volgere del xV se-colo8, la struttura presenta uno spazio claustraledi impianto planimetrico quadrangolare, quasiintatto, ancorché abbandonato al più cupo de-grado, realizzato con l’utilizzo di litotipi misti –calcare e tufo grigio – e scandito da arcate ogivaliconfezionate, come i pilastri sui quali scaricano,con conci regolari di piperno, configuranti unospazio coperto con crociere a sesto acuto9.
Riferendosi a strutture del xVI secolo, in-vece, è utile analizzare le murature esterne delmonastero della Maddalena a Carinola (Fig. 71),apparecchiate con “cantieri” di tufo grigio di al-tezza pari a 68-72 cm, caratterizzati da costi-
tuenti di foggia rustica con forme generalmentetendenti al rettangolo o al trapezio. Altri interes-santi edifici cinquecenteschi, sempre a Carinola,sono la villa Saraceni, limitatamente al primo li-vello, oggi adibito a cantina, che presenta “can-tieri” di tufo grigio più bassi (48-52 cm),assimilabili a due palmi, ed il vescovado, semprelimitatamente al primo livello, affiancato allatorre campanaria della cattedrale, con “cantieri”di tufo grigio alti 65 cm circa.
In quest’ultimo caso si nota la presenza di“spaccatoni”, collocati in lungo e in largo, di di-mensioni assimilabili a quelle sancite dalla pram-matica di Pedro Afan De Ribera, segnodell’uniformazione ai canoni dettati dal governovicereale.
Invece, l’estesa masseria sita nel vicinoborgo di S. Ruosi al civico 2 di via Gentili, chepresenta due fasi costruttive, entrambe ascrivibilial xVI secolo, è caratterizzata da apparecchi mu-rari “a cantieri” di tufo grigio e giallo, alti me-diamente 54 cm circa, pari a due palmi (Fig. 72).L’imponente edificio, ormai allo stato di rudere,articolato su due livelli, offre una notevole oc-casione per analizzare le tecniche costruttive neldistretto carinolese riferibili al primo Cinque-cento.
91
Fig. 53. Sessa Aurunca (CE), torre dei Cappuccini, basescarpata, paramento esterno, muratura “a cantieri” di tufogiallo (xV sec.). Si evidenziano la collocazione “ad inca-stro” dei costituenti e l’altezza dei “cantieri”, quest’ultimatendente a due palmi (da FIENGO, GUERRIERO 2008).
Inoltre, a pochi metri dal borgo, in dire-zione nord, è ancora rinvenibile l’ingresso adun’antica cava di tufo giallo, materiale cheemerge estesamente in diversi punti della zona.
Appare infine utile riportare il caso delcomplesso dei Carmelitani in Sessa Aurunca, ri-feribile al volgere del xVI secolo, che, come ri-levato in recenti studi sulle tecniche costruttivemurarie del distretto, presenta, in alcuni punti,“cantieri” più alti rispetto ad edifici dello stessoperiodo, che assumono valori di 60-80 cm(quindi variabili da poco più di due a tre palmi),ad ogni modo prevalentemente attestati sui 67cm circa (2,5 palmi).
I ricorsi orizzontali arrivano a contenereanche quattro allineamenti di pietrame spaccatodi tufo giallo, pareggiati da un numero non ele-vato di elementi minuti, segno della presenza diuna gran quantità di malta negli spazi interstizialitra un costituente e l’altro10.
L’aumento dell’altezza dei “cantieri”, avu-tosi in queste aree dalla seconda metà del Cin-quecento, è segnalato dalla confezione diapparecchi murari più arditi; questi, sebbene nonsempre beneficianti di costituenti “normati”dalla prammatica vicereale o di un gran numerodi zeppe o “asche” per il pareggiamento dei ri-
corsi orizzontali, tendevano a superare agevol-mente i due palmi; misura, invece, ampiamenteriscontrata dall’ultima fase del dominio angioinoa tutto il periodo della dominazione aragonese.
Cantonali
L’analisi effettuata sui campioni murari evi-denzia, nell’arco temporale individuato, la pre-senza di un modello mensiocronologicoricorrente, con apparecchi murari a filari, con-fezionati con l’utilizzo di conci più o meno squa-drati, perlopiù tendenti alla regolarità dei profili,con altezza assimilabile, in genere, alla misura diun palmo napoletano, confermando, nellagrande maggioranza dei casi, una prassi ereditatadalla cultura costruttiva angioino-aragonese. Uncospicuo numero di confezioni angolari di que-sto tipo è rinvenibile, in particolar modo, nei di-stretti di Carinola, Sessa Aurunca e Pontelatone.
Nel primo, ha interesse evidenziare i canto-nali a facciavista sud-est e nord-est di palazzoPetrucci (Tav. 18), riferibili al xIV-xV secolo,composti da conci regolari di tufo grigio alti 26-35 cm, larghi 27 cm circa e lunghi 61-90 cm, col-locati alternativamente in lungo e in largo.
Purtroppo, a seguito del recente restauro,entrambi, a causa del ringrosso dello spessoredell’intonaco, si trovano in sottosquadro di al-meno 2-3 cm.
Il robusto contrafforte della chiesa dell’An-nunziata (xV secolo) (Tav. 19), invece, offreconci alti 20-34 cm, larghi sino ad un palmo elunghi sino a tre palmi; ancora a Carinola è visi-bile, tra i ruderi del castello, nella porzione fruttodi intraprese costruttive quattrocentesche, uncantonale realizzato con conci di tufo grigio dialtezza largamente tendente ad un palmo, lun-ghezza di 41-43 cm (1,5 palmi circa) e larghezzapari a 22 cm circa (Fig. 73); idoneo, dunque, allaconfigurazione di “cantieri” alti due palmi.
Ulteriore esempio è il cantonale sito nellacorte interna del già citato edificio di via Spinea Sessa Aurunca, ascrivibile al xV secolo, chepresenta costituenti di tufo giallo grossolana-
92
Fig. 54. Sessa Aurunca (CE), torre di sud-ovest, para-mento esterno, muratura “a cantieri” (xV sec.) alti 42-50cm. Si registra, unitamente al litotipo maggiormente uti-lizzato, il tufo giallo, l’occasionale presenza di frammentidi cocciopesto e di costituenti di tufo grigio.
mente squadrati alti 27 cm circa, con lunghezzaprevalente pari a 45 cm circa e larghezza di 18-22 cm (Fig. 74).
Diverse analogie, per quanto riguarda il li-totipo utilizzato – tufo giallo – sono rinvenibilinella citata abitazione di via Casa Licciardi a Pu-gliano di Teano, che presenta anch’essa concisquadrati, ma di dimensioni minori: altezza e lar-ghezza pari a 13 cm circa (½ palmo) e lunghezzadi 27 cm circa (un palmo).
Nel distretto sessano, più che altrove, neibasamenti dei cantonali sono stati utilizzati, neltardo Medioevo, in luogo di costituenti lapidei,elementi di spoglio (Fig. 75), in genere colonnerisalenti all’epoca romana, in taluni casi com-prensive anche del capitello.
A Pontelatone si segnalano, in particolare,due cantonali: quelli dei palazzi Rotondo e Gal-
piati; quest’ultimo, sebbene in gran parte obnu-bilato da intonaco cementizio, che sporge di al-meno tre centimetri rispetto alla superficie deiblocchi a facciavista, soffocando anche le cornicidelle finestre del piano nobile, offre utili infor-mazioni sulla confezione muraria, presentandoconci squadrati di tufo grigio, alti 27-34 cm, lar-ghi un palmo e lunghi 1,5-2 palmi.
Nel distretto di Mondragone si ritrovano,invece, varie strutture realizzate con l’utilizzo dilitotipi misti (come il convento di S. Francesco),per via della presenza contemporanea di consi-stenti giacimenti calcarei e di una cava di tufogrigio coltivata intensivamente sino al xIx se-colo. Tra gli altri, significativo è il caso della torreducale (Fig. 76) – una delle strutture turrite piùimponenti del periodo vicereale – riferibile alxVI secolo11, che presenta – similmente ad epi-
93
Fig. 56. Sessa Aurunca (CE), edificio in via Scanzati 30,paramento esterno, piano terra, muratura “a cantieri” ditufo giallo (xIV-xV sec.) alti 40-45 cm.
Fig. 55. Sessa Aurunca (CE), torre di S. Biagio, particolaredel paramento interno della base scarpata. In evidenza,l’apparecchio murario “a cantieri” di tufo giallo (xV sec.)alti 52 cm circa.
94
Fig. 57. Sessa Aurunca (CE), edificio in via Spine 14,piano terra, androne, lato sud-ovest, muratura “a cantieri”di tufo giallo (xV sec.) alti 45-52 cm.
Fig. 58. Sessa Aurunca (CE), edificio in via Spine 14,piano terra, androne, lato sud-est, muratura “a cantieri”di tufo grigio (xV sec.) alti 45-52 cm.
95
sodi riferibili al xV secolo – in corrispondenzadella base scarpata, spesse angolate di conci ditufo grigio e giallo alti generalmente 27 cm.questi ultimi determinano gli allineamenti dei“cantieri”, con i quali la stessa è apparecchiata,configurati in pezzame spaccato di calcare, tufogrigio e giallo. Inoltre, ne caratterizzano ancheil corpo superiore, assumendo altezze simili aquelle riscontrate sulla scarpa; ciò ad ulterioredimostrazione del costante ricorso al tufo per laconfezione di elementi squadrati.
Infine, sempre in riferimento ad episodi delxVI secolo, è utile segnalare, per le sue peculia-rità, il cantonale nord-ovest della citata masseriasita nel borgo di S. Ruosi a Carinola (Fig. 77).Infatti, a differenza degli esempi sinora riportatied in linea con le intraprese costruttive del Cin-quecento in altri distretti di Terra di Lavoro esoprattutto napoletani12, esso è allestito “a can-tieri” di tufo grigio e giallo. I ricorsi orizzontali,confezionati facendo largo uso di “spaccatoni”lunghi 52-55 cm, hanno un’altezza ricorrente di52 cm circa (due palmi).
Aperture arcate
Il repertorio di aperture arcate esaminato, inparte già oggetto di molteplici studi, soprattuttoriguardo al distretto di Carinola, è utile alle fina-lità della presente ricerca limitatamente all’op-portunità di raffrontare elementi stilisticamentericonoscibili e con caratteristiche tra loro simili,facenti parte di strutture edilizie diverse, per at-testare – ove possibile – i rapporti cronologicitra le stesse intercorrenti.
Prescindendo, dunque, da ulteriori analisisu portali e finestre già ampiamente studiati eclassificati in letteratura13, cui si è fatto in questasede talora cenno all’esclusivo fine di chiarire leproblematiche di datazione di alcuni edifici, siriporta una rassegna delle aperture arcate rite-nute significative per il conseguimento degliscopi suddetti.
In ordine ai casi analizzati nei sub-areali distudio per il periodo considerato, ha interesse
asserire che è stato rinvenuto sostanzialmenteun unico tipo di confezione, caratterizzata, dalpunto di vista della forma dei costituenti, dal-l’utilizzo di materiale squadrato, che si giova,nella gran parte dei casi, di accurata sagomatura,tendenzialmente cuneiforme, resa possibileanche dall’ottima lavorabilità offerta dal mate-riale tufaceo.
Riferendosi nuovamente al castello di Cari-nola, è utile citare l’apertura al secondo livello,con arco a sesto acuto, conformata da elementidi tufo grigio modellati con cura e riportantedue fregi, in corrispondenza dei piedritti, coneleganti motivi floreali (Fig. 78).
Ulteriori campioni di aperture arcate, concaratteristiche affini ma meno pretenziose, sonoriscontrabili nella corte del palazzo Petrucci(Figg. 79-80); quest’analogia consente di acco-
Tav. 12. Carinola (CE), edificio adiacente al palazzo Pe-trucci, fronte est, paramento esterno, piano terra, mura-tura in tufo grigio (xV sec.). Il campione murario indagatopresenta un apparecchio “a cantieri” alti, ad eccezione delricorso inferiore che ha un allineamento irregolare, 51 cmcirca, composti da due allineamenti di costituenti. Gli ele-menti litoidi presentano prevalentemente pezzatura ru-stica, registrando una scarsa presenza di materiale minuto,perché disposti in maniera serrata. I giunti di malta, arre-trati, presentano granulometria grossolana.
97
Fig. 59. Sessa Aurunca (CE), edificio in via Spine 14, corteinterna, piano terra. Si nota appena, in gran parte copertada una struttura recente edificatale a ridosso, una tipica fi-nestra catalana, probabilmente a croce guelfa.
Tav. 13. Carinola (CE), edificio in vico Macello, fronte nord-ovest, paramento esterno, piano terra, muratura in tufogrigio (xIV-xV sec.). Il campione murario indagato è allogato in un’insula posta negli immediati pressi del sedile e dellachiesa dell’Annunziata. Presenta un apparecchio “a cantieri”, ben riconoscibili soltanto nei due ricorsi centrali, conaltezza di 36-49 cm, ciascuno composto da due allineamenti di elementi litoidi. I costituenti registrano la presenza dipezzame spaccato e materiale minuto. I giunti di malta sono perlopiù arretrati e presentano granulometria grossolana.Per gran parte il paramento è ricoperto da intonaco. Accanto ai “cantieri”, sulla destra, è ben visibile un robusto can-tonale, parte di una struttura stratigraficamente anteriore, apprestato con conci pseudo-regolari con altezza di 12-21cm.
98
stare, in chiave temporale, alcune fasi costruttivedei due manufatti, rientranti nel contesto storicoinquadrato tra l’ultima fase del governo an-gioino, la presenza durazzesca e gli albori dellabreve dominazione aragonese (xIV-xV secolo).
Non v’è dubbio, infatti, che l’apertura ar-cata del castello, probabilmente non di molto se-riore a quella presente nel palazzo Petrucci, neabbia mutuato, abbellendole, le caratterizzazioniformali.
Sempre per il palazzo in questione è statopossibile anche analizzare, con completezza, ilpilastro centrale che sorregge le arcate del primo
livello della loggia (Tav. 20), apparecchiato conconci squadrati di tufo grigio che configuranofilari alti 28-32 cm.
Ancora, arcate simili a quelle descritte sipossono rinvenire nel citato episodio del con-vento di S. Francesco a Mondragone, riferibile,come in precedenza affermato, al termine delxV secolo, confermando la sostanziale perma-nenza di istanze costruttive legate alla culturatardo-gotica.
Anche la cattedrale di Carinola offre un in-teressante esempio di arco a sesto ogivale di sti-lema catalano, collocato, come si è detto, tra la
99
Fig. 60 Sessa Aurunca (CE), palazzo di Consalvo Fer-rando de Cordoba, ingresso principale.
Fig. 61. Teano (CE), fraz. Pugliano, via casa Licciardi, edi-ficio a destinazione abitativa (xV sec.), prospetto princi-pale. In evidenza, la finestra di stilema catalano e l’oculostrombato all’incrocio delle falde del tetto.
Tav. 14. Pontelatone (CE), torre Marzano, muratura intufo grigio (xIV sec.). Il campione murario indagato pre-senta un apparecchio “a cantieri” con altezza mediamentepari a 54 cm, ad eccezione di due orizzontamenti, collocatinella parte sommitale della base scarpata, in corrispon-denza dell’ingresso, con altezza lievemente maggiore (70e 60 cm). Gli elementi litoidi, composti da due allinea-menti di pezzame spaccato e pietre rustiche, a tratti impi-lati, registrano una modesta presenza di “asche”, sempredi tufo grigio, per il pareggiamento dei “cantieri”.
navata centrale ed il sistema absidale pentago-nale. Non fanno eccezione le frazioni del sitocarinolese: infatti, a Nocelleto, in vico Aurora 1,si rinviene il già citato portale con arco a sestoogivale, confrontabile con episodi simili, ancor-ché più raffinati, presenti a Sessa Aurunca (Fig.81), ai caratteri compositivi dei quali è stato chia-ramente informato.
Infine, nel distretto di Formicola, nella fra-zione Fondola, è possibile analizzare un piccoloportale, dell’ampiezza di 1,50 m circa, che pre-senta, appena riconoscibile perché estesamenteintonacato, un arco a sesto ribassato realizzatofacendo ricorso a costituenti caratterizzati dauna lavorazione meno accurata, evidentementefrutto di intraprese più modeste rispetto agliesempi sinora enunciati (Fig. 82). Sempre per lostesso distretto, riferendosi alla frazione Caval-
lari, si ricorda la loggia del citato edificio in viaCavallari 17, riportante, al primo livello, aperturearcate a sesto acuto, realizzate con conci squa-drati di tufo grigio.
Prospettive di tutela
La colpevole e generalizzata assenza di iniziativemiranti alla protezione del vasto e significativopatrimonio culturale analizzato in questa sede èsenza dubbio la principale causa del degrado chelo affligge da molti decenni a questa parte. A talproposito, ha senza dubbio interesse avviare al-cune considerazioni sull’attuale contesto opera-tivo.
C’è da rilevare, innanzitutto, che nella tota-lità dei distretti in causa gli edifici indagati rica-
101
Fig. 62. Teano (CE), fraz. Pugliano, via casa Licciardi, edi-ficio a destinazione abitativa, scorcio del prospetto poste-riore. Si noti l’apparecchio murario “a cantieri” di tufogrigio e giallo, linearizzati da cantonali confezionati conconci di tufo giallo collocati in lungo e in largo.
dono, perlopiù, all’interno di centri storici ormaiquasi del tutto abbandonati o in frazioni perife-riche, poste in aree scarsamente abitate e, per-tanto, poco considerate o, al più, interessate dainterventi parziali o episodici.
Ne deriva che, generalmente, essi non sigiovano delle opportune politiche di conserva-zione che meriterebbero, ma sono spesso og-getto del disinteresse pubblico e privato, o,peggio, subiscono interventi di ristrutturazioneper niente rispettosi del loro aspetto esteriore edella distribuzione interna.
Operazioni tipiche di una simile inadeguataconcezione culturale, originata dalla pericolosapretesa di piegare gli edifici storicizzati a nonmeglio identificate esigenze figlie della contem-poraneità, determinandone, nella gran parte deicasi, un utilizzo non compatibile, sono, in primo
luogo: la rimozione dei solai lignei in favore diquelli latero-cementizi; la sostituzione degli in-fissi in legno; l’impiego di intonaci a base ce-mentizia in luogo di quelli a base di calce; lacopertura delle murature storiche facciavista, pe-raltro senza nulla prima documentare, col risul-tato di obliterarne l’aspetto figurale.
A tutto ciò va certamente unito, come ulte-riore e dannoso effetto, il frazionamento degliimmobili in più unità abitative, con la conse-guenza della realizzazione di superfetazioni abu-sive piccole e grandi. Senza contare la mancanzadi qualsivoglia programma di manutenzione distrutture e finiture, che causa, tra le altre proble-matiche – come l’inevitabile presenza di quadrifessurativi complessi – anche l’insorgere di ve-getazione infestante, di tipo erbaceo o addirit-tura arboreo e di fenomeni di umidità cheesprimono livelli significativi di degrado.
Giova, a tal proposito, considerare che, perquanto riguarda le strutture storicizzate, ancor-ché non auliche e dunque non oggetto – comepurtroppo sovente accade – della dovuta atten-zione da parte degli organismi preposti alla tu-tela dei beni culturali, l’inadeguato utilizzospesso concorre a pregiudicarne irreversibil-mente il carattere originario e le stratificazionipresenti.
In casi del genere, a nulla vale assumerequalsivoglia iniziativa se prima non ci si preoc-cupa di eliminare le superfetazioni e di ripararei danni strutturali individuati. D’altro canto,anche gli pseudo-restauri, condotti senza seguirela logica della conservazione, bensì cavalcandonecessità di trasformazione o di riconduzionead un non meglio precisato “antico splendore”,provocano un danno notevole al patrimonio cul-turale e, per ovvie ragioni, soprattutto ai manu-fatti non rientranti nei circuiti ufficiali promossidagli enti di tutela.
Nei distretti indagati, ad esempio, i palazziPetrucci a Carinola e Galpiati a Pontelatonehanno subito alterazioni che in gran parte sareb-bero state scongiurabili proprio a causa dei re-stauri realizzati. In essi, infatti, l’interventoannunciato come soluzione delle problematiche
102
Fig. 63. Teano (CE), fraz. Pugliano, via S. Maria degli An-geli, edificio a destinazione abitativa (xV sec.), prospettolaterale. In evidenza, la base scarpata ed il corpo superiore.Si notino, sulla prima, i robusti cantonali, apparecchiaticon conci squadrati di tufo grigio, meno regolari in corri-spondenza del corpo superiore.
Fig. 64. Teano (CE), frazione Pugliano, via S. Maria degliAngeli, edificio a destinazione abitativa (xV sec.), pro-spetto laterale, paramento esterno, piano terra. Il cam-pione murario analizzato presenta un apparecchio a corsisub-orizzontali di bozze con zeppe di tufo grigio e giallo,alti 27 cm circa, non mancando altezze leggermente mi-nori (22 cm circa). Gli elementi litoidi sono di foggia ru-stica e forma quadrangolare, triangolare e trapezoidale.L’allineamento dei corsi è ottenuto tramite un discreto nu-mero di zeppe di tufo grigio.
che li affliggevano, non ha purtroppo sortitol’effetto auspicato; cosa all’attualità ancora facil-mente riscontrabile, persino attraverso un’analisinon approfondita.
La rimozione dei solai lignei “incartati” dipalazzo Petrucci e la ricostruzione di una por-zione della finestra a croce guelfa di palazzoGalpiati (Figg. 83-84) sono esempi paradigmaticidella discutibile, sebbene purtroppo sempre piùattuale, esigenza di “mimesi” che guida taluni in-terventi, portando a trasfigurare il carattere dipalinsesto della struttura – semplificandone acri-ticamente ed artificialmente la complessità – perrelegarla in una sorta di limbo figurale, nel qualele stratificazioni rischiano di non essere più lettecome parte integrante di un contesto narrativo,ma piuttosto a guisa di meri elementi di discon-tinuità formale.
Il vulnus tuttora maggiormente riscontrabilein parecchi interventi è il largo ed inadeguatoutilizzo di malta ed intonaco di natura cementi-zia, sconsigliabili per un materiale con elevateproprietà idrofile qual è il tufo campano; altresì,danno di non secondaria importanza è rappre-sentato dalla ricostruzione delle parti mancantio danneggiate, condotta seguendo – anacroni-sticamente – le ampiamente superate logiche delrestauro stilistico, alla ricerca di una sempre piùimprobabile “unità”, subordinata al gusto im-provvisato del “restauratore” ed alla sua scarsa– se non addirittura inesistente – conoscenza deitratti e caratteri del moderno dibattito sui temidel restauro architettonico.
D’altronde, l’analisi dei campioni muraricondotta in questa sede conferma, in via ulte-riore, come i fenomeni di degrado delle strutture
103
Fig. 65. Formicola (CE), fraz. Cavallari, via Cavallari 17,edificio a corte con loggia arcata (xV-xVIII sec.). In evi-denza, il pilastro ottagonale quattrocentesco e le aperturearcate a sesto leggermente ogivale.
allestite ricorrendo a costituenti tufacei sianomolto più articolati e complessi di quelli che, adesempio, affliggono i manufatti realizzati fa-cendo ricorso alla pietra calcarea.
Sul deterioramento del materiale tufaceo,infatti, incidono molteplici fattori, in primoluogo la non ragguardevole resistenza mecca-nica; peraltro, quando esposto all’azione conti-nua degli agenti atmosferici, esso subisce azionierosive dovute a corrasione, risultando ancheesposto all’aggressione di agenti biodeteriogeni.
Anche la corrosione, provocata da fattori diorigine chimica, ha come effetto il verificarsi di
evidenti fenomeni erosivi, che ne danneggiano– irreversibilmente e a fondo – la materia costi-tuente. Appare utile indicare, di seguito, percompletezza d’indagine, i fenomeni più ricor-renti di degrado del tufo grigio campano, che inquesta sede non ha interesse approfondire, inconsiderazione del noto e qualificato supportoscientifico e documentario esistente in merito,snodatosi in letteratura attraverso svariati studi.
Seguendo la diversificazione operata in let-teratura dal noto Lessico Normal14 tra fenomenimacroscopici, dunque visibili ad occhio nudo, di“alterazione” (modificazione di un materialenon implicante necessariamente un peggiora-mento delle sue caratteristiche sotto il profiloconservativo) e “degrado” (modificazione di unmateriale comportante un peggioramento dellesue caratteristiche sotto il profilo conservativo),sono senz’altro da segnalare, riferendosi allaprima categoria, l’alterazione cromatica e lapatina biologica. Nella seconda categoria, quellache annovera le patologie maggiormente lesiveper il materiale lapideo, vanno invece necessari-amente considerate l’alveolizzazione, il distacco,l’erosione, l’esfoliazione, la mancanza e la frat-turazione o fessurazione.
queste ultime patologie, maggiormente ri-correnti per il materiale tufaceo, originate dafenomeni fisici, chimici o composti, secondo di-verse modalità e con differenti quote di gravità,portano ad un unico risultato: il sacrificio diporzioni più o meno significative di materia,pregiudicando, in tal modo, l’integrità degli ele-menti che costituiscono i manufatti storicizzati.
La differenziazione delle patologie implicauna gestione oculata delle misure atte a scongiu-rarne le ripercussioni. Infatti, condurre un inter-vento mirante alla conservazione della materiasoggetta a degrado senza comprenderne afondo le dinamiche, potrebbe addirittura dan-neggiarla. Per tale motivo, è necessaria una cor-retta analisi dei fenomeni di degrado, dacondursi anche attraverso l’applicazione di mo-derne indagini strumentali.
L’analisi diagnostica delle murature, attuataprediligendo – ove possibile – tecniche non in-
104
Fig. 66. Formicola (CE), fraz. Cavallari, via Cavallari 17,edificio a corte con loggia arcata, ipovista delle voltine(xVIII sec.). Si notino le arcate realizzate con bozzette ditufo grigio.
Fig. 67. Castel Volturno (CE), borgo di S. Castrese, vicoV S. Castrese 2, fronte nord-ovest, paramento esterno,piano terra. Si notino i “cantieri”, pareggiati da una granquantità di elementi fittili di piccole dimensioni, e spoliadel ponte romano, affiancati a costituenti di tufo grigio egiallo.
105
Tav. 15. Formicola (CE), edificio in trav. via S. Cristina,fronte nord-est, paramento esterno, piano terra, muraturain tufo grigio (xV sec.). Il campione murario indagatopresenta un apparecchio “a cantieri” alti 43-50 cm. I co-stituenti, organizzati in due allineamenti di pezzame spac-cato, hanno dimensioni eterogenee, registrando anche lapresenza di elementi rustici e una discreta quantità di ma-teriale minuto utilizzato per l’allineamento dei ricorsi oriz-zontali.
vasive, può rappresentare un’azione utile per in-dividuare le procedure applicabili per la loroconservazione15. Grande importanza dovrà es-sere riconosciuta non soltanto alla qualità ed allecaratteristiche del materiale analizzato, ma ancheal magistero murario che lo caratterizza, a se-conda del quale, come poc’anzi richiamato, pos-sono senza dubbio mutare i valori di resistenzafisico-meccanica di una struttura; per tale mo-tivo, devono necessariamente essere ben ponde-rate le dinamiche di intervento.
A tal uopo, l’innegabile utilità di studi in-centrati sulle tecniche costruttive murarie – e in
particolar modo sulla necessità di analizzarle intermini comparativi – risiede anche nella realiz-zazione, e successiva riproposizione in altriareali, di opportuni protocolli di ricerca, di cuipiù volte in questa sede si è fatto cenno.
questi ultimi dovranno concorrere fattiva-mente alla qualificazione – attraverso il ricono-scimento e la conseguente esplicitazione dicaratterizzazioni altrimenti non rivelate o non ri-velabili – di un moderno esercizio della tuteladel costruito storico, sia dal punto di vista cul-turale sia, soprattutto, in ordine agli interventida attuare per assicurarne la conservazione e la
106
Fig. 68. Castel Volturno (CE), borgo di S. Castrese, brecciamuraria. Si noti il nucleo “incastrato”, costituito da ele-menti di tufo grigio e giallo e da una gran quantità dimalta, configurante “cantieri” alti 40-45 cm.
custodia all’indirizzo delle future generazioni,nel sempre più attuale solco della concezione ru-skiniana.
Note:1 Giova, a tal proposito, citare il brano conclusivo di
un interessante saggio sulle tecniche costruttive tradizio-nali, che, sebbene riguardi un altro areale di studio – co-munque campano – la Costiera amalfitana, è significativoper la comprensione del rapporto tra lo spessore delle se-
zioni murarie e l’altezza dei “cantieri”: «Non vi è dubbiosul fatto che l’elemento distintivo più importante per fis-sare l’età di una muratura allestita “a cantieri” è l’altezzadi questi ultimi. Alla luce del suddetto parametro si è con-statato che essa è generalmente inferiore a m. 0,50 nelcorso del xII secolo; oscilla, invece, tra m. 0,50 e 0,65 nelxIII secolo e si attesta sopra i m. 0,60 nei due secoli se-guenti. La rilevata tendenza è funzione dello spessore dellestrutture. In altri termini, nell’area amalfitana, le muraturedel xII secolo sono tendenzialmente più grosse di quelledel secolo successivo. L’impiego in esse di abbondantemalta tra le pietre rustiche ed in corrispondenza degli oriz-
107
Fig. 69. Castel Volturno (CE), borgo di S. Castrese. Ele-menti decorativi superstiti di un edificio diruto, le men-sole, di foggia quattrocentesca, sono realizzate conl’utilizzo di costituenti di tufo grigio accuratamente lavo-rati.
Fig. 70. Mondragone (CE), convento di S. Francesco (xVsec.), piano terra, scorcio del chiostro. Si notino le arcatea sesto ogivale realizzate con conci squadrati di piperno(da BUONANNO 1981).
Tav. 16. Pontelatone (CE), palazzo Rotondo, fronte nord-est, paramento esterno, piano primo, muratura in tufo grigio(xV sec.). CM1: cantonale posto sulla parte sinistra del muro, formato da conci pseudo-regolari di tufo grigio, conaltezza di 10-16 cm, che scandisce l’articolazione dei “cantieri”, regolandone gli allineamenti. CM2: muratura in tufogrigio (xV sec.). Il campione murario indagato è allestito con apparecchio “a cantieri”, apprestati con pietre spaccatedisposte su due allineamenti e diffusamente impilate, con altezza di 27-30 cm, non mancando altezze minori (24 cmcirca). I “cantieri” sono regolarizzati tramite l’utilizzo di un gran numero di elementi minuti, perlopiù “asche”, di tufogrigio e, in misura minore, di pezzi di coppi.
zontamenti consigliò, ai fini della presa, del successivo in-durimento e del conseguente calo di questa, l’adozione di“cantieri” bassi ed anche di tempi più lunghi nell’avanza-mento dell’opera. Per contro, nel xIII secolo, la maggioreleggerezza delle volte, il cui spessore strutturale, anche incorrispondenza di luci cospicue, spesso non supera m.0,10 o 0,15, e l’irrobustimento dei pilastri angolari di sca-rico delle crociere, liberando le pareti da funzioni portanti,resero più rapidi i tempi di costruzione e, quindi, consen-
tirono l’attribuzione ai “cantieri” di un’altezza maggiore.Ecco perché, in definitiva, l’altezza del cantiere va relazio-nata al suo spessore. Difatti, la cinquecentesca torre diCrapolla, le cui murature non sono inferiori a m. 2,00 dispessore, ha “cantieri” alti quanto quelli di tre secoliprima». G. FIENGO, L’Atlante delle tecniche costruttive tradi-zionali di Napoli e Terra di Lavoro (XVI-XIX sec.) in C. VA-RAGNOLI (a cura di), Muri parlanti. Prospettive…, cit., pp.31-32, 34.
108
2 Cfr., a tal proposito, F. MIRAGLIA, C. VALENTE,Mondragone: persistenze della “Terra Murata” nel tessuto urbanodella città contemporanea, “Terra Laboris. Itinerari di ricerca”1, Marina di Minturno 2012, nello specifico il paragrafoLa murazione della Terra di Mondragone: caratterizzazioni co-struttive dei tratti sud-ovest e nord-est, pp. 11-14. Nel saggio inquestione (p. 11) si mette in enfasi che «la presenza di trattidella murazione, riscontrati in diverse aree della città untempo incluse nella Terra Murata, fa comprendere comele direttrici di sviluppo dell’edilizia contemporanea ab-biano sostanzialmente seguito, anche e soprattutto per esi-genze di economicità di realizzazione, gli originari tracciatidifensivi, sovente assorbendoli nelle nuove strutture. Par-tendo da questo assunto, verificabile agevolmente in situ,incrociando i dati offerti da rilievi aerofotogrammetrici,
catastali e satellitari, si è potuto giungere alla ricostruzionedel tratto della murazione in questo punto» rilevando, adogni modo, che «solo un’analisi meticolosa, da condursisu ogni abitazione (...) potrà offrire ulteriori delucidazioniin merito alla configurazione planimetrica e tecnologicadella murazione».
3 Ulteriori ragguagli sull’apparecchio murario dellatorre Marzano sono in L. GUERRIERO, F. MIRAGLIA, op.cit. e in M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi…, cit., p.283, n. 111.
4 È noto, infatti, che nel caso di manufatti a destina-zione militare le maestranze avevano l’incombenza di rea-lizzare strutture con la capacità di resistere agli attacchinemici, dunque certamente più resistenti di quelle a de-stinazione abitativa, soprattutto all’avvento di strumenti
109
Fig. 71. Carinola (CE), monastero della Maddalena, frontesud, paramento esterno, piano terra, muratura “a cantieri”di tufo grigio (xVI sec.) alti 68-72 cm.
Fig. 73. Carinola (CE), castello, fronte sud-ovest, primolivello, cantonale in tufo grigio (xV sec.). Parte integrantedell’ampliamento quattrocentesco del fortilizio, l’angolataè apparecchiata facendo ricorso a costituenti squadrati ditufo grigio, collocati in lungo e in largo, di altezza presso-ché identica, pari a 27 cm circa.
Fig. 72. Carinola (CE), borgo di S. Ruosi, masseria in viaGentili 2, fronte ovest, paramento esterno, piano terra,muratura a “cantieri” di tufo grigio e giallo (xVI sec.) alti54 cm circa.
bellici di notevole potere offensivo, quali le cosiddette“bombarde”. questa necessità impellente portava, nellagran parte dei casi – tra le altre cose – alla configurazionedi murature con sezioni significative.
5 Un’analisi del paramento murario, che riporta similirisultati, è in C. GIANNATTASIO, Strutture protomoderne intufo..., cit., p. 267.
6 A tal proposito, si veda anche C. GIANNATTASIO,La costruzione in tufo…, cit., p. 112, Fig. 3.
7 «Il primo stemma, che sembra essere il più antico,riporta, la data dell’edificio, in numeri romani, al 1456.L’insegna, realizzata in tufo grigio, ha forma rettangolareed ha come base uno dei lati lunghi. Essa comprende unacornice fortemente incisa nel tufo, sulla quale è raffigurata,all’interno, una pianta dalla ricca vegetazione, la quale,probabilmente, simboleggia, con il suo vigore arboreo,l’albero della vita; un cuore trafitto, collocato nell’angolobasso a destra subito al di sotto di esso e la sopraccitatadata del 1456». A. BALASCO, Alcune note sull’architettura “ca-talana” nell’alta Terra di Lavoro, in A. PANARELLO (a curadi), Conoscere il Roccamonfina. 2. L’architettura…, cit., p. 57.
8 L’edificazione del convento è attribuita da fra Fran-cesco Gonzaga ad Antonio Carafa principe di Stigliano,duca di Mondragone, che nel 1480 ottenne dal suo senatol’autorizzazione per costruire, tra le mura della cittadellafortificata, una dimora per i padri francescani zoccolanti,
i quali ancora oggi ne detengono le sorti. Cfr. R. CASTRI-ChINO, G. SUPINO, San Francesco D’Assisi a Gaeta e a Casa-nova di Carinola, Formia 1991, p. 46.
9 Il chiostro del convento di S. Francesco «fu realiz-zato secondo una re-interpretazione autoctona di stilemigotici, in palese ritardo nei confronti della dinamiche cul-turali del Rinascimento». F. MIRAGLIA, Piccoli tesori vulnerati.Il triste destino dell’ex Convento di San Francesco (già dell’Annun-ziata) in Mondragone, in “Civiltà Aurunca. Rivista trime-strale di cultura”, 70 (2008), p. 41.
10 Cfr. C. GIANNATTASIO, Strutture protomoderne intufo…, cit., p. 265 e, della stessa autrice, La costruzione intufo…, cit., pp. 117-118.
11 La torre ducale di Mondragone, posta nei pressidel casale medievale di S. Angelo, presenta una base scar-pata di forma tronco-piramidale sormontata da un corpodi fabbrica parallelepipedo, sovrastato a sua volta da unapossente merlatura, all’attualità quasi del tutto conservata.L’altezza e la possanza di questo interessante edificio al-ludono alle strutture difensive realizzate in epoca medie-vale, piuttosto che alle basse e tozze architetture militaririnascimentali, meno vulnerabili alle artiglierie; ciò sarebbedovuto al fatto che la torre, anche se lontana dal mare,rappresentava una significativa postazione di difesa e diavvistamento in favore delle aree interne, comunque vul-nerabili agli attacchi saraceni o da parte del brigantaggio
Tav. 17. Castel Volturno (CE), borgo di S. Castrese, vico V S. Castrese 2, fronte nord-ovest, paramento interno, pianoterra, muratura in tufo grigio e giallo (xV sec.). Il campione murario indagato presenta un apparecchio “a cantieri” conaltezze grossomodo costanti (40-45 cm). I “cantieri” subiscono una soluzione di continuità dovuta alla collocazione diuna nicchia arcata, anch’essa realizzata con elementi di tufo. I costituenti presentano sbozzatura grossolana, registrandouna scarsa quantità di materiale minuto per il pareggiamento dei ricorsi orizzontali.
110
locale. A tal uopo cfr. L. SANTORO, Case-torri del Cinquecentonel vicereame di Napoli, in “Napoli nobilissima”, IV s., xxIx(1990), pp. 11-16 e C. VALENTE, Lineamenti di storia dell’ar-chitettura mondragonese, in “Le radici & il futuro”, 3 (2003),pp. 99-108. Ad ogni modo, uno dei motivi di questa ispi-razione a dinamiche costruttive e formali medievali va ri-cercato senza dubbio anche nell’accennata necessità, daparte degli artefici, soprattutto nei territori periferici delregno di Napoli, che non si giovavano dei fermenti cultu-rali che caratterizzavano invece la capitale, di seguire – eapprofondire – prassi costruttive più vicine alle loro co-noscenze in campo edilizio, perché frutto di esperienzeormai consolidate.
12 In letteratura è stato osservato che, nell’età vice-reale, a Napoli ed in Terra di Lavoro i cantonali di tufo
grigio e giallo erano costantemente «allestiti secondo ri-corsi di orizzontamento periodici, “a cantieri”, alti inmedia 2 palmi (circa 52 cm), facendo ricorso, per le pietreangolari, prevalentemente a “spaccatoni” e a “spaccate”.Nei campioni del primo Cinquecento, questi sono lavoratimolto rapidamente, senza curare particolarmente la spia-natura degli assetti orizzontali, pur segnalandosi per il no-tevole volume». L. GUERRIERO, G. CECERE, op. cit., pp.159-160.
13 È sembrato opportuno non riproporre in questasede il più che nutrito apparato grafico e documentariodisponibile sui portali e le finestre di stilema durazzescoe catalano massicciamente presenti a Carinola, Sessa Au-runca e Pontelatone ed oggetto, sin dall’inizio del xx se-colo e soprattutto negli ultimi anni, di diversi studi di
111
Fig. 74. Sessa Aurunca (CE), edificio in via Spine 14, corteinterna, cantonale in tufo giallo (xV sec.). Si notino anchele due aperture in facciata; quella in alto, trilobata, realiz-zata con identico litotipo utilizzato per apprestare il can-tonale, e quella posta più in basso, seriore, con cornice afascia girata in tufo grigio pipernoide, parzialmente ta-gliata.
Fig. 75. Sessa Aurunca (CE), edificio in via S. Antonio,cantonale. La soluzione angolare al piano terra è ottenutacon l’utilizzo di due elementi monolitici sovrapposti.
Tav. 18. Carinola (CE), palazzo Petrucci, piano terra, can-tonale in tufo grigio (xIV-xV sec.). Il campione murarioindagato è apparecchiato con filari di conci squadrati ditufo grigio con altezza di 26-35 cm, collocati in lungo ein largo.
112
Fig. 76. Mondragone (CE), torre ducale, fronte sud-est,cantonale in conci di tufo grigio e giallo (xVI sec.). I co-stituenti, disposti in lungo e in largo, hanno dimensioniomogenee, con altezza tendente ad un palmo, non man-cando elementi leggermente più bassi (22 cm circa).
Fig. 77. Carinola (CE), borgo di S. Ruosi, masseria in viaGentili 2, fronte nord-ovest, cantonale “a cantieri” di tufogrigio e giallo. In evidenza, gli “spaccatoni” utilizzati perapparecchiare i ricorsi orizzontali.
113
Fig. 78. Carinola (CE), castello, fronte sud, secondo livello.L’apertura a sesto ogivale, simile a quella della loggia dipalazzo Petrucci, è riferibile alla fase costruttiva “C” delfortilizio (prima metà xV sec.).
Tav. 19. Carinola (CE), chiesa dell’Annunziata, piano terra, cantonale in tufo grigio (xV sec.). Il campione murario in-dagato presenta un apparecchio a filari, a tratti irregolari mercé lo sfalsamento dei giunti orizzontali, di conci squadratialti 20-34 cm. I costituenti, in corrispondenza della sommità del basamento, mostrano una lavorazione più accurata, as-sumendo forma trapezoidale, mentre quelli della parte inferiore hanno perlopiù foggia rustica.
114
respiro nazionale, preferendo riportare materiale inedito.Ad ogni modo, utili approfondimenti in tal senso, soprat-tutto per quanto riguarda i distretti di Carinola e Sessa Au-runca, sono in M. ROSI, Carinola…, cit., E. CARELLI,Elementi architettonici…, cit. e C. CUNDARI (a cura di), Versoun repertorio…, cit.
14 Riferendosi alle note “Definizioni di degrado esimbolizzazione grafica proposte dalla RaccomandazioneNormal 1/88” (quest’ultima recentemente aggiornatadall’Uni Normal 11182 dell’aprile 2006, che ne riprendesostanzialmente le linee operative aggiornandone alcunedefinizioni), si possono agilmente comprendere, in primaistanza, i fenomeni di degrado poc’anzi richiamati; l’indi-viduazione degli stessi – cui dovranno far seguito oppor-tuni interventi per attenuarne e, ove possibile, eliminarnele azioni – è opera istruttoria per qualsivoglia interventodi restauro. La letteratura, a tal proposito, informa che «ildocumento NORMAL 1/88 ha fornito un chiaro contri-buto nel riordino del lessico e degli apparati descrittividelle diverse forme di degrado, anche se limitatamente aimateriali lapidei prevalentemente naturali. Occorre sotto-
lineare che il metodo espositivo e la tecnica di comunica-zione adottati sono necessariamente sintetici e riferiti aclassi di fenomeni molto generali». C. ARCOLAO, La dia-gnosi nel restauro architettonico. Tecniche, procedure, protocolli, Vi-cenza 2008, p. 32.
15 Per le caratterizzazioni strutturali del tufo si ve-dano G. GUERRIERO, P. LENzA, Le murature storiche napole-tane..., cit., G. FIENGO, L. GUERRIERO, P. LENzA, Strutturemurarie campane in tufo giallo (XVI-XIX). Caratterizzazionemetrologica e modellazione strutturale, in A. AVETA, S. CA-SIELLO, F. LA REGINA, R. PICONE (a cura di), Restauro e con-solidamento, Roma 2005, pp. 171-180, B. CALDERONI, E.A.CORDASCO, L. GUERRIERO, P. LENzA, G. MANFREDI, Ex-perimental tests…, cit., B. CALDERONI, E.A. CORDASCO, L.GUERRIERO, P. LENzA, Prove a compressione…, cit., B. CAL-DERONI, E.A. CORDASCO, L. GUERRIERO, P. LENzA, G.MANFREDI, Mechanical behaviour…, cit., e B. CALDERONI,G. CECERE, E.A. CORDASCO, L. GUERRIERO, P. LENzA, G.MANFREDI, Metrological definition…, cit.
115
Fig. 79. Carinola (CE), palazzo Petrucci, loggia, primo li-vello. In evidenza, le aperture con arco a sesto ogivale.
Fig. 81. Sessa Aurunca (CE), portale tardo-gotico in viaDelio, realizzato con conci squadrati di tufo giallo (archi-vio M.A. Russo).
Fig. 80. Carinola (CE), palazzo Petrucci, loggia, secondolivello. Si notino le aperture con arco a sesto ribassato e ilsistema originariamente utilizzato per convogliare le acquepiovane, ormai con funzione meramente decorativa.
Tav. 20. Carinola (CE), palazzo Petrucci, fronte sud, piano terra, pilastro in tufo grigio (xIV-xV sec.). Il pilastro è com-posto da conci grossolanamente squadrati, ben visibili soltanto su una delle quattro facce, di dimensioni prevalenti va-riabili, pari a 32 x 54 x 26 cm e 28 x 32 x 28 cm. I costituenti sono ben ammorsati, disposti alternativamente in lungoe in largo (rielab. da rilievo di A. Navarra, G. Pirozzi, M. Romano).
116
Fig. 82. Formicola (CE), fraz. Fondola, portale in via Fon-dola 14. Si notino, sulla sinistra, superiormente all’aperturaarcata a tutto sesto, i costituenti di un arco a sesto ribas-sato, in parte obnubilati dall’intonaco.
Fig. 83. Pontelatone (CE), palazzo Galpiati, facciata prin-cipale, finestra a croce guelfa. Si notino gli evidenti danniprovocati alle eleganti membrature (da AA.VV., 1989: Pon-telatone dall’età longobarda all’età aragonese).
Fig. 84. Pontelatone (CE), palazzo Galpiati, facciata prin-cipale, finestra a croce guelfa. In evidenza, l’intervento diripristino “in stile” delle parti mancanti (da AA.VV. 2009:Pontelatone dall’età aragonese all’eversione della feudalità).
117
119
Nel seguito sono enumerate cronologicamente lefonti consultate, suddivise in sezioni tematiche.
Inquadramento storico e territoriale
- G.B. PACIChELLI, Il Regno di Napoli in prospettivadiviso in dodici provincie, v. I, Sala Bolognese 1979.Ripr. facs. dell’ed.: Napoli, 1702-1703.- L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico-ragionato delRegno di Napoli, Sala Bolognese 1984. Ripr. facs.dell’ed: Napoli, 1804.- L. GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatichedel Regno di Napoli, t. xIV, Napoli 1805.- C. AFAN DE RIVERA, Tavole di riduzione dei pesi edelle misure delle Due Sicilie, Napoli 1841.- C. MINIERI RICCIO, Memorie storiche degli scrittorinati nel Regno di Napoli, Sala Bolognese 1990.Ripr. facs. dell’ed.: Napoli, 1844.- G. DEL RE, Cronisti e scrittori sincroni napoletaniediti ed inediti ordinati per serie e pubblicati. Storia dellamonarchia. Normanni, v. I, Napoli 1845.- G. MORONI ROMANO, Dizionario di erudizione sto-rico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, v.LxIV, Venezia 1853.- C. PORzIO, La congiura de’ Baroni del Regno di Na-poli contra il re Ferdinando I, ristampa a cura di S.D’Aloe, Napoli 1859.- G.E. STREET, Some account of Gothic architecturein Spain, London 1865.- R. FILANGIERI, Architettura e scultura catalana inCampania nel secolo XV, in “Boletin de la SociedadCastellonense de cultura”, xI, Castellon 1930.- R. FILANGIERI (illustrato da), Il codice miniato dellaconfraternita di Santa Marta in Napoli, Firenze 1950.- G. ChIERICI, Il palazzo italiano dal secolo XI al se-colo XIX, Milano 1957.- P.M. LUGLI, Storia e cultura della città italiana, Bari1967.- R. PANE, Il Rinascimento nell’Italia meridionale, Mi-lano 1975.- L. SANTORO, Aspetti e problemi dell’ambiente cam-pano, Napoli 1979.- AA.VV., Guida d’Italia. Campania, Milano 1981.- M. D’ONOFRIO, V. PACE, Italia romanica. LaCampania, Milano 1981.- I. hOGG, Storia delle fortificazioni, Novara 1982.
- L. SANTORO, Castelli angioini e aragonesi nel Regnodi Napoli, Segrate 1982.- M. ROSI, Architettura meridionale del Rinascimento,Napoli 1983.- G. ALISIO, Napoli nel Seicento. Le vedute di France-sco Cassiano de Silva, Napoli 1984.- V. VALERIO, L’Italia nei manoscritti dell’officina to-pografica conservati nella Biblioteca Nazionale di Na-poli, Napoli 1985.- G. GALASSO, R. ROMEO (a cura di), Storia delMezzogiorno, v. V, Roma 1986.- G. FIENGO, I Regi Lagni e la bonifica della “Campa-nia Felix” durante il viceregno spagnolo, Firenze 1988.- L. SANTORO, Case-torri del Cinquecento nel vice-reame di Napoli, in “Napoli nobilissima”, IV s.,xxIx (1990), pp. 11-16.- V. VALERIO, Società uomini e istituzioni cartografichenel Mezzogiorno d’Italia, Firenze 1993.- M.S. CALò MARIANI, R. CASSANO (a cura di),Federico II. Immagine e potere, Venezia 1995.- G. LABROT, Quand l’histoire murmure. Villages etcampagnes du royaume de Naples (XVI-XVIII siècle),Roma 1995.- R. DI BATTISTA, La porta e l’arco di Castelnuovo aNapoli, in “Annali di architettura. Rivista delCentro internazionale di Studi di ArchitetturaAndrea Palladio di Vicenza”, 10-11 (1998-1999),pp. 7-21.- F. RUSSO, Trenta secoli di fortificazioni in Campania,Piedimonte Matese 1999.- A. SERRA DESFILIS, “è cosa catalana”: la GranSala de Castel Nuovo en el contexto mediterráneo, in“Annali di architettura. Rivista del Centro inter-nazionale di Studi di Architettura Andrea Palla-dio di Vicenza”, 12 (2000), pp. 7-16.- A. GAMBARDELLA (a cura di), Ager Campanus ri-cerche di architettura, Napoli 2002.- V. VALERIO, Costruttori di immagini. Disegnatori,incisori e litografi nell’Officio Topografico di Napoli(1781-1879), Napoli 2002.- AA.VV., Ritratto di Terra di Lavoro, Caserta 2005.- G. AMIRANTE, M.R. PESSOLANO, Immagini diNapoli e del Regno. Le raccolte di Francesco Cassianode Silva, Napoli 2005.- L. CARDI, Carte geografiche e vedute di Terra di Lavorodal XVI al XIX secolo, Marina di Minturno 2006.
Bibliografia
120
- S. PALMIERI, Il Castelnuovo di Napoli. Una postilla, in“Napoli nobilissima”, V s., VII (2006), pp. 161-178.- C. DE SETA, A. BUCCARO (a cura di), Iconografiadelle città in Campania. Le province di Avellino, Bene-vento, Caserta, Salerno, Napoli 2007.- M. ROSI, L’altro Rinascimento. Architettura meri-dionale nel ‘400, Napoli 2007.- G. FIENGO, L. GUERRIERO, La residenza arago-nese della Conigliera in Napoli, in “Napoli nobilis-sima”, VI s., I (2010), pp. 81-102.
Sub-areali di studio
- S. ThEO, Cenni sulle origini di Carinola, Na-poli 1843.- L. MENNA, Saggio istorico della città di Carinola (acura di A. Marini Ceraldi), Scauri 1980. Ripr.facs. dell’ed.: Aversa, 1848.- E. BERTAUx, L’art dans l’Italie méridionale, Parigi 1904.- A. VENTURI, Storia dell’arte italiana, v. IV - v.VIII, t. II, Milano 1923.- P. TOESCA, Storia dell’arte italiana. I: il Medioevo,Torino 1927.- U. TAVANTI, Carinola. Una piccola città catalana inItalia, in “Le vie d’Italia”, 7 (1931).- B. CARAVITA DI TORRITTO (a cura di), Una mi-nuscola città del Quattrocento, Aversa 1936.- AA.VV., Miscellanea in onore di J. Puig y Cadafalch,Barcelona 1947-1951, pp. 37-40.- G. D’ANGELO, Carinola nella storia e nell’arte,Teano 1958.- R. PANE, Note su Guillermo Sagrera architetto, in“Napoli nobilissima”, III s., I (1961-62), pp.151-162.- G. ALOMAR, Los discipulos de Guillermo Sagrera enMallorca Napoles y Sicilia (I), in “Napoli nobilis-sima”, III s., III (1963-64), pp. 85-96.- G. ALOMAR, Los discipulos de Guillermo Sagrera enMallorca Napoles y Sicilia (II), in “Napoli nobilis-sima”, III s., III,(1963-64), pp. 125-135.- G. D’ANGELO, Carinola la città catalana, in “Ras-segna Aurunca”, 4/5 (1964), pp. 16-21.- M. ASSO, Carinola (Caserta). Chiesa di S. GiovanniApostolo (ex Cattedrale), in “Bollettino d’Arte”, Vs., LII, II, aprile-giugno 1967, p. 118.- E. CARELLI, Elementi architettonici durazzeschi e ca-
talani a Sessa Aurunca, in “Napoli nobilissima”,III s., xI (1972), pp. 33-45.- A. VENDITTI, Presenze ed influenze catalane nell’ar-chitettura napoletana del regno d’Aragona (1442-1503), in “Napoli nobilissima”, III s., xIII(1974), pp. 3-21.- R. CAUSA, Piccolo itinerario nell’arte catalana, in“Civiltà della Campania”, 4 (1976), pp. 12-17.- M. ROSI, Carinola. Pompei quattrocentesca, Na-poli 1979.- M. ROSI, Il palazzo Marzano di Carinola, Na-poli 1979.- B. BUONANNO, Notizie storiche del Convento dellaChiesa e dei Frati di Mondragone, Napoli 1981.- G. CARBONARA (a cura di), Restauro e cemento inarchitettura, Roma 1981.- TOURING CLUB ITALIANO, Città da scoprire.Guida ai centri minori. Italia meridionale e insulare,Milano 1985.- G. GUADAGNO (a cura di), Storia economia ed ar-chitettura nell’Ager Falernus (Atti delle giornate distudio febbraio-marzo 1986), Marina di Min-turno 1987.-AA.VV., Pontelatone dall’età longobarda all’età ara-gonese, Curti 1989.- R. CASTRIChINO, G. SUPINO, San Francesco D’As-sisi a Gaeta e a Casanova di Carinola, Formia 1991.- L. CRIMACO, Volturnum, Roma 1991.- G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), Storia e ci-viltà della Campania. Il Rinascimento e l’Età Barocca,Napoli 1994.- A.M. VILLUCCI, Sessa Aurunca: un itinerario cul-turale, in “Civiltà Aurunca. Rivista trimestrale dicultura”, 28 (1994), pp. 15-26.- G. DI MARCO, Sessa e il suo territorio tra medioevoed età moderna, Marina di Minturno 1995.- M. ROSI, Pontelatone e l’area di Montemaggiore, Na-poli 1995.- A. BRODELLA, Storia della sagrestia della Cattedraledi Carinola e due censimenti della popolazione della città,Marina di Minturno 1996.- T. COLLETTA (a cura di), Le cinte murarie urbanedella Campania. Teano, Sessa Aurunca, Capua, Na-poli 1996.- A. CAPRIO, Castel Volturno. La storia, la cultura, imonumenti, le famiglie, Napoli 1997.
121
- CIRCOLO LEGAMBIENTE NUOVA CALENUM, Ca-rinola tra storia e immagini, Caserta 1997.- F. MIRAGLIA, C. VALENTE (a cura di), La Cul-tura del Rispetto. Orizzonti di salvaguardia integrata,Marina di Minturno 1998.- G.P. BROGIOLO (a cura di), Atti del II CongressoNazionale di Archeologia Medievale (Brescia, 28 set-tembre-1 ottobre 2000), Firenze 2000.- G.M. MASUCCI, Carinola: censimento del patrimonioedilizio urbano di un insediamento feudale tra tardo me-dioevo ed età moderna, Tesi di Dottorato in Storiae conservazione dei Beni Architettonici - xIIIciclo (tutor G. Fiengo), Seconda Università degliStudi di Napoli, 2000.- F. MIRAGLIA, R. NOCCO, C. VALENTE, Carinola.Viaggio nel dominio della memoria, Napoli 2000.- Carinola. Lo spirito & il Potere, Edizioni Cult Arts.a.s. 2001 (cd-rom).- F. MIRAGLIA, Schede. Carinola, in “Civiltà Aurunca.Rivista trimestrale di cultura”, 42 (2001), pp. 67-72.- R. SASSO, Schede. Sessa Aurunca, in “Civiltà Au-runca. Rivista trimestrale di cultura”, 44 (2001),pp. 59-76.- C. VALENTE, Schede. Mondragone, in “Civiltà au-runca. Rivista trimestrale di cultura”, 47 (2002),pp. 61-73.- Carinola. Arte, storia e natura, Napoli 2003.- C. CUNDARI, L. CARNEVALI (a cura di), Carinola e ilsuo territorio. Rassegna dei beni architettonici, Roma 2003.- C. CUNDARI (a cura di), Palazzo Novelli a Cari-nola. La storia, il rilievo, il restauro, Roma 2003.- M. PICCIRILLO (a cura di), Io notaio Nicola DeMartoni. Il pellegrinaggio ai Luoghi Santi da Carinolaa Gerusalemme 1394-1395, Gorle 2003.- A. CASAMENTO, E. GUIDONI (a cura di), Le cittàmedievali dell’Italia meridionale e insulare (Atti delconvegno, Palermo, 28-29 novembre 2002),Roma 2004.- A. BRODELLA, Storia della Diocesi di Carinola, Ma-rina di Minturno 2005.- A. BRODELLA, Appendice alla storia della Diocesidi Carinola, Marina di Minturno 2005.- C. CUNDARI (a cura di), Verso un repertorio del-l’architettura catalana. Architettura catalana in Cam-pania. Province di Benevento, Caserta, Napoli,Subiaco 2005.
- G. PAROLINO, Sessa Aurunca. Storia della topono-mastica, Marina di Minturno 2005.- A. GAMBARDELLA, D. JACAzzI (a cura di), Ar-chitettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento.Campania ricerche, Roma 2007.- A. GAMBARDELLA, D. JACAzzI (a cura di), Ar-chitettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento.Campania saggi, Roma 2007.- F. MIRAGLIA, Piccoli tesori vulnerati. Il triste destinodell’ex Convento di San Francesco (già dell’Annunziata)in Mondragone, in “Civiltà Aurunca. Rivista trime-strale di cultura”, 70 (2008), pp. 41-49.- C. VALENTE, L’Università baronale di Carinolanell’Apprezzo dei beni Anno 1690, Marina di Min-turno 2008.- AA.VV., Pontelatone dall’età aragonese all’eversionedella feudalità, Curti 2009.- S. FRANCO, I partiti politici in Terra di Lavoro(1919-1926), Marina di Minturno 2009.- F. MIRAGLIA, Note sulla rappresentazione della cittàe del territorio di Carinola tra il XVII ed il XVIII se-colo. La veduta tardoseicentesca di Francesco Cassianode Silva, in “Civiltà Aurunca. Rivista trimestraledi cultura”, 75-76 (2009), pp. 71-77.- A. PANARELLO (a cura di), Conoscere il Roccamon-fina. 1. Il geosito (Atti del convegno – Roccamon-fina, 11 luglio 2009, Volume primo – Relazioni),Formia 2009.- G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Monu-menti e documenti. Restauri e restauratori del secondoNovecento (Atti del seminario nazionale), Napoli2011.- F. MIRAGLIA, La raffigurazione di Sessa nelle vedutetardoseicentesche di Francesco Cassiano de Silva, in “Ci-viltà Aurunca. Rivista trimestrale di cultura”, 81(2011), pp. 57-65.- F. MIRAGLIA, Sessa Aurunca nella cartografia storicatra Cinquecento e Settecento, in “Civiltà Aurunca. Ri-vista trimestrale di cultura”,83 (2011), pp. 49-55.
Lineamenti geomorfologici e materiali dacostruzione
- F. DE CESARE, La scienza dell’architettura applicataalla costruzione, alla distribuzione, alla decorazionedell’architettura civile, I, Napoli 1855.
122
- L. RAGUCCI, Principj di pratica di architettura, IIed., Napoli 1859.- F. PENTA, I materiali da costruzione dell’Italia me-ridionale, v. I, Napoli 1935.- P. DI GIROLAMO, Petrografia dei tufi campani, in“Rendiconti dell’Accademia di Scienze Fisichee Matematiche”, xxxV (1968), pp. 5-70.- F. SCARSELLA, Note illustrative della Carta Geolo-gica d’Italia, Foglio 172, “Caserta”, In appendice:“vulcano di Roccamonfina”, Fogli 160-161-171-172 (C. BERGOMI, V. MANGANELLI), Roma 1971.- P. DI GIROLAMO ET AL, Correlazioni stratigrafichefra le principali formazioni piroclastiche della Campania(Roccamonfina, Campi flegrei, Somma-Vesuvio), in“Rendiconti della Società Italiana di Mineralogiae Petrografia”, xxVIII (1972), pp. 77-124.- D.G.A. WhITTEN, J.R.V. BROOKS, Dizionario digeologia (ed. it.), Milano 1978.- A. PETRONE zOLFO, Considerazioni geografichesulla piana di Mondragone, Sant’Arpino 1979.- F. ORTOLANI, F. APRILE, Principali caratteristichestratigrafiche e strutturali dei depositi superficiali dellapiana campana, in “Bollettino Società GeologicaItaliana”, 1985, pp. 195-206.
Tecniche costruttive tradizionali
- G. FIENGO, La chiesa e il convento di S. Maria delPozzo a Somma Vesuviana, in “Napoli nobilis-sima”, III s., IV (1964-65), pp. 125-132.- G. FIENGO, Organizzazione e produzione ediliziaa Napoli all’avvento di Carlo di Borbone, Napoli1983.- P. PEDUTO, Nascita di un mestiere. Lapicidi, inge-gneri, architetti di Cava dei Tirreni (secc. XI-XVI),Cava dei Tirreni 1983.- F. PATRONI GRIFFI, «Ad uso de bono maestro». Mu-ratori cavesi a Napoli nel ‘400, in “Napoli nobilis-sima”, III s., xxIV (1985), pp. 60-62.- A. AVETA, Materiali e tecniche tradizionali nel na-poletano. Note per il restauro architettonico, Napoli1987.- J.P. ADAM, L’arte di costruire presso i Romani. Ma-teriali e tecniche, Milano 1988.- U. MENICALI, I materiali dell’edilizia storica, Roma1992.
- F. STRAzzULLO, Documenti per la storia dell’ediliziae dell’urbanistica nel regno di Napoli dal ‘500 al ‘700,Napoli 1993.- A. GISOLFI (a cura di), Multimedia. Beni culturalie formazione (Atti del Convegno Nazionale “Si-stemi multimediali intelligenti. Multimedia ebeni culturali. Multimedia e formazione”, Ra-vello 1994), CUEBC, Salerno 1994.- T. MANNONI, Caratteri costruttivi dell’edilizia sto-rica, Genova 1994.- M. MORONI, P. SARTORI (a cura di), Proceedingsof the International Symposium “Dealing with defectsin building”, Varenna 1994.- R. CASSANELLI (a cura di), Cantieri medievali, Mi-lano 1995.- F. STRAzzULLO, Edilizia e urbanistica a Napoli dal‘500 al ‘700, Napoli 1995.- S. DELLA TORRE (a cura di), Storia delle tecnichemurarie e tutela del costruito. Esperienze e questioni dimetodo (Atti del Convegno, Brescia 1995), Milano1996.- D. FIORANI, Tecniche costruttive murarie medievali.Il Lazio meridionale, Roma 1996.- Scala nel Medioevo (Atti delle Giornate Interna-zionali di Studio, Scala 1995), Amalfi 1996.- S. DELLA TORRE, T. MANNONI, V. PRACChI (acura di), Magistri d’Europa. Eventi, relazioni, strut-ture della migrazione di artisti e costruttori dai laghilombardi (Atti del convegno internazionale,Como 1996), Como 1997.- G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Muraturetradizionali napoletane. Cronologia dei paramenti tra ilXVI ed il XIX secolo, Napoli 1998.- S. GELIChI, Introduzione all’archeologia medievale.Storia e ricerca in Italia, Roma 1998.- M. RUSSO, Aspetti della cultura costruttiva napole-tana tra XVI e XVII secolo, in “Napoli nobilis-sima”, IV s., xxxVII (1998), pp. 215-229.- G. AUSIELLO, Architettura medievale. Tecniche co-struttive in Campania, Napoli 1999.- S. D’AVINO, M. SALVATORI (a cura di), Metrolo-gia e tecniche costruttive (Atti della Giornata di Stu-dio, Pescara 1998), Roma 1999.- M. D’APRILE, Murature angioino-aragonesi in Terradi Lavoro, Napoli 2001.- G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Atlante
123
delle tecniche costruttive tradizionali. Lo stato dell’arte,i protocolli della ricerca. L’indagine documentaria (Attidel I e del II Seminario Nazionale), Napoli 2003.- P.F. PISTILLI, Castelli normanni e svevi in Terra diLavoro. Insediamenti fortificati in un territorio di con-fine, San Casciano V. P. 2003.- h. ROTOLO, Restauri antichi e nuovi nel palazzo diAntonello Petrucci in Napoli, “quaderni del Dipar-timento di Restauro e Costruzione dell’Archi-tettura e dell’Ambiente”, 3, Napoli 2003.- C. CROVA, Insediamenti e tecniche costruttive medie-vali. Il Latium adiectum e la Terra Laboris, Monte-cassino 2005.- G. COPPOLA, E. D’ANGELO, R. PAONE (a cura di),Mezzogiorno & Mediterraneo. Territori, strutture, relazionitra antichità e medioevo (Atti del Convegno Interna-zionale. Napoli 9-11 giugno 2005), Napoli 2006.- M. SALVATORI, Manuale di metrologia per architetti stu-diosi di storia dell’architettura ed archeologi, Napoli 2006.- R. ChIOVELLI, Tecniche costruttive murarie medievali:la Tuscia, Roma 2007.- L. D’ORTA, Murature post-medievali in calcare diTerra di Lavoro. Caratterizzazione cronotipologica,Tesi di Dottorato in Conservazione dei Beni Ar-chitettonici - xxI ciclo (tutor L. Guerriero), Se-conda Università degli Studi di Napoli, 2008.- G. FIENGO, L. GUERRIERO (a cura di), Atlantedelle tecniche costruttive tradizionali. Napoli, Terra diLavoro (XVI-XIX), 2 tt., Napoli 2008.- SALIM ELWAzANI, ShAThA MALhIS, JAMAL AL-qAWASMI, Responsibilities and Opportunities in Ar-chitectural Conservation: Theory, Education, andPractice, I, CSAAR Press 2008.- L. GUERRIERO, L. RONDINELLA, The men-siochronology of traditional building elements as way tosafe the authenticity of monuments and urban environ-ments, in Proceeding of Icomos 16th International Sci-entific Symposium “Finding the spirit of place”(quebec, Canada, 2008), cd-rom, pp. 1-12.- V. PRACChI (a cura di), Lo studio delle tecniche co-struttive storiche: stato dell’arte e prospettive di ricerca,Como 2008.- C. VARAGNOLI (a cura di), Muri parlanti. Prospet-tive per l’analisi e la conservazione dell’edilizia storica(Atti del convegno, Pescara 26-27 Settembre2008), Firenze 2009.
- A. PANARELLO (a cura di), Conoscere il Roccamon-fina. 2. L’architettura (Atti del convegno e cata-logo della mostra, Roccamonfina, 11 settembre2010), San Nicola La Strada 2010.- C. CROVA, L’arte di costruire al tempo di FedericoII. Cantieri e tecniche costruttive in Terra di Lavoro,in “Napoli nobilissima”, VI s., II (2011), pp.81-104.- F. MIRAGLIA, Palazzo Marzano a Carinola: i re-stauri degli anni Trenta del Novecento, in “Civiltà au-runca. Rivista trimestrale di cultura”, 84 (2011),pp. 43-62.- S. D’AGOSTINO (a cura di), Storia dell’Ingegneria(Atti del 4° Convegno Nazionale. Napoli, 16-17-18 aprile 2012), 2 tt., Santa Maria a Vico 2012.- P. DE JOANNA, D. FRANCESE, A. PASSARO
(Eds.), Proceedings of the 1st International SMC –CITTAM Conference. Sustainable MediterraneanConstruction. Sustainable Environment in the Mediter-ranean region: from Housing to city and land scale Con-struction, Milano 2012.- F. MIRAGLIA, C. VALENTE, Mondragone: persi-stenze della “Terra Murata” nel tessuto urbano dellacittà contemporanea, “Terra Laboris. Itinerari di ri-cerca” 1, Marina di Minturno 2012.- G. LEVA, F. MIRAGLIA, La tutela del palazzo Mar-zano a Carinola tra gli anni quaranta e settanta del No-vecento attraverso l’attività della Soprintendenza aiMonumenti della Campania, “Terra Laboris. Itine-rari di ricerca” 2, Marina di Minturno 2012.
Tecniche di conservazione e consolida-mento strutturale
- G. FIENGO (a cura di), Diagnosi dei dissesti e con-solidamento degli edifici, Napoli 1978.- S. MASTRODICASA, Dissesti statici delle strutture edi-lizie, Milano 1993.- A. AVETA, Tecniche per il restauro. Problemi di umi-dità negli edifici monumentali, Napoli 1996.- G. CARBONARA, Trattato di restauro architettonico,v. II, Torino 2004.- A. CATALANO, G. FRUNzIO (a cura di), Diagno-stica per la tutela dei materiali e del costruito (Atti delconvegno, 4 dicembre 2003, sito reale di SanLeucio), Napoli 2004.
- A. AVETA, S. CASIELLO, F. LA REGINA, R. PI-CONE (a cura di), Restauro e consolidamento (Atti delConvegno, Napoli 2003), Roma 2005.- Conference proceedings, The Tenth North AmericanMasonry Conference (St. Louis, Missuori, June 3-6,2007), Omnipress 2007.- C. ARCOLAO, La diagnosi nel restauro architettonico.Tecniche, procedure, protocolli, Vicenza 2008.- B. CALDERONI, E.A. CORDASCO, L. GUER-RIERO, P. LENzA, G. MANFREDI, Mechanical behav-
iour of post-medieval tuff masonry of the Naples area,in “Masonry International. Journal of the Inter-national Masonry Society”, v. 21, n. 3 (2009), pp.85-96.- B. CALDERONI, G. CECERE, E.A. CORDASCO,L. GUERRIERO, P. LENzA, G. MANFREDI, Metro-logical definition and evaluation of some mechanicalproperties of post-medieval Neapolitan yellow tuff ma-sonry, in “Journal of Cultural heritage”, v. 11, n.2 (2010), pp. 163-171.
124
Indice dei nomi*
Adam J. P., 45 (n. 33)Afan de Ribera P., 14, 33, 38, 44 (nn. 26, 30), 91Afan de Rivera C., 44 (n. 24)Alberti L.B., 32Alfonso il Magnanimo (o Alfonso V o Alfonsod’Aragona), 14 (n. 1), 29 (n. 27), 32, 52, 55, 71(n. 23), 86Alomar G., 32, 42 (n. 8)Amirante G., 28 (n. 22), 29 (n. 24)Aprile F., 27 (n. 4)Arcolao C., 115 (n. 14)Asso M., 71 (n. 29) AvetaA., 27 (n. 10), 115 (n. 15)Balasco A., 110 (n. 7)Baldovino II di Costantinopoli, 47, 67 (n. 6)Bernardo vescovo di Carinola, 62Bicco M., 14 (n. 2)Brodella A., 71 (n. 28)Brooks J.V.R., 27 (n. 7)Buccaro A., 29 (n. 22), 30 (n. 33)Burattini E., 43 (n. 15)Calderoni B., 44 (n. 27), 115 (n. 15)Calò Mariani M.S., 67 (n. 4)Caprio A., 30 (n. 38)Carafa (o Carafa della Stadera) (famiglia), 23, 25,30 (n. 42)- Antonio, 110 (n. 8)- Diomede I, 25, 26- Francesco II, 26- Luigi, 29 (n. 31)- Nicola Guzmàn, 20Caravita di Torritto B., 68 (n. 14)Carbonara G., 27 (n. 5)Carelli E., 29 (n. 28), 115 (n. 13)Carnevali L., 69 (n. 15), 71 (n. 28)Carillo S., 14 (n. 2)Carlo I d’Angiò, 47, 67 (n. 6), 68 (n. 7)Carlo di Borbone, 27 (n. 9)Casamento A., 30 (n. 38)Casiello S., 115 (n. 15)Cassano R., 67 (n. 4) Cassiano de Silva F., 21, 23, 28 (n. 22), 29 (n. 23),30 (nn. 34, 35)Castrichino R., 110 (n. 8)
Catalano A., 44 (n. 23)Cavallaccio S., 14 (n. 2)Cecere G., 14 (n. 2), 27 (nn. 4, 8, 11), 43 (n. 16),44 (n. 27), 45 (n. 31), 111 (n. 12), 115 (n. 15)Chierici G., 71 (n. 22)Chiovelli R., 45 (n. 30)Colacino P., 29 (n. 32)Consalvo II, 23, 29 (n. 31)Coppola (famiglia), 71 (n. 24)Cordasco E.A., 44 (n. 27), 115 (n. 15)Crimaco L., 30 (n. 38)Crova C., 7, 44 (n. 29), 69 (n. 15)Cundari C., 29 (n. 27), 69 (n. 15), 70 (n. 20), 71(nn. 25, 27, 28), 115 (n. 13)D’Agostino S., 66 (n. 1)D’Aloe S., 68 (n. 12)D’Aprile M., 7, 14 (n. 2), 27 (n. 7), 41 (n. 1), 42 (n.4), 43 (nn. 12, 19, 21), 44 (nn. 22, 28), 45 (nn. 32,34), 69 (n. 15), 70 (n. 17), 72 (n. 31), 109 (n. 3)D’Avino S., 43 (n. 15)D’Orta L., 14 (n. 2)de Cordoba C.F. (Gran Capitano), 23, 84de Luna G., 32de Toledo P., 33, 44 (n. 30)De Cesare F., 45 (n. 31)De Marco C., 14 (n. 2)De Martoni N., 48, 68 (n. 9)De Seta C., 29 (n. 22), 30 (n. 33)De Stasio G., 68 (n. 14)Del Balzo (famiglia), 71 (n. 24)Del Re G., 67 (n. 3)Della Torre S., 14 (n. 2), 41 (n. 2), 43 (nn. 11, 15)Di Girolamo P., 27 (n. 4)Di Marco G., 29 (n. 30)Donsì Gentile J., 68 (n. 7)Eleonora d’Aragona, 25, 29 (n. 27), 55, 86Federico II di hohenstaufen, 22, 67 (n. 4)Ferdinando II di Borbone, 44 (n. 24)Ferdinando il Cattolico, 23Ferrante I (o Ferdinando I) d’Aragona, 13, 14(n. 1), 25, 26, 29 (n. 29), 44 (n. 24), 48, 56, 68 (n.12), 71 (nn. 23, 24)Ferri L., 14 (n. 2)Fiengo G., 7, 9, 14 (nn. 2, 5), 15 (nn. 6, 7), 27
125
I numeri si riferiscono alle pagine del testo; se sono in parentesi e preceduti dalle lettere “n.” o“nn.”, si riferiscono invece alle note.
(nn. 4, 9), 30 (n. 37), 41-42 (n. 2), 42 (nn. 3, 5),43 (nn. 15, 17), 44 (nn. 22, 27, 30), 45 (n. 31), 70(n. 18), 71 (nn. 26, 29), 108 (n. 1), 115 (n. 15)Filangieri di Candida R. (o Filangieri), 32, 42 (n.7), 70 (n. 21), 71 (n. 23)Filippo re di Tessaglia, 47Fiorani D., 43 (n. 11)Forcimanya Matteo, 32Frunzio G., 44 (n. 23)Galasso G., 26 (n. 1)Galluccio Antonio, 21, 29 (n. 32), 48Gentile A., 26 (n. 1)Giannattasio C., 14 (n. 2), 30 (n. 37), 110 (nn. 5,6, 10)Giovanna I d’Angiò, 29 (n. 27)Giustiniani L., 28 (nn. 12, 20), 30 (nn. 40, 42,44), 45 (n. 31)Gonzaga fra Francesco, 110 (n. 8)Grillo de Mari Marc’Antonio, 21Grimoaldo, 24Guerriero L., 7, 9, 14 (nn. 2, 3, 4), 15 (nn. 6, 7),26 (n. 2), 27 (nn, 4, 8, 11), 30 (nn. 37, 39), 41-42(n. 2), 42 (nn. 3, 5), 43 (nn. 15, 16, 17, 20), 44(nn. 22, 23, 27), 45 (n. 31), 70 (n. 18), 71 (n. 29),109 (n. 3), 111 (n. 12), 115 (n. 15)Guidoni E., 30 (n. 38)La Regina F., 115 (n. 15)Labrot G., 30 (n. 32)Lapazzaia (o Lapizzaia) G., 33Lenza P., 44 (nn. 23, 27), 115 (15)Lepre A., 26 (n. 1)Leva G., 71 (n. 29)Lugli P.M., 28 (n. 15)Manco A., 70 (n. 18)Manfredi G., 44 (n. 27), 115 (n. 15)Mannoni T., 15 (n. 8), 41 (n. 2)Marzano (famiglia), 9, 14 (n. 1), 22, 23, 25, 29(n. 27), 62, 84- Giovanni Antonio, 22, 29 (n. 27)- Marino, 14 (n. 1), 23, 25, 29 (n. 27), 32, 42 (n.7), 55, 70 (n. 21), 71 (n. 23), 86- Tommaso, 25, 26, 29 (n. 27), 65Minieri Riccio C., 67 (n. 7), 68 (n. 11)Miraglia F., 7, 8, 14 (n. 3), 26 (n. 2), 28 (nn. 14, 16,22), 29 (n. 23), 30 (nn. 35, 39), 42 (n. 8), 66 (n. 1), 70(n. 19), 71 (nn. 22, 28, 29), 109 (nn. 2, 3), 110 (n. 9)
Montuori M., 14 (n. 2)Moroni M., 43 (n. 15)Mussolini B., 17Nocco R., 28 (n. 14), 71 (n. 28)Novelli (famiglia), 56Ortolani F., 27 (n. 4)Pacichelli G.B., 22, 29 (n. 25), 30 (n. 33)Palladio, 32Panarello A., 14 (n. 3), 27 (n. 2), 110 (n. 7)Pandolfo Capodiferro, 22, 29 (n. 26)Pane R., 9, 19, 28 (n. 18)Peduto P., 42 (n. 1)Penta F., 26 (n. 2), 27 (n. 3)Pessolano M.R., 28 (n. 22), 29 (n. 24)Petrone zolfo A., 27 (n. 3)Petrucci (famiglia), 56, 57- Antonello, 14 (n. 5), 48, 56, 71 (n. 24)- Giov. Antonio, 68 (n. 14)- Giovan Francesco, 48, 68 (n. 12)Piccirillo M., 68 (n. 9)Picone R., 115 (n. 15)Pistilli P.F., 67 (n. 4)Plinio il Vecchio, 17Porzio C., 48, 68 (nn. 11, 12), 71 (n. 23)Pracchi V., 41 (n. 2)Ragucci L., 45 (n. 31)Raucci C., 71 (n. 30)Redi F., 69 (n. 16)Robotti C., 68 (n. 7), 69 (n. 15)Romeo R., 26 (n. 1)Rosi M., 28 (nn. 13, 17), 30 (n. 41), 68 (n. 7), 70(n. 21), 71 (n. 28), 115 (n. 13)Rotolo h., 14 (n. 5), 71 (n. 26)Ruggiano L., 21, 29 (n. 32), 48Rumolo M., 30 (nn. 41, 43)Russo F., 68 (n. 10)Russo M., 42 (n. 9), 43 (nn. 15, 18), 44 (nn. 25,30), 45 (n. 31)Russo V., 71 (n. 25)Sagrera G., 32, 42 (nn. 7, 8)Sagrera J., 32Salvatori M., 43 (n. 15)Santello L., 27 (n. 2)Santoro L., 28 (n. 19), 66 (n. 2), 67 (nn. 4, 5), 111 (n. 11)Sartori P., 43 (n. 15)Scamozzi V., 32
126
Serlio S., 32Strazzullo F., 42 (n. 6), 44 (n. 30)Supino G., 110 (n. 8)Teodomaro di Montecassino, 24Torriero G., 70 (n. 20)Trinchera F., 29 (n. 29)Ugone Falcando, 66 (n. 3)Valente C., 28 (nn. 14, 21), 71 (n. 28), 109 (n. 2),111 (n. 11)
Valerio V., 29 (n. 22)Varagnoli C., 14 (n. 4), 27 (n. 5), 30 (n. 37), 69(n. 16), 108 (n. 1)Venditti M., 29 (n. 27)Venè A., 68 (n. 13), 70-71 (n. 22)Venturi A., 19Villucci A.M., 30 (n. 36)von Daun W.P., 28 (n. 22)Whitten D.G.A., 27 (n. 7)
127
Indice delle località*
ager Falernus (vedi agro Falerno)agro Falerno, 7, 9, 17, 19, 33Airola, 28 (n. 22)Alianello, 29 (n. 32)Alife, 29 (n. 27), 47, 67 (nn. 4, 7)Alifie (vedi Alife)Ardore, 29 (n. 32)Atina, 67 (n. 4)Avellino, 17, 29 (n. 22), 67 (n. 4)Aversa, 37, 67 (n. 4)- edifici religiosi:- complesso monasteriale di S. Lorenzo ad Sep-timum, 37Bacoli, 27 (11)Baia, 26Benevento, 17, 24, 29 (nn. 22, 26, 27), 44 (n. 26)Caiazzo, 47, 67 (n. 4)Calabria, 29 (n. 27)Calvello, 29 (n. 32)Camaldoli, 18Campagna, 29 (n. 32)Campania, 7, 15 (n. 7), 17, 22, 27 (n. 6), 29 (nn.22, 27), 30 (n. 38), 41 (n. 2), 45 (n. 31), 54, 56,67 (n. 4), 68 (n. 10), 70 (n. 22), 71 (nn. 23, 28)Campania Felix (vedi Terra di Lavoro)Campi Flegrei, 17, 27 (n. 3)Campolataro, 29 (n. 32)Capo Miseno, 27 (n. 11)Capua, 28 (n. 19), 29 (n. 26)Carini, 67 (n. 3)Carinola, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22,23, 25, 28 (nn. 14, 17, 19, 20, 21), 28-29 (n. 22),29 (nn. 23, 30, 31), 30 (n. 33), 32, 33, 34, 35, 42(nn. 7, 8), 47, 48, 49, 55, 56, 63, 65, 66, 66 (nn.1, 3), 68 (nn. 7, 9, 12, 13, 14), 68-69 (n. 15), 70(nn. 17, 18, 19, 20, 21), 71 (nn. 22, 25, 27, 28,29), 73, 81, 82, 84, 86, 89, 91, 92, 97, 99, 102,110 (n. 8), 111 (n. 13), 115 (n. 13)- edifici civili:- casa Di Cresce, 63, 65, 84- casa in vico Aurora, 65, 101- castello, 8, 12, 13, 19, 21, 29 (n. 23), 33, 47, 48, 50, 52,53, 60, 62, 65, 66, 66 (nn. 1, 3), 68 (nn. 7, 12, 13, 14), 68-69 (n. 15), 70 (nn. 17, 18), 73, 74, 76, 79, 82, 92, 97, 99
- masseria in via Gentili, 91, 97- palazzo Marzano (o casa Martullo), 8, 19, 28(n. 16), 32, 42 (n. 8), 52, 54, 55, 56, 70 (nn. 19,21), 70-71 (n. 22), 71 (n. 23), 89- palazzo Parascandolo, 32, 52- palazzo Petrucci (o palazzo Novelli), 8, 12, 13,19, 28 (n. 16), 32, 34, 42 (n. 8), 47, 52, 55, 60, 61,71 (nn. 25, 27), 78, 79, 82, 86, 92, 97, 99, 102, 103- porta dell’Annunziata, 47- sedile, 81- edifici religiosi:- cattedrale, 8, 28 (n. 16), 29 (n. 23), 60, 61, 62,68 (n. 9), 71 (n. 29), 91, 99- chiesa dell’Annunziata, 28, 81, 92- chiesa dell’Annunziata (Nocelleto), 63- monastero della Maddalena, 91- frazioni, località:- Casale, 19- Casanova, 19, 110 (n. 8)- Foro Claudio, 62- Nocelleto, 8, 19, 63, 65, 84, 101- S. Donato, 19- S. Ruosi, 19, 91, 97- S. Croce, 19- Ventaroli, 19Carinulum (vedi Carinola)Caserta (o provincia di Caserta), 17, 29 (n. 22,27), 67 (n. 4), 71 (n. 29)Castel Volturno, 8, 9, 14 (n. 3), 17, 19, 24, 26 (n.2), 30 (nn. 38, 40), 33, 90- edifici civili: - casa in vico V S. Castrese, 90- castello, 24, 25, 30 (n. 39)- frazioni, località:- borgo di S. Castrese, 8, 24, 25, 90Castelforte, 29 (n. 32)Castelgrande, 29 (n. 32)Caulonia, 29 (n. 32)Cava dei Tirreni, 31, 42 (n. 2)Celenza, 29 (n. 32)Città S. Angelo, 29 (n. 32)Colletorto, 29 (n. 32)Corfù, 48Coroglio, 27 (n. 11)
129
I numeri si riferiscono alle pagine del testo; se sono in parentesi e preceduti dalle lettere “n.” o“nn.”, si riferiscono invece alle note.
Crecchio, 29 (n. 32)Ferrazzano, 29 (n. 32)Fondi, 28 (n. 19), 29 (n. 32), 67 (n. 4)Formicola, 7, 9, 14 (n. 3), 17, 19, 26, 26 (n. 2),30 (n. 44), 33, 86, 101- edifici civili: - casa in via S. Cristina, 86- edificio in via Cavallari, 86, 101- frazioni, località:- Cavallari, 26, 86, 101- Fondola, 26, 101- Lautoni, 26- Pizzo S. Salvatore, 26Frosinone, 17Gaeta, 67 (n. 4)Gerusalemme, 48, 68 (n. 9)Grottacastagnara, 29 (n. 32)Isernia,17Itri, 29 (n. 32)Latina, 17Laviano, 29 (n. 32)Lazio, 17Liberi, 26litorale Domizio, 7, 9, 20Maddaloni, 67 (n. 4)Malvito, 29 (n. 32)Melfi, 17Mellento, 66 (n. 3)Molise, 17Monasterace, 29 (n. 32)Mondragone, 8, 21, 23, 27 (n. 3), 47, 67 (n. 4),81, 91, 93, 99, 109 (n. 2), 110 (nn. 8, 9, 11)- edifici civili:- torre ducale, 93, 110 (n. 11)- edifici religiosi:- convento di S. Francesco (o convento france-scano), 91, 93, 99, 110 (n. 9)monte Callicola, 26monte Cicoli, 19monte Maggiore (o Montemaggiore), 7, 9, 17,25, 26, 26 (n. 2), 30 (n. 41), 33, 65, 81monte Massico, 19monte Pecoraro, 19monte Petrino, 19monte S. Croce, 26 (n. 2)monte Serrone, 26
monte Tre croci, 19monte Trentaremi, 27 (n. 11)monti Ausoni, 17, 26 (n. 2)Montecorice, 29 (n. 32)Montefusco, 29 (n. 32)Montemalo, 29 (n. 32)Monteverde, 29 (n. 32)Napoli (o provincia di Napoli o regno di Na-poli), 7, 9, 14 (nn. 2, 5), 17, 18, 22, 23, 27 (nn. 4,9), 27-28 (n. 12), 28 (nn. 13, 19, 22), 29 (nn. 27,29), 30 (n. 37), 31, 32, 33, 36, 37, 42 (n. 6), 43(n. 15), 44 (nn. 22, 25, 26, 27, 30), 45 (n. 31), 48,57, 67 (n. 4), 68 (nn. 8, 11, 12), 70 (n. 18), 71 (n.23), 108 (n. 1), 111 (nn. 11, 12)- edifici civili:- Castel Nuovo, 32, 47, 50, 55- Castelcapuano, 67 (n. 4)- palazzo Petrucci, 14 (n. 5), 57Nisida, 27 (n. 11)Palermo, 67 (n. 3)Partinico, 66 (n. 3)Pietravairano, 66- edifici civili:- torre, 66, 71 (n. 31)Ponteladrone o Pontelatrone (vedi Pontelatone)Pontelatone, 7, 8, 9, 12, 14 (n. 3), 17, 19, 25, 26,26 (n. 2), 30 (nn. 41, 42, 43), 32, 33, 34, 35, 65,71 (n. 30), 81, 89, 92, 93, 102, 111 (n. 13)- edifici civili:- palazzo Affinito, 25- palazzo Galpiati, 25, 34, 35, 93, 102, 103- palazzo Rotondo, 8, 25, 34, 89, 93- palazzo Scirocco, 25, 34- torre Marzano, 8, 12, 25, 65, 66, 81, 109 (n. 3)Principato citerior, 31Rapone, 29 (n. 32)Riardo, 29 (n. 32)Ripacandida, 29 (n. 32)Rocca D’Arce, 67 (n. 4)Rocca D’Evandro, 67 (n. 4)Roccamonfina (apparato vulcanico), 15, 17, 22,26-27 (n. 2), 110 (n. 7)Roccanova, 29 (n. 32)Roccapiperozzi, 26Roccella, 29 (n. 32)Roma, 21, 22, 23, 29 (n. 29), 68 (n. 11)
130
Rossano, 29 (n. 27)Salerno, 17, 29 (nn. 22, 26)Sant’Arcangelo, 29 (n. 32)Sasso, 26Scafati, 31- edifici religiosi:- abbazia di Realvalle, 31, 32Schiavi, 26Sessa (o Sessa Aurunca), 7, 8, 9, 12, 17, 19, 22,23, 26, 28 (n. 19), 29 (nn. 27, 28, 29, 30, 31), 30(nn. 34, 35, 36, 37), 32, 33, 34, 35, 47, 55, 67 (n.4), 69 (n. 15), 83, 92, 101, 111-115 (n. 13)- edifici civili:- castello, 22, 23, 24, 35- porta dei Cappuccini, 23- torre dei Cappuccini, 12, 35, 83- torre di S. Biagio, 8, 22, 23, 30 (n. 34), 83- edifici religiosi:- complesso dei Carmelitani, 92- monastero di S. Germano, 22- monastero di S. Stefano, 22- palazzo in via Spine, 83, 84, 92- porta della Maddalena, 23Sessano, 29 (n. 32)Sesto, 26
Sora, 67 (n. 4)Sperlonga, 29 (n. 32)Stigliano, 29 (n. 32)Suessa (vedi Sessa)Teano, 8, 30 (n. 33), 47, 67 (n. 4), 84, 93- edifici civili:- abitazione in via Casa Licciardi, 84, 93- casa in via S. Maria degli Angeli, 86- frazioni, località:- Pugliano, 8, 84, 86, 93Terra di Lavoro, 7, 9, 10, 14 (nn. 2, 3), 17, 18,26, 26 (nn. 1, 2), 27 (nn. 4, 7), 29 (n. 27), 30 (nn.32, 37), 34, 39, 40, 43-44 (n. 22), 44 (nn. 27, 29),66, 67 (n. 4), 69 (n. 17), 74, 91, 97, 108 (n. 1),110 (n. 7), 111 (n. 12)Terra di Mondragone (vedi Mondragone)Terra Laboris (vedi Terra di Lavoro)Tito, 29 (n. 32)Torella, 29 (n. 32)Torre a mare, 29 (n. 32)Traetto, 24, 29 (n. 32)Trebola, 30 (n. 44)Turris Feniculi (vedi Formicola)Vienna, 28 (n. 22)Volturnum (vedi Castel Volturno)
131
Stampato nel mese di dicembre 2012presso le ARTI GRAFIChE CARAMANICA
Via Appia, 814 - tel. 0771.680838MARINA DI MINTURNO (Latina)
€ 25,00 ISBN 978-88-7425-110-0
Lo studio analizza, attraverso l’applicazione di protocolli mensiocronologici di respiro nazionale, le tec-niche costruttive murarie in tufo grigio tardo-medievali di alcuni areali della Campania settentrionale,privilegiando la conoscenza di quelle impiegate su larga scala, per identificare gli elementi ricorrenti dellaproduzione architettonica storicizzata, ai fini della sua conservazione e valorizzazione, in accordo conle istanze del moderno esercizio della tutela.
Francesco Miraglia (Formia 1972) è architetto, giornalista pubblicista e dottore di ricerca in Conservazione deibeni architettonici. Autore di diversi studi a diffusione nazionale ed internazionale sulla tutela del patrimonio cul-turale, attualmente è Cultore della Materia in Restauro presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale“L. Vanvitelli” della Seconda Università di Napoli e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno.