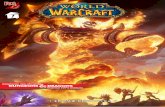Articolo recovery e recupero della soggettività - versione definitiva corretta
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Articolo recovery e recupero della soggettività - versione definitiva corretta
Luigi Basso Servizio Psichiatrico del Comprensorio Sanitario di Bolzano
I percorsi di recovery nella prospettiva del recupero dellasoggettività
Introduzione
Nel corso degli ultimi decenni si è progressivamente affermata nelcampo della salute mentale la necessità di considerare comeessenziali indicatori di outcome una serie di parametri riguardantidirettamente l’esperienza vissuta ovvero la dimensione soggettivadegli utenti affetti da disturbi psichiatrici gravi e dei lorofamiliari. Concetti quali “empowerment” e “recovery” hannoconquistato una posizione di assoluta centralità nell’ambito dellasalute mentale, all’interno di una prospettiva di crescentepartecipazione attiva di utenti e familiari ai processi divalutazione ed alle scelte terapeutiche ed organizzative deiservizi, con effetti sempre più rilevanti sulle politichesanitarie. Le valutazioni dei bisogni, della qualità della vita,del carico familiare, della soddisfazione relativa agli interventiricevuti ed ai servizi, dei life goals degli utenti a confronto congli obiettivi terapeutico-riabilitativi definiti dagli operatoricostituiscono oggi parametri ineludibili nel valutare processi edesiti. Indicatori di esito, quindi, che non possono più esserericondotti soltanto a fattori “oggettivi” quali il tasso direcidive, il numero di ricoveri e giornate di ospedalizzazione odi permanenza in strutture residenziali psichiatriche.Allo stesso concetto di recovery afferiscono due ambiti diriferimento, due paradigmi. Il primo, sviluppato nel contestodella ricerca clinica sull’efficacia dei trattamenti, è centratosul raggiungimento di esiti di tipo clinico/funzionale e basato sucriteri definiti operativamente. Il secondo si è sviluppato apartire dal contributo, espresso spesso in senso antagonistarispetto alla psichiatria tradizionale, dei movimenti e delleassociazioni di utenti e con l’apporto particolarmentesignificativo di voci quali J. Chamberlin (1978, 1984), S. Zinman(1982, 1987), P. Deegan (1988, 1990, 1992, 1993, 2005, 2006), K.Steele (2005), R. Coleman (1999), FJ. Frese III (1998, 2001, 2009)e molti altri. Questo secondo paradigma è focalizzatosull’esperienza soggettiva del processo evolutivo di cambiamentodei propri obiettivi, valori, ruoli, atteggiamenti, nell’ottica di
un consapevole ampliamento del concetto di sé, andando oltre lamalattia mentale. Cercheremo di tracciare un percorso recovery-oriented che illustri lediverse prospettive di valorizzazione della dimensione soggettiva,sul versante della psicopatologia e della clinica (con particolareriferimento allo spettro schizofrenico), da un lato, e dellaprospettiva in prima persona degli utenti, dall’altro, nei loroaspetti di peculiarità, convergenza, divergenza, complementarietà,talvolta antiteticità, nella consapevolezza che se una dialettica traesse è verosimilmente ineludibile, l’integrazione è l’orizzonte versocui tendere. Verrà rivolta particolare attenzione al concetto di“insight” (nella duplice veste di “consapevolezza di malattia” e, inuna dimensione più estesa, di “consapevolezza di sé”) ed alle suecontroverse connessioni con il processo di recovery.
Soggettività e psicopatologia
La dimensione di centralità dell’esperienza soggettiva rispetto aiparadigmi clinici tradizionali, basati sostanzialmentesull’osservazione naturalistica del comportamento, è frutto di unaprogressiva trasformazione che ha ribaltato uno dei presuppostiiniziali su cui si è fondata storicamente la psichiatria, ovvero lanon attribuzione di importanza e significatività all’esperienzasoggettiva. Tra la fine del 17° e l’inizio del 19° secolo ritenere, adesempio, che vi fossero pazienti consapevoli di essere affetti dauna malattia mentale grave avrebbe implicato una contraddizionelogica e sarebbe stata considerata una affermazione priva disenso, poiché non veniva attribuito valore e tantomeno significatoalcuno all’esperienza riportata dai pazienti e “la presenza dicompromissione della capacità di insight non era una variabile maun parametro nella definizione dell’infermità mentale” (Berrios,Markova, 2004). La dimensione introspettiva non era compatibilecon la definizione di follia e bisognerà aspettare la prima metàdel 19° secolo perchè tale componente cominci ad essere presa inconsiderazione. Fino al 18° secolo “essere folli e perdere lapropria ragione era una sorta di stato permanente che siripercuoteva sull’intera persona” (Berrios, Markova, ibidem). Ilparadigma della follia era dato dallo smarrimento totale eirreversibile della ragione e difficile da spiegare era casomai ilfatto che potessero prodursi condizioni di reversibilità daglistati psicotici fino alla guarigione vera e propria, come giàallora era documentabile.
A mettere in discussione questo paradigma contribuì la nozione diinfermità mentale parziale, che prese piede in seguitoall’influsso delle idee di Xavier Bichat (1771 – 1802) e chepresupponeva un modello modulare della mente e una più o menospecifica localizzazione cerebrale. Molti alienisti della primametà dell’ottocento, tra cui Pinel, Prichard ed Esquirol,evidenziarono infatti come i pazienti potessero essere colpitidalla follia o con modalità alternanti o solo in alcune aree dellaloro psiche, mentre altre funzioni restavano intatte o comunquemeno compromesse. Da qui l’individuazione di quadri clinici qualila monomania, la follia morale, la manie sans délire, la folie raisonnante,ecc. Questo apriva la strada da un lato ad una esplorazioneselettiva delle diverse facoltà psicologiche (intellettive,emotive, volitive, ecc.), dall’altro alla valorizzazione di quantoi pazienti riferivano in termini di esperienza vissuta e diconsapevolezza di ciò che stava loro accadendo. Nella seconda metàe soprattutto verso la fine del diciannovesimo secoloconquisteranno poi sempre maggior risonanza concetti come“coscienza” (nell’accezione di “consapevolezza”), “introspezione”e “sé”, in un clima scientifico dove la dimensione soggettivaverrà sempre più considerata parte integrante della definizione diinfermità mentale e sempre maggior risalto avranno le descrizionidelle esperienze interiori come elementi imprescindibili per ladiagnosi e la classificazione delle malattie mentali (Moreau deTours, 1845). Questa prospettiva si concretizzò nello sviluppo diun linguaggio descrittivo aperto e attento alla dimensioneintrospettiva e al tentativo di derivarne approcci terapeuticiconsequenziali (Danzinger, 1980; Lyons, 1986; Berrios, Markova,2004). E’ questo il preludio alla rivoluzione concettualedeterminata dall’ingresso nella psichiatria dell’epoca, diimpostazione sostanzialmente naturalistica, di concetti quali il“comprendere” (“Verstehen”, pertinente alle “scienze dellospirito”), contrapposto allo “spiegare” (“Erklaeren”, pertinentealle “scienze della natura”), di “esperienza vissuta” (Erlebnis) e inseguito di “intenzionalità” e di “autocoscienza”. Le opere diWilhelm Dilthey (1833-1911), di Franz Brentano (1838-1917) esuccessivamente di Edmund Husserl (1859-1938) saranno ilriferimento filosofico principale di tale cambiamento di paradigmae costituiranno il fondamento della psichiatria fenomenologica.Secondo Dilthey (1894) "noi spieghiamo la natura, mentrecomprendiamo la vita psichica”. In tal senso i fenomeni psichicivanno compresi dall'interno, poichè "noi li possiamo riprodurre,fino a un certo punto, in noi, in base all'osservazione dei nostri
stessi stati" e possiamo giungere a una conoscenza di baseintuendo i singoli eventi rappresentati con il concorso dellanostra esperienza vissuta. E’ con Brentano e Husserl che ilconcetto di Erlebnis si definisce sempre più chiaramente all’internodi una dimensione della coscienza necessariamente orientata insenso “intenzionale”, ovvero sempre diretta verso un oggetto eavente sempre un contenuto, finendo per costituire lacaratteristica principale dei fenomeni psichici, differenziati suquesta base dai fenomeni fisici. Secondo tale prospettiva divieneimpossibile indagare oggettivamente la realtà psicologica al difuori della relazione che questa intrattiene con il soggetto cheesperisce. I fenomeni psichici possono pertanto essere coltisolamente attraverso l'indagine sull'esperienza interna immediata,attraverso il metodo fenomenologico. Innegabile è stata laportata radicalmente trasformativa sulla psichiatria di talipresupposti filosofici, in particolare per quanto riguarda ilpassaggio da uno sguardo distaccato, prettamente naturalistico,sul comportamento/sintomo, che non contempla alcun coinvolgimentosul piano relazionale, ad una dimensione di ”incontro”, ovvero ad“una lettura basata sulle sinergie di emozioni e pensieri, ecollegata alle relazioni intersoggettive” (Ferro, 2010). Scriveancora Ferro: “Le riflessioni di Brentano e Husserl, il definirsidel concetto di Erlebnis e il suo passaggio dal campo del pensierofilosofico alla psicopatologia ha significato, soprattutto apartire dall’orizzonte del 1910, un cambiamento d’ottica radicalenello statuto della clinica… Nella complessità di questi momentidi ‘comprensione’ (Jaspers), di ‘intuizione’ (Minkowski nella sciadi Bergson), di ‘immedesimazione (Gruhle), si sono delineate leanalisi degli studiosi ispirati dalla fenomenologia”. Parallelamente il nascente movimento psicoanalitico si confrontavadirettamente con i vissuti dei pazienti (Ellenberger, 1970),indagandone il senso profondo e le dinamiche, sviluppando ilconcetto di “transfert” e integrando “comprensione” e“interpretazione” (Ferro, 2010). Freud a più riprese indagò escrisse in merito alle psicosi, seppure non ritenesse i pazientipsicotici idonei al trattamento analitico, in quanto incapaci, asuo modo di vedere, di sviluppare un rapporto di transfert su cuilavorare analiticamente. Il convincimento della non trattabilitàanalitica delle psicosi fu poi messo sempre più in discussione,seppur con gli opportuni adattamenti dei parametri tecniciutilizzati con le nevrosi, da numerosi analisti su posizionivariamente eterodosse rispetto al fondatore della psicoanalisi,tra cui C.G. Jung, K. Abraham, M. Klein, P. Federn, fino agli
sviluppi più recenti di H.S. Sullivan, F. Fromm-Reichmann, H.Searles, W.R. Bion, H. Rosenfeld, P.-C. Racamier e molti altri(Berti Ceroni, Correale, 1999).La dimensione soggettiva data dall’esperienza vissuta del paziente(e dal conseguente “urto” su quella del terapeuta) si èprogressivamente conquistata un posto di primo piano nella clinicae costituisce il fondamento della psicopatologia, come avvaloratodalle parole di Karl Jaspers (1913): “L’autoosservazione deipazienti è una delle più importanti fonti di conoscenza riguardoalla vita psichica morbosa; quindi è tramite la loro attenzionealla loro esperienza anormale e alla loro elaborazione diosservazioni nella forma di un giudizio psicologico che loropossono comunicare a noi qualche cosa della loro vita interiore”.Come scrivono Stanghellini e Rossi Monti (2009), “i fenomenipsichici abnormi ai quali la psicopatologia di ascendenzajaspersiana attribuisce particolare valore sono le esperienze deipazienti, ciò che è immediatamente rinvenibile nel loro campo dicoscienza, reso accessibile dalle autodescrizioni dei pazientistessi”. Con questa dimensione fenomenica lo psicopatologo siconfronta attraverso un approccio basato sulla comprensione“intesa come riattualizzazione delle esperienze del paziente permezzo dell’empatia” e orientato “a cogliere e individuare ifenomeni mentali soggettivi per ordinarli secondo categoriesemantiche, nell’ambito di un progetto più ampio inteso a faredella psicopatologia il linguaggio comune della salute mentale”(Stanghellini, Rossi Monti, ibidem). E’ su questi aspetti che sifonda il modello di psicopatologia generale di Jaspers: l’individuazionedelle configurazioni principali (ad es. il delirio, leallucinazioni, l’esperienza depressiva, ecc.) e dei principigenerali dell’accadere psichico patologico senza direttecorrelazioni diagnostico/nosografiche. Si tratta di indagare edesplicitare il come e il perché di tali fenomeni, analogamente acome la patologia generale si occupa dei meccanismi generali con iquali si manifestano e si producono i vari quadri morbosidell’organismo (ad es. la febbre, l’infiammazione, ecc.). Sarà poiKurt Schneider (1950) attraverso il suo progetto di psicopatologiaclinica a tentare di correlare direttamente la psicopatologiajaspersiana alla nosografia descrittiva. Schneider si propone diarrivare alla diagnosi clinica attraverso l’identificazione deisintomi patognomonici delle diverse entità morbose, intesi perònon come sintomi dell’espressione, del comportamento, così come liosservava e oggettivava la psichiatria clinica tradizionale, macome specifiche configurazioni delle esperienze soggettive, dei
vissuti dei pazienti, con particolare riferimento alle loro“qualità formali”, più che al contenuto. La psicopatologia clinicadi Schneider costituirà poi il riferimento principale per laelaborazione da parte dell’American Psychiatric Association del “Manualediagnostico e statistico dei disturbi mentali” (DSM). Va altresìricordato un considerevole limite storico ed epistemologico dellapsicopatologia di matrice jaspersiana, condiviso da Schneider,costituito dalla presupposizione che, pur avendo l’esperienzavissuta una posizione di centralità nella descrizionepsicopatologica, dal punto di vista della “comprensibilità” leesperienze schizofreniche si collochino nel campodell’”incomprensibile”. Dichiarata e netta è la contrapposizionecon le posizioni antropoanalitiche di Binswanger e con l’approcciopsicoanalitico nel suo insieme (Rossi Monti, Stanghellini, 1999).Ad ampliare la visione prospettica in termini di complessità edinamicità del “comprendere” psicopatologico contribuiranno altrimodelli, quali quello del “delirio di rapporto sensitivo”,descritto da Ernst Kretschmer (1918). Secondo questo modello, apartire da un dato assetto temperamentale, che oggi definiremmocome vulnerabilità di origine biologica, attraverso l’interazionecon fattori personologici, ambientali e life-events specifici, siattua uno sviluppo di personalità “comprensibile” che conduce aldelirio. Si profilano in questo modo i lineamenti di una“psicopatologia dinamica”, che, come scrivono Stanghellini e RossiMonti (2009) “si è venuta declinando in modelli cosiddetti‘dialettici’ secondo i quali sintomi, sindromi e decorsipsicopatologici originano dall’interazione tra due componenti:vulnerabilità e persona”. Sono queste le premesse del modellovulnerabilità-stress (Zubin, Spring, 1977) e di quello che oggi èdefinito paradigma bio-psico-sociale. Lo schema delineato nellatabella 1 riassume alcuni tra i principali modelli dellaschizofrenia, che storicamente si sono succeduti, basati in modopiù o meno esplicito su una tale concezione dinamico/dialettica.
Tabella 1: I principali modelli dialettici della schizofrenia (Stanghellini,Rossi Monti, 2009)
Autore Modello
Bleuler (1911) Sintomi primari + Reazione psicologicaMinkowski (1927) Fattore schizofrenico evolutivo + Personalità
schizoideWyrsch (1949) Processo schizofrenico + Presa di posizione
della persona
Janzarik (1959) Dinamica irruttiva + Intenzionalitàstabilizzatrice
Gross, Huber (1983) Sintomi-base + Coping psico-reattivoMundt (1985) Rottura dell’intenzionalità + Riparazione
dell’intenzionalitàStrauss (1989) Malattia primaria + Coping
L’estrema attenzione alle esperienze soggettive ed alle lorotrasformazioni nel corso di una psicosi schizofrenica è alla basedi tutti gli studi sulle cosiddette “sequenze di transizione”, dicui il volume di Karl Conrad, "Die beginnende Schizophrenie" del 1958,costituisce il punto di partenza e di riferimento. Conrad delineaun processo caratterizzato da alcune fasi (da non considerare comepassaggi obbligati, ma come un percorso-tipo, di valoreprimariamente euristico). Tali fasi sono costituite in un primomomento dal “Trema” (paura), fase prodromica in cui il soggettosperimenta uno stato di limitazione della propria libertà, disinistra inquietudine e angoscia, di tensione e oppressione, distato di allarme. Il soggetto si trova sempre più immerso nellacosiddetta “Wahnstimmung” (“stato d’animo” o “atmosfera”delirante), dove ha la sensazione che qualcosa di terribile, maancora indecifrabile stia per accadere, un cambiamento minacciosoe incombente, dove prevale l’impressione dell’estraneità, l’attesadensa di angoscia, la perplessità. Si attua una destrutturazionedel campo percettivo, che comporta la fine di ogni sicurezza. Siaccede quindi alla fase dell’”apofania” (rivelazione), ovverol’abnorme attribuzione di significato in chiave di auto-riferimento delirante agli eventi percepiti. Si altera ilrapporto tra figura e sfondo, poichè quest’ultimo ha perso la suadimensione abituale di neutralità e irrompe continuamente nellacoscienza del soggetto: nulla è più indifferente, “nuovisignificati (sino allora soltanto presentiti) si disvelano”(Maggini, 2010), tutto assume un ”carattere estraneo, sinistro,enigmatico, in un incubo di incantesimo maligno, in un’atmosferada venerdì santo” (Callieri, 1982). La fase dell’apofania èstrettamente correlata alla fase dell’”anastrofè” (capovolgimento),che corrisponde al vissuto di essere al centro del mondo, definitodalla scuola francese “centralité” (Grivois, 2002). Tutto ruotaintorno al soggetto, che ha perduto la capacità di cambiare, aseconda delle necessità e delle situazioni, sistema di riferimentoe prospettiva. Non gli è più possibile vedersi dall’interno comefonte della propria percezione o giudizio, e contemporaneamente
sentirsi parte di un mondo umano condiviso. Le osservazioni diConrad hanno aperto la strada ai modelli di sequenze ditransizione sviluppati dalla scuola di Bonn (Gross, Huber, 1983;Gross et al. 1987; Huber, Gross, 1995) e successivamente diColonia (Klosterkötter, 1999) ed in particolare allo studio dellatransizione dai cosiddetti “sintomi di base” ai sintomi psicoticiconclamati. E’ facilmente riscontrabile negli studi longitudinalisul decorso della schizofrenia che i soggetti non presentanocostantemente sintomatologia psicotica florida, ma sintomiaspecifici che in particolari condizioni (ad esempio di stressemotivo) si intensificano e si trasformano in sintomi psicoticiconclamati. Si tratta di “disturbi soggettivi, elementari easpecifici della spinta, delle emozioni, della percezione, delpensiero, del linguaggio, della propriocettività e dellapianificazione delle attività, che ricorrono nella faseprepsicotica, negli episodi psicotici e negli stati residui”(Maggini, 2010). Da sottolineare come il presupposto sia sempre ilfocus sull’esperienza soggettiva, più che sul comportamento. E’stata descritta anche in questo caso una progressione in tre fasi,definite “irritazione”, “esternalizzazione” e “concretizzazione”.A partire da queste osservazioni sono state elaborate alcune scaledi valutazione dei sintomi di base (BSABS, FBF, SPI-A) e prodottenumerose ricerche (Klosterkötter, 1999).Un altro importante filone di ricerca psicopatologica, che sipropone di integrare acquisizioni neurobiologiche, psichiatriafenomenologica e scienze cognitive, è quello relativo ai disturbidella “coscienza di sé” (autocoscienza) nella schizofrenia(Lysaker P.H., Lysaker J.T., 2010; Zahavi, 2005). Come scriveStanghellini (2010), “la coscienza del proprio Sé è queldispositivo fondamentale che fa di noi ciò che sentiamo di essere:titolari dei nostri stati mentali, vissuti come propri (‘meità’) einiziati da noi (attività), dotati inoltre dei caratteridell’unitarietà, della continuità nel tempo e della demarcazionerispetto al mondo esterno”. Anne Rau, la paziente affetta daschizofrenia che ha ispirato il testo più importante di WolfgangBlankenburg (1971), così si esprimeva:
“Che cosa mi manca davvero? Qualche cosa di Piccolo, di strano, qualchecosa di Importante, di indispensabile per vivere. A casa, da mia madre,umanamente non c’ero. Non ero all’altezza. Mi limitavo a stare lì, stavosemplicemente in quel posto, ma senza essere presente… Ho bisogno diappoggio nelle cose quotidiane più elementari. Sono ancora troppopiccola, piccola nel modo di pensare. Non ci riesco da me. Senza dubbiomi manca l’evidenza naturale”
A partire da quella che Minkowski (1927, 1966) definiva “perditadel contatto vitale con la realtà” correlata al concetto di“autismo schizofrenico”, per arrivare alla “perdita dell’evidenzanaturale” di Blankenburg, si è delineato un modello che individuacome disturbo basale della schizofrenia un disturbo dellacoscienza di sé pre-riflessiva (Sass, Parnas, 2003; Parnas, 2000,2010, Parnas et al., 2002). Tale disturbo basale dell’”ipseità”andrebbe a provocare distorsioni complementari dell’attodell’auto-consapevolezza: l’iper-riflessività, che comporta unadimensione esasperata di auto-coscienza della propria interioritàesperita come fosse un oggetto esterno, e la diminuita “auto-presenza”, nel senso di un indebolito senso dell’esistenza comefonte vitale e personale di consapevolezza e di azione (Sass,Parnas, 2003). Tali “forme generali di infrastruttureesperienziali” si articolerebbero in processi a lungo termine ditransizioni evolutive, con modalità spesso psicologicamentecomprensibili. In tal senso, pertanto, l’emergenza, laprogressione o la trasformazione dei sintomi schizofrenici nondevono essere considerate esclusivamente come contingenti, casualiirruzioni nella coscienza di manifestazioni "primarie" provenientida un “substrato” biologico malfunzionante, ma come una“riorganizzazione della coscienza secondo schemi e traiettorie disviluppo incanalate attraverso specifiche trasformazioni dell’ipseità e dell'atto della consapevolezza” (Sass, Parnas, 2003).
Psicopatologia, soggettività e insight
Assai controverso è il rapporto fra psicopatologia, soggettività einsight, termine generalmente correlato al problema della maggiore ominore consapevolezza di malattia. Il primo uso clinico deltermine “carenza di insight” risale a R. Krafft-Ebing, che cosìscriveva nel 1893: “Negli stadi più avanzati dell’alienazionementale, dove si verificano sistematiche idee deliranti o unadisgregazione intellettiva, il paziente è completamente privo diinsight rispetto al suo stato di malattia”. Tale definizione verràvariamente messa in discussione dai ricercatori successivi, senzache si sia tuttora giunti ad una piena convergenza, datasoprattutto l’eterogeneità delle concezioni relative al fenomenoinsight. Tra i principali riferimenti storici sul concetto di insightresta la definizione di A. Lewis (1934): “In qualsiasi patologiamentale, che sia modesta oppure grave, permanente o breve, che siaincomprensibile o comprensibile, il paziente osserva il proprio
stato o i propri sintomi individuali attraverso la sua interamente disturbata e in questa patologia ci sono disturbi diversiper grado, combinazione o genere dalla funzione sana”. A sua voltaJaspers (1913) distinse tra consapevolezza di malattia(Krankheitsbewusstsein) ovvero l’esperienza di sentirsi malati ocambiati e insight vero e proprio (Krankheitseinsicht) ovvero la capacitàdi fare una stima corretta del tipo e della gravità dellamalattia. Il concetto era e permaneva sfuggente, difficilmenteinterpretabile in modo univoco e di fatto il termine cadde indisuso “fino a quando l’avvento degli psicofarmaci non lo hariportato alla ribalta, nell’ipotesi di una correlazione tral’assenza di consapevolezza di malattia e la non-compliance aitrattamenti” (Pini, 2010). Si è delineato quindi un concetto di insight che comprende laconsapevolezza del soggetto di stare sperimentando esperienzesensoriali, pensieri ed emozioni di natura patologica, che talisintomi siano correlati ad uno stato di malattia mentale, chequesta malattia comporti una serie di conseguenze e che vi sia lanecessità di un trattamento specifico (Amador et al., 1991). Inquesta cornice, a partire dalla fine degli anni ’80 del secoloscorso sono state elaborate diverse definizioni, scale divalutazione (ad es. ITAQ, SUMD, SAI-E, IS) e modelliinterpretativi del fenomeno “insight”, che possono essere cosìschematicamente riassunti (Corbelli, 2009): un modello clinico,che considera la mancanza di insight un sintomo primario in sensobleuleriano, cioè che origina direttamente dal processopsicopatologico; un modello neuropsicologico, che considera lacarenza di insight una forma di anosognosia/agnosia autonoeticaderivante da alterazioni di specifiche aree cerebrali (cortecciadorsolaterale prefrontale e orbitofrontale, parietale e delle loroassociazioni corticali e delle vie neurali subcorticali) estrettamente correlata a deficit neurocognitivi; un modellodifensivo o psicologico che vede nella mancanza di insight ilprodotto di meccanismi di difesa (diniego), di strategie di copingdi rigetto dell’etichetta di malato inguaribile o di stilicognitivi tendenti all’ipertrofica considerazione di sé. Insight ediniego sarebbero in questo ultimo modello contesto-dipendenti,in relazione alla storia personale e al contesto familiare,sociale, culturale. I principali ricercatori si orientano oggiverso modelli multifattoriali e multidimensionali dell’insight, atutt’oggi non correlati linearmente con la psicopatologia. Si fastrada la convinzione che piuttosto che scegliere tra la carenzadi insight come deficit neuropsicologico o come guidata da meccanismi
psicologici di difesa e da strategie di coping, potrebbe esserepiù utile considerare che esistano due distinti gruppi di pazienticon carenza di insight: quelli con disfunzioni al lobo frontale equelli con una strategia di comportamento evitante, dove i primitendono a presentare quadri clinici più gravi, inconsapevolezzapiù marcata e persistente e altri deficit neurocognitiviassociati, in particolare delle funzioni esecutive (Startup, 1996;Lysaker et al, 2003; Amador et al, 2004), mentre i secondi, seppurcon funzioni neurocognitive non compromesse, tendono a nonaccettare e quindi a negare la realtà spiacevole della malattia(Lysaker, Bell, 2004). Viene altresì sottolineato come laconsapevolezza di qualsiasi tipo di malattia non possa essereconsiderata esclusivamente come un singolo fattore cognitivo, macome una sottocategoria della conoscenza di sé (Markova, Berrios,1992, 1995) e in generale come un elemento di una più grandecomprensione personale e narrativa della propria vita (Kleinmann,1988; Kirmeyer, Corin, 1998; Lysaker et al, 2003). Gliorientamenti di ricerca attuali (Lincoln et al., 2007; Quee etal., 2011; Lysaker et al, 2011) evidenziano che nelle personeaffette da schizofrenia il deficit di insight non è uniforme nellediverse fasi della malattia e nelle diverse configurazioni disintomi e di compromissioni neurocognitive e metacognitive, e chevi sono sempre più evidenze contro il modello di un “awarenessmodule” unitario e onnicomprensivo a favore di una “multipleawareness”: “awareness is multiply fractionated and multiply determinated” (Gilleenet al, 2011). La consapevolezza relativa a ciascuna componente(consapevolezza delle esperienze/sintomi, correlazione di questead una malattia mentale e accettazione della terapia) èindipendente e modulata da fattori diversi rispetto alle altre,con variabili correlazioni con il decorso e l’outcome. Sia laricerca che la prassi quotidiana ci presentano situazioni dove, adesempio, la accettazione dell’etichetta diagnostica non correlanecessariamente con una adeguata aderenza e viceversa, così comelo stesso riconoscimento del bisogno di trattamento non semprecorrela positivamente con l’aderenza effettiva, chiamandoverosimilmente in causa, oltre ai fattori individuali, fattorifamiliari, sociali, culturali e contesto-specifici qualil’alleanza terapeutica (Morgan, David, 2011). Vi sono inoltreevidenze a favore di significative correlazioni variamenteinterdipendenti (ma senza chiarezza sui rapporti di causalità) frale diverse componenti dell’insight, la sintomatologia, alcuni deficitneurocognitivi e deficit delle funzioni afferenti allametacognizione/mentalizzazione/social cognition/theory of mind (Lysaker,
2011, Lysaker et al., 2011; Quee et al., 2011; Gilleen et al.,2011). Da queste acquisizioni derivano importanti suggerimenti sulpiano terapeutico-riabilitativo, ad esempio l’utilità diinterventi sequenziali che consentano di lavorare su targetdifferenziati. Molte persone con carenza di insight possono averbisogno di sviluppare un certo grado di consapevolezza sui propripensieri ed emozioni (self-reflection) e su quelli altrui, prima didivenire consapevoli dei propri sintomi e comportamenti edimparare poi ad utilizzare la conoscenza acquisita per far frontein modo più funzionale ai propri problemi. Come scrivono Lysaker eDimaggio (2011), “per pensare in modo sensato ai propri statimentali è richiesto il senso di proprietà dei pensieri e il sensodi agency, l’abilità di nominare o essere consapevole dei propristati emotivi, l’abilità di distinguere tra pensieri più vicinialla fantasia e altri più aderenti alla realtà e infine l’abilitàdi integrare in modo coerente aspetti diversi dellarappresentazione di sé con gli altri”. In tal senso anche iprogrammi psicoeducativi orientati a favorire la conoscenza deisintomi e dei farmaci e l’aderenza alla terapia andrebberointegrati e modulati con interventi di terapia cognitivo-comportamentale e interventi riabilitativi psicosociali adorientamento metacognitivo o basati sulle “personal narratives” (Lysaker,Buck, 2011; Hasson-Ohayon et al., 2011), a cui accenneremo inseguito.
Ma esistono correlazioni forti fra insight e prognosi nellaschizofrenia? Il problema è assai controverso e la letteratura nonè univoca in merito (Lysaker et al, 2009). Posizioni contrastantiemergono sul rapporto tra insight e insorgenza di depressione(Carroll et al., 1999; Moore et al., 1999; Iqbal et al, 2000) etra insight e suicidio (Schwartz et al., 1997; Schwartz, 2001;Amador et al. 1996). Alcuni autori sostengono che nei pazienti chevanno incontro ad un recupero sia rintracciabile un continuum digradi di accettazione della malattia dal rigetto all’integrazione(McGlashan et al., 1975). Altri sottolineano come il diniegodella malattia potrebbe essere motivato dal rifiuto di accettarelo stigmatizzante ruolo sociale associato alla malattia mentalecronica e potrebbe riflettere il desiderio di alcuni pazienti dipreservare l’autonomia personale e la dignità che l’accettazionedell’etichetta di malattia mentale potrebbe compromettere (Link,1987; Warner et al., 1989). Pragmaticamente A.S. David (1990)afferma che in questi casi un livello di “insight di compromesso”,sufficiente a favorire l’accettazione di un trattamento, ma non
tale da indurre il soggetto a soffermarsi costantemente sullagravità della propria malattia, potrebbe essere più adattivo.Analogamente altri autori (Lincoln et al., 2007) propongono ilconcetto di “insight utilizzabile” (usable insight), che consenta di nonidentificare la malattia con l’identità e preservi la speranza.Non è ancora chiaramente dimostrato che l'insight “di per sé” sia unfattore prognostico positivo secondo una relazione di causalitàlineare tra maggiori livelli di insight ed esito più favorevole,mentre appare più consistente il dato che influisca sullacompliance/aderenza”(Lincoln et al., 2007; Lysaker et al, 2009). Viè tuttora la necessità di disegni di ricerca rigorosi chedefiniscano meglio l’oggetto di studio e misurino e correlino ifattori dei diversi domini. E’ evidentemente necessario cercare di correlare le variabili diinsight ed esito con altre variabili, come viene proposto, ad esempioin un importante studio (Lysaker, Roe, Yanos, 2007) dove, su 75soggetti affetti da schizofrenia, sono stati messi incorrelazione stigma interno, ovvero l’accettazione supinadell’etichetta di malato cronico, insight nel senso di accettazionedella propria malattia, speranza e autostima, adattamento allamalattia e funzionamento sociale. La combinazione più favorevoledi fattori, ovvero quella che correlava con il migliorfunzionamento sociale era costituita da: rigetto dello stigma,accettazione della malattia, alta speranza/autostima, miglioradattamento alla malattia. Si traducevano invece in un peggiorfunzionamento sociale sia il cluster caratterizzato da stigmainterno, accettazione di malattia, bassa speranza/autostima epeggior adattamento alla malattia, che quello caratterizzato dastigma interno, rifiuto della malattia, alta speranza/autostima,peggior adattamento alla malattia. In accordo con altri studi(Hasson-Ohayon et al., 2006; Kravetz et al., 2000; Moore et al.,1999), gli autori concludono che l’insight tradizionalmente intesocome accettazione dell’etichetta di malattia non sia sempre ecomunque desiderabile per le persone affette da schizofrenia, senon è accompagnato dal rigetto dello stigma interno e dallosviluppo di speranza, autostima e autoefficacia, e proprio asviluppare tali aspetti dovrebbero essere orientati interventiterapeutico-riabilitativi specifici (Warner, 1994).Di fronte all’apparente contraddizione tra una posizione che vedel’insight come una precondizione per l’aderenza alla terapia e per ilprocesso di recovery ed un’altra che ne sottolinea gli aspetti cheinducono depressione e favoriscono lo stigma interno, si delineapertanto una terza prospettiva, quella di una “narrative view of insight”
(Lysaker et al, 2009), che mette in luce la distinzione tra insight“narrativo” e “descrittivo” (Roe et al., 2008). In questa ottical’”insight narrativo” va considerato non come l’accettazione pura esemplice di fatti dati per oggettivi e di etichette che lidefiniscono, ma un processo individuale di attribuzione di sensoin cui la narrazione personale delle proprie esperienze e delleconseguenze che ne derivano viene collegata alla malattia. Gliautori sottolineano altresì che per essere adattiva questanarrazione personale deve essere trasmissibile, comprensibile econdivisibile con gli altri, deve favorire il rigetto dello stigmae degli stereotipi correlati alla malattia mentale ed in talidirezioni devono pertanto essere orientati gli interventiterapeutico-riabilitativi atti a promuoverla. Significativa è lacorrelazione tra i benefici percepiti relativi ai trattamentipsichiatrici ricevuti ed i significati attribuiti alla malattia edai trattamenti stessi, così come la necessità di ritrasformare ilvissuto di sé da quello di “paziente psichiatrico” in quello di“persona” (Roe, 2001; Roe, Kravetz, 2003; Roe, Davidson, 2005). Laqualità della vita ed il senso di benessere di una personasofferente di un disturbo (non necessariamente psichiatrico) concaratteristiche di ricorrenza o cronicità sono funzione del gradoin cui il soggetto riesce a bilanciare l’impatto dei sintomi edelle loro conseguenze con il senso di coerenza della suanarrativa personale/biografia e le concezioni sulla natura dellasua identità (Lysaker, Roe, Yanos, 2007; Albrecht et al., 1999;Lambert et al., 1997). A conclusione di queste controverse note sull’insight riteniamoparticolarmente significative le considerazioni su questo tema diF.J. Frese III, che ha vissuto in prima persona (essendogli statadiagnosticata una sindrome schizofrenica quando da giovaneprestava servizio nel Corpo dei Marine) tali lacerantiproblematiche, che ha saputo tradurre in testimonianza e impegnoconcreto, personale e professionale. Frese ha dapprima acquisitoun dottorato in psicologia presso la Ohio University, divenendopoi direttore della Sezione di Psicologia presso il WesternReserve Psychiatric Hospital, poi professore associato dipsicologia presso il Northeastern Ohio Universities College ofMedicine e successivamente, fra le altre cariche, coordinatoredel Summit County Recovery Project. Assieme a Patricia Deegan,Daniel Fisher e molti altri esperti (tra utenti, professionisti eprofessionisti/utenti), è stato uno degli estensori del documento“National consensus statement on mental health” (SAMHSA, 2008) elaborato nel2004 nell’ambito della consensus conference promossa
dall’organizzazione governativa statunitense “Substance Abuse andMental Health Services Administration”. Frese incarna ilparadosso tipico dell’ “American way of life”, per cui a fronte di unconsistente numero di homeless affetti da disturbi psichiatricigravi e privi di assistenza adeguata, si possono avere direttoridi dipartimento dichiaratamente affetti da schizofrenia, che fannodella loro esperienza come (ex)utenti un punto di forza especificità nella loro carriera di professionisti, formatori,dirigenti. Scrive Frese (2004):
“L’insight non è necessariamente correlato a come gli altri vedono la tua condizione, perché glialtri spesso non sono nemmeno d’accordo tra loro rispetto ai propri punti di vista. In secondoluogo l’insight comporta più di una accettazione di avere una condizione che gli altri consideranouna malattia mentale. L’insight comporta anche lo sviluppo di una comprensione del modo in cuiuna simile condizione ti affligge e con buone speranze l’imparare come vivere meglio con una talecondizione. In terzo luogo sono giunto a comprendere che ho una condizione con cui devocostantemente imparare a convivere. Mi sento molto a mio agio nel considerare ciò come causatoda uno stato neurologico del cervello da cui i miei pensieri, sentimenti e percezioni tendono aessere affetti. Tuttavia (…) non significa che necessariamente ritenga che questo sia l’unico modoin cui tutti possono sviluppare insight. Altre persone possono avere interpretazioni più filosofiche,mistiche e persino religiose della loro esperienza”. Soggettività e recovery Dal punto di vista delle politiche sanitarie, a porsi il problemadi valutare su larga scala una serie di fattori inerenti lasoggettività degli utenti dei servizi psichiatrici e sanitari ingenerale sono stati per primi i paesi anglosassoni, dove lagestione della salute è già da tempo strettamente vincolata dacriteri di efficienza e la valutazione standardizzata dei processie degli esiti, compresi quelli di tipo soggettivo, è parteintegrante dell’organizzazione dei servizi e della praticaclinica. Si tratta comunque di storia recente. Infatti i primistudi sulla qualità della vita in psichiatria (Lehman et al.,1982, 1986; Baker & Intagliata, 1982; Shadish et al., 1985) sonostati realizzati all’inizio degli anni ‘80 del novecento negliStati Uniti con l’obiettivo di valutare l’impatto sulla vita deipazienti psicotici cronici di alcuni programmi volti alla lorodimissione dagli ospedali psichiatrici statali e alla successivaricollocazione nell’ambito del contesto comunitario (Lasalvia,Ruggeri, 2003). Le prime ricerche sui bisogni di cura inpsichiatria sono stati effettuate alla fine degli anni ‘80 e neiprimi anni ‘90 in Gran Bretagna (Brewin et al., 1987, 1988, 1993;Phelan et al. 1995). Infine i primi studi sulla soddisfazione
degli utenti nei confronti del trattamento in psichiatriarisalgono alla fine degli anni ‘70 negli Stati Uniti e GranBretagna (Ware et al., 1976; Larsen et al., 1979; Love et al.,1979).Nel capitolo precedente, trattando di insight, sono comparsi alcunielementi decisamente in secondo piano finchè si metteva inrelazione la soggettività soltanto con la psicopatologia:speranza, aspettative, autostima, autoefficacia, consapevolezza,autonomia personale, dignità. Il focus si è di fattoprogressivamente spostato dalla “malattia” alla “persona” e aisuoi valori, bisogni, desideri, aspettative, opinioni,responsabilità e diritti. Storicamente l’emergere in primo pianodi questi aspetti appartenenti alla “prospettiva dell’utente”(cfr. Rivista Sperimentale di Freniatria n. 2, 2007) risale aglianni ’70 del secolo scorso, in seguito alla messa in discussionedelle istituzioni e delle prassi psichiatriche tradizionali edalla nascita dei movimenti di deistituzionalizzazione . Neipaesi anglosassoni ed in particolare negli Stati Uniti si èassistito, sull’onda delle lotte per i diritti civili, al formarsidi una pluralità di associazioni di utenti, gruppi di advocacy egruppi di auto-mutuoaiuto (Bonner, Pellegrino, 2007; Frese et al,2009). Negli Stati Uniti la pubblicazione nel 1978 del libro “OnOur Own: Patient-controlled alternative to the mental system” di Judi Chamberlinha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere un atteggiamentoalternativo e rivendicativo rispetto ai propri diritti da partedegli utenti. Parallelamente anche in Europa si sono formatigruppi di utenti più o meno organizzati, variamente critici oostili nei confronti delle istituzioni psichiatriche, alcuni deiquali si sono federati nella European Network for (ex)Users and Survivors ofPsychiatry. In Italia i movimenti e le associazioni di utenti hannostentato a darsi una dimensione di autonomia, per vari motivilegati verosimilmente a differenze socio-culturali nel confrontocon le istituzioni e nell’approccio all’associazionismo, ma ancheperché, a differenza degli altri paesi, la “gestione” delmovimento di deistituzionalizzazione in Italia è stata fattapropria da una consistente parte della psichiatria stessa, di cuiFranco Basaglia è stato il maggiore esponente, e che ha portatoalla legge di riforma dell’assistenza psichiatrica del 1978 e apratiche alternative alla gestione asilare, come lo sviluppodell’impresa sociale (Bonner, Pellegrino, 2007). Riteniamo che,seppur partendo da presupposti scientifici, filosofici, ideologicie contesti socio-culturali assai diversi, vi siano importantipunti di contatto tra l’insegnamento basagliano del “mettere tra
parentesi” (che non vuol dire “negare”) la malattia per porre alcentro la persona, ricostruendo attraverso percorsi di inclusionesociale il “diritto di cittadinanza”, e quel mosaico di interventitransteoretici di origine anglosassone costituito dalla“riabilitazione psicosociale”. Orientata allo sviluppo delleabilità e del funzionamento sociale, la riabilitazionepsicosociale persegue il raggiungimento di mete significative perla persona (Lysaker P.H., Lysaker J.T., 2010), enfatizza aspettiquali la soddisfazione, il successo, la scelta, l’assunzione diresponsabilità, la presa di distanza dalla propria malattia, ilraggiungimento di un ruolo sociale valido e valorizza il supportofra pari, l’empowerment e il ruolo sempre più attivo degli utentinella gestione dei servizi stessi (Anthony et al., 2002). E’ statoa partire dalla fine degli anni ’80 che ha cominciato ad esseresempre più preso in considerazione, in antitesi con il modellodella “stabilizzazione” e del “mantenimento”, il paradigma delrecovery (recupero – ripresa - guarigione) dalla malattia mentalegrave (Carozza, 2006, 2010a, 2010b). Si è ben presto delineata una apparente doppia valenza di questoconcetto: esito e/o processo. Da un lato la prospettiva di esitodel recovery, di origine e pertinenza dell’ambito clinico e diricerca, deriva dagli ormai numerosi e consistenti studilongitudinali sugli esiti a lungo termine della schizofrenia, chedimostrano aldilà di ogni dubbio che di schizofrenia si può siaguarire pienamente sul piano clinico e funzionale (full recovery) cheraggiungere livelli di “guarigione parziale” (Carozza, 2010a).Guarigione parziale che si traduce nel vivere in modosoddisfacente e dignitoso, recuperando un ruolo sociale attivonella comunità, imparando a convivere con la disabilità, a gestiree ridurre al minimo l’impatto distruttivo della malattia sullapropria vita, a riguadagnare il controllo sulla malattia e sullapropria vita (Davidson, Strauss, 1992). Questo comporta lanecessità di sviluppare un modello multidimensionale (Anthony,2007) e criteri operativi (Liberman et al., 2002) per valutarel’esito in termini di recovery, che comprendano il funzionamentoemotivo, cognitivo, sociale e lavorativo, l’adattamentopsicosociale alla disabilità, lo stato soggettivo di benessere ela qualità della vita, il livello di gravità e persistenza dellasintomatologia, il ruolo sociale e l’integrazione nella comunità.Dall’altro lato emerge la prospettiva “in prima persona” degliutenti, da cui deriva una concezione di recovery inteso comeprocesso di sviluppo personale che dura tutta la vita, diverso dapersona a persona, non lineare, che si svolge in una dimensione di
continuum in antitesi alla dicotomia guarito/non guarito (Anthony,2007; Spaniol et al., 2002; Carozza, 2010a). Secondo la notadefinizione di Anthony (1993):
“il recovery è un processo unico, personale e profondo, in cui leattitudini, i valori, i sentimenti, gli obiettivi e i ruoli cambiano. E’un modo di vivere più soddisfacente e produttivo, in cui si recuperano leaspettative positive, a prescindere dalle limitazioni causate dallamalattia mentale. Il recovery implica lo sviluppo di nuovi propositi esignificati esistenziali, a mano a mano che la persona si evolve oltregli effetti catastrofici del disturbo psichiatrico”.
Ron Coleman (2001) ne mette altresì in risalto l’approcciocollettivo, dove l’appropriarsi dell’esperienza è “essenzialmenteun processo politico e liberatorio”. Il “peer-support” inquest’ottica va oltre la contingenza dell’auto-mutuoaiuto econsente la costruzione di “spazi negoziali” (Saraceno, 1995),ovvero processi di “identità condivisa, ‘costruita’ econtinuamente rinegoziata” (Barnes, Bowl, 2003), veicolo diempowerment. Naturalmente gli studi sugli aspetti di processo del recoveryafferiscono primariamente alla “ricerca qualitativa”, basata sulleanalisi dei racconti delle esperienze dei pazienti, e alla“ricerca partecipata”, dove gli utenti hanno un ruolo attivo anchenella costruzione del disegno di ricerca. Gli aspetti qualificantidella ricerca qualitativa sul recovery sono il far emergere laprospettiva in prima persona di chi ha vissuto l’esperienza diripresa/guarigione da un disturbo mentale grave, la propriapercezione dei fattori che sono stati utili al fine di unsuperamento, anche se parziale, della condizione di disabilità,la testimonianza delle modalità con cui la persona ha potutosuperare tale condizione. Particolare interesse rivestono glistudi sulle fasi dei processi di recovery. Abbiamo visto inprecedenza come la ricerca psicopatologica si sia concentratasoprattutto sulle “sequenze di entrata” nella psicosi. Radicale èil cambiamento di prospettiva: dal focus sull’ingresso nellamalattia, a quello sul recovery, sulla guarigione. Le sequenzeriportate hanno molti punti di contatto, come evidenzia la tabella2.
Tabella 2 Confronto tra le fasi di recovery in cinque studi (R. Andresen, P. Caputi, L. Oades, 2003)
Andresen, Caputi, Oades, 2003
Davidson, Strauss (1992)
Baxter, Diehl (1998) Young, Ensing (1999)
Pettie, Triolo (1999)
Spaniol et al. (2002)
Fase 1 1. Crisi Perché 1. Essere
Moratorium Recupero proprio a me?
sopraffattodalla disabilità
Fase 2Consapevolezza
1. Consapevolezza di un Sé più attivo
1. Avvio delpercorso di recovery
Significato della malattia
Fase 3Preparazione
2. Fare un bilancio di sé 3. Mettersi in
azione
2. Decisione Ricostruzione dell’indipendenza
E adesso? 2. Lottarecontro la disabilità
Fase 4Ricostruzione
4. Appellarsi alsé
3. Risveglio Ricostruzione dell’interdipendenza
2. Riconquistare e andare avanti
Ricostruire l’identità
3. Convivere con la disabilità
Fase 5Crescita
3. Migliorarela qualità della vita
4. Vivere oltre la disabilità
Anche in questo caso si tratta di processi-tipo, data la nonlinearità e variabilità individuale. In sintesi la persona sisente dapprima sopraffatta dai sintomi, dalla disabilità e dallemodalità con le quali viene affrontata dal sistema dei servizi.Successivamente comincia a lottare contro la condizione didisabilità e a ricostruire connessioni con sé, gli altri,l’ambiente e gli scopi della vita. Accetta poi di convivere con ladisabilità e comincia a valorizzare le connessioni che haristabilito con sé, gli altri, l’ambiente e i significatidell’esistenza. Infine il soggetto riesce ad andare oltre ladisabilità, superando il senso di subalternità derivante dallesue limitazioni. Conduce una vita più autentica, in connessionepositiva con il suo ambiente. Altro filone importante di indagine correlato al paradigma delrecovery è quello afferente alle cosiddette “narrative personali”,ovvero ad un modello derivato dalla psicologia dialogica e dallescienze cognitive che vede nell’esperienza del sé il risultato diun ”dialogo interno” di sfaccettature multiple, dalla cui coerenzanarrativa dipende la coesione del senso di sé (Lysaker P.H.,Lysaker J.T., 2010). Nella schizofrenia si produrrebbe unacompromissione di tale dialogo interno, con una perdita di“complessità narrativa”. Gli elementi-chiave messi in luce(Silverstein, Bellack, 2008) dagli studi sull’argomento sono:1) la schizofrenia è caratterizzata da una riduzione nel dialogointerno tra i diversi aspetti del sé (Lysaker, Hermans, 2007); 2) le narrative personali delle persone affette da schizofreniaappaiono spesso carenti nell’attibuzione del senso di auto-efficacia (Lysaker et al., 2003);
3) gli effetti della psicoterapia sembrano promuovere un aumentodi complessità e dinamismo nelle narrative interne, ma non lacreazione di narrazioni radicalmente nuove o il “risveglio” di un“vecchio” Sé (Lysaker, Lancaster, 2003); 4) Lo sviluppo delle narrative personali è associato con unaumento dei livelli di auto-stima e di disponibilità alcambiamento (Lysaker et al., 2006);5) narrative impoverite possono essere collegate, in parte, adeficit neurocognitivi e metacognitivi, rispetto ai quali èpossibile mettere in atto specifici interventi terapeutico-riabilitativi (Lysaker et al., 2005; Lysaker et al, 2007; Lysakeret al., 2008; Lysaker, Buck, 2011; Hasson-Ohayon et al., 2011).Sempre più numerosi sono anche gli studi che si interrogano suifattori facilitanti il processo di recovery. A titoloesemplificativo riportiamo la sintesi fatta a partire da alcunilavori (Silverstein, Bellack, 2008; Roe, 2001; Lysaker et al.2006): ruolo e significato del lavoro, aspettative e atteggiamentiverso i trattamenti, relazioni significative, auto-stima, auto-efficacia, locus of control (interno vs esterno), ottimismo appresoverso impotenza/disperazione appresa, speranza, empowerment,processi di trasformazione del Sé (ricostruzione di narrativepersonali orientate al recovery). Analogamente nel documento disintesi della già citata consensus conference SAMSHA (2008) sono statievidenziati i seguenti 10 elementi costitutivi dei processi direcovery: Auto-direzione, dimensione individualizzata e centratasulla persona, empowerment, dimensione olistica, non linearità, basesui punti di forza, peer-support, rispetto, responsabilità, speranza.La dimensione di approccio all’esperienza vissuta nei processi direcovery si arricchisce nella letteratura di innumerevolisfaccettature, che costituiscono la ricchezza ed il limite di talecampo di indagine e comportano margini di ambiguità e vaghezza(Silverstein, Bellack, 2008), così come un uso sempre più diffuso,aspecifico e “di moda” del termine recovery espone al consistenterischio di fare “retorica” più che ricerca (Slade, Hayward,2007). In tal senso va letto il richiamo di Silverstein eBellack (2008) a definire un insieme di programmi rigorosi diricerca sul recovery, che siano focalizzati sui seguenti quesiti: 1) Come sono correlati gli aspetti di esito e di processo relativi alrecovery, e in che misura queste correlazioni variano tra gli individui?2) Quali sono i disegni di ricerca più idonei per studiare il tipo dicambiamento a lungo termine implicito nel concetto di recovery orientatoal processo? 3) Come si avvia processo di recovery?
4) Si può accelerarne l’avvio?5) Come si svolge il processo?6) Ci sono tappe precise?7) Quali fattori contribuiscono al processo: quali eventi esterni /fattori interni lo favoriscono e quali lo ostacolano?8) In quali condizioni le riacutizzazioni dei sintomi si rivelanoostacoli alla possibilità di crescita?9) Qual è il ruolo dei supporti naturali, tra cui, ma non solo, lafamiglia?10) Qual è il rapporto tra il processo di recovery, le aspettative pre-morbose e quelle attuali?
ConclusioniRiteniamo, in conclusione, che l’integrazione delle due dimensionidi “esito” e di “processo”, “oggettiva” e “soggettiva”, “clinica”ed “esperienziale” dei percorsi di recovery sia un compitoessenziale della psichiatria dei prossimi decenni (Jacobson,Greenley, 2001; Carozza, 2010a). Del resto, come sottolineaBarbato (2011) la dicotomia esito-processo è più apparente chereale o quantomeno è il risultato di un equivoco semantico.Ogniqualvolta infatti che ci si confronta con un fenomeno che hauno svolgimento nel corso del tempo, non si può non valutarlo intermini processuali sul piano longitudinale ed in termini di esitosul piano trasversale. Un aspetto implica sempre l’altro. Piùproficuo (ma purtroppo ancora scarsamente messo in atto) sul pianodella ricerca è sicuramente il valutare i processi/esiti di undisturbo psichiatrico in un’ottica multiassiale, dove l’aspettobiomedico è misurabile attraverso indicatori neurobiologici (atutt’oggi di fatto non ancora chiaramente individuati), quelloclinico sulla base dei sintomi psicopatologici, quelloneuropsicologico sulla base delle funzioni cognitive, quellosociale attraverso un assessment delle funzioni lavoro, vitaautonoma, relazioni sociali, quello esperienziale attraverso ilbenessere soggettivo, la padronanza di sé, la qualità della vita,le narrazioni personali. Proprio questo aspetto, “in primapersona”, è stato sicuramente quello finora più trascurato dallaricerca e dalla prassi tradizionale psichiatrica ed è quello cheinvece il “movimento del recovery” ha posto in primo piano. Lavalorizzazione dell’esperienza “in prima persona” nell’otticarecovery-oriented ha consentito ai protagonisti di questo processo diautonomizzarsi dallo sguardo esclusivo e filtrante dellopsichiatra/psicopatologo e di spostare il focus dalla parte malatacentrata sul sintomo alla parte sana centrata sui valori, leaspettative, le scelte, la speranza, il ruolo sociale, la vita nel
suo insieme, dalle sequenze di transizione verso la malattia aquelle verso la guarigione. Abbiamo qui cercato di tracciare sommariamente un tragitto cheillustrasse il rapporto dialettico tra psicopatologia e clinica dauna parte e “prospettiva dell’utente” dall’altra. Siamo partiti daun discorso esclusivamente interno alla clinica e allapsicopatologia, passando da un approccio basato su un tipo dicomprensione naturalistica esclusivamente “in terza persona”(spiegazione/ricerca di rapporti causali) al tentativo dicostruire una comprensione “in prima persona” (approcciosoggettivo/empatico). Queste due dimensioni rimangono tuttoraineludibili nella costruzione delle narrative cliniche, ma ilcardine della relazione tra operatori della salute mentale eutenti non può che essere costituito da un approcciointersoggettivo “in seconda persona”, che consenta la costruzionedi “narrative condivise” (Stanghellini, Rossi Monti, 2009),presupposto di ogni approccio terapeutico-riabilitativo centratosulla persona.
Bibliografia ALBRECHT G.L., DEVLEIGER P.J. (1999) The disability paradox: high quality of
life against all odds. Soc Sci Med. 48:977-988.
AMADOR X.F, STRAUSS D.H., YALE S.A., GORMAN J.M. (1991) Awareness of illness in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, n. 17, pp. 113–132.
AMADOR X.F, A.S. DAVID (2004) (a cura di) Insight e Psicosi. Tr. It. Fioriti, Roma 2009
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2000) Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV-TR). Tr. it. Masson, Milano 2001.
ADRESEN R., CAPUTI P., OADES L. (2003), The experience of recovery from schizophrenia: towards an empirically validated stage model. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 37: 586-594.
ANTHONY W.A. (1993) Recovery from mental illness: the guiding vision of the mental health service system in the 1990’s. Psychosoc Rehabil J. 16: 11-23.
ANTHONY W.A., COHEN M., FARKAS M., GAGNE C. (2002) Riabilitazione psichiatrica. Tr. It. 2003. CIC Ed. Int., Roma.
ANTHONY W.A. (2007) Toward a vision of recovery. Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University.
BAKER F., INTAGLIATA J. (1982) Quality of life in the evaluation of community support system. Evaluation and Program Planning. 5: 69-79.
BARBATO A. (2011) Recovery from severe mental disorders. An introduction. Relazione introduttiva “International Conference on recovery”. Atti in press, Bolzano.
BARNES M., BOWL R. (2003), Empowerment e salute mentale. Erickson, Trento.
BAXTER E.A., DIEHL S. (1998) Emotional stages: consumers and family members, recovering form the trauma of mental illness. Psychiatry Rehabilitation Journal. 21:349-355.
BERRIOS G.E., MARKOVA I.S. (2004) L’Insight nella psicosi: storia di un concetto. In: X.F. AMADOR, A.S. DAVID (a cura di) Insight e Psicosi. Tr. It. Fioriti, Roma 2009.
BERTI CERONI G., CORREALE A. (1999), Psicoanalisi e psichiatria. Cortina, Milano.
BLANKENBURG W. (1971) La perdita dell’evidenza naturale. Un contributo allo studio delle schizofrenie paucisintomatiche. Tr. It. Cortina, Milano 1998.
BLEULER, E. (1911) Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie. Tr. it. Il Pensiero Scientifico, Roma 1985.
BONNER Y.D.B, PELLEGRINO R. (2007) Editoriale. In: La prospettiva dell’utente. L’inclusione come costruzione della persona. Rivista Sperimentale di Freniatria. Vol. CXXXI – n. 2.
BREWIN C.R., WING J.K., MANGEN S.P., BRUGHA T.S., MACCARTHY B. (1987) Principles and practice of measuring needs in the long-term mentallyill: the MRC Needs for Care Assessment. Psychological Medicine. 17: 971-981.
BREWIN C.R., WING J.K., MANGEN S.P., BRUGHA T.S., MACCARTHY B., LESAGE A. (1988) Needs for care among the long-term mentally ill: a report from the Camberwell High Contact Survey. Psychological Medicine. 18: 457-468.
BREWIN C.R., WING J.K. (1993) The MRC needs for care assessment: progress and controversy. Psychological Medicine. 23: 837-841.
CALLIERI B. (1982) Quando vince l’ombra, Roma, Editore Città Nuova.
CAROZZA P. (2006) Principi di riabilitazione psichiatrica. FrancoAngeli, Milano.CAROZZA P. (2010a) La guarigione dalla malattia mentale: esito o processo?
Psichiatria di Comunità. Vol. IX, n. 1.CAROZZA P. (2010b) La psichiatria di comunità tra scienza e soggettività. FrancoAngeli,
Milano.CARROLL A., FATTAH S., CLYDE Z., COFFEY I., OWENS D.G.C. and JOHNSTONE E.C.
(1999) Correlates of insight and insight change in schizophrenia. Schizophrenia Research. 35: 247-53.
CHAMBERLIN J. (1978) On Our Own: Patient-Controlled Alternatives to the Medical Health System. New York, NY: Hawthorn Books.
CHAMBERLIN J. (1984) Speaking for ourselves. An overwiew of the expsychiatric inmates movement. Psychosoc Rehabil J. 8:56-63.
COLEMAN R. (1999) Guarire dal male mentale Tr. It. Manifestolibri, Roma 2001. CONRAD, K. (1958) Die beginnend Schizophrenie. Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns.
Thieme, Stuttgart.CORBELLI L. (2009) Introduzione all’edizione italiana. In: X.F. AMADOR,
A.S. DAVID (a cura di) Insight e Psicosi. Fioriti, Roma 2009.DANZINGER K. (1980) The history of introspection reconsidered. Journal of the
History of the Behavioral Sciences. 16: 241-62.DAVID A.S. (1990) Insight and psychosis. British Journal of Psychiatry. 156: 798-
805.
DAVIDSON L., STRAUSS J.S. (1992) Sense of self in recovery from severe mental illness. British Journal of Medical Psychology. 65:131-145.
DEEGAN P.E. (1988) Recovery: the lived experience of rehabilitation. Psychosoc Rehabil J. 11:11-19.
DEEGAN P.E. (1990) Spirit breaking:when the helping professionals hurt. Human Psychol. 18:301-313.
DEEGAN P.E. (1992) The independent living movement and people with psychiatric disabilities: taking back control over our own lives. Psychosoc Rehabil J.15:3-19.
DEEGAN P.E. (1993) Recovering our sense of value after being labeled. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 31:7-11.
DEEGAN P.E. (2005) The importance of personal medicine: a qualitative study of resilience in people with psychiatric disabilities. Scand J Public Health. 66:29-35.
DEEGAN P.E. Drake RE. (2006) Shared-decision-making and medication management in the recovery process. Psychiatr Serv. 57:1636-1639.
DILTHEY W. (1894) Idee su una psicologia descrittiva e analitica in Gesammelte Schriften, a cura di B. Groethuysen, G. Misch, P. Ritter, H. Nohl e altri, Leipzig 1914.
ELLENBERGER H.F. (1970) La scoperta dell’inconscio. Storia della psichiatria dinamica. Tr. It. Boringhieri, Torino 1976.
FERRO F.M. (2010) Erlebnis (Vissuto). In: MAJ M., MAGGINI C., SIRACUSANO A. (a cura di) Lessico di Psicopatologia Il Pensiero Scientifico Ed., Roma 2010
FRESE F.J. III (1998) Advocacy, recovery, and the challenges of consumerism for schizofrenia. In: Buckley P, ed. Psychiatric Clinics of North America. Philadelphia, Pa: W.B. Saunders. 233-249.
FRESE F.J. III, STANLEY J, KRESS K, VOGEL-SCIBILIA S. (2001) Integrating evidence-based practices and the recovery model. Psychiatr Serv. 52;1462-1468.
FRESE F.J. III, (2004) Dentro l’”insight”: una prospettiva personale sull’insight nella psicosi. In X.F. AMADOR, A.S. DAVID (a cura di) Insight e Psicosi. Tr it. Fioriti, Roma 2009
FRESE F.J, KNIGHT L.E., SAKS E. (2009) Recovery from schizophrenia: with views of psychiatrist, psychologists, and others diagnosed with thisdisorder. Schizophrenia Bulletin . vol.35 no.2 pp 370-380.
GILLEEN J., GREENWOOD K., DAVID A.S. (2011) Domains of awareness in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin . vol.37 no.1 pp 61-72.
GROSS G., HUBER G. (1983) Psychopathology of basic stages in schizofrenia in view of formal thought disturbances. Psychopathology. 18: 115-119.
GROSS, G., HUBER, G., KLOSTERKÖTTER J. et al. (1987) BSABS Bonner Skala für die Beurteilung von Basissymptomen. Springer, Berlin.
HASSON-OHAYON I., KRAVETZ S., ROE D., WEISER M. (2006) Insight into severe mental illness, perceived control over the illness, and quality of life. Compr Psychiatry. 194(7):538-42.
HASSON-OHAYON I., KRAVETZ S., ROE D. (2011) Empatia e processi della teoria della mente. Il nucleo dialogico di un approccio metacognitivo alla riabilitazione psichiatrica. In: DIMAGGIO G., LYSAKER P.H. (a cura di) Metacognizione e psicopatologia. Valutazione e trattamento. Cortina, Milano.
IQBAL Z., BIRCHWOOD M., CHADWICK P. and TROWER P. (2000) Cognitive approach todepression and suicidal thinking in psychosis. 2. Testing the validity of a social ranking model. British Journal of Psychiatry. 177: 522-8.
JACOBSON N., GREENLEY D. (2001) What is recovery? A conceptual model and explication. Psychiatric Services. 52: 482-485.
JANZARIK, W. (1959) Dynamische Grundkonstellationen in Endogenen Psychosen. Springer, Berlin.
JASPERS, K. (1913 [1959]) Psicopatologia generale. Tr. it. Il Pensiero Scientifico, Roma 1964.
KIRMAYER L.J. and CORIN E. (1998) Inside knowledge: Cultural constructions of insight in psychosis. In X. F. Amador and A.S. David (ed.). Insight and Psychosis, New York: Oxford University Press.
KLEINMAN A. (1988) The Illness Narratives,Suffering, healing and the human condition., New York: Basic Books.
KLOSTERKÖTTER J. (1999) Vulnerabilità schizofrenica e sintomi di base. In: Rossi Monti M., Stanghellini G. (a cura di). Psicopatologia della schizofrenia. Cortina, Milano, 1999: 107-136.
KRAVETZ S., FAUST M., DAVIS M., (2000) Accepting the mental illness label, perceived control over the illness, and quality of life. Psychiatry Rehabil J. 23:323-332.
KRAFFT-EBING R., (1893) Lehrbuch der Psychiatrie. Enke, Stuttgart.KRETSCHMER, E. (1918) Der sensitive Beziehungswahn. Springer, Berlin, 1954 3a ed.
LAMBERT B.L., STREET R.L., CEGALA F.J., SMITH D.N., KURTZ S., SCHOFIELD T. (1997) Provider patient communication patient centered care and the mangle of practice. Health Commun. 9: 27-43.
LARSEN D.L., ATTKISSON et al. (1979) Assessment of client/patient satisfaction: development of a general scale. Eval Prog Planning. 2: 197.
LASALVIA A., RUGGERI M. (2003) L’esito della schizofrenia. Centro Scientifico Editore, Torino
LEHMAN A.F., WARD N.C., LINN L.C. (1982) Chronic mental patients: the quality of life issue. American Journal of Psychiatry. 139: 1271-1275.
LEHMAN A.F., ROSSIDENTE S., HAWKER F. (1986) The quality of life of chronic patients in a state hospital and in community residences. Hospital and Community. 37: 901-907.
LEWIS A. (1934) The Psychopathology of Insight. British Journal of Medical Psychology. 14: 332-48.
LIBERMAN R.P., KOPELOWICZ A., VENTURA J., GUTKING D. (2002) Operational criteria and factors related to recovery from schizophrenia. International Review of Psychiatry. 14: 256-272.
LINCOLN T.M., LÜLLMANN E., RIEF W. (2007) Correlates and long-term consequences of poor insight in patients with schizophrenia. A systematic review. Schizophrenia Bulletin vol. 33 no.6 pp. 1324–1342.
LINK B. (1987) Understanding labelling effects in the area of mental disorders: An assessment of the effects of expectations of rejections. American Sociologial Review. 52: 96-112.
LOVE R.E., CAID C.D., DAVIS A. (1979) The User Satisfaction Survey:
consumer evaluation of an inner city community mental health center. Eval Health Profession. 2:42.
LYONS W., (1986) The disappearance of Introspection. MA: MIT Press, Cambridge. LYSAKER P.H., LANCASTER R.S., LYSAKER J.T. (2003) Narrative transformation as
an outcome in the psychotherapy of schizophrenia Psychology and Psychotherapy: Theory, Research,and Practice. 76: 285-299.
LYSAKER P.H., WICKETT A.M., WILKE N., LYSAKER J. (2003) Narrative incoherencein schizophrenia: The absent agent-protagonist and the collapse of internal dialogue. American Journal of Psychotherapy. 57:153-166.
LYSAKER P.H., BRYSON G.J., LANCASTER R., EVANS J.D. and BELL M.D. (2003) Insight in schizophrenia: Associations with executive function and coping style. Schizophrenia Research. 59 (1): 41-7.
LYSAKER P.H., BELL M.D. (2004) La consapevolezza di malattia nella schizofrenia: I recenti contributi della ricerca sulla riabilitazione psicosociale. In X.F. AMADOR, A.S. DAVID (a cura di) Insight e Psicosi. Tr it. Fioriti, Roma 2009.
LYSAKER P.H., FRANCE C.M., HUNTER N.L., & DAVIS L.W. (2005) Personal narratives of illness in schizophrenia: Associations with neurocognition and symptoms. Psychiatry. 68: 140-151.
LYSAKER P.H., TAYLOR A.C., MILLER A., BEATTIE N., STRASBURGER A., and DAVIS L.W.(2006) The Scale to Assess Narrative Development: Association with other measures of self and readiness for recovery in schizophrenia spectrum disorders. Journal of Nervous and Mental Disease. 194: 223-225.
LYSAKER P.H., DIMAGGIO G., BUCK K.D., CARCIONE A.., & NICOLÒ G. (2007) Metacognition within narratives of schizophrenia: Associations with multiple domains of neurocognition. Schizophrenia Research. 93: 278-287.
LYSAKER P.H., HERMANS H.J. (2007) The dialogical self in psychotherapy forpersons with schizophrenia: A case study. Journal of Clinical Psychology. 63:129-139.
LYSAKER P.H.,ROE D., YANOS P.T. (2007) Toward the understanding the insightparadox: Internalized stigma moderates the association between insight and social functioning, hope, and self-esteem among people with schizophrenia spectrum disorder. Schizophrenia Bulletin, vol. 33, no.1 pp. 192-199.
LYSAKER P.H., BUCK K.D., TAYLOR A.C., ROE D. (2008) Associations of metacognition and internalized stigma with quantitative assessment of self-experience in narratives of schizophrenia. Psychiatry Research. 157: 31-38.
LYSAKER P.H., YANOS P.T., ROE D. (2009) The role of insight in the processof recovery from schizophrenia: a review of three views. Psychosis, vol. 1, no 2: 113-121.
LYSAKER P.H., DIMAGGIO G, BUCK K.D., CALLAWAY S.S., SALVATORE G., CARCIONE A., NICOLÒ G., STANGHELLINI G. (2011) Poor insight in schizophrenia: links between different forms of metacognition with awareness of symptoms, treatment need, and consequences of illness. Comprehensive Psychiatry. 52: 253-260.
LYSAKER P.H. (2011) La metacognizione nei disturbi dello spettro schizofrenico: Metodi di valutazione della metacognizione nella narrazione e legami con la neurocognizione. In: DIMAGGIO G., LYSAKER P.H. (a cura di) Metacognizione e psicopatologia. Valutazione e trattamento. Cortina, Milano.
LYSAKER P.H., BUCK K.D. (2011) La capacità metacognitiva come focus per la
psicoterapia individuale della schizofrenia. In: DIMAGGIO G., LYSAKERP.H. (a cura di) Metacognizione e psicopatologia. Valutazione e trattamento. Cortina, Milano.
LYSAKER P.H., DIMAGGIO G. (2011) Conclusioni. Metacognizione e disturbi psicologici. Un commento. In: DIMAGGIO G., LYSAKER P.H. (a cura di) Metacognizione e psicopatologia. Valutazione e trattamento. Cortina, Milano.
MINKOWSKI, E. (1927) La schizofrenia. Psicopatologia degli schizoidi e degli schizofrenici. Tr.it. Einaudi, Torino 1998.
MINKOWSKI, E. (1966) Trattato di psicopatologia. Tr. it. Feltrinelli, Milano 1973.
MOORE O., CASSIDY E., CARR A., O’CALLAGHAN E. (1999) Unawareness of illness and its relationship with depression and self-deception in schizophrenia. Eur Psychiatry. 14:264-269.
MOREAU DE TOURS J.J. (1845) Du Hachisch et de l’Aliénation Mentale. Paris: Fortin Masson et Cie.
MORGAN K.D., DAVID A.S. (2011) La consapevolezza non è accettazione. Esplorazione del pensiero dietro l’insight e l’aderenza al trattamento. In: DIMAGGIO G., LYSAKER P.H. (a cura di) Metacognizione e psicopatologia. Valutazione e trattamento. Cortina, Milano.
PARNAS J. (2000) The Self and intentionality in the pre-psychotic stages of schizophrenia: a phenomenologic study. In Zahavi D (ed). Exploring the Self: psychopathological and philosophical perspectives on Self-awareness. Philadelphia: Benjamins, pp. 115-147.
PARNAS J., (2010) Disturbi del Sé. In: MAJ M., MAGGINI C., SIRACUSANO A. (a cura di) Lessico di Psicopatologia Il Pensiero Scientifico Ed., Roma 2010.
PARNAS J., BOVET P., ZAHAVI D. (2002) Schizophrenic autism: clinical phenomenology and pathogenetic implications. World Psychiatry. 1: 131-135.
PETTIE D., TRIOLO A.M. (1999) Illness as evolution: The search for identityand meaning in the recovlery process. Psychiatric Rehabilitation Journal. 22:255-262.
PHELAN M., SLADE M., THORNICROFT G., DUNN G., HOLLWAY F., WYKES T., STRATHDEE G.,LOFTUS L., MCCRONE P., HAYWARD P. (1995) The Camberwell Assessment of Need: the validity and reliability of an instrument to assess the needs of people with severe mental illness. British Journal of Psychiatry. 167: 589-595.
PINI S. (2010) Insight. In: MAJ M., MAGGINI C., SIRACUSANO A. (a cura di) Lessico di Psicopatologia Il Pensiero Scientifico Ed., Roma 2010.
QUEE P.J., VAN DER MEER L., BRUGGEMAN R., DE HAAN L., KRABBENDAM L., CAHN W., MULDER N.C.L., WIERSMA D., ALEMAN A. (2011) Insight in psychosis: relationship in neurocognition, social cognition and clinical symptoms depends on phase of illness. Schizophrenia Bulletin, vol. 37, no.1 pp. 29-37.
ROE D., KRAVETZ S. (2003) Different ways of being aware of and acknowledging a psychiatric disability. A multifunctional narrative approach to insight into mental disorder. J Nerv Ment Dis.191: 417-424.
ROE D., DAVIDSON L. (2005) Self and narrative in schizophrenia: time to author a new story. J Med Humanit. 31:89-94.
ROE D., HASSON-OHAYON I., KRAVETZ S., YANOS P.T., LYSAKER P.H. (2008) Call it a monster for lack of anything else. Narrative insight in psychosis.
J Nerv Ment Dis. 196: 859-865.
SAMHSA (2008) NATIONAL CONSENSUS STATEMENT ON MENTAL HEALTH RECOVERY DEFINITION, http://mentalhealth.samhsa.gov/pubblications/allpubs/sma05-4129. Accessed September 17
SARACENO B. (1995) La fine dell’intrattenimento. ETASLIBRI- RCS, Milano.
SASS L., PARNAS J. (2003) Schizophrenia, consciousness, and the self. Schizophrenia Bulletin. 29(3): 427-444.
SCHNEIDER, K. (1950) Psicopatologia clinica. Tr. it. Fioriti, Roma 2004.SCHWARTZ R.C. (2001) Self-awareness in schizophrenia: its relationship to
depressive synptomatology and broad psychiatric impairments. J Nerv Ment Dis. 189: 401-403.
SCHWARTZ R.C., COHEN B.N. and GRUBAUGH A. (1997) Does insight affect longterm inpatient treatment outcome in chronic schizophrenia? Comprehensive Psychiatry. 38: 283-8.
SHADISH W.R., ORWIN R.G., SILBER B.G., BOOTZIN R.R. (1985) The subjective well-being of mental patients in nursing homes. Evaluation and Program Planning. 8: 239-250.
SILVERSTEIN S.M., BELLACK A.S. (2008) A scientific agenda for the concept ofrecovery as it applies to schizophrenia. Clinical Psychology Review. 28: 1108-1124.
SLADE M., HAYWARD M. (2007) Recovery, psychosis and psychiatry: research isbetter than rhetoric. MedicineActa Psychiatrica Scandinavica. 116: 81-83.
SPANIOL L., WEWIORSKI N., GAGNE C., ANTHONY WA. (2002) The process of recoveryfrom schizophrenia. International Review of Psychiatry. 14: 327-336.
STANGHELLINI G., ROSSI MONTI M. (2009) Psicologia del patologico. Cortina, Milano.
STANGHELLINI G. (2010), Disturbi della coscienza di Sé. In: MAJ M., MAGGINI C., SIRACUSANO A. (a cura di) Lessico di Psicopatologia Il Pensiero Scientifico Ed., Roma 2010
STARTUP M.E. (1996) Insight and cognitive deficits in schizophrenia: evidence for a curvilinear relationship. Psychological Medicine. 26: 1277-81.
STEELE K. (2005) E venne il giorno che le voci tacquero. Mimesis, Milano.STRAUSS, J.S. (1989) Mediatine processes in schizophrenia: towards a new
dynamic psychiatry. British Journal of Psychiatry. 155 (suppl.5): 22-28.WARE J.E., SNYDER M.K., WRIGHT W.R. (1976) Development and validation of scale to
measure patient satisfaction with health care service. Vol. 1-A NTSI Publ No PB 288-329, Springfield, VA.
WARNER R, TAYLOR D, POWERS M, HYMAN R. (1989) Acceptance of the mental illness label by psychotic patients: effects on functioning. Am J Orthopsychiatry. 59:389-409.
WARNER R. (1994) Recovery From Schizophrenia: Psychiatry and Political Economy. New York,NY: Routledge.
WYRSCH, J. (1949) Die Person des Schizophrenen. Haupt, Bern.
YOUNG S.L. & ENSING D. (1999) Exploring recovery from the perspective of people with psychiatric disabilities. Psychiatry Rehabilitation Journal. 22: 219-231.
ZAHAVI D. (2005) Subjectivity and selfhood: investigating the first-person
perspective. Cambridge: MIT Press.
ZINMAN S. (1982) A Patient-run residence. Psychosoc Rehabil J. 6: 3-11. ZINMAN S., HARP H.T., BUDD S. (1987) Reaching Across: Mental Health Clients Helping
Each Other. Riverside, Calif: California Network of Mental Health Clients.
ZUBIN J., SPRING B. (1977) Vulnerability. A new view on schizophrenia. J. Abnorm. Psychol. 86: 103-126.