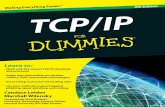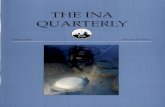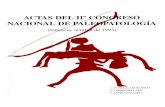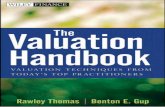Una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano
-
Upload
mondodomani -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano
An International, Yearly and Peer-Reviewed Journal.The eContent is archived with Clokss and Portico.
*
DirettoreNicola Bonacasa
Comitato scientificoMostafa el-Abbadi · Saleh R. Agab Abdalha
Anthony Bonanno · Mounir BouchenakiFrancesco D’Andria · Mhamed H. FantarVassos Karageorghis · Vincenzo La Rosa
Marc Mayer i Olivé · Dimitrios PandermalisFrançois Queyrel · Donald White
RedazioneAntonella Mandruzzato
*
Centro di Ricerca per l’Archeologia del Mediterraneo,Dipartimento di Beni Culturali, Sezione Archeologica,
Facoltà di Lettere, Viale delle Scienze (Edificio 12),Università degli Studi, I 90128 Palermo,
tel. +39 091 23899412/456, fax +39 091 23860651,[email protected]
MARE INTERNUMA RC H E O LO G I A E C U LT U R E
D E L M E D I T E R R A N E O
4 · 2012
PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMXIII
Amministrazione e abbonamentiFabrizio Serra editore®
Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa, tel. +39 050542332, fax +39 050574888, [email protected]
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.Print and/or Online official subscription rates are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net.
I pagamenti possono essere effettuati tramite versamento su c.c.p. n. 17154550 o tramite carta di credito (American Express, Visa, Eurocard, Mastercard)
Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa, tel. +39 050542332, fax +39 050574888, [email protected]
Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma, tel. + 39 06 70493456, fax + 39 06 70476605, [email protected]
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 10 del 17 aprile 2008Direttore responsabile: Fabrizio Serra
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzoeffettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta
della Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2013 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
Stampato in Italia · Printed in Italy
www.libraweb.net
issn 2035-0783issn elettronico 2036-5160
SOMMARIO
contributi
Nicola Bonacasa, Antonino Di Vita e noi 11Giuseppe Castellana, Prefazione e considerazioni sul testo inedito di G. Caputo Dal culto popolare dell’acqua sulfurea
al culto autocratico del toro di Falaride 15Giacomo Caputo, Dal culto popolare dell’acqua sulfurea al culto autocratico del toro di Falaride 23Elena Ghisellini, \EÓı¿‰Â ÎÂÖÌ·È ‰‡ÛÌÔÚÔ˜. Una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano 29Fausto Zevi, Maria Elisa Micheli, Un fregio tra Ostia e Berlino: problemi di iconografia e di topografia ostiense 41Salvatore Garraffo, L’importanza del Tesoro di Misurata per lo studio della monetazione tardoromana in aes arricchito
di argento 59Giuseppe Pucci, Cadaveri eccellenti: le vittime di Pompei nell’immaginario moderno 71
note e discussioni
Patrizia Minà, ^EÓ º·Ú›– Á·›– ı˘ÌeÓ àÔÊı›ÌÂÓÔ˜. Gli ipogei dell’Isola di Pharos nell’età medioellenistica 91Antonella Mandruzzato, Sabratha. Edilizia privata residenziale. 2. La “Casa del Peristilio” di Sabratha: anticipazioni
e problemi 109Rosa Maria Bonacasa Carra, Ritratto femminile del iv secolo d.C. nella Catacomba di Villagrazia di Carini 119
K·ÏÏÈÌ¿¯Ô˘|ÌÓËÌÂÖÔÓ|âÓ àÓıÚÒÔÈ|ÛÈ Ùfi‰\ öÛÙ·ÈØ|¯·›ÚÂÙ ‰\ Ôî |·ÚÈfiÓÙ˜,|â<Á>g ‰b ÏÈ|gÓ ·ÙÚ›‰|· âÓı¿‰Â ÎÂÖ|Ì·È ‰‡ÛÌÔ|ÚÔ˜,ç‰b Ê›ÏÔ˜ ÁÔ|Ó¤·˜ âȉÒÓ.
on queste parole Kallimachos lamenta il proprio desti-no di morte in un’iscrizione sepolcrale attica degli inizi
del iv secolo a.C.1 Il motivo del defunto afflitto per la propriasorte trova espressione visiva attraverso un misurato ma in-cisivo linguaggio dei gesti su una stele funeraria conservatasul mercato antiquario romano (Fig. 1). Compresa nel corpusdei monumenti sepolcrali attici di epoca classica redatto daCh. Clairmont, la stele è stata in seguito solo episodicamentecitata,2 sebbene meriti una più attenta analisi appunto in vir-tù del tema della rappresentazione, che ricorre con scarsa fre-quenza nell’ambito della scultura funeraria classica.
La lastra, di marmo pentelico,3 ha un’altezza totale di cm70 e una larghezza variabile dai 44,5 cm alla base ai 43,5 cmalla sommità; i fianchi sono lisciati e hanno uno spessore ap-pena decrescente verso l’alto (da 7 a 6 cm); il lato posterioreè sbozzato. Il prolungato contatto con un terreno acido hadeterminato una estesa corrosione della superficie, che è ri-vestita da una patina rosata e da diffuse incrostazioni; la lastraè fratturata in basso, con conseguente perdita di parte degliarti inferiori delle figure, e presenta una lacuna sul lato sini-stro, che appare ora risarcita in gesso; scheggiature di mode-sta entità interessano alcuni dettagli della figurazione.4
Il campo figurato, conservato per un’altezza di cm 55, è pri-vo di cornici laterali ed è chiuso superiormente da un kymaliscio, che media la transizione al frontone triangolare, corre-dato da acroteri, il cui timpano è chiuso da geisa a listello epreserva ancora le tracce di una decorazione dipinta, chesembra consistere in una palmetta centrale nascente da volu-te. La scena scolpita nel campo si compone di tre figure, cheemergono dal fondo con un rilievo poco accentuato (aggettomassimo cm 1,5). Al centro campeggia un personaggio ma-schile, che gravita sulla gamba destra e scarta di lato la sini-stra flessa, con il viso rivolto di prospetto e il corpo quasifrontale, che accenna una torsione di tre quarti verso sinistra;un himation avvolge la spalla sinistra e si drappeggia intornoalle gambe e all’addome lasciando scoperti la spalla destra eil torace, contraddistinto da pettorali espansi e carnosi; all’al-tezza del ventre il mantello si addensa in un rotolo arcuato,solcato da pieghe concentriche, che si adagia sull’avambrac-cio sinistro per poi ricadere lungo il fianco; dal risvolto delmanto fuoriesce la mano con il pollice e l’indice tesi, quasi atrattenere la stoffa. Il braccio destro è piegato verso il volto,che poggia la guancia destra sul palmo della mano; il viso,
dall’ovale piuttosto appiattito, con zigomi larghi, è ombreg-giato da una corta barba, a ciocchette corpose, e mostra li-neamenti poco più che abbozzati: occhi di taglio allungato,ravvicinati e racchiusi entro palpebre carnose, bocca piccola,un po’ dischiusa, con labbro inferiore prominente, nettamen-te separato dal mento pesante. I capelli, realizzati in manieraapprossimativa, sono acconciati in una massa spessa e com-patta di ciocche rigonfie, che si dispongono ad arco intornoalla fronte bassa e alle tempie e coprono l’orecchio sinistro.
Sulla sinistra compare una bambina, di circa tre-quattroanni, che si volge di profilo verso la figura centrale con la testae il braccio destro sollevati, stringendo nella mano un ogget-
* Le foto alle Figg. 2-6 (Negg. d-dai-ath-Grabrelief 0638, d-dai-ath-nm0417, d-dai-ath-Peloponnes 0139. Photograph: José Dörig, d-dai-ath-nm4994. Photograph: Eva-Maria Czakò, d-dai-ath-Kerameikos 8843) e 8-12(Negg. d-dai-ath-nm 0461, d-dai-ath-Grabrelief 0637, d-dai-ath-nm 5529.Photograph: Eva-Maria Czakò, d-dai-ath-Grabrelief 0606, d-dai-ath-nm3869. Photograph: Emil Kunze) sono state gentilmente concesse all’A. dal-l’Istituto Archeologico Germanico di Atene, che ne detiene i diritti.
1 IG ii/iii2, n. 11780; Peek 1955, n. 83.2 CAT 1.863 (Clairmont ha visto il rilievo sul mercato antiquario romano
nel 1991, ma al momento della pubblicazione del corpus, nel 1993, a propositodel luogo di conservazione scrive: «the present whereabouts unknown»);
Osborne, Byrne 1994, p. 267, n. 18, s.v. Kleophon; Bergemann 1997, p. 164, n.248; Huber 2001, pp. 151, 229, n. 230. La stele è esposta attualmente nella Galleria d’Arte di Valerio Turchi. Ringrazio Massimiliano Papini per l’attentalettura del testo e i preziosi suggerimenti.
3 Il riconoscimento del marmo è stato effettuato da Matthias Bruno, cheringrazio per la gentile collaborazione.
4 Risultano scheggiati il margine destro della lastra, il naso, la mano de-stra e alcune pieghe del mantello della figura centrale, la testa e il volto delgiovanetto effigiato a destra, la mano destra della bambina posta a sinistra,il cui viso è completamente abraso; spezzati gli acroteri laterali e la sommitàdi quello centrale.
EN£A¢E KEIMAI ¢Y™MOPO™ .UNA STELE FUNERARIA ATTICA
SUL MERCATO ANTIQUARIO ROMANO*
Elena Ghisellini
C
Fig. 1. Stele funeraria. Roma, mercato antiquario(foto Valerio Turchi).
30 elena ghisellini
to non più identificabile;1 la bimba, di dimensioni assai ridot-te e connotata dalle proporzioni tozze tipiche della più tenerainfanzia, scarica il peso sulla gamba destra tesa e avanza leg-germente la sinistra flessa; indossa un chitone a maniche cor-te e un mantello che fascia la parte inferiore del corpo e at-traversa diagonalmente il busto. Le fa riscontro, sulla destra,un giovanetto nudo, dalle forme corporee asciutte e scattan-ti, anch’egli girato di profilo in direzione dell’immagine cen-trale, verso cui indirizza lo sguardo alzando la testa; è rappre-sentato stante sulla gamba sinistra, con la gamba destrapiegata, e porta le braccia abbassate davanti al corpo, con unamano posata sull’altra.
Alla sommità del campo figurato corre un’iscrizione, le cuilettere sono distribuite ai lati della testa del personaggio cen-trale, del quale ci restituiscono il nome: KÏÂÔÊáÓ.
Dal punto di vista della tettonica il pezzo si inquadra nellacategoria delle stele con frontone autoportante e denota qua-li elementi distintivi, oltre all’assenza delle ante sui lati, il pro-filo molto marcato del kyma di passaggio dal piano della la-stra al coronamento, il geison orizzontale più alto di quelliobliqui, il frontone e gli acroteri di medie proporzioni.2 La ti-pologia delle stele a frontone prive di ante si afferma in diver-si ambienti di produzione dalla seconda metà del v secoloa.C. e gode di vasto credito sino al primo venticinquennio deliv secolo a.C., allorquando, pur non scomparendo del tutto,viene soppiantata dalla tipologia del naiskos chiuso da ante,che diventa pressoché esclusiva nel corso del iv secolo a.C.
Speciale interesse riveste la conservazione di tracce di colo-re nel timpano, che assicura che l’intera stele prevedeva uncompletamento pittorico, i cui avanzi, non visibili a occhio nu-do, potrebbero con ogni probabilità essere individuati attra-verso le moderne tecnologie di indagine.3 Del resto le ricerchecondotte negli ultimi anni vanno definendo sempre meglio ilruolo svolto dalla pittura e dal colore nella rifinitura dei monumenti sepolcrali e proprio alla luce dei risultati recente-mente conseguiti è possibile restituire in via ipotetica, ma conun buon margine di verosimiglianza, alcuni dettagli della policromia originaria: sulla modanatura di transizione dalcampo figurato al frontone è ricostruibile un kymation ionicodipinto, che su stele e lekythoi attiche di norma si staglia su unosfondo rosso, alternando ovuli blu bordati di giallo a lancettegialle.4 Il geison orizzontale doveva essere suddiviso in tre fa-sce; gli acroteri centrale e laterali erano decorati con palmettesu doppie volute.5 L’ornato vegetale che tuttora si scorge nellospazio triangolare del timpano trova numerosi confronti,6mentre appare difficile immaginare l’impianto cromatico della scena figurata, che poteva forse risaltare su un fondo dipinto di blu, come documentano esemplari consimili.
Nelle stele con frontone autoportante l’iscrizione con ilnome del defunto è incisa in genere sul geison orizzontale,
meno comunemente all’interno del timpano;7 non mancanoperò casi in cui è apposta nel campo figurato, di solito al disopra della testa del personaggio a cui si riferisce,8 soluzioneche viene spesso impiegata nelle stele di piccolo formato divaria tipologia9 e negli esemplari con decorazione esclusiva-mente dipinta. Nel monumento in esame si è fatto ricorso aun singolare impaginato del testo, che si scinde sui due latidella testa del protagonista, determinando un’artificiosa ce-sura nel nome.10 Le lettere sono abbastanza regolari e mo-strano il ductus canonico tra la fine del v secolo a.C. e l’età diAlessandro Magno: il secondo tratto orizzontale dell’epsilonè un po’ raccorciato rispetto agli altri due, il primo tratto delny è lievemente più lungo rispetto al terzo, l’omega è ancoramolto aperto. L’omicron, come di consueto, è un po’ più pic-colo delle altre lettere e mostra un puntino inciso al centro,nel quale con ogni probabilità si deve ravvisare il segno lascia-to dal compasso che è stato utilizzato per tracciare il grafemacon maggiore precisione.
Il nome Kleophon (“colui che rifulge di gloria”) non è al-trimenti attestato su rilievi sepolcrali attici. Può essere tutta-via utile analizzarne la distribuzione attraverso le occorrenzeepigrafiche: Isole dell’Egeo (22 occorrenze);11 Attica (22 oc-correnze);12 Dalmazia, Itaca, Corinto (3 occorrenze);13 Foci-de (1 occorrenza);14 Asia Minore costiera (2 occorrenze).15
Risulta immediatamente evidente il favore accordato alnome in ambito ionico e principalmente in Attica e nelle isoleegee, con una significativa concentrazione a Thasos, che an-novera ben 12 occorrenze, la metà delle quali risalenti al v-ivsecolo a.C.
La collocazione dell’iscrizione non lascia dubbi circa il ri-conoscimento del defunto nel personaggio centrale, sul qua-le si focalizza la stesura compositiva della scena, che è sapien-temente studiata per convogliare su di lui lo sguardo dellospettatore mediante la convergenza verso il centro delle duefigure laterali. Le dimensioni, di gran lunga eccedenti quelledelle figure che lo affiancano, e soprattutto la presentazionefrontale enfatizzano ulteriormente l’immagine del protago-nista. Kleophon è ritratto nei panni del polites, con l’himationelegantemente drappeggiato intorno al corpo, secondo unoschema iconografico prediletto sui rilievi funerari attici tantoper personaggi ancora imberbi, quanto per uomini di età ma-tura.16 Lo schema di base ammette un certo numero di varia-zioni nella disposizione del mantello,17 che nel nostro pezzoè caratterizzato da un lembo poggiato sull’avambraccio sini-stro piegato e da qui ricadente lungo il fianco, dove si arrestaall’altezza dell’anca, assetto che si ritrova, ad esempio, nel-l’immagine di un efebo su un naiskos a Parigi, Musée du Lou-vre, inv. Ma 807,18 in quella di un giovane uomo in compagniadel vecchio padre su un rilievo nel Museo Nazionale di Atene,inv. n. 967,19 e in quella di un uomo barbato su una stele fram-
1 Rimane soltanto una sagoma tondeggiante; Clairmont ipotizza che potesse trattarsi di un uccellino, fondandosi su una serie di esempi analoghi(cfr. infra).
2 Gli elementi enucleati non forniscono indizi circa la cronologia del mo-numento, in quanto la loro morfologia non segue una linea evolutiva, ma siriallaccia alle consuetudini delle singole botteghe: Stupperich 1977, pp. 123-124. Sulle stele con frontone autoportante: Ensoli 1987, pp. 246-262, con bibl.prec. a nota 247 (l’autrice opera una classificazione tipologica degli esempla-ri, tentando di individuare dei criteri di evoluzione, ma i raggruppamenti chepropone a volte denunciano scarsa coerenza interna).
3 Sulle nuove metodologie di indagine: Brinkmann 2004. Sulla policro-mia della scultura greca si consultino i contributi raccolti in Brinkmann,Wünsche 2004; Kunze 2011; sui monumenti funerari attici, in particolare:Posamentir 2006.
4 Koch-Brinkmann, Posamentir 2004, p. 151; Koch-Brinkmann, Po-samentir 2004a, p. 163; Posamentir 2006, pp. 101-105.
5 Si considerino, ad esempio: Posamentir 2006, Kat. nn. 18, 19.6 Posamentir 2006, pp. 57-66; Kat. nn. 11, 25, 34, 39, 40, 43, 48, 51, 53, 55, 56,
57, 59, 60, 61, 65-68, 73, 75-79, 89, 93, 94, 114, 119, 135.7 CAT, vol. v, pp. 7-8.
8 CAT 0.860 (= Scholl 1996, n. 83), 2.278 (= Scholl 1996, n. 123), 2.431b(= Scholl 1996, n. 505).
9 Scholl 1996, nn. 17, 20, 23, 24, 68, 91, 102, 167, 171, 210, 212, 213, 356, 366,387, 461, 473, 480, 481.
10 Si confronti la stele frammentaria di Oinanthe, nella quale la prima li-nea dell’iscrizione, contenente il nome della defunta, è incisa sopra la testadella figura, mentre nella seconda linea l’etnico Salaminia è distribuito ai duelati della testa: CAT 2.313b.
11 Fraser, Matthews 1987, p. 263.12 Osborne, Byrne 1994, p. 267.13 Fraser, Matthews 1997, p. 249.14 Fraser, Matthews 2000, p. 238.15 Corsten, Catling, Ricl 2010, p. 250.16 Stupperich 1977, pp. 102-105; CAT, Intr., p. 30; Bergemann 1997, pp. 76-
77 (l’autore riconduce le figure maschili stanti con himation a sei schemi figu-rativi, che sono definiti da un attributo o un atteggiamento comune: l’imma-gine di Kleophon rientra nello schema 5 della sua classificazione).
17 Alcune varianti sono esemplificate da una Bildfeldstele nel Museo Na-zionale di Atene, inv. n. 1985 (Fig. 2): CAT 4.319; Scholl 1996, p. 274, n. 190,tav. 17,1. 18 CAT 1.278; Hamiaux 1992, p. 156, n. 151.
19 CAT 2.250.
una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano 31
mentaria a tre figure nel Museo del Pireo, inv. nn. 221+1190,1quest’ultimo rappresentato, come Kleophon, con l’indice e ilpollice della mano sinistra tesi. Le figure citate sono riprodot-te con il corpo in veduta quasi frontale, ma con la testa giratadi tre quarti verso la sua destra; il braccio destro è teso versoil basso con la mano impegnata a tenere un attributo o nel ge-sto della dexiosis. Una variante degna di nota si osserva in unastele del Museo Nazionale di Atene, inv. n. 730,2 sulla qualeun giovane è immortalato nello schema descritto, ma, comeKleophon, piega l’avambraccio destro verso l’alto, stringen-do nella mano uno strigile.
Il viso del defunto, la cui barba corta denuncia l’età ancoragiovanile, è incorniciato da una capigliatura a massa rigonfia,dal contorno unitario, che delinea un arco continuo intornoalla fronte e alle tempie. Sui rilievi funerari attici una simileacconciatura è sfoggiata prevalentemente da personaggi gio-vani, efebi3 o uomini nel fiore degli anni, come nel caso di Ni-kodemos, che è ritratto in posizione frontale tra la madre e lasorella su un naiskos datato intorno al 360 a.C. e conservato aMalibu, J. Paul Getty Museum, inv. n. 78.AA.58.4 La capiglia-tura di Nikodemos si avvicina a quella in esame anche per iltrattamento sommario, quasi ad abbozzo, delle ciocche, chesi conforma a una prassi esecutiva relativamente comune neimonumenti sepolcrali di produzione attica, sui quali non dirado sono resi con analoga rapidità anche i volti, la cui fisio-nomia è spesso delineata con pochi tratti essenziali.5 È quan-to si osserva nel viso di Kleophon, che sul piano fisionomicopuò essere accostato a quello, visto quasi frontalmente, di ungiovane defunto su un frammento di naiskos del secondoventicinquennio del iv secolo a.C. nel Museo del Pireo, inv.n. 1877,6 che denota anch’esso una struttura piena dell’ovale,con zigomi larghi e guance dai piani ampi e tesi.
Il dato che più colpisce nella stele in esame è l’insolita fron-talità del defunto, del corpo come del viso, che si rivolge ver-so lo spettatore catturandone l’attenzione e instaurando conchi guarda una relazione immediata e fortemente coinvol-gente dal punto di vista emotivo.7 Dai decenni finali del v se-colo a.C. la frontalità costituisce una cifra figurativa adottatadi preferenza nelle stele a figura unica, che eternano il ricor-do di personaggi vittime di una morte prematura: bambini ebambine, efebi, connotati come guerrieri, cacciatori, atleti espesso scortati da un pais, giovanette, talora in compagnia diun’ancella, esibiscono en face i corpi acerbi, più raramente ivolti, che in genere si girano di profilo o di tre quarti.8 Intor-no al 380 a.C. prende avvio la consuetudine di riprodurre ladefunta seduta con la testa e il busto rivolti frontalmente, losguardo perso nel vuoto, mentre una parente o una serva laosserva in un atteggiamento di composta mestizia.9 La ten-denza alla frontalità si accentua nella seconda metà del iv se-colo a.C., quando nelle composizioni con più membri della
famiglia spesso compaiono figure sussidiarie, normalmenteancelle, che si affacciano sullo sfondo del rilievo, al centro frai protagonisti, e assistono alla scena con il corpo, e a volte an-che la testa, presentati di pieno prospetto.10
Il gesto compiuto da Kleophon, che piega verso l’altol’avambraccio destro e posa la guancia sul palmo della mano,ha una lunga tradizione e conosce un’ininterrotta fortuna nelcorso dei secoli. L’ideazione del motivo viene fatta risalire al-la pittura protoclassica e le sue più antiche formulazioni si in-contrano nella produzione artistica di stile severo, che vedela definizione delle due varianti principali dello schema, laversione seduta, esemplificata al meglio dal noto tipo statua-
1 CAT 3.454; Bergemann 1997, p. 168, n. 394, tavv. 45.1, 58.3-4, 83.3-4.2 CAT 1.201.3 Fra i molti esempi si ricordano, a titolo puramente indicativo, gli efebi
effigiati su un naiskos nel Museo Nazionale di Atene, inv. n. 827 (CAT 1.282),su un esemplare diviso fra l’Antiken Museum di Basilea, inv. BS 233/S 175, eil Museo di Brauron, inv. be 812 (CAT 1.289), e su una stele a Leiden, Rijksmu-seum, inv. n. 1821 (CAT 1.364).
4 CAT 3.343; Bergemann 1997, p. 171, n. 508, tavv. 53.3-4, 85.3, 110.2-4; Gros-sman 2001, pp. 29-31, n. 9. Vd. anche Bergemann 1997, tavv. 84,3.4, 85,1, 87,3.4.
5 Si rimanda alla ricca campionatura di esempi e alle ottime illustrazionidi Bergemann 1997, tavv. 66-108.
6 CAT 2.370a; Bergemann 1997, p. 162, n. 157, tav. 93,1.2.7 Sul significato della raffigurazione kata prosopon condivido pienamente
le considerazioni di Papini 2003, pp. 85, 89. Sulla frontalità sui monumenti funerari si vedano: Kenner 1960, pp. 26, 28-30; Himmelmann 1971, p. 33;Schmaltz 1983, pp. 204-206; Scholl 1996, pp. 116-117; Bergemann 1997, p.91; Himmelmann 1999, pp. 109, 140.
8 Di seguito una serie di esempi, senza alcuna pretesa di completezza: a.bambini: CAT 0.710, 0.777, 0.778, 0.785, 0.788, 0.830, 0.834, 0.835, 0.841, 0.846,0.852, 0.853, 0.855-0.857, 0.862, 0.866, 0.866a, 0.867a, 0.870, 0.870a, 0.871a,0.873, 0.873a, 0.874a, 0.876, 0.878, 0.880-0.882, 0.884, 0.913, 0.914, 0.917, 0.920,
0.921, 0.923, 0.940, 0.942, 0.945, 0.980; b. bambine: CAT 0.721, 0.722, 0.783, 0.787,0.840, 0.850, 0.851, 0.853a, 0.859, 0.859a, 0.860a, 0.864, 0.890, 0.908, 0.911, 0.912,0.918, 0.941; c. efebi: CAT 1.200, 1.210a, 1.214, 1.221, 1.230, 1.271, 1.278, 1.282,1.289, 1.302, 1.317, 1.331, 1.342, 1.348, 1.355, 1.361, 1.364, 1.368, 1.371, 1.375, 1.385,1.391, 1.392, 1.415, 1.436, 1.550, 1.790, 1.795, 1.825, 1.837, 1.841, 1.847, 1.850, 1.855,1.856, 1.866, 1.875, 1.879, 1.880, 1.930, 1.935, 1.944, 1.951, 1.955, 1.968, 1.983, 1.984,2.449a (con il padre), 2.892; d. fanciulle: CAT 1.180, 1.182, 1.280, 1.291, 1.294,1.310, 1.312, 1.315, 1.316, 1.321a, 1.329, 1.332, 1.356, 1.357, 1.359, 1.360, 1.370a, 1.382,1.413, 1.428, 1.433, 1.465, 1.471, 1.490, 1.814, 1.862, 1.883, 1.898, 1.905, 1.932, 1.967,2.125. Sul significato delle stele con giovani defunti, travolti da un destino dimors immatura, da ultimo: Schmaltz, Salta 2003, pp. 146-153, con bibl. prec.Eccezionale è la rappresentazione en face di uomini maturi: CAT 1.457, 1.460,1.947, 1.970, 1.981; Himmelmann 1999, pp. 137-140, figg. 54-55.
9 CAT 2.426b, 2.431, 2.432a, 2.433, 2.464, 2.909, 3.284, 3.388, 3.457, 4.235. Su ta-le tipologia di rappresentazione: Himmelmann 1999, pp. 60-64, 108; Huber2001, pp. 153-154.
10 CAT 3.285, 3.342, 3.343, 3.357, 3.368, 3.368b, 3.371b, 3.372a, 3.380, 3.381a,3.383c, 3.384, 3.386c, 3.387, 3.389b, 3.390a, 3.394b, 3.397a, 3.398, 3.404a, 3.405a,3.407, 3.407a, 3.408, 3.414a, 3.415a, 3.416, 3.418, 3.421, 3.423, 3.457a, 3.458, 3.460,3.467, 3.861, 3.862, 3.895, 3.911, 4.381, 4.384, 4.415, 4.417, 4.424, 4.431, 4.438, 4.440,4.446, 4.472, 4.950, 5.450, 5.480, 6.905.
Fig. 2. Atene, Museo Nazionale. Bildfeldstele (inv. n. 1985).
32 elena ghisellini
rio della Penelope, creato intorno al 460 a.C.,1 e quella stante,utilizzata prevalentemente per figure femminili, che sonorappresentate con un avambraccio che attraversa orizzontal-mente il torace e l’altro sollevato verso il viso, con la manoportata alla guancia o al mento (c.d. Peliadenpose).2
Ben presto il gesto acquisisce anche un’accezione funera-ria e dalla fine del v secolo a.C. viene frequentemente ripro-posto sui monumenti sepolcrali attici, che lo riservano per lopiù a immagini di ancelle o di congiunte, quasi sempre stanti,che di solito sono effigiate di profilo ai margini della compo-sizione, ovvero in posizione frontale al centro di essa.3 Saltua-riamente assumono tale posa personaggi maschili, ritratti da
soli (cfr. infra) o in scene a più figure, come nel caso del vec-chio Tolmides, il quale, su una stele nel Museo Nazionale diAtene, inv. n. 749 (Fig. 3),4 è testimone della tragica mortedella figlia durante il parto.
Il successo del motivo dipende dalla sua adattabilità ai piùdifferenti contesti, al cui interno si colora di molteplici sfu-mature di significato, esprimendo di volta in volta sentimentimutevoli: meditazione, turbamento, ansiosa incertezza, cor-ruccio, ma anche, in ambito funerario, afflizione, cordoglio.Come si è giustamente osservato, proprio la ricchezza semantica implicita nel gesto lo rende idoneo a tradurre visi-vamente la complessità delle reazioni umane dinanzi al co-mune, ineluttabile destino di morte.5 Inoltre la pacata com-postezza dell’atteggiamento ben si accorda con lo spiritodominante nell’arte funeraria attica di epoca classica, che ri-fugge dalle manifestazioni plateali del dolore, tipiche del pe-riodo arcaico,6 a favore di una sobrietà e semplicità dei gestiche è anche segnale di una consapevole interiorizzazione dellutto. Tanto sereno distacco rispecchia un nuovo codice dicomportamento, che dagli inizi del v secolo a.C. si impone,favorito da disposizioni legislative, nella vita come nell’arte,codice che esige un rigoroso autocontrollo delle emozioni eche diviene vincolante per il buon cittadino, mentre le donne,i bambini, i servi possono più liberamente dare sfogo ai propri sentimenti.7 Per tali categorie sociali la trascrizione figurativa dei moti dell’animo sui monumenti sepolcrali puòessere perciò più esplicita e fare persino ricorso a una certaenfasi dei gesti, come nel caso di una trapeza funeraria da Atene,8 che mostra su un lato una parente del defunto che siabbandona al pianto coprendosi il volto con un braccio, azione che ritorna nell’immagine di una ancella che assistepiangendo alla morte per parto della padrona su una lekythosnella Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen, inv. n. 2564.9
Sulla stele in esame il Trauergestus è compiuto dal defuntostesso, un uomo ancora giovane, che esterna il proprio penthos per la morte sopraggiunta anzitempo. Il tema del de-funto affranto per la propria sorte ricorre con una certa insi-stenza sulle lekythoi attiche a fondo bianco, che spesso ripro-ducono il protagonista, generalmente una figura femminile,seduto sui gradini della tomba in posa riflessiva e malinconi-ca, con lo sguardo abbassato e il mento sorretto da una ma-no; eccezionalmente il lutto si estrinseca con gesti veementi,di tradizione arcaica, come quello di strapparsi i capelli.10 Suimonumenti funerari in pietra i defunti di norma non lascianotrapelare apertamente la propria afflizione, che può esseresuggerita in termini allusivi dall’inclinazione del capo, dalvolto adombrato da un velo di tristezza, dal calmo ripiega-mento su se stessi. Non numerosi sono i rilievi sui quali il
1 Jacobsthal 1931, pp. 74, 165, 192-198; Kenner 1960, pp. 26, 28-30; Set-tis 1975, pp. 12-16 (con analisi della fortuna della formula nei secoli); ParisiPresicce 1999; Balty 2000 (pp. 12-17: fortuna del motivo nell’arte moder-na); Huber 2001, pp. 22, 123-124, 206-207; Pasquier 2005, p. 42; Sojc 2005,pp. 77-82, 138; Franzoni 2006, pp. 113-119 (pp. 148-152: fortuna del tipo ico-nografico).
2 Kenner 1960, pp. 30-33; Huber 2001, pp. 124-125; Franzoni 2006, pp.145-148.
3 L’elenco seguente, puramente esemplificativo, concerne solo il gestodella guancia poggiata su una mano, non prendendo in considerazione gestisimili (come quello, tipicamente femminile, della mano portata all’altezzadella spalla o del collo a sollevare un lembo del mantello, su cui cfr. Cavalier1989-1990, pp. 17-24), che veicolano differenti sfumature di significato. Ancel-la: CAT 6, 1.894, 2.186, 2.243, 2.298, 2.315b, 2.353, 2.705, 2.850, 3.265, 3.284, 3.309,3.326, 3.339a, 3.345, 3.374, 3.379, 3.396c, 3.922, 4.415, 4.417, 4.431, 4.438, 4.467, 4.850,4.910, 5.380. Congiunta: CAT 12, 2.337, 2.343c, 2.386, 2.870b, 2.909, 3.244, 3.252,3.282, 3.289, 3.319, 3.325, 3.334, 3.348, 3.356b, 3.359b, 3.360, 3.370b, 3.371a, 3.380a,3.381b, 3.382b, 3.386b, 3.388, 3.390, 3.391, 3.416b, 3.418b, 3.419, 3.425a, 3.437, 3.441,3.441a, 3.449, 3.454, 3.465a, 3.466, 3.471, 3.827, 3.881, 3.920, 3.970, 4.120, 4.190,4.206, 4.367, 4.371, 4.423, 4.439, 4.680, 4.930. Sulla diffusione e sul significato delgesto sui rilievi funerari attici: Kenner 1960, pp. 46-47; Neumann 1965, pp.125-136, 149-152 (lo studioso analizza una serie di gesti affini e tenta di decodi-ficarne le accezioni contenutistiche, giungendo a una classificazione eccessi-vamente rigida); CAT, Intr., pp. 110-115; Bergemann 1997, pp. 56-59, 67, 88, 126-
127, 145, 225-226, Anhang 4,1 (l’autore riconosce contenuto emozionale soltan-to al gesto in esame e a quello, tipicamente maschile, di portare di slancio lamano sulla testa, ma al riguardo si vedano le obiezioni, del tutto condivisibili,di Himmelmann 1999, pp. 114-115 e Papini 2003, pp. 74-78); Huber 2001, pp.29, 151-159, 167, 205-212; Hoffmann 2006, p. 62.
4 CAT 4.470; Scholl 1996, pp. 243-244, n. 67, tav. 42,1; Huber 2001, pp. 155,231, n. 250, fig. 20. Si vedano inoltre CAT 1.330, 1.353, 2.273a, 3.371c, 3.375c,3.406a, 3.463, 4.219.
5 Franzoni 2006, p. 144. Un’interessante chiave di lettura del gesto è sug-gerita da Cirucci 2007, pp. 19-34.
6 Un significativo mutamento si avverte nell’opera di Exekias, che in unascena dipinta sui pinakes funerari ora a Berlino ritrae una figura femminilecaratterizzata da nuovi Trauergesten, improntati a un misurato riserbo: la te-sta, velata dal mantello, si inclina dolente ed è sorretta dalla mano, posta sot-to il mento. Vd. Kenner 1960, p. 14; Mommsen 1997, pp. 55-59, F 1813, tav. xv;Huber 2001, pp. 96-97, 220-221, n. 85.
7 Kenner 1960, pp. 44, 52; Huber 2001, pp. 205-206; Polojiorghi 2003,p. 108; Franzoni 2006, pp. 186-187; Maderna 2011, p. 65.
8 Atene, Agorà Romana, Fethiye-Moschee, inv. n. 1955-nam 90: CAT 10;Polojiorghi 2003. Cfr. Appendice, n. 1.
9 CAT 2.917; Koch-Brinkmann, Posamentir 2004a.10 Neumann 1965, pp. 136-140; Shapiro 1991, in particolare pp. 652-653;
Huber 2001, pp. 136-145; Oakley 2004, in particolare pp. 152-158; Maderna2011, pp. 49, 58.
Fig. 3. Atene, Museo Nazionale. Stele funeraria (inv. n. 749).
una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano 33
defunto si lascia andare allo sconforto per avere abbandonatoil mondo dei vivi.1 La serie si apre, intorno alla metà del v se-colo a.C., con un piccolo esemplare da Geronthrai (Appen-dice, n. 15, Fig. 4), nei pressi di Sparta, che effigia un giova-netto seduto, con il busto piegato in avanti, la testaviolentemente inclinata a poggiare la fronte su una mano,2atteggiamento colmo di disperazione, che è ostentata in ma-niera drammatica e diretta. Analoga drammaticità, peraltrorara nell’arte attica, che tende a stemperare l’espressione deisentimenti entro formule misurate e composte, pervade unastele del secondo venticinquennio del iv secolo a.C. (Appen-dice, n. 9, Fig. 5), su cui una figura femminile, Eutychis, vol-ge lo sguardo verso il giovane Moschion, il quale, seduto eparzialmente avvolto nel mantello, in preda all’angoscia cur-va il torace in avanti e sostiene la testa con una mano portataall’altezza della tempia. Il motivo della mano portata allatempia per sorreggere la testa fortemente inclinata ricompa-re in un certo numero di stele (Appendice, nn. 6, 10-14), di di-verso formato e qualità, che immortalano un efebo nudo, chesi appoggia a un pilastrino o a una loutrophoros, con le gambeaccavallate l’una sull’altra; il giovane, il cui tipo iconografico,derivante da un modello eroico, è adottato con varianti nellacelebre stele dell’Ilisso, può essere accompagnato dal padre oda entrambi i genitori (Fig. 6) e, negli esemplari di maggiori
dimensioni, è caratterizzato come atleta dalla presenza diuno schiavetto, che dorme accoccolato ai suoi piedi.3 Unasingolare scelta iconografica è operata in un rilievo del Mu-seo Nazionale di Atene (Appendice, n. 2), che riproduce ilgiovane oplita Demokleides seduto sul ponte di una nave,nell’atto di fissare sconsolato i flutti fra i quali ha perso la vita,con la guancia posata sul palmo della mano: la scena, che esu-la dal repertorio consueto, è stata appositamente elaborataper rievocare il tragico destino di morte del protagonista, vit-tima di un naufragio.4 Più enfatico è l’atteggiamento di undefunto ritratto su un lato di una trapeza funeraria (Appen-dice, n. 1), già menzionata: il giovane volge di prospetto ilcorpo, drappeggiato nel mantello, e si dispera portando dislancio una mano sulla testa.
Nella maggior parte dei casi, come è del resto logico aspet-tarsi, il defunto che piange la propria sorte è un giovane, rapitodalla morte nel fiore degli anni, mentre solo episodicamentesono raffigurati uomini maturi o di età avanzata. L’unica rappresentazione sicura5 è restituita da una modesta Bildfeld-stele del Museo Nazionale di Atene (Appendice, n. 5, Fig. 7),che mostra un uomo anziano, stante di tre quarti verso sini-stra, che accosta alla guancia la mano destra sollevata: per ilgesto, l’impostazione del corpo, l’assetto dell’himation, la figu-ra risulta del tutto simile al protagonista della nostra stele.
Non mancano infine esempi di defunte che lamentano lapropria sorte. Il tema, poco comune nel repertorio attico,sembra invece godere di un certo favore nella produzione diambiti regionali periferici, trovando le prime attestazioni indue stele di fattura provinciale (Appendice, nn. 16-17) prove-nienti da Sinope e databili intorno al 450 a.C., che immorta-lano la defunta seduta, con la testa inclinata e il mento pog-giato sulla mano sinistra. Nelle figure femminili il dolore siesprime con gesti più pacati e contenuti, che risultano sog-getti a una forte standardizzazione: la defunta, stante o piùspesso seduta, porta una mano al volto, che è inclinato e ta-lora si presenta in veduta frontale (Appendice, nn. 3, 4, 18, 19,20, 22); in un caso la mestizia si manifesta nella testa abbassatae nel gesto delle mani intrecciate in grembo (Appendice, n.21).6 Possono accompagnare la protagonista una o più figure
1 I rilievi sono elencati nell’Appendice, a cui si rinvia anche per la biblio-grafia. In generale, sulla rappresentazione del defunto afflitto si vedano Him-melmann-Wildschütz 1956, p. 17; Kenner 1960, pp. 46-47; Franzoni2006, pp. 205-206; Maderna 2011, pp. 62-63.
2 Sul gesto e il suo contenuto emozionale: Neumann 1965, pp. 141-148;Franzoni 2006, pp. 107-113.
3 Himmelmann-Wildschütz 1956, pp. 27-28; Kokula 1984, pp. 55-60;Scholl 1996, p. 134; Himmelmann 1990, pp. 106-114; Himmelmann 1999, pp.86, 106-108 con nota 132, p. 115, nota 142; Himmelmann 2000, p. 139 (negli ultimi due testi di Himmelmann è menzionato un naiskos inedito al Pireo, lacui figurazione rientra nella serie in esame). Lo stesso schema iconografico
è utilizzato su una stele del Museo di Maratona, inv. be14 (CAT 1.953), ma inquesto caso il giovane solleva la mano destra verso la testa stringendo fra ledita un lembo del mantello.
4 La posa di Demokleides è ripresa in età ellenistica da una serie di rilievimicroasiatici, che rappresentano giovani defunti seduti su una roccia, taloraaccanto alla prora di una nave: Pfuhl-Möbius 1977, i, p. 216, nn. 823-828, tav.120; Huber 2001, pp. 192-193; Cirucci 2007, pp. 25-27.
5 Due ulteriori, possibili esempi sono ricordati nell’Appendice, nn. 7-8,ma in entrambi i casi la lettura delle scene non è univoca.
6 Sul gesto cfr. infra.
Fig. 5. Atene, Museo Nazionale. Stele funeraria (inv. n. 3697).
Fig. 4. Sparta, Museo. Rilievo funerario laconico.
34 elena ghisellini
femminili, ancelle o parenti, che partecipano del suo dolorecon un sobrio linguaggio dei gesti.
La bambina raffigurata nella metà sinistra della stele inesame ripete uno schema iconografico ben collaudato sui ri-lievi funerari attici, che lo utilizzano per fanciulli di diverseetà e di entrambi i sessi.1 La differenziazione fra i sessi è affi-data all’abbigliamento, che prevede per i bambini il solo man-tello, avvolto intorno alla parte inferiore del corpo sì da la-sciare nudi il petto e una spalla, mentre le bambine indossanol’himation sopra un chitone a maniche corte. Lo schema fa lasua comparsa nelle ultime decadi del v secolo a.C. ed è atte-stato in scene a due o più figure durante tutto il iv secoloa.C., con particolare frequenza nella sua prima metà. Nellecomposizioni a due figure il bambino è posto dinanzi a unadulto stante o seduto, identificabile con il padre, la madre,in un caso un fratello maggiore, verso il quale protende unbraccio. Fra bambino e adulto si crea talora un rapporto dia-
logico: i due si guardano negli occhi e si scambiano un ogget-to, abitualmente un uccellino, che l’uno dà amorevolmenteall’altro.2 Su una stele nel Museo Nazionale di Atene, inv. n.778 (Fig. 8),3 un uomo maturo seduto, Euempolos, con la de-stra offre un volatile al bambino, che allunga una mano toc-cando l’indice della mano sinistra del genitore, gesto colmodi tenerezza, che nella sua quotidiana semplicità è capace dievocare l’intensa carica affettiva che lega padre e figlio, infon-dendo alla scena un tono di malinconica intimità. A volte fraadulto e fanciullo non c’è comunicazione: così su un rilievo aBaltimora, The Walters Art Gallery, inv. n. 23.176,4 un bambi-no porge un uccellino alla madre defunta, che però ignora ilgesto del figlio, essendo assorta nella contemplazione di unneonato che stringe fra le braccia. Su una stele nel Museo Na-zionale di Atene, inv. n. 1896 (Fig. 9),5 datata nel primo ven-ticinquennio del iv secolo a.C., un bambino offre un volatilea una giovane donna, che non contraccambia la sua attenzio-ne e rimane chiusa in se stessa; come nel nostro esemplare,la defunta è colta in veduta frontale, con la testa appena incli-nata su un lato, irreparabilmente distante dal fanciullo, checon il suo gesto premuroso cerca invano di entrare in contat-to con lei.6 In maniera analoga nelle composizioni a più figu-re ora il bambino stabilisce una relazione con il defunto, at-traverso lo scambio degli sguardi e la reciprocità dei gesti(Fig. 10), ora invece il suo gesto non trova risposta, il che po-ne maggiormente in evidenza l’isolamento del defunto e ilsuo distacco dal mondo dei vivi.7
1 Sulle rappresentazioni di bambini sui monumenti sepolcrali attici:Stupperich 1977, pp. 111-112; Hirsch-Dyczek 1983, in particolare pp. 12-13(classificazione dei tipi di rappresentazioni dei bambini e degli schemi com-positivi delle scene in cui compaiono bambini), 18-57 (stele di epoca classica);Vorster 1983, pp. 1-47; Scholl 1996, pp. 115-117, 124; Grossman 2007; Oa-kley 2009, pp. 208-213 (lekythoi a fondo bianco), 213-231 (stele funerarie).
2 CAT 0.789 (bambino con giovanetto, identificabile con un fratello); 1.786(bambino davanti alla madre seduta).
3 CAT 1.690 (alle spalle del bambino si trova la sorella stante, che assiste al-la scena).
4 CAT 1.714. 5 CAT 1.721.6 Abbiamo qui un tipico esempio di quella che Himmelmann ha efficace-
mente definito “Trennung in der Verbundenheit”, che può dirsi un tratto distintivo delle scene sui rilievi funerari: Himmelmann-Wildschütz 1956,pp. 18-19; Himmelmann 1999, p. 80.
7 CAT 2.630 (Fig. 10), 2.670, 2.777, 2.801a, 2.834 (bambino nello schema inesame, ma con il corpo nudo), 2.844b, 2.871a, 2.914, 3.727. Lo schema è statoassimilato anche in ambienti periferici, come attesta una stele funeraria daMagnesia, conservata nel Ginnasio di Ajà, inv. n. 17: Biesantz 1965, pp. 11-12,n. 15, tavv. 13-14.
Fig. 6. Atene, Museo del Ceramico. Bildfeldstele (inv. nn. P1137 e I 183).
Fig. 7. Atene, Museo Nazionale. Bildfeldstele (inv. n. 1010)(da A. Conze, Die attischen Grabreliefs, iii, Berlin, 1906,
n. 911, tav. clxxx).
una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano 35
Il giovanetto stante a destra di Kleophon riprende unoschema iconografico che è adoperato su un numero abba-stanza ristretto di rilievi funerari per la rappresentazione diun servitore.1 Si tratta solitamente di scene a due figure chemostrano lo schiavetto nudo, posto di profilo o di tre quartiaccanto al suo padrone, usualmente un efebo (Fig. 11), di ra-do un bambino o un uomo maturo, verso cui indirizza losguardo, sollevando leggermente la testa; eccezionalmentesu un naiskos del Museo di Budapest, inv. n. 6359, il pais, quicon la testa girata di prospetto, compare in una composizio-ne a tre figure, al centro fra il padrone e la sua sposa.2 Lo sche-ma ammette una variante nel movimento della gamba libera,che può essere avanzata ovvero incrociata su quella portante,postura che conferisce al corpo una maggiore scioltezza rit-mica.
L’immagine dello schiavo si canonizza sui monumenti fu-nerari attici al passaggio fra v e iv secolo; raffigurato comebambino o come adolescente, nudo oppure vestito di exomis,corto chitone o mantello, comunemente reca gli attributi delpadrone, che può essere connotato come palestrita, cacciato-re o guerriero.3 Nella maggioranza degli esempi il defuntocorredato da un pais è un efebo, spesso effigiato nudo e carat-terizzato come atleta, ma il servitore può anche rapportarsia un uomo barbato, avvolto nel mantello,4 che talora è mu-nito di attributi allusivi alla sfera atletica, talora è privo di at-tributi e rappresentato nei panni del polites. In tutti i casi loschiavetto possiede una funzione essenzialmente attributivae sottolinea con la sua presenza il rango sociale e la ricchezzadel protagonista e della sua famiglia.
Alla luce di quanto esposto sembra probabile che nel gio-vanetto stante accanto a Kleophon si debba individuare un
pais, piuttosto che un figlio del defunto. Parrebbero confer-marlo, in aggiunta allo schema iconografico, che si direbbeesclusivo dei servitori, la nudità, che difficilmente è adottataper i giovani liberi, ove non siano ritratti come atleti, e soprat-tutto le dimensioni, che sono eccessivamente ridotte in rapporto alla presumibile età del personaggio, che ha formecorporee slanciate e sode, tipiche dell’adolescenza. Tale con-statazione trova conforto nel principio della Bedeutungsgroße,che domina l’iconografia attica degli schiavi in epoca classicae che comporta che il pais possa essere rappresentato con unfisico ben sviluppato, ma sempre, indipendentemente dallasua età, di statura di gran lunga inferiore rispetto al padrone,sì da evidenziarne l’inferiorità sul piano sociale e culturale.5
La figura ha la sua nota distintiva nell’atteggiamento dellebraccia, che sono abbassate davanti al ventre, con una manoposata sull’altra, gesto che, insieme con quello analogo dellemani intrecciate, si incontra più volte sui monumenti sepol-crali attici del iv secolo a.C., sui quali figure maschili o fem-minili nella posa descritta sono riprodotte stanti accanto aldefunto, nell’atto di contemplarlo ovvero con la testa inclina-ta e lo sguardo abbassato. Ritroviamo la formula nel riccocampionario di pose offertoci dal sarcofago delle Piangenti,sul quale ricorre anche il gesto della mano portata alla guan-cia, compiuto da figure di ambo i sessi.6 Il significato del motivo delle mani intrecciate è stato indagato ripetutamente,soprattutto in rapporto alla sua redazione più felice, la statua
1 CAT 0.855a, 1.810, 1.826. 1.856 (Fig. 11), 1.880, 1.933.2 CAT 2.957.3 Sulla figura del servitore nel repertorio funerario attico: Stupperich
1977, pp. 110-111; Hirsch-Dyczek 1983, pp. 54-55; Vorster 1983, p. 10; Scholl1996, p. 126; Grossman 2007, pp. 318-320.
4 CAT 1.873 1.874, 1.933, 1.945, 1.947, 2.751, 2.790, 2.819, 2.824, 2.856, 2.870a,2.883a, 2.886, 2.889, 2.893, 2.923, 2.957, 3.694, 3.776, 3.827, 3.845, 3.859, 3.861,3.922. Cfr. Bergemann 1997, pp. 72-73.
5 Himmelmann 1971, pp. 27, 41; Thalmann 2011, p. 82; Wrenhaven 2011,pp. 105-107, 111.
6 Fleischer 1983, pp. 34-40, piangenti con mani intrecciate: p. 36, B3, C1,tavv. 26, 30; piangenti con mano accostata al viso: p. 36, A6, tav. 23; pp. 44-54(balaustrata), figura maschile con mani intrecciate: B7, tav. 37,2; figura maschi-le con mano portata al viso: B1, tav. 36,1; pp. 54-55 (fregio sui lati brevi, sopra irampanti frontonali), personaggi maschili barbati, seduti a terra, con manoportata al volto: C2 e D2, tavv. 40.1, 41.1; pp. 58-59 (frontoni), figure femminilisedute con mano portata al viso: tavv. 42-43. Cfr. Huber 2001, pp. 158-159.
Fig. 9. Atene, Museo Nazionale. Stele funeraria (inv. n. 1896).
Fig. 8. Atene, Museo Nazionale. Stele funeraria (inv. n. 778).
36 elena ghisellini
di Demostene; scarsa attenzione si è però prestata alla possi-bile differenza semantica fra le mani intrecciate e le manipoggiate l’una sull’altra.1 È del tutto verosimile che il motivoimplichi una vasta gamma di sfaccettature contenutistiche,mutevoli a seconda del contesto; le sue modalità di utilizzoin ambito funerario invitano a ritenere che possa annoverarsifra i Trauergesten, risultando idoneo a veicolare nozioni di ri-flessione sull’umano destino e di contenuta afflizione.
Dall’analisi condotta si ricava che sulla nostra stele ci si èavvalsi per le singole figure di tipi iconografici ben consolidatinella tradizione funeraria attica. Insolita è tuttavia la lorocombinazione, che rimane al momento priva di confronti: siconservano infatti monumenti che raffigurano un uomo ma-turo stante in associazione con un bambino o una bambina,2oppure seduto e accompagnato da due figli in tenera età, co-me nel caso della già ricordata stele di Euempolos (Fig. 8),3ma non si conoscono altri rilievi che immortalano il defuntocon una figlia e con un servitore. È chiaro perciò che lo sche-ma compositivo della scena deve essere stato elaborato pervenire incontro alle specifiche esigenze di rappresentazionedell’acquirente, desideroso di porre l’accento sullo status so-ciale elevato, comprovato dallo schiavetto, e nel contempo
interessato ad alludere, con la presenza della bambina, allaprossima generazione della famiglia, alla quale spettava ilcompito fondamentale di praticare il culto funerario per i ge-nitori scomparsi.4 A ciò si aggiunga che la bambina evoca unasfera affettiva a cui Kleophon ha dovuto rinunciare per sem-pre e inoltre, con il suo vano tentativo di relazionarsi al padre,rende tangibile la invalicabile frattura che ormai separa il de-funto dal mondo dei vivi.
Dal punto di vista compositivo la figura del pais fa da con-trappunto all’immagine della fanciulla, nella statica comenell’atteggiamento, carico di dolente concentrazione quellodel servitore, più vivacemente mosso quello della bambina,che con il gesto del braccio sollevato guida lo sguardo dell’os-servatore in direzione del defunto. Entrambi i personaggi sirivolgono di profilo verso il centro, con la testa sollevata, egiocano un ruolo essenziale nel mettere in risalto la figura delprotagonista, il quale, chiuso nel suo isolamento, campeggianel mezzo e, offrendosi alla vista di prospetto, sollecita la partecipazione emotiva dello spettatore al suo dolore per laperdita della vita e per il distacco dagli affetti più cari.
La stesura della scena, per quanto efficace sul piano espres-sivo, calibra con scarso equilibrio la distribuzione delle figure
1 Dohrn 1955, pp. 55-73 (lo studioso analizza una serie di varianti del ge-sto); Kenner 1960, pp. 34, 49-50; Settis 1975, pp. 4-12; CAT, Intr., p. 112 (cfr.CAT, vi, pp. 112-113); Zanker 1995, pp. 85-89 (l’autore nega alla posa il valoredi Trauergestus, ritenendo che esprima calma e autocontrollo); Fittschen2001, pp. 330-332; Huber 2001, pp. 156, 207.
2 CAT 1.687, 1.689, 1.713, 1.715, 1843.
3 CAT 1.630, 1.690. Su un rilievo frammentario da Kos, di fattura ionica maesemplato su modelli attici, è effigiato un personaggio maschile seduto, conuna bambina fra le ginocchia, alle cui spalle rimane parte della gamba di ungiovane stante, che Clairmont identifica con il figlio del defunto, sebbenenon si possa escludere che si tratti di un pais: Pfuhl, Möbius 1977, p. 25, n.55, tav. 15; CAT 2.717.
4 Cfr. al riguardo Vorster 1983, p. 28; Scholl 1996, p. 124.
Fig. 10. Atene, Museo Nazionale. Lekythos (inv. n. 810). Fig. 11. Calcide, Museo. Stele funeraria (inv. n. 11).
una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano 37
ai lati del protagonista, sicché il servetto risulta troppo addos-sato al suo padrone, con cui compone quasi una massa uni-taria, saldandosi alla rigida ricaduta verticale delle pieghe delmantello. Del resto anche il rendimento delle forme rivela al-cune sordità, per cui le figure appaiono piuttosto legnose, pri-ve di vita e connotate da proporzioni un po’ disarmoniche,come è palese nell’estrema sottigliezza dell’avambraccio de-stro di Kleophon in rapporto all’eccessivo sviluppo della spal-la sinistra; un certo impaccio si avverte poi nella resa frontaledel volto, dai lineamenti poco più che accennati. L’immaginedi Kleophon trova un buon confronto in quella del giovanePrikon, che è rappresentato, in compagnia del suo cane, sullastele, già ricordata, del Museo Nazionale di Atene, inv. n. 730,datata nel primo venticinquennio del iv secolo a.C.1 Presso-ché identico risulta lo schema iconografico, ove si eccettui ilfatto che Prikon stringe uno strigile nella mano destra solle-vata e ha la testa impostata di tre quarti; del tutto simile è l’as-setto dell’himation, le cui pieghe sottili accompagnano edesaltano il ritmo del corpo: un fascio di pieghe oblique corredalla gamba sinistra flessa al fianco destro, corrispondente al-la gamba portante, la cui funzione statica è ribadita dalla ver-ticalità della piega a cannello ricadente accanto ad essa; un ro-tolo di limitato spessore, solcato da fini pieghe concentriche,attraversa il torso ponendo in evidenza l’espansione dei pet-torali, tesi e asciutti quelli di Prikon, più morbidi e rilassatiquelli di Kleophon. Motivi di raffronto si individuano inoltrenel rilievo del decreto di symmachia fra il demos di Kerkyra eAtene (Fig. 12),2 che mostra un’affine complementarietà frastruttura corporea e panneggio e un analogo rapporto tra ilfondo e le immagini, che si stagliano su di esso di prospettoo di tre quarti, delimitate da contorni nitidamente segnati.
Il rilievo citato si riconduce al 376-375 a.C.; intorno agli stes-si anni si può verosimilmente datare anche la nostra stele, checostituisce un esempio emblematico di come gli scultori atti-ci, con consumata padronanza del mestiere, fossero in gradodi arricchire e trasformare il proprio repertorio attraversoabili variazioni e sempre nuove combinazioni di ben speri-mentati tipi iconografici, giungendo alla creazione di prodot-ti di volta in volta diversi, capaci di soddisfare le svariate ri-chieste della committenza.
Abbreviazioni bibliografiche
Balty 2000 = J. Ch. Balty, Pénélope. Notes sur la diffusion d’un typeiconographique, in Agathòs Daimon, Mythes et cultes. Études d’icono-graphie en l’honneur de Lilly Kahil, «bch» Suppl., 38, Athènes, 2000,pp. 9-18.
Bergemann 1997 = J. Bergemann, Demos und Thanatos. Untersu-chungen zum Wertsystem der Polis im Spiegel der attischen Grabreliefsdes 4. Jahrhunderts v.Chr. und zur Funktion der gleichzeitigen Grab-bauten, München, 1997.
Biesantz 1965 = H. Biesantz, Die thessalischen Grabreliefs, Mainz,1965.
Brinkmann 2004 = V. Brinkmann, Einführung in die Ausstellung.Die Erforschung der Farbigkeit antiker Skulptur, in Brinkmann,Wünsche 2004, pp. 25-34.
Brinkmann, Wünsche 2004 = Bunte Götter. Die Farbigkeit antikerSkulptur, Ausstellung München 2003-2004, a cura di V. Brin-kmann, R. Wünsche, München, 2004 (traduzione italiana: I coloridel bianco. Policromia nella scultura antica, Città del Vaticano- Roma, 2004).
CAT = Ch.W. Clairmont, Classical Attic Tombstones, i-vi + Intro-ductory Vol. (CAT, Intr.) e Supplementary Vol. (CAT, Suppl.), Kil-chberg, 1993-1995.
Cavalier 1989-1990 = O. Cavalier, La stèle des adieux. Jamais plustoujours, «CahMariemont», 20-21, 1989-1990, pp. 6-24.
Cirucci 2007 = G. Cirucci, Considerazioni su alcuni rilievi funeraridi età ellenistica da Efeso, in Lo sguardo archeologico. I normalisti perPaul Zanker, a cura di F. de Angelis, Pisa, 2007, pp. 19-34.
Clair 2005 = Mélancolie génie et folie en Occident, Mostra Paris-Ber-lin, 2005-2006, a cura di J. Clair, Paris, 2005.
Corsten, Catling, Ricl 2010 = A Lexicon of Greek Personal Names, vA. Coastal Asia Minor: Pontos to Ionia, a cura di T. Cor-sten, R. W. V. Catling, M. Ricl, Oxford, 2010.
Despinis 1967 = G. Despinis, Kykladische Grabstelen des 5./4. Jh. v.Chr., «AntPl», vii, Berlin, 1967, pp. 77-86.
Despinis, Stefanidou Tiveriou, Voutiras 1997 = G. Despi-nis, Th. Stefanidou Tiveriou, Em. Voutiras, Catalogue ofSculpture in the Archaeological Museum of Thessaloniki, i, Thessalo-niki, 1997.
Dohrn 1955 = T. Dohrn, Gefaltete und verschränkte Hände. EineStudie über die Gebärde in der griechischen Kunst, «JdI», 70, 1955, pp.50-80.
Ensoli 1987 = S. Ensoli, L’Heroon di Dexileos nel Ceramico di Atene.Problematica architettonica e artistica attica degli inizi del iv secoloa.C.,«MemLinc», Serie viii, xxix, 1987, pp. 155-329.
Fittschen 2001 = K. Fittschen, Zur Mantelstatue aus dem Heraionvon Samos, in òAÁ·ÏÌ·. MÂϤÙ˜ ÁÈa ÙcÓ àÚ¯·Ö· Ï·ÛÙÈÎc Úe˜ÙÈÌcÓ ÙÔÜ °ÈfiÚÁÔ˘ ¢ÂÛ›ÓË, Thessaloniki, 2001, pp. 325-332.
Fleischer 1983 = R. Fleischer, Der Klagefrauensarkophag aus Sidon, «IstForsch», 34, Tübingen, 1983.
Förtsch 2001 = R. Förtsch, Kunstverwendung und Kunstlegitima-tion im archaischen und frühklassischen Sparta, Mainz, 2001.
Franzoni 2006 = C. Franzoni, Tirannia dello sguardo. Corpo, gesto, espressione nell’arte greca, Torino, 2006.
Fraser, Matthews 1987 = A Lexicon of Greek Personal Names, i. TheAegean Islands Cyprus Cyrenaica, a cura di P. M. Fraser, E.Matthews, Oxford, 1987.
Fraser, Matthews 1997 = A Lexicon of Greek Personal Names, iiiA.The Peloponnese Western Greece Sicily and Magna Graecia, a cura diP.M. Fraser, E. Matthews, Oxford, 1997.
Fraser, Matthews 2000 = A Lexicon of Greek Personal Names, iiiB.Central Greece from Megarid to Thessaly, a cura di P. M. Fraser, E.Matthews, Oxford, 2000.
Friis Johansen 1951 = K. Friis Johansen, The Attic Grave-Reliefsof the Classical Period. An Essay in Interpretation, Copenhagen,1951.
Grossman 2001 = J. B. Grossman, Greek Funerary Sculpture. Cat-alogue of the Collections at the Getty Villa, Los Angeles, 2001.
Grossman 2007 = J. B. Grossman, Forever Young: An Investigationof the Depictions of Children on Classical Attic Funerary Monuments,in Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy, a cura diA. Cohen, J.B. Rutter, «Hesperia», Supplement 41, Princeton,2007, pp. 309-322.
Hamiaux 1992 = M. Hamiaux, Musée du Louvre. Les sculpturesgrecques i. Des origines à la fin du ive siècle avant J.-C., Paris, 1992.
Himmelmann 1971 = N. Himmelmann, Archäologisches zum Pro-blem der griechischen Sklaverei, «AbhMainz», 13, 1971.
Himmelmann 1990 = N. Himmelmann, Ideale Nacktheit in dergriechischen Kunst, «JdI», 26. Ergh., Berlin-New York, 1990.
1 CAT 1.201. 2 Atene, Museo Nazionale, inv. n. 1467: Meyer 1989, p. 280, A 51, tav. 16,2;Lawton 1995, pp. 126-127, tav. 50 (ivi datato al 375-374 a.C.).
Fig. 12. Atene, Museo Nazionale. Rilievo di decreto (inv. n. 1467).
38 elena ghisellini
Himmelmann 1999 = N. Himmelmann, Attische Grabreliefs,«Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträ-ge G 357», Opladen/Wiesbaden, 1999.
Himmelmann 2000 = N. Himmelmann, Quotations of Images ofGods and Heroes on Attic Grave Reliefs of the Late Classical Period, inPeriplous. Papers on Classical Art and Archaeology presented to SirJohn Boardmann, a cura di G. R. Tsetskhladze, A. J. N. W. Prag, A.M. Snodgrass, London, 2000, pp. 136-144.
Himmelmann-Wildschütz 1956 = N. Himmelmann-Wil-dschütz, Studien zum Ilissos-Relief, München, 1956.
Hirsch-Dyczek 1983 = O. Hirsch-Dyczek, Les représentations desenfants sur les stèles funéraires attiques, «PraceA», 34, 1983, pp. 3-57.
Hoffmann 2006 = G. Hoffmann, Ordre et variété dans la gestuelledes monuments funéraires attiques de l’époque classique, in L’expres-sion des corps. Gestes, attitudes, regards dans l’iconographie antique,a cura di L. Bodiou, D. Frère, V. Mehl, Rennes, 2006, pp. 61-74.
Huber 2001 = I. Huber, Die Ikonographie der Trauer in der grie-chischen Kunst, Mannheim am Möhnesee, 2001.
Jacobsthal 1931 = P. Jacobsthal, Die Melischen Reliefs, Berlin-Wilmersdorf, 1931.
Kenner 1960 = H. Kenner, Weinen und Lachen in der griechischenKunst, «SBWien», 234. Band, 2. Abhandlung, Wien, 1960.
Koch-Brinkmann, Posamentir 2004 = U. Koch-Brinkmann,R. Posamentir, Die Grabstele der Paramythion, in Brinkmann,Wünsche 2004, pp. 149-155.
Koch-Brinkmann, Posamentir 2004a = U. Koch-Brinkmann,R. Posamentir, Ornament und Malerei einer attischen Grableky-thos (Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen), in Brinkmann, Wün-sche 2004, pp. 157-165.
Kokula 1984 = G. Kokula, Marmorlutrophoren, «am», 10. Beih.,Berlin, 1984.
Kunze 2011 = Die Artemis von Pompeji und die Entdeckung der Farbig-keit griechischer Plastik, Ausstellung Stendal 2011-2012, a cura diM. Kunze, Mainz, 2011.
Lawton 1995 = C. L. Lawton, Attic Document Reliefs. Art and Politics in Ancient Athens, Oxford, 1995.
Maderna 2011 = C. Maderna, Tod und Leben an attischen Gräbernder klassischer Zeit, «Thetis», 18, 2011, pp. 40-68.
Meyer 1989 = M. Meyer, Die griechischen Urkundenreliefs, «am», 13.Beih., Berlin, 1989.
Meyer 1999 = M. Meyer, Gesten der Zusammengehörigkeit und Zuwendung. Zum Sinngehalt attischer Grabreliefs in klassischer Zeit,«Thetis», 5/6, 1999, pp. 115-132.
Mommsen 1997 = H. Mommsen, Exekias i. Die Grabtafeln, «Kera-meus», 11, Mainz, 1997.
Neumann 1965 = G. Neumann, Gesten und Gebärden in der grie-chischen Kunst, Berlin, 1965.
Oakley 2004 = J. H. Oakley, Picturing Death in Classical Athens.The Evidence of the White Lekythoi, Cambridge, 2004.
Oakley 2009 = J. H. Oakley, Children in Athenian Funerary Art during the Peloponnesian War, in Art in Athens during the Pelopon-nesian War, a cura di O. Palagia, Cambridge, 2009, pp. 207-235.
Osborne, Byrne 1994 = A Lexicon of Greek Personal Names, ii, Atti-ca, a cura di M. J. Osborne, S. G. Byrne, Oxford, 1994.
Papini 2003 = M. Papini, I rilievi funerari tardo-classici: un mondosenza emozioni e ambizioni eroiche?, «ArchCl», 54, 2003, pp. 69-96.
Parisi Presicce 1999 = C. Parisi Presicce, Penelope, in Odysseus.Mythos und Erinnerung, Ausstellung München 1999-2000, a curadi B. Andreae, Mainz, 1999, pp. 335-358.
Pasquier 2005 = A. Pasquier, Tristesse et mélancolie dans l’art grec,in Clair 2005, pp. 38-43.
Peek 1955 = W. Peek, Griechische Vers-Inschriften. i. Grabepigramme,Berlin, 1955.
Pfuhl, Möbius 1977 = E. Pfuhl, H. Möbius, Die ostgriechischenGrabreliefs, Mainz, 1977.
Polojiorghi 2003 = M. Polojiorghi, Neue Untersuchungen zu einem Grabmal des 4. Jahrhunderts v. Chr., «am», 117, 2003, pp. 91-114.
Posamentir 2006 = R. Posamentir, Bemalte attische Grabstelenklassischer Zeit, München, 2006.
Schild-Xenidou 2008 = V. Schild-Xenidou, Corpus der boioti-schen Grab- und Weihreliefs des 6. bis 4. Jahrhunderts v. Chr., «am»,20. Beih., Mainz, 2008.
Schmaltz 1983 = B. Schmaltz, Griechische Grabreliefs, Darmstadt,1983.
Schmaltz, Salta 2003 = B. Schmaltz, M. Salta, Zur Weiter-und Wiederverwendung attischer Grabreliefs klassischer Zeit, «JdI»,118, 2003, pp. 49-203.
Scholl 1996 = A. Scholl, Die attischen Bildfeldstelen des 4. Jhs. v.Chr. Untersuchungen zu den kleinformatigen Grabreliefs im spätklas-sischen Athen, «am», 17. Beih., Berlin, 1996.
Schweitzer 1963 = B. Schweitzer, Die Darstellung des Seelischenin der griechischen Kunst, in Zur Kunst der Antike. AusgewählteSchriften, i, Tübingen, 1963, pp. 316-334.
Settis 1975 = S. Settis, Immagini della meditazione, dell’incertezza edel pentimento nell’arte antica, «Prospettiva», 2, 1975, pp. 4-18.
Shapiro 1991 = H. A. Shapiro, The Iconography of Mourning inAthenian Art, «aja», 95, 1991, pp. 629-656.
Sojc 2005 = N. Sojc, Trauer auf attischen Grabreliefs. Frauendarstel-lungen zwischen Ideal und Wirklichkeit, Berlin, 2005.
Stibbe 1996 = C. M. Stibbe, Das andere Sparta, Mainz, 1996.Stupperich 1977 = R. Stupperich, Staatbegräbnis und Privatgrab-
mal im klassischen Athen, Münster, 1977.Thalmann 2011 = W. G. Thalmann, Some Ancient Greek Images
of Slavery, in Reading Ancient Slavery, a cura di R. Alston, E. Hall,L. Proffitt, London, 2011, pp. 72-96.
Vorster 1983 = Ch. Vorster, Griechische Kinderstatuen, Köln,1983.
Wrenhaven 2011 = K. L. Wrenhaven, Greek Representations ofthe Slave Body: A Conflict of Ideas?, in Reading Ancient Slavery, a cura di R. Alston, E. Hall, L. Proffitt, London, 2011, pp. 97-120.
Zanker 1995 = P. Zanker, Die Maske des Sokrates. Das Bild des Intellektuellen in der antiken Kunst, München, 1995.
una stele funeraria attica sul mercato antiquario romano 39
a. Rilievi di produzione attica
1. Trapeza funeraria, Agorà Romana, Fethiye-Moschee, inv. n. 1955-NAM 90.1
Su un lato del monumento, decorato da rilievi su tre facce, so-no rappresentati a partire da sinistra: una giovanetta in vedutafrontale, una figura femminile con la testa reclinata nell’atto diasciugarsi le lacrime con la mano destra, una matrona di dimen-sioni imponenti che si rivolge verso un giovane, posto a una cer-ta distanza, che porta con enfasi la mano destra alla testa. Secon-do l’interpretazione più verosimile il defunto può riconoscersinel giovane, che lamenta il proprio tragico destino alla presenzadella madre e, forse, di due sorelle.
Metà del iv secolo a.C.2. Stele di Demokleides, Atene, Museo Nazionale, inv. n. 752.2
Il giovane Demokleides siede sul ponte di una nave e contem-pla il mare, dove ha perso la vita, sostenendo la testa con la manodestra poggiata sulla guancia. Alle sue spalle sono lo scudo e l’elmo.
Secondo venticinquennio del iv secolo a.C.3. Frammento di stele, Paris, Musée du Louvre, inv. Ma 3266.3
Si conserva la testa di una giovane donna, rappresentata di trequarti verso destra, inclinata e sorretta dalla mano sinistra, chesi appoggia al mento e alla guancia.
Secondo venticinquennio del iv secolo a.C.4. Bildfeldstele di Prosousia, Atene, Museo Nazionale, inv. n. 789.4
Prosousia, una giovane donna, siede verso destra, con la testainclinata, sorretta dalla mano sinistra poggiata sul mento.
Secondo venticinquennio del iv secolo a.C.5. Bildfeldstele, Atene, Museo Nazionale, inv. n. 1010 (Fig. 7).5
Un uomo anziano, barbato, è effigiato stante di tre quarti verso sinistra; è avvolto nell’himation e poggia la guancia destrasulle dita piegate della mano.
Secondo venticinquennio del iv secolo a.C.6. Stele di Antiphilos, collocazione attuale ignota.6
Il giovane Antiphilos, forse un meteco originario di Olinto,si appoggia, con le gambe incrociate, a una loutrophoros-anforae porta la mano sinistra all’altezza della tempia per sorreggerela testa fortemente inclinata. La loutrophoros allude alle nozzeche il giovane non ha potuto celebrare a causa della morte prematura (cfr. n. 14). Lo stesso schema ricorre sugli esemplarinn. 10-14.
Seconda metà del iv secolo a.C.7. Stele frammentaria di Gelon, Atene, Museo Nazionale, inv.
n. 971.7Nella parte sinistra del campo figurato Gelon, un uomo
maturo e barbato, giace semidisteso su una kline, tenendo unacoppa nella mano destra protesa; sulla destra è effigiato l’anzia-no Kallistratos, stante, avvolto nel mantello, nell’atto di portarela mano destra alla fronte.
L’interpretazione della scena è controversa: Clairmont rico-nosce in Gelon il defunto, in Kallistratos un fratello o un amicoche ne piange la sorte; Scholl, invece, avanza il dubbio che Kal-listratos possa essere un secondo defunto.
Primo venticinquennio del iv secolo a.C.
18. Lekythos, Leiden, Rijksmuseum, inv. n. 1821.8Un giovane stante si rivolge verso un personaggio barbato,
che siede su una roccia, poggiando l’avambraccio sinistro sullasommità di uno scudo posto al suo fianco, mentre il braccio de-stro è sollevato a portare la mano sul pilos, per togliere il copri-capo, secondo Clairmont, ovvero, a parere di C. Maderna, permanifestare platealmente il proprio dolore.
Primo venticinquennio del iv secolo a.C.19. Stele di Moschion, Atene, Museo Nazionale, inv. n. 3697
(Fig. 5).9Eutychis stante, in veduta frontale, inclina la testa verso il
giovane Moschion, che siede con il busto curvo in avanti e latesta poggiata sulla mano destra.
Secondo venticinquennio del iv secolo a.C.10. Stele, Atene, Museo Nazionale, inv. n. 871.10
Un uomo anziano, stante, si volge verso il figlio, un giovane,caratterizzato come atleta, che si appoggia a un pilastro con legambe incrociate e la testa fortemente reclinata sorretta dallamano destra. Davanti al pilastro è accoccolato un servitore addormentato.
Insieme con i nn. 11 e 12 appartiene alla serie delle c.d. varian-ti della stele dell’Ilisso; il tipo iconografico del giovane defuntosi ripete sugli esemplari nn. 6 e 13-14.
Terzo venticinquennio del iv secolo a.C.11. Frammento di stele, Atene, Museo Nazionale, inv. n. 987.11
Si tratta di una replica della stele n. 10; si conservano la parteinferiore delle gambe del giovane e il pais seduto a terra.
Terzo venticinquennio del iv secolo a.C.12. Frammento di stele, collocazione attuale ignota.12
Si tratta di una replica della stele n. 10; si conserva solo il torso del giovane.
Terzo venticinquennio del iv secolo a.C.13. Bildfeldstele, Atene, Museo Nazionale, inv. n. 6208.13
Un giovane, rivolto verso destra, con la parte inferiore delcorpo avvolta nell’himation, si appoggia a una roccia, con la te-sta inclinata, sorretta dalla mano sinistra. Davanti a lui sono unpersonaggio maschile e una figura femminile stanti, in atteg-giamento di lutto, identificabili con i genitori. Lo schema delgiovane defunto ricorre sugli esemplari nn. 6, 10-12, 14.
Seconda metà del iv secolo a.C.14. Bildfeldstele di Alexandros Samios, Atene, Museo del Ceramico,
inv. nn. P 1137 e I 183 (Fig. 6).14Il giovane Alexandros, nudo, si appoggia a una loutrophoros-
anfora, con la testa fortemente inclinata e poggiata sulla manosinistra. La loutrophoros allude alle nozze che il giovane non hapotuto celebrare a causa della morte prematura (cfr. n. 6). Da-vanti a lui i genitori, che lo fissano e compiono gesti di lutto. Lafigura di Alexandros utilizza lo stesso tipo iconografico presen-te sugli esemplari nn. 6, 10-13.
Seconda metà del iv secolo a.C.
b. Rilievi di ambiti regionali diversi dall’Attica
15. Rilievo da Geronthrai/Geraki, Sparta, Museo, inv. n. Geraki 1(Fig. 4).15
1 CAT 10; Polojiorghi 2003, pp. 91-114.2 CAT 1.330; Huber 2001, pp. 152, 230, n. 232; A. Pasquier, in Clair 2005,
p. 49, n. 3; Franzoni 2006, pp. 117, 205-206, fig. 57.3 CAT 1.337; Hamiaux 1992, p. 164, n. 159; Bergemann 1997, p. 172, n. 540.4 CAT 1.341; Scholl 1996, p. 249, n. 85 (datazione: 400-390 a.C.).5 CAT 1.353; Scholl 1996, p. 263, n. 140 (datazione: 400-390 a.C.).6 CAT 1.456; Scholl 1996, p. 311, n. 330 (datazione: 340-330 a.C.).7 CAT 2.278; Scholl 1996, p. 259, n. 123, tav. 41,3 (datazione: 380-370 a.C.).8 CAT 2.279b; Meyer 1999, pp. 128-129, fig. 17; Maderna 2011, pp. 62-63,
fig. 31.
9 CAT 2.373; Scholl 1996, pp. 282-283, n. 226, tav. 30,3 (datazione: 370-360a.C.).
10 CAT 2.954; Bergemann 1997, pp. 165-166, n. 301, tavv. 86,3.4, 108,1.2; Maderna 2011, pp. 63-64, fig. 32.
11 CAT 2.955; Bergemann 1997, p. 178, n. 787. 12 CAT 2.956.13 CAT 3.450; Polojiorghi 2003, p. 107, tav. 17,2.14 CAT 3.455; Scholl 1996, pp. 126, 242, n. 61, tav. 36,1 (datazione: 350-340
a.C.); Himmelmann 1999, p. 115, nota 142.15 Friis Johansen 1951, p. 88, fig. 40; Schweitzer 1963, pp. 321-322;
Neumann 1965, pp. 145-147; Stibbe 1996, pp. 254-258, fig. 138; Förtsch 2001,
appendice
RILIEVI FUNERARI CON RAPPRESENTAZIONEDEL DEFUNTO AFFLITTO
40 elena ghisellini
Un giovanetto siede verso destra con la testa fortemente reclinata e la fronte poggiata sulla mano sinistra, nella manodestra tiene forse una mela.
Attribuita a officina laconica e datata alla metà del v secoloa.C.
16. Stele da Sinope, Kastamonu, Museo.1La defunta siede verso destra, con la testa inclinata e il
mento poggiato sulla mano sinistra sollevata. Davanti a lei sono due ancelle stanti, una delle quali partecipa al dolore dellapadrona portando alla guancia la mano destra.
Datata intorno alla metà del v secolo a.C.17. Stele da Sinope, Kastamonu, Museo.2
Si ripete, semplificata, la scena della stele n. 16. In questo caso una sola ancella in atteggiamento dolente fronteggia ladefunta.
Datata intorno alla metà del v secolo a.C.18. Stele da Palaiopolis, Andros, Museo.3
La defunta siede su un diphros, con la testa inclinata e laguancia poggiata sul dorso delle dita della mano sinistra. Da-vanti a lei è una figura femminile stante con una cassetta,un’ancella o una sorella minore. La stele è stata reimpiegatadue volte e il rilievo ha perciò subito estese rilavorazioni.
Attribuita a officina cicladica e datata intorno al 390 a.C.19. Stele da Rodosto, Salonicco, Museo Archeologico, inv. n. 932.4
Defunta stante con testa inclinata e avambraccio sinistro
piegato verso l’alto a sfiorare la guancia con le dita della mano.Sulla destra, a una certa distanza, si volge verso di lei una giovanetta stante.
Prima metà del iv secolo a.C.20. Stele da Rodosto, Salonicco, Museo Archeologico, inv. n. 934.5
A sinistra si staglia in veduta frontale una figura femminilestante, con la guancia poggiata sulla mano sinistra sollevata; sirivolge verso di lei una figura femminile stante, con la testa reclinata, completamente avvolta nel mantello e seguita daun’ancella.
Terzo venticinquennio del iv secolo a.C.21. Stele da Rodosto, Salonicco, Museo Archeologico, inv. n. 933.6
A destra siede la defunta, con il capo velato, inclinato, e lemani intrecciate in grembo. A sinistra è una figura stante, in ve-duta frontale, con la mano sinistra sollevata e portata al volto,che ripete il tipo iconografico dell’immagine di sinistra dellastele n. 20.
Terzo venticinquennio del iv secolo a.C.22. Frammento di stele, Heraklion, Museo Archeologico, inv. n.
366.7Si conserva parzialmente una figura femminile seduta, con
testa fortemente inclinata, viso di tre quarti verso lo spettatore,mano sinistra sollevata e accostata alla guancia.
Dipende da modelli attici, ma non è attico. Primo venticin-quennio del iv secolo a.C.
pp. 217-218, fig. 341; Huber 2001, pp. 124, 225, n. 148; Franzoni 2006, pp. 117,205-206, fig. 56.
1 Pfuhl, Möbius 1977, p. 17, n. 23, tav. 6; Huber 2001, p. 225, n. 147.2 Pfuhl, Möbius 1977, p. 17, n. 24, tav. 6.3 Despinis 1967, pp. 81-83, iii, tavv. 36-37; CAT, Suppl. 2.260.4 Pfuhl, Möbius 1977, p. 24, n. 51, tav. 13.5 Pfuhl, Möbius 1977, p. 24, n. 52, tav. 14; CAT 2.272a, nota 1; Despinis,
Stefanidou Tiveriou, Voutiras 1997, pp. 34-35, n. 17, fig. 35 (G. Despinis.
Lo studioso identifica la defunta con la figura centrale e scorge nella figura asinistra la madre afflitta o una parente; in realtà sembra preferibile riconosce-re la defunta nell’immagine di sinistra, che ha un ruolo dominante nell’eco-nomia della scena per le dimensioni maggiori, la frontalità e il volgersi versodi lei delle rimanenti due figure).
6 Pfuhl, Möbius 1977, p. 30, n. 70, tav. 18; CAT 2.272a, nota 1; Despinis,Stefanidou Tiveriou, Voutiras 1997, pp. 35-36, n. 18, fig. 36.
7 CAT 1.216.